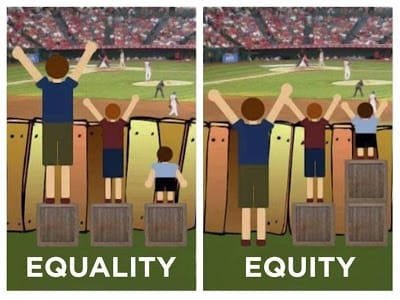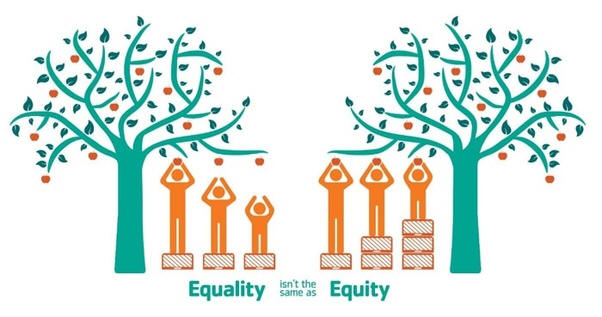Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI

 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
ANNO 2020
IL GOVERNO
PRIMA
PARTE
DI ANTONIO
GIANGRANDE

ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale, pluritematico e
pluriterritoriale, riferito al 2019, consequenziale a quello del 2018. Gli
argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati ed
approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e degradanti di
queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando del nulla, ma
dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio che l'offeso si
ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE
SIAMO.
UNA BALLATA
PER AVETRANA (di Antonio Giangrande). L’AVETRANA
CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA
INVASIONE BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA
ITALIOPOLI.
SOLITA
LADRONIA.
SOLITO
GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED ESAMI DI STATO
TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO
AFFAIRE ALDO MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE MANI SPORCHE DI
MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO
COMUNISTA BENITO MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5
STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI
COMUNISTI. CHI LI CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO
AMICO TERRORISTA.
1968
TRAGICA ILLUSIONE IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO
STEFANO CUCCHI & COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA
MANETTOPOLI.
SOLITA
IMPUNITOPOLI. L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI
MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA:
UNA STRAGE PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA
MAFIOPOLI.
SOLITE
MAFIE IN ITALIA.
SOLITA
MAFIA DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA
USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO
TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED I MEDIA
LA SCIENZA
E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE, OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
GLI ANNIVERSARI DEL 2019.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
IL GOVERNO
INDICE PRIMA PARTE
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE
SIAMO.
UNA BALLATA
PER AVETRANA (di Antonio Giangrande). L’AVETRANA
CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE. (Ho scritto un saggio dedicato)
La Credibilità.
L’Involuzione sociale e politica. Dal dispotismo all’illuminismo,
fino all’oscurantismo.
LA SOLITA INVASIONE BARBARICA SABAUDA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Il lungo viaggio temporale in Italia.
E gli "storici"? Tacciono…
Il Massone Garibaldi a disposizione della Chiesa di
Roma.
Napoli e Sud poco combattivi?
La Grande Guerra.
La Seconda Guerra.
Carmine Crocco, il Brigante
Generale.
Re galantuomo o Re caporale?
Anche le donne a capo del casato.
Liberatori d’Italia dal
nazifascismo: pellerossa e non comunisti.
Quelli che…o tutti o nessuno e poi vogliono la secessione!
Le oche starnazzanti.
La Questione Settentrionale.
Il metodo della “Spesa Storica”. Il ladrocinio degli evasori.
Sorpresa: il Nord si prende la gran parte dei soldi pubblici.
Il Sud Sbancato.
A-Nazionalità ed Anti-Italianità.
Ecco chi ha ucciso la nostra Patria.
LA SOLITA ITALIOPOLI. (Ho scritto un saggio dedicato)
Ma quale latrina?
L'Italia è federale per natura.
Un paese di inventori.
Il Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes e dell’Istat.
L'onore offeso di Nassirya.
Toponomastica Partigiana.
Paese di indigenti spendaccioni.
SOLITA LADRONIA. (Ho scritto un saggio dedicato)
Tutti dentro…
I Furbetti del Cartellino.
Gli italiani onesti. Quelli che
chiamano ladri gli altri.
INDICE SECONDA PARTE
SOLITO GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’. (Ho
scritto un saggio dedicato)
La prossima Egemonia Culturale.
Il referendum.
Cosa vuol dire «suffragio».
I Sondaggi.
Cosa è la politica?
Le battaglie a difesa del
Parlamento.
Candidati: pecore e porci…
Lo Stupidario della politica.
Avanti! Savoia.
I Disobbedienti. Radicali.
Liberisti e Comunisti.
I Liberali contro tutti.
L’Ordine Sociale e l'orgoglio di
dirsi Conservatore.
Il Paese di tutti contro tutti.
Ecco l'Anpi senza più partigiani.
Io sono il Potere Dio tuo.
I Conflitti d’Interesse.
Il Conflitto dei cognati.
I Redditi dei Governanti.
L’Infodemia: ossia l’indecisione su scelte su dati eccessivi e
non riscontrati.
Italia Commissariata.
Impreparati, incompetenti, immaturi: il ceto politico non è mai stato così
ignorante, come i suoi commissari.
Una politica senza alcuna
credibilità.
Impresentabili?
Il Governo dei Misteri.
Transatlantico addio!
L'Egocrazia.
I Voltagabbana.
Legge marketta e fondi markette.
Pensioni d’oro e vitalizi.
La Spazzacorrotti: a chi?! I contributi politici opachi.
Il Finanziamento ai Partiti.
La Rimborsopoli.
La Lottizzazione degli “Onesti e
Puri”.
Addio Partiti.
I Movimenti di Protesta.
Quelli del non-voto.
La "Likecrazia".
Senza Rabbia non c’è rivoluzione.
Il Cnel.
SOLITA APPALTOPOLI. (Ho scritto un saggio dedicato)
Codice Appalti illegale.
Era Corruzione…
Non era Corruzione…
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED ESAMI DI STATO
TRUCCATI. (Ho scritto un saggio dedicato)
La Cittadinanza col Trucco.
L’Amicocrazia.
Concorsi Pubblici (truccati) e
Pubblico Impiego. Sì…non per tutti. La Stabilizzazione del precariato amico.
Miur. "Tracce comprate, pressioni
dei sindacati". Quelle ombre sul concorsone.
Il concorso Mibac da 200mila persone.
Commercialisti, l'esame è una
scommessa.
Concorso presidi annullato.
Quei Concorsi Pubblici truccati all’Università.
Consulenti legali di Stato: ora
basta sprechi e favoritismi.
Il Concorso Pubblico di Consigliere-Assistente Parlamentare.
Il Concorso truccato per i
magistrati.
Gli Assistenti Giudiziari.
Il Concorso dei Poliziotti.
La Laurea dei poliziotti.
“Sesso in cambio di esami”.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE TRUCCATA. (Ho
scritto un saggio dedicato)
Avvocati si diventa pure così…
SOLITO SPRECOPOLI. (Ho scritto un saggio dedicato)
Le Regioni a statuto speciale
sempre pronte a battere cassa.
Il Costo dell’Inefficienza.
Più bidelli che carabinieri.
Lo spreco delle scorte.
Lo spreco delle Auto blu.
Il Costo del Caffè.
Difesa, oltre 3.000 le case occupate (senza titolo) da ex
militari, figli e mogli.
Vent’anni di crack delle banche
sono costati ai cittadini 45 miliardi di euro.
Il Finanziamento alle ONLUS.
Il Finanziamento alla Cultura.
Il Finanziamento all’Editoria.
Finanziamento ai Compagni.
La Marchetta ai Lgbt.
Lo Spreco in Rai.
Lo spreco nei cieli.
Lo Spreco in Alitalia.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE SPECULAZIONI.
Debito pubblico italiano: quanto
cresce e perché.
Lo Stato padrone.
Lo Stato Insolvente.
Il Golden Power.
L’Economia Italiana in balia dei Magistrati e della Iella.
Storia delle Tasse - Le tasse
nella storia. Meglio tartassati dalla Monarchia o dalla Repubblica?
Il Paradiso Fiscale.
Tassopoli.
Previdenziopoli.
Bancopoli.
Assicuropoli.
Acquisto, leasing o noleggio?
Tutte le trappole sulle auto.
La Telefonia truffaldina.
Così l’euro ha danneggiato
l’Italia.
"Il capitalismo è nelle mani dei
capitalisti senza capitale".
I Ricconi della Terra.
Lotterie e Giochi d’Azzardo.
IL GOVERNO
PRIMA PARTE
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande)
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Tra i nostri avi abbiamo condottieri, poeti, santi, navigatori,
oggi per gli altri siamo solo una massa di ladri e di truffatori.
Hanno ragione, è colpa dei contemporanei e dei loro governanti,
incapaci, incompetenti, mediocri e pure tanto arroganti.
Li si vota non perché sono o sanno, ma solo perché questi danno,
per ciò ci governa chi causa sempre e solo tanto malanno.
Noi lì a lamentarci sempre e ad imprecare,
ma poi siamo lì ogni volta gli stessi a rivotare.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Codardia e collusione sono le vere ragioni,
invece siamo lì a differenziarci tra le regioni.
A litigare sempre tra terroni, po’ lentoni e barbari padani,
ma le invasioni barbariche non sono di tempi lontani?
Vili a guardare la pagliuzza altrui e non la trave nei propri
occhi,
a lottar contro i più deboli e non contro i potenti che fanno
pastrocchi.
Italiopoli, noi abbiamo tanto da vergognarci e non abbiamo più
niente,
glissiamo, censuriamo, omertiamo e da quell’orecchio non ci si
sente.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Simulano la lotta a quella che chiamano mafia per diceria,
ma le vere mafie sono le lobbies, le caste e la massoneria.
Nei tribunali vince il più forte e non chi ha la ragione
dimostrata,
così come abbiamo l’usura e i fallimenti truccati in una
giustizia prostrata.
La polizia a picchiare, gli innocenti in anguste carceri ed i
criminali fuori in libertà,
che razza di giustizia è questa se non solo pura viltà.
Abbiamo concorsi pubblici truccati dai legulei con tanta malizia,
così come abbiamo abusi sui più deboli e molta ingiustizia.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Abbiamo l’insicurezza per le strade e la corruzione e
l’incompetenza tra le istituzioni
e gli sprechi per accontentare tutti quelli che si vendono alle
elezioni.
La costosa Pubblica Amministrazione è una palla ai piedi,
che produce solo disservizi anche se non ci credi.
Nonostante siamo alla fame e non abbiamo più niente,
c’è il fisco e l’erario che ci spreme e sull’evasione mente.
Abbiamo la cultura e l’istruzione in mano ai baroni con i loro
figli negli ospedali,
e poi ci ritroviamo ad essere vittime di malasanità, ma solo se
senza natali.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Siamo senza lavoro e senza prospettive di futuro,
e le Raccomandazioni ci rendono ogni tentativo duro.
Clientelismi, favoritismi, nepotismi, familismi osteggiano
capacità,
ma la nostra classe dirigente è lì tutta intera da buttà.
Abbiamo anche lo sport che è tutto truccato,
non solo, ma spesso si scopre pure dopato.
E’ tutto truccato fin anche l’ambiente, gli animali e le risorse
agro alimentari
ed i media e la stampa che fanno? Censurano o pubblicizzano solo
i marchettari.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Gli ordini professionali di istituzione fascista ad imperare e
l’accesso a limitare,
con la nuova Costituzione catto-comunista la loro abolizione si
sta da decenni a divagare.
Ce lo chiede l’Europa e tutti i giovani per poter lavorare,
ma le caste e le lobbies in Parlamento sono lì per sé ed i loro
figli a legiferare.
Questa è l’Italia che c’è, ma non la voglio, e con cipiglio,
eppure tutti si lamentano senza batter ciglio.
Che cazzo di Italia è questa con tanta pazienza,
non è la figlia del rinascimento, del risorgimento, della
resistenza!!!
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Questa è un’Italia figlia di spot e di soap opera da vedere in
una stanza,
un’Italia che produce veline e merita di languire senza speranza.
Un’Italia governata da vetusti e scaltri alchimisti
e raccontata sui giornali e nei tg da veri illusionisti.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma se tanti fossero cazzuti come me, mi piacerebbe tanto.
Non ad usar spranghe ed a chi governa romper la testa,
ma nelle urne con la matita a rovinargli la festa.
Sono un italiano vero e me ne vanto,
ma quest’Italia mica mi piace tanto.
Rivoglio l’Italia all’avanguardia con condottieri, santi, poeti e
navigatori,
voglio un’Italia governata da liberi, veri ed emancipati sapienti
dottori.
Che si possa gridare al mondo: sono un italiano e me ne vanto!!
Ed agli altri dire: per arrivare a noi c’è da pedalare, ma
pedalare tanto!!
Antonio Giangrande (scritta l’11 agosto 2012)
Il Poema di
Avetrana di Antonio Giangrande
Avetrana mia, qua sono nato e che possiamo fare,
non ti sopporto, ma senza di te non posso stare.
Potevo nascere in Francia od in Germania, qualunque sia,
però potevo nascere in Africa od in Albania.
Siamo italiani, della provincia tarantina,
siamo sì pugliesi, ma della penisola salentina.
Il paese è piccolo e la gente sta sempre a criticare,
quello che dicono al vicino è vero o lo stanno ad inventare.
Qua sei qualcuno solo se hai denari, non se vali con la mente,
i parenti, poi, sono viscidi come il serpente.
Le donne e gli uomini sono belli o carini,
ma ci sposiamo sempre nei paesi più vicini.
Abbiamo il castello e pure il Torrione,
come abbiamo la Giostra del Rione,
per far capire che abbiamo origini lontane,
non come i barbari delle terre padane.
Abbiamo le grotte e sotto la piazza il trappeto,
le fontane dell’acqua e le cantine con il vino e con l’aceto.
Abbiamo il municipio dove da padre in figlio sempre i soliti
stanno a comandare,
il comune dove per sentirsi importanti tutti ci vogliono andare.
Il comune intitolato alla Santo, che era la dottoressa mia,
di fronte alla sala gialla, chiamata Caduti di Nassiriya.
Tempo di elezioni pecore e porci si mettono in lista,
per fregare i bianchi, i neri e i rossi, stanno tutti in pista.
Mettono i manifesti con le foto per le vie e per la piazza,
per farsi votare dagli amici e da tutta la razza.
Però qua votano se tu dai,
e non perché se tu sai.
Abbiamo la
caserma con i carabinieri e non gli voglio male,
ma qua pure i
marescialli si sentono generale.
Abbiamo le scuole elementari e medie. Cosa li abbiamo a fare,
se continui a studiare, o te ne vai da qua o ti fai raccomandare.
Parlare con i contadini ignoranti non conviene, sia mai,
questi sanno più della laurea che hai.
Su ogni argomento è sempre negazione,
tu hai torto, perché l’ha detto la televisione.
Solo noi
abbiamo l’avvocato più giovane d’Italia,
per i paesani,
invece, è peggio dell’asino che raglia.
Se i diamanti
ai porci vorresti dare,
quelli li
rifiutano e alle fave vorrebbero mirare.
Abbiamo la piazza con il giardinetto,
dove si parla di politica nera, bianca e rossa.
Abbiamo la piazza con l’orologio erto,
dove si parla di calcio, per spararla grossa.
Abbiamo la piazza della via per mare,
dove i giornalisti ci stanno a denigrare.
Abbiamo le chiese dove sembra siamo amati,
e dove rimettiamo tutti i peccati.
Per una volta alla domenica che andiamo alla messa dal prete,
da cattivi tutto d’un tratto diventiamo buoni come le monete.
Abbiamo San Biagio, con la fiera, la cupeta e i taralli,
come abbiamo Sant’Antonio con i cavalli.
Di San Biagio e Sant’Antonio dopo i falò per le strade cosa mi
resta,
se ci ricordiamo di loro solo per la festa.
Non ci scordiamo poi della processione per la Madonna e Cristo
morto, pure che sia,
come neanche ci dobbiamo dimenticare di San Giuseppe con la Tria.
Abbiamo gli oratori dove portiamo i figli senza prebende,
li lasciamo agli altri, perché abbiamo da fare altri faccende.
Per fare sport abbiamo il campo sportivo e il palazzetto,
mentre io da bambino giocavo giù alle cave senza tetto.
Abbiamo le vigne e gli ulivi, il grano, i fichi e i fichi d’india
con aculei tesi,
abbiamo la zucchina, i cummarazzi e i pomodori appesi.
Abbiamo pure il commercio e le fabbriche per lavorare,
i padroni pagano poco, ma basta per campare.
Abbiamo la spiaggia a quattro passi, tanto è vicina,
con Specchiarica e la Colimena, il Bacino e la Salina.
I barbari padani ci chiamano terroni mantenuti,
mica l’hanno pagato loro il sole e il mare, questi cornuti??
Io so quanto è amaro il loro pane o la michetta,
sono cattivi pure con la loro famiglia stretta.
Abbiamo il cimitero dove tutti ci dobbiamo andare,
lì ci sono i fratelli e le sorelle, le madri e i padri da
ricordare.
Quelli che ci hanno lasciato Avetrana, così come è stata,
e noi la dobbiamo lasciare meglio di come l’abbiamo trovata.
Nessuno è profeta nella sua patria, neanche io,
ma se sono nato qua, sono contento e ringrazio Dio.
Anche se qua si sentono alti pure i nani,
che se non arrivano alla ragione con la bocca, la cercano con le
mani.
Qua so chi sono e quanto gli altri valgono,
a chi mi vuole male, neanche li penso,
pure che loro mi assalgono,
io guardo avanti e li incenso.
Potevo nascere tra la nebbia della padania o tra il deserto,
sì, ma li mi incazzo e poi non mi diverto.
Avetrana mia, finchè vivo ti faccio sempre onore,
anche se i miei paesani non hanno sapore.
Il denaro, il divertimento e la panza,
per loro la mente non ha usanza.
Ti lascio questo poema come un quadro o una fotografia tra le
mani,
per ricordarci sempre che oggi stiamo, però non domani.
Dobbiamo capire: siamo niente e siamo tutti di passaggio,
Avetrana resta per sempre e non ti dà aggio.
Se non lasci opere che restano,
tutti di te si scordano.
Per gli altri paesi questo che dico non è diverso,
il tempo passa, nulla cambia ed è tutto tempo perso.
La Ballata ti l'Aitrana di Antonio Giangrande
Aitrana mia,
quà già natu e ce ma ffà,
no ti pozzu
vetè, ma senza ti te no pozzu stà.
Putia nasciri
in Francia o in Germania, comu sia,
però putia
nasciri puru in africa o in Albania.
Simu italiani,
ti la provincia tarantina,
simu sì
pugliesi, ma ti la penisula salentina.
Lu paisi iè
piccinnu e li cristiani sempri sciotucunu,
quiddu ca
ticunu all’icinu iè veru o si l’unventunu.
Qua sinti
quarche tunu sulu ci tieni, noni ci sinti,
Li parienti
puè so viscidi comu li serpienti.
Li femmini e
li masculi so belli o carini,
ma ni spusamu
sempri alli paisi chiù icini.
Tinimu lu
castellu e puru lu Torrioni,
comu tinumu la
giostra ti li rioni,
pi fa capii ca
tinimu l’origini luntani,
no cumu li
barbari ti li padani.
Tinimu li
grotti e sotta la chiazza lu trappitu,
li funtani ti
l’acqua e li cantini ti lu mieru e di l’acitu.
Tinimu lu
municipiu donca fili filori sempri li soliti cumannunu,
lu Comuni
donca cu si sentunu impurtanti tutti oluni bannu.
Lu comuni
‘ntitolato alla Santu, ca era dottori mia,
ti fronti alla
sala gialla, chiamata Catuti ti Nassiria.
Tiempu ti
votazioni pecuri e puerci si mettunu in lista,
pi fottiri li
bianchi, li neri e li rossi, stannu tutti in pista.
Basta ca
mettunu li manifesti cu li fotu pi li vii e pi la chiazza,
cu si fannu
utà ti li amici e di tutta la razza.
Però quà
votunu ci tu tai,
e no piccè
puru ca tu sai.
Tinumu la
caserma cu li carabinieri e no li oiu mali,
ma qua puru li
marescialli si sentunu generali.
Tinimu li
scoli elementari e medi. Ce li tinimu a fà,
ci continui a
studià, o ti ni ai ti quà o ta ffà raccumandà.
Cu parli cu li
villani no cunvieni,
quisti sapunu
chiù ti la lauria ca tieni.
Sobbra
all’argumentu ti ticunu ca iè noni,
tu tieni
tuertu, piccè le ditto la televisioni.
Sulu nui
tinimu l’avvocatu chiù giovini t’Italia,
pi li paisani,
inveci, iè peggiu ti lu ciucciu ca raia.
Ci li diamanti
alli puerci tai,
quiddi li
scanzunu e mirunu alli fai.
Tinumu la
chiazza cu lu giardinettu,
do si parla ti
pulitica nera, bianca e rossa.
Tinimu la
chiazza cu l’orologio iertu,
do si parla ti
palloni, cu la sparamu grossa.
Tinimu la
chiazza ti la strata ti mari,
donca ni
sputtanunu li giornalisti amari.
Tinimu li
chiesi donca pari simu amati,
e donca
rimittimu tutti li piccati.
Pi na sciuta a
la tumenica alla messa do li papi,
di cattivi
tuttu ti paru divintamu bueni comu li rapi.
Tinumu San
Biagiu, cu la fiera, la cupeta e li taraddi,
comu tinimu
Sant’Antoni cu li cavaddi.
Ti San Biagiu
e Sant’Antoni toppu li falò pi li strati c’è mi resta,
ci ni
ricurdamo ti loru sulu ti la festa.
No nni
scurdamu puè ti li prucissioni pi la Matonna e Cristu muertu, comu sia,
comu mancu ni
ma scurdà ti San Giseppu cu la Tria.
Tinimu
l’oratori do si portunu li fili,
li facimu batà
a lautri, piccè tinimu a fà autri pili.
Pi fari sport
tinimu lu campu sportivu e lu palazzettu,
mentri ti
vanioni iu sciucava sotto li cavi senza tettu.
Tinimu li
vigni e l’aulivi, lu cranu, li fichi e li ficalinni,
tinimu la
cucuzza, li cummarazzi e li pummitori ca ti li pinni.
Tinimu puru lu
cummerciu e l’industri pi fatiari,
li patruni
paiunu picca, ma basta pi campari.
Tinumu la
spiaggia a quattru passi tantu iè bicina,
cu
Spicchiarica e la Culimena, lu Bacinu e la Salina.
Li barbari
padani ni chiamunu terruni mantinuti,
ce lonnu
paiatu loro lu soli e lu mari, sti curnuti??
Sacciu iù
quantu iè amaru lu pani loru,
so cattivi
puru cu li frati e li soru.
Tinimu lu
cimitero donca tutti ma sciri,
ddà stannu li
frati e li soru, li mammi e li siri.
Quiddi ca
nonnu lassatu laitrana, comu la ma truata,
e nui la ma
lassa alli fili meiu ti lu tata.
Nisciunu iè
prufeta in patria sua, mancu iù,
ma ci già natu
qua, so cuntentu, anzi ti chiù.
Puru ca quà si
sentunu ierti puru li nani,
ca ci no
arriunu alla ragioni culla occa, arriunu culli mani.
Qua sacciu ci
sontu e quantu l’autri valunu,
a cinca mi oli
mali mancu li penzu,
puru ca loru
olunu mi calunu,
iu passu a
nanzi e li leu ti mienzu.
Putia nasciri
tra la nebbia di li padani o tra lu disertu,
sì, ma ddà mi
incazzu e puè non mi divertu.
Aitrana mia,
finchè campu ti fazzu sempri onori,
puru ca li
paisani mia pi me no tennu sapori.
Li sordi, lu
divertimentu e la panza,
pi loro la
menti no teni usanza.
Ti lassu sta
cantata comu nu quatru o na fotografia ti moni,
cu ni
ricurdamu sempri ca mo stamu, però crai noni.
Ma ccapì: simu
nisciunu e tutti ti passaggiu,
l’aitrana
resta pi sempri e no ti tai aggiu.
Ci no lassi
operi ca restunu,
tutti ti te si
ni scordunu.
Pi l’autri
paisi puè qustu ca ticu no iè diversu,
lu tiempu
passa, nienti cangia e iè tuttu tiempu persu.
Testi
scritti il 24 aprile 2011, dì di Pasqua.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE. (Ho scritto un saggio dedicato)
Dr. Antonio Giangrande. Orgoglioso di essere diverso.
"Io non mi sento italiano": Giorgio Gaber aveva capito tutto.
Marco Castoro il 18 dicembre 2020. «IO NON mi sento
italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono». Questi versi della canzone di
Giorgio Gaber (datata 2003) la dicono tutta sull’Italia di ieri, di oggi e
chissà anche di domani, se neanche con la scossa dei fondi europei riusciamo a
scuoterla per cambiarla. Quanti di noi non si sentono italiani, vuoi perché il
Paese è prigioniero della burocrazia, vuoi perché è gestito da politici e
burocrati che pensano solo alle poltrone e a complicare la vita degli italiani.
Una classe politica e dirigenziale che non sa prendere decisioni, che si becca
come in un pollaio con le elezioni come unico pensiero e obiettivo. Nel «per
fortuna o purtroppo lo sono» c’è tutta l’Italia e l’italiano. C’è la bellezza
del clima, del mare e dei monti, del sole e delle scogliere. C’è la bellezza
dell’arte che ti lascia a bocca aperta. Dal Romano al Rinascimento, dal Barocco
al Neorealismo. Orgoglio della patria, così come la nazionale di calcio, la moda
e l’artigianato, l’arte di arrangiarsi e la creatività degli italiani. Nel
«purtroppo lo sono» invece c’è la disperazione di non vedere mai l’uscita del
tunnel, di pagare delle tasse elevate per poi ricevere dei servizi scadenti, di
vedere scappare all’estero i migliori cervelli. Di vedere l’Alta Velocità che si
ferma a Salerno. La banda larga ultraveloce che diventa un lusso per pochi
invece che un servizio per tutti, anche per chi non vive nelle grandi città. La
didattica a distanza ha messo a nudo il problema. «Un Bel Paese pieno di poesia
ma che nel mondo occidentale è la periferia», per citare ancora Gaber che
ammette la sconfitta dell’Italia quando sentenzia: «Non vedo alcun motivo per
essere orgogliosi». Il mitico G.G. se la prende anche con il Mameli: «Non sento
un gran bisogno dell’inno nazionale di cui un po’ mi vergogno». Per poi radere
al suolo i politici e i parlamentari, la vera zavorra di un Paese che non cresce
e che paga le loro incompetenze. «Ma questo nostro Stato che voi rappresentate
mi sembra un po’ sfasciato. È anche troppo chiaro agli occhi della gente che
tutto è calcolato e non funziona niente… Persino in parlamento c’è un’aria
incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente… il grido ‘Italia,
Italia’ c’è solo alle partite». Attualissima anche la frase «Abbiam fatto
l’Europa, facciamo anche l’Italia», che si potrebbe tradurre come una
invocazione al governo, all’opposizione, alle task force e alle Regioni a
sfruttare al massimo i soldi del Next Generation Eu. In modo da poter finalmente
dire: Io mi sento italiano.
La
contemporaneità italiana raccontata ai posteri ed agli stranieri.
Se la
Storia la scrivono i vincitori, ora tocca ai vinti raccontare quello che non si
riporta dalla Cultura del pensiero unico ed imperante e dai Media ideologizzati
asserviti al potere politico ed economico.
Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Sono qualcuno, ma non avendo nulla per poter dare, sono nessuno.
Sono un guerriero e non ho paura di morire.
Non ho alcun
potere. Ho provato a difendere gli indifesi quando praticavo nei Tribunali. Non
guardavo in faccia nessuno per l’amor di verità e giustizia. Il risultato è che
sono stato cacciato e perseguitato. Inoltre, coloro che difendevo mi hanno
voltato le spalle. I politici a cui segnalavo le anomalie mi prendevano per
pazzo o mitomane.
Purtroppo le
controversie sono risolte dai magistrati nei processi con l’ausilio degli
avvocati difensori.
I quesiti a
cui dare risposta sono:
Ci sono
magistrati degni di stima e rispetto, che applichino la legge secondo legalità
ed equità?
Ci sono
avvocati che spingono i magistrati a prendere le decisioni secondo giustizia?
Ci sono
governanti e legislatori che ascoltano le preghiere dei cittadini, avendo potere
d’intervento sui magistrati?
Cosa fa il
“popolo” per cambiare le cose?
La risposta è
che ognuno guarda i “cazzi” suoi”.
Allora la mia
considerazione naturale è:
Parafrasi ed Assioma con intercalare. Non ho nulla più da
chiedere a questa vita che essa avrebbe dovuto o potuto concedermi secondo i
miei meriti. Ma un popolo di coglioni sarà sempre governato, amministrato,
giudicato, istruito, informato, curato, cresciuto ed educato da coglioni. Ed è
per questo che un popolo di coglioni avrà un Parlamento di coglioni che sfornerà
“Leggi del Cazzo”, che non meritano di essere rispettate. Chi ci ha
rincoglionito? I media e la discultura in mano alle religioni; alle ideologie;
all’economie. Perché "like" e ossessione del politicamente corretto ci
allontanano dal reale. In quest'epoca di post-verità un'idea è forte quanto più
ha voce autonoma. Se la libertà significa qualcosa allora ho il diritto di dire
alla gente quello che non vuole sentire.
Lettera al
''Giornale'' il 20 ottobre 2020. Tale Simona Bonafè (Pd) in tv, ospite di Nicola
Porro, ha testualmente affermato «non facciamo gli italiani più imbecilli di
quanto non siano». Informo la svampita onorevole che gli italiani non meritano
di essere offesi da una scappata di casa che sostiene un governo che dell'
imbecillità ha fatto una bandiera! Giuseppe Metelli
Risponde Tony
Damascelli sul ''Giornale'' il 20 ottobre 2020. Gentile signor Giuseppe ogni
volta che leggo o ascolto una corbelleria mi tornano alla mente le battute di
Totò, il quale anticipava i tempi non immaginando comunque che addirittura i
rappresentanti delle istituzioni scendessero al ruolo di comparse e battutisti.
Lei segnala, appunto, un passaggio delle parole pronunciate dalla parlamentare
Bonafé Simona la quale, in coerenza con il proprio cognome, dunque in buona
fede, ha detto testualmente. «non facciamo gli italiani più imbecilli di quanto
non siano». Meglio avrebbe fatto a usare la prima persona plurale del verbo,
dunque «..di quanto non siamo..» ma mi rendo conto che questo sarebbe stato un
salto culturale e di coscienza che una esponente di questo governo non può
avere, appartenendo a un clan esclusivo di nati già imparati. Ecco perché mi è
tornata in mente la frase del principe De Curtis: «Lei è un cretino, si
informi», un riassunto che spiega tutto, un invito che è una condanna alla
berlina pubblica. Può darsi che noi italiani siamo così cretini che nemmeno una
parlamentare può immaginarlo, ma si dovrebbe presumere che la nostra imbecillità
derivi proprio dal fatto di essere rappresentati da simili personaggi. Non
voglio scadere nelle facili e volgari provocazioni ma spesso la Bonafé è
scivolata in modo imprevedibile e goffo, scambiando congiunto con congiuntivo,
un errore di sbaglio si potrebbe dire per mettersi allo stesso livello ma, come
sostiene la stessa deputata di Azzate, non siamo mica tutti imbecilli.
«Il popolo è una puttana e va col
maschio che vince» (Mussolini a proposito del sentimento filotedesco in Italia
dopo i primi successi della Wermacht) (Renzo De Felice, Breve storia del
fascismo, Mondadori)
"Il popolo cornuto era e cornuto resta: la differenza è che il
fascismo appendeva una bandiera sola alle corna del popolo e la democrazia
lascia che ognuno se l'appenda da sé, del colore che gli piace, alle proprie
corna... Siamo al discorso di prima: non ci sono soltanto certi uomini a nascere
cornuti, ci sono anche popoli interi; cornuti dall'antichità, una generazione
appresso all'altra...- Io non mi sento cornuto - disse il giovane - e nemmeno
io. Ma noi, caro mio, camminiamo sulle corna degli altri: come se ballassimo..."
Leonardo Sciascia dal libro "Il giorno della civetta".
Un chierico medievale si imbatté in un groviglio di serpi su cui
spiccava un ramarro che già da solo sarebbe bastato a spaventarlo. Tuttavia,
confrontata a quelle serpeggianti creature, la bestiola gli parve graziosa ed
esclamò: «Beati monoculi in terra caecorum», nella terra dei ciechi anche l’orbo
è re.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Quando
esprimiamo giudizi gratuiti, cattivi ed illogici lo facciamo con la nostra bocca
ma inconsapevolmente per volontà di altri. Lo facciamo in virtù di quanto
ricevuto: dall’educazione familiare, dall’istruzione di regime,
dall’indottrinamento politico e religioso, dall’influenza mediatica. Niente è
farina del nostro sacco. Se ci basassimo solo sulle nostre esperienze staremmo
solo zitti, sapendo che nessuno sarebbe capace e disposto ad ascoltarci.
Cos’è la Legalità: è la conformità alla legge.
La dimensione sociale della legalità e i benefici dello
sviluppo del diritto positivo. Daniela Piana su Il
Dubbio il 13 agosto 2020.
Un grave errore mettere in secondo piano il protocollo
sottoscritto dal Consiglio nazionale forense con il ministero dell’Istruzione
sul terreno della cultura del diritto. Sono ormai mesi che ci misuriamo, in modo
più o meno consapevole, più o meno condiviso e chiaramente articolato, con un
grande dilemma: quali sono gli strumenti che ci permettono di rendere
prevedibile, ovvero determinabile, e quindi, anche, governabile in modo lineare,
il comportamento sociale? Per quanto un diffuso e serpeggiante understatement
emerso nel crollo delle grandi teorie – non delle grandi ideologie – sul
funzionamento delle nostre società ci abbia accompagnato e ci abbia incoraggiati
ad aderire ad un rassicurante evitamento delle grandi domande – “tanto, poi, non
si trovano le risposte e quando le si trovano sono già oggetto di discussione e
giammai di consenso, dunque inutili per prendere decisioni collettive” – questo
pensiero minimo oggi ci aiuta assai poco. La realtà dei fatti ci ha sbattuto in
faccia, con una violenza inedita, dapprima la questione del “Cigno nero”, poi la
questione di come originare, di colpo nell’arco temporale di qualche giorno, un
nomos sociale tutto nuovo, sospendendo e disapplicando i dispositivi di
regolazione sociale cui eravamo abituati nel gestire le nostre vite quotidiane,
gettandoci nello spaesamento di un mondo di regole artefatte, cogenti e
strutturanti ( cosi ci è parso, vedendoci camminare per strada, pochi e
distanziati, vedendoci cedere il passo per non incrociarci nello spazio
pubblico) per poi costringerci a cimentarci di nuovo con la questione dei limiti
dello strumento del diritto positivo nell’orientare, no, anzi nel determinare, i
comportamenti individuali. Ben venga dunque la presentazione al pubblico della
traduzione del volume di Christian List, Why Free Will is Real, avvenuta qualche
giorno fa sulla Lettura. Ben venga perché con la categoria del free will ci
portiamo dietro moltissime conseguenze che pesano come macigni e che al contempo
ci costringono ad interrogarci su uno strumento, quello cardine della società
moderna e democratica, con cui siamo propensi a regolare i comportamenti
individuali: ossia lo strumento del diritto positivo. Poniamoci alcune domane a
mò di esempio. I cittadini italiani hanno seguito le regole del confinamento
perché prevedevano le sanzioni previste dai Dpcm che si sono susseguiti, perché
percepivano nel loro campo visivo quotidiano i segni palesi del controllo
pubblico esercitato dalle forze dell’ordine – e quindi ne prevedevano in modo
certo il potere sanzionatorio – o perché sulla base di informazioni e di valori
interiorizzati hanno aderito ad una prospettiva di tutela collettiva? Ancora: le
vicende che hanno messo al centro del dibattito istituzionale la questione del
rapporto fra magistratura e politica si leggono, interpretano ed esplicano nei
termini di “non sufficientemente cogenti interazioni” fra le strategie
individuali e le norme disciplinari, ovvero le loro applicazioni, oppure abbiamo
bisogno di categorie che ci aiutino a rimettere al centro la autonomia del
giudizio e, quindi, quell’insieme di norme e di valori che non sono pos( i) te
nelle leggi e nelle regolazioni, ma che attengono alla integrità? Sulla stessa
falsariga: la recentissima vicenda dell’utilizzo distorto dei bonus ci parla di
un comportamento che avrebbe dovuto essere prevenuto – ossia impedito – dalle
norme che regolano l’erogazione dei bonus oppure di un self- restraint che sia
interiorizzato dalle persone che svolgono funzioni pubbliche? Sarebbe troppo
facile liquidare questi interrogativi come divertissement estivi di una vagante
immaginazione filosofica, che forse puo’ dare soddisfazione ad alcuni studiosi
di eccellenza, come List, ma che poco ci aiuta nel governo e nella
prospettazione della società di domani. Troppo facile: e quando le cose sono
troppo facili, forse non sono correttamente impostate. Più adeguato ci pare sia
tempo interrogarci su cosa siamo intenzionati a chiedere allo strumento del
diritto positivo – sottraendolo così allo spazio della autonomia del giudizio e
dell’azione regolati da meccanismi self restraining di integrità e diciamolo
dalla dimensione sociale della legalità, proprio nel momento in cui la questione
della disciplina e della coniugazione di comportamenti individuali con
l’integrità pubblica ci appare uno dei grandi temi su cui investire per il
futuro. Solo un difetto visivo che non ci possiamo concedere giustificherebbe
dunque il passare a coté del protocollo recentemente sottoscritto dal Consiglio
Nazionale Forense con il Ministero dell’Istruzione sul tema della cultura della
legalità. Se si colgono nelle recenti esperienze fatte sul territorio italiano
dagli Ordini forensi, in partenariato con le scuole, le radici di un modo di
vedere la legalità nella sua dimensione sociale, che si nutre di un uso corretto
delle parole per definire correttamente i comportamenti, dell’uso della prassi
apprese in un percorso corale, come comportamenti che si rinforzano anche
attraverso i meccanismi di controllo orizzontale – e non solo quelli verticali –
come apprendimento di un diritto che ha le sue radici innanzitutto nella mente
delle persone, prima che nei testi di legge, forse potremmo concederci un cauto,
ma non freddo, positivo sentire, che vede nel diritto positivo una delle
dimensioni della legalità, la quale sarebbe però incardinata nel senso
dell’equità e della reciprocità, promosse attraverso due strumenti sui quali il
Paese deve investire in modo sistematico: formazione e professionalità,
interiorizzate, vissute, praticate dalle persone, governati e governanti. E deve
farlo ora.
Cos’è la natura umana, lo stimolante confronto tra Chomsky e
Foucault. Filippo La Porta su Il Riformista il 10
Luglio 2020. Ma esiste la “natura umana”, o qualcosa definibile in quanto tale
sul quale basare la nostra azione politica? Ad esempio i valori della giustizia,
dell’integrità, dell’amore per gli altri. Faccio un passo indietro. Come ognuno
sa il repertorio illimitato che offre la Rete ha modificato la nostra insonnia,
ci ha reso possibile, entro certi limiti, “usarla” (come occasione preziosa di
conoscenza e apprendimento). Colpito da insonnia stagionale (calura estiva)
nelle ultime notti ho navigato in Rete alla ricerca di argomenti sfiziosi,
curiosità e lontane remininescenze. Non si pensi solo alla “cultura alta”: ad
esempio ho rivisto i deliziosi monologhi televisivi di Walter Chiari, poi a un
certo però mi sono imbattuto nel confronto, alla tv olandese, tra Noam Chomsky del Mit e Michel
Foucault del Collège de France (1971) proprio sulla “natura umana” (ho
successivamente scoperto che ne sono usciti due libretti, uno Derive/Approdi,
l’altro Castelvecchi, infarciti di postfazioni). Ritengo che questo confronto
sia straordinario, formativo, e un raro esempio di altissima drammaturgia
filosofica. Cosa dicono i due grandi intellettuali?
Chomsky teorizza coerentemente la esistenza di una natura umana,
che secondo lui consiste fondamentalmente – e in ciò risale a Cartesio (che
definisce la mente come qualcosa che si contrappone al mondo fisico) – in una
capacità creativa: si tratta di una facoltà che ogni bambino dimostra quando
alle prese con una nuova situazione reagisce ad essa, la descrive, la pensa in
modo nuovo, e che gli permette di apprendere la propria lingua madre rapidamente
e senza impararne le regole. Una facoltà naturale, metastorica, che fonda il
nostro agire politico contro ogni potere coercitivo (ed ad esempio le varie
forme di disobbedienza civile): se questo bisogno di ricerca creativa (a partire
dal linguaggio), di libera creazione, è un elemento della natura umana, un
invariante biologico, allora una società più giusta dovrebbe permetterci di
massimare la possibilità di realizzare tale caratteristica umana.
Foucault replica che invece tutto è prodotto della Storia, che
nella nozione di natura umana c’è sempre qualcosa di regolativo, che quando la
definiamo prendiamo in prestito elementi della nostra cultura e civiltà.
Onestamente dà l’impressione di essere più sottile, più sofisticato del suo
interlocutore, almeno fino a quando non cita come massima fonte
autorevole Mao-Tse -Tung, che parlava di natura umana borghese e di natura umana
proletaria. E aggiunge che il proletariato combatte la classe dirigente non
perché lo ritiene giusto ma perché vuole prendere il potere (rivelando una
antropologia alla Hobbes!). Non si mostra interessato a definire cos’è l’uomo
(la sua “essenza”, definibile solo in termini metafisici) ma a capire cosa si
può e si deve fare dell’uomo (in ciò singolarmente vicino a Sartre, con cui pure
era spesso in polemica).
Cosa ricavarne? Non pretendo di trovare una soluzione e anzi
lascio al lettore la libertà di trarne le sue conclusioni. Mi limito a osservare
che in genere il buon senso (americano ed ebraico) di Chomsky me lo rende più
simpatico: dice ad esempio che se il proletariato vincendo la sua battaglia
creasse uno stato di polizia fondato sul Terrore allora lui vi si opporrebbe,
appunto in nome di valori umani fondamentali, radicati nella nostra natura.
Anche se vedo la problematicità della sua posizione: in fondo anche
Hitler avrebbe potuto appellarsi alla “natura umana”, magari assumendo come sua
prerogativa principale il bisogno di sicurezza! Inoltre: è anche vero che quel
bisogno di creatività è un prodotto storico, nato dalla interazione sociale
(tralascio la questione se davvero donne e uomini abbiano la “stessa” natura…).
Provo allora a suggerire una terza posizione. A me sembra che la negazione
integrale – foucaultiana – della natura umana abbia portato (si pensi
all’oltranzismo di certe posizioni sul gender) alla insofferenza verso qualsiasi
“limite”, alla cancellazione di ogni vincolo naturale, e dunque alla irrealtà.
Per Proudhon la giustizia nasceva – in società – dal riconoscimento della
dignità di ogni essere umano: «è il rispetto, spontaneamente provato e
reciprocamente garantito, della dignità umana, in qualsiasi persona». Certo,
questo riconoscimento è emerso a un certo punto della Storia umana, non prima,
ma diventerà un punto di non ritorno. E può fondare qualsiasi tipo di resistenza
al potere. In tal senso allora una azione politica potrebbe fondarsi non tanto
sulla natura umana quanto su ciò che intendiamo valorizzare della natura umana
(sempre contraddittoria, un poco “lunatica”, come osservò Orwell), però senza
poterne prescindere.
Liberale=amante della libertà propria e rispetto di quella
altrui. Secondo diritto naturale, non economico. Per esempio: i poveri non si
sostengono economicamente, per farli rimanere tali, ma si aiutano a diventare
ricchi, eliminando ogni ostacolo posto sulla loro strada da caste e lobbies.
In parole povere. Spiegazione con intercalare efficace: Fare i
cazzi propri, senza rompere il cazzo agli altri.
Attenzione, pero, a nominare il termine “liberale” invano,
perché i liberali non esistono.
Si spacciano come tali quelli come Berlusconi, ma sono solo
lobbisti capitalisti. E molto hanno in comune con i comunisti, leghisti e
fascisti e gli inconsistenti 5 stelle. Tutti fanno solo i cazzi loro, rompendo
il cazzo agli altri.
Non c'è nessun però o nessun ma. Il diritto di aiutare è un gesto
solidale. Ma l'aiuto non è per tutti. Cassa integrazione, indennità di
disoccupazione, reddito di cittadinanza sono sostegni economici non per tutti.
Quindi l'aiuto è tale solo se ricambiato. Il dovere di abbattere caste è lobbies
per affermare l'equità è doveroso. Io voglio, se valgo, il posto degli incapaci
che mi dicono cosa fare. Invece l'assuefazione al chiedere e l'abitudine a
ricevere ha reso le masse proletarie parassitarie. I Poveri, anzichè battersi
per i diritti, ora sono pronti a vendersi per gli oboli, diventando schiavi dei
potentati gattopardiani.
Qual è la differenza tra equità e uguaglianza?
L’uguaglianza
comporta che chi non si vuole sbattere, ottenga lo stesso di chi invece si fa il
mazzo.
Equità significa che se uno per esempio fa carriera (e i soldi) e
l’altro no, pur avendo frequentato entrambi la stessa scuola nelle stesse
condizioni, quello rimasto al palo, dovrebbe biasimare solo sè stesso, perchè
hanno avuto entrambi la stessa opportunità.
Mattia Biella, System Integrator, Tecnico di automazione(1995
-oggi) su it.quora.com. Ha Risposto il 12 dicembre 2018.
Eccone un’immagine interessante. Uguaglianza è quando tutti sono
trattati allo stesso modo (figura a sinistra).
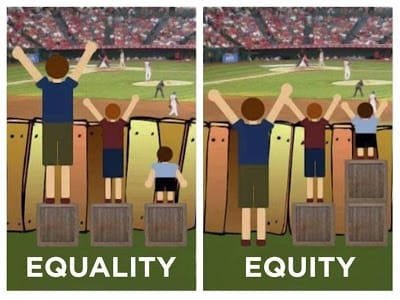
Da qph.fs.quoracdn.net
Non è detto che cambi qualcosa: a chi già poteva non cambia
nulla, per chi non poteva non è detto che adesso possa. A destra
invece l’equità: non è detto che tutti ricevano lo stesso, ma ciascuno riceve
quello che gli serve. Uguaglianza significa avere tutti la stesa
cosa, equità significa avere tutti le stesse opportunità. Mentre l’uguaglianza è
facile da ottenere, l’equità comporta scelte da parte di chi deve fornire gli
strumenti. Oltretutto, chi beneficia di eventuali aiuti vede una differenza
magari marcata tra ciò che egli riceve e quello che riceve invece il suo
vicino/amico/compagno, e scatta il tormentone perchè lui ne ha avuto di più?
Equità però significa anche che se uno per esempio fa carriera (e i soldi) e
l’altro no pur avendo frequentato entrambi la stessa scuola nelle stesse
condizioni, quello rimasto al palo dovrebbe biasimare solo sè stesso perchè
hanno avuto entrambi la stessa opportunità. L’uguaglianza comporta che chi non
si vuole sbattere ottenga lo stesso di chi invece si fa il mazzo. Quindi chi non
vuole sbattersi pensa chi me lo fa fare dato che poi comunque ho lo stesso ciò
che mi serve? mentre quello che si sbatte pensa chi me lo fa fare se poi
comunque non mi resta in mano nulla più di quelli che non si sbattono?. In
realtà l’immagine completa comprenderebbe un terzo pannello, in cui la
staccionata non c’è più ed è stata sostituita da una rete, e quella situazione
rappresenta la situazione in cui gli ostacoli sono stati rimossi e tutti possono
godere fin da subito delle stesse opportunità, ma va oltre la domanda posta.
Questa immagine rende meglio l’idea, credo. In questo caso è
lampante come l’uguaglianza sia di fatto discriminante, anche se a molti sembra
un paradosso.

Da qph.fs.quoracdn.net
Anche in questa immagine direi che la differenza è chiara.
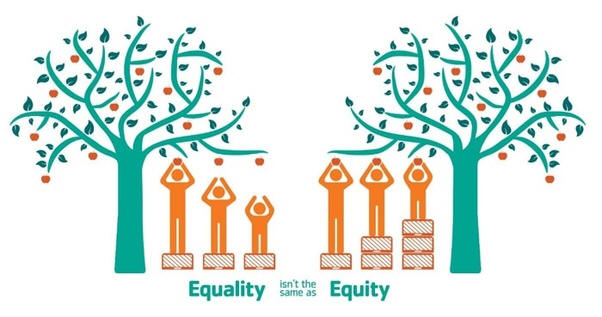
Da qph.fs.quoracdn.net
Che governi l'uno, o che governi l'altro, nessuno di loro ti
ha mai cambiato la vita e mai lo farà. Perchè? Sono tutti Comunisti e
Statalisti. Sono sempre contro qualcuno. Li differenzia il motto: Dio, Patria e
Famiglia...e i soldi.
Gli uni sono per il cristianesimo come culto di Stato. Gli
altri sono senza Dio e senza Fede, avendo come unico credo l'ideologia, sono per
l'ateismo partigiano: contro i simboli e le tradizioni cristiane e parteggiando
per l'Islam.
Gli uni sono per la Patria e la difesa dei suoi confini. Gli
altri sono senza Patria e, ritenendosi nullatenenti, sono senza terra e senza
confini e, per gli effetti, favorevoli all'invasione delle terre altrui.
Gli uni sono per la famiglia naturale. Gli altri sono senza
famiglia e contro le famiglie naturali, essendo loro stessi LGBTI. E per i
Figli? Si tolgono alle famiglie naturali.
Gli uni sono ricchi o presunti tali e non vogliono dare soldi
agli altri tutto ciò che sia frutto del proprio lavoro. Gli altri non hanno
voglia di lavorare e vogliono vivere sulle spalle di chi lavora, facendosi
mantenere, usando lo Stato e le sue leggi per sfruttare il lavoro altrui.
Arrivando a considerare la pensione frutto di lavoro e quindi da derubare.
Alla fine, però, entrambi aborrano la Libertà altrui,
difendendo a spada tratta solo l'uso e l'abuso della propria.
Per questo si sono inventati "Una Repubblica fondata sul
Lavoro". Un nulla. Per valorizzazione un'utopia e una demagogia e legittimare
l'esproprio della ricchezza altrui.
Ecco perchè nessuno si batterà mai per una Costituzione
repubblicana fondata sulla "Libertà" di Essere e di Avere. Ed i coglioni
Millennials, figli di una decennale disinformazione e propaganda ideologica e di
perenne oscurantismo mediatico-culturale, sono il frutto di una involuzione
sociale e culturale i cui effetti si manifestano con il reddito di cittadinanza,
o altre forme di sussidi. I Millennials non si battono affinchè diventino ricchi
con le loro capacità, ma gli basta sopravvivere da poveri.
La sinistra ha il buonismo ed il Politicamente Corretto su
immigrazione ed LGBTI, la destra il proibizionismo ed il punizionismo moralista
sul sesso e la droga. Il Giustizialismo per entrambi è per gli altri, il
garantismo per se stessi.
Avvolti nella loro coltre di arroganza e presunzione, i
Millennials, non si sono accorti che non sono più le Classi sociali o i Ceti ad
affermare i loro diritti, ma sono le lobbies e le caste a gestire i propri
interessi.
Nord e Sud ed i ladri e razzisti dentro.
"Sbagliato dare gli stessi stipendi a Milano e Reggio Calabria" dice il sinistro
Beppe Sala, sindaco di Milano. Dovrebbe sapere, lui, se fosse solo ignorante e
non in malafede, che a parità di stipendio il maggiore costo della vita elevato
al Nord va a pareggiare i maggiori costi dei diritti negati al Sud, a causa del
ladrocinio padano dei Fondi nazionali e comunitari destinati al meridione. Da
buoni comunisti (Padani) per loro vale il detto: “quello che è mio è mio; quello
che è tuo è pure mio”.
La verità è che al Sud la vita costa di più.
Angelo Bruscino, Imprenditore impegnato nella Green Economy,
giornalista e scrittore, su Huffingtonpost.it il 13/07/2020. Caro sindaco di
Milano, la verità è che al Sud la vita costa di più. Costa di più, perché
abbiamo una pressione fiscale maggiore in cambio di servizi inesistenti. Costa
di più, perché il tempo per aprire una impresa è il triplo che a Milano. Costa
di più, perché la burocrazia è un costo occulto per cittadini e imprese. Costa
di più, perché la nostra aspettativa di vita media è più bassa, ci ammaliamo di
più e dobbiamo andare al Nord a farci curare, di tasca nostra. Costa di più,
perché i processi sono infiniti. Costa di più, perché non abbiamo l’Alta
velocità ma l’altra velocità. Costa di più, perché non abbiamo metrò, ma strade
fatiscenti: andiamo al lavoro in auto, mica in Tav, con tutti i costi ambientali
che ciò comporta. Costa di più, perché le scuole crollano, mancano gli asili e
chi può manda i figli a studiare alla Bocconi a spese proprie. Costa di più,
perché da Palermo a Messina o da Salerno a Reggio Calabria è una odissea. Costa
di più, perché i prodotti che consumiamo vengono dal Nord, a eccezione di
frutta, verdura e pesce, le uniche cose che costano di meno perché le
produciamo! Dimenticando che i redditi degli impiegati pubblici servono proprio
ad acquistare i beni del Nord, così che Lei possa dire: “Milano non si ferma”.
Patrimoni sconosciuti del Sud. La
maggioranza dei comuni meridionali ignora i beni pubblici che amministra. Perché
non censire le nostre risorse? La proposta per dare nuova vitalità al territorio
e lavoro ai giovani. Piero Bevilacqua il 5 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Questi brevi suggerimenti nascono dalla necessità di fornire, in tempi il più
possibile brevi, delle opportunità di lavoro ai tanti giovani, in gran parte
laureati, spesso di ritorno nel Sud a causa della pandemia, perché trovino per
lo meno ragioni di permanenza temporanea, suscettibile di sviluppi futuri. Io
credo che la grandissima maggioranza dei comuni meridionali ignorino i patrimoni
pubblici che pure amministrano (terreni, edifici e vari beni immobili, monumenti
artistici, acque interne, risorse naturali, dotazioni ambientali e di
biodiversità) per i quali i giovani laureati in scienze agrarie, in economia, in
architettura, in giurisprudenza, in ingegneria, materie umanistiche, ecc
potrebbero in breve tempo essere chiamati a compiere una ampia operazione di
ricognizione e di censimento di comprensibile utilità. Pensiamo al lavoro per
rendere noti i terreni potenzialmente disponibili ad uso agricolo. Naturalmente
non tutti i comuni sono nelle stesse condizioni, ma assai spesso si tratta di
fare emergere, soprattutto nelle campagne interne, tanto i fondi e i beni
comunali, che quelli demaniali, gli usi civici, ma anche le terre private
abbandonate. Ricordo che tale lavoro risulterebbe utile non solo ai fini
propriamente agricoli, ma anche per individuare i siti, poco vocati
all’agricoltura, o ad altro uso produttivo, in cui installare veri e propri
centri di generazione di energia solare. Il territorio improduttivo ma che gode
di prolungato irraggiamento, può essere utile anche a questo. Una operazione
simile andrebbe condotta inoltre, per conto dei comuni e in collaborazione con
gli istituti competenti, nei tanti paesi, borghi, cittadine in vie di
spopolamento per avere un quadro del patrimonio abitativo in abbandono, dei beni
artistici e monumentali spesso dimenticati, del loro stato di conservazione, dei
tanti lasciti spesso preziosi di conventi, palazzi padronali, fontane, cisterne,
canali, ponti, briglie idrauliche, e non solo. Moltissimi comuni del Sud
avrebbero bisogno di conoscere lo stato dei loro suoli e corsi d’acqua di cui ci
si ricorda quando esondano per qualche alluvione. Un tempo i grandi geografi
italiani facevano il censimento delle frane dell’Appennino, oggi, con i tecnici
comunali e provinciali che teoricamente dovrebbero sovraintendere alla loro
sorveglianza, i giovani potrebbero offrire un di più di conoscenza diretta, per
potere intervenire con piani preventivi di contenimento. È con le piccole opere
diffuse e capillari che si evitano i grandi disastri. Si parla sempre e con
asfissiante monotonia di ambiente, ma pochi sanno di che cosa realmente parlano.
Eppure l’ambiente meridionale presenta grandi problemi e straordinarie
potenzialità. Qualche esempio per atterrare dalla nuvola “ambiente” alla realtà.
I nostri boschi sono spesso in condizioni di grave degrado. In tanti casi la
macchia selvatica li rende impraticabili e talora arriva ad ucciderli. Io ho
visto personalmente Monte Reventino, in Sila, migliaia di alberi soffocati dalla
vitalba, un elegante parassita infestante, che si estende in alte liane per via
aerea e con radici sotterranee. In Aspromonte si possono scorgere vaste pinete
con le chiome degli alberi letteralmente coperte da nidi di processionarie che
li stanno uccidendo o li hanno già uccisi. Solo alcuni esempi per indicare un
immenso patrimonio naturalistico in pericolo che potrebbe peraltro conoscere
forme di valorizzazione economiche incredibilmente trascurate. Noi importiamo
legname pregiato da opera (castagni, noci e ciliegi) e non riusciamo a
coltivarne le essenze neanche in habitat vantaggiosi. Senza dire che in queste
terre d’altura non si fanno allevamenti di volatili e di piccoli animali,
realizzabili con poca spesa. Mentre le acque interne (torrenti, piccoli laghi,
stagni) raramente danno luogo ad attività di acquacoltura. Si parla spesso di
biodiversità da tutelare. Sarebbe molto utile conoscerla e tanti giovani
agronomi e laureati in scienze naturali potrebbero, ad esempio, essere
impiegati, in cooperazione con gli esperti dei luoghi, a censire nei vari siti
le erbe officinali di cui è ricca la flora meridionale. Erbe, oggi anche
coltivate, che trovano impiego nella produzione di articoli di largo commercio,
nell’alimentazione macrobiotica e nella cosmetica. Analogo censimento
meriterebbe tanto il patrimonio della biodiversità che della varietà agricola
(alberi e piante da orto), ignorato, possiamo dire, dall’intera popolazione
meridionale, mai educata a conoscere la propria straordinaria eredità, storica e
naturale. Esistono in alcune regioni, come la Calabria, dei tesori di varietà
delle piante da frutto, e anche di vitigni antichi, sopravvissuti alla
fillossera, che sono custoditi nei vivai o dispersi nei fondi privati, e che non
conoscono da oltre mezzo secolo alcuna valorizzazione agricola. Naturalmente ci
sarebbe anche altro da censire, nel loro stato attuale e nei loro bisogni di
riparazione: dalle chiese rupestri, ai siti archeologici in abbandono, ai lidi
marittimi colpiti da fenomeni di erosione, o gravemente inquinati da corsi
d’acqua di cui si ignora l’origine. Ma di straordinario rilievo sarebbe anche
indagare sui luoghi e presso le famiglie l’evasione scolastica dei ragazzi,
talora il lavoro minorile dei nuovi poveri del Sud. Per il potenziamento della
cultura al Sud, attraverso la costituzione di biblioteche popolari, e altri
centri di formazione che cooperino con le scuole, occorrerebbe ovviamente una
riflessione a parte. Qui si son voluti fare solo degli esempi e spetterebbe ai
comuni, ai sindacati, agli stessi giovani, elaborare con impegno e creatività
progetti capaci di soddisfare queste esigenze. Stimolare una nuova intelligenza
pubblica dei beni comuni, naturali e storici, può aiutare molto, non solo a
fornire nuova vitalità economica e sociale alle nostre aree interne, ma
offrirebbe occupazione qualificata alle nuove generazioni. Tenendo sempre
presente che di queste fanno parte, a pieno titolo, i migranti che fuggono da
guerre, miseria e catastrofi climatiche.
No, i ricchi non diventano ricchi a spese dei poveri.
La mentalità della "somma zero" che è alla base delle teorie
socialiste è stata smentita dai fatti. Rainer Zitelmann, Domenica 05/07/2020 su
Il Giornale. Sono in molti a credere che i ricchi possano fare soldi solamente a
spese di qualcun altro. Questa concezione del mondo viene anche detta mentalità
«a somma zero», dal momento che i suoi seguaci sono convinti che nella vita
economica, come in una partita di tennis, affinché un giocatore possa vincere è
necessario che un altro debba perdere. Come scrisse Bertolt Brecht nella sua
poesia Alfabeto, «Disse il povero, bianco in volto/ Se io non fossi un
miserabile, tu non saresti ricco». Sebbene questo modo di pensare sia molto
diffuso, è fondamentalmente sbagliato, come dimostrano gli incredibili
avvenimenti in Cina negli ultimi quarant'anni. Nella storia, non è mai accaduto
che un numero così grande di persone uscisse dalla più abietta povertà con la
velocità che si è verificata in Cina. Secondo i dati della Banca Mondiale, nel
1981 la percentuale dei cittadini cinesi che viveva in condizioni di estrema
povertà era pari all'88,3% della popolazione. Di lì al 1990, questa percentuale
si era ridotta al 66,2%, mentre nel 2015 solo lo 0,7% dei cinesi viveva nella
miseria. In questo stesso periodo, il numero di cinesi poveri è calato da 878
milioni e meno di 10.
«LASCIATE CHE ALCUNI DIVENTINO RICCHI PRIMA DEGLI ALTRI». Il
miracolo economico cinese è iniziato con le riforme di Deng Xiaoping. Fu Deng ad
affermare «Lasciate che alcuni diventino ricchi prima degli altri». Nei decenni
successivi, lo Stato cinese ha autorizzato la proprietà privata dei mezzi di
produzione e ha permesso che il mercato esercitasse una maggiore influenza. A
dispetto del fatto che altre libertà (la libertà politica, ad esempio) non sono
rispettate e che la presa dello Stato sull'economia cinese è ancora ferrea, dai
tempi di Mao Zedong il suo ruolo si è sostanzialmente ridotto. Inoltre, sotto
Deng sono state create in tutta la Cina delle «Zone economiche speciali» a
regime capitalista. Quando regnava Mao, in Cina non esisteva nessun miliardario:
nel 2010, grazie alle riforme di Deng, i miliardari cinesi erano diventati 64.
Oggi, in Cina vi sono 324 miliardari, per non parlare dei 71 che vivono a Hong
Kong. Nessun paese al mondo, con l'eccezione degli Stati Uniti, ha altrettanti
miliardari della Cina. Se la concezione della somma zero fosse corretta, questo
sarebbe impossibile. Ma la mentalità a somma zero è sbagliata: l'impressionante
riduzione della povertà e l'altrettanto impressionante aumento del numero di
miliardari che si è prodotto contestualmente sono due facce della stessa
medaglia. In generale, i ricchi non diventano tali perché prendono ai poveri, ma
perché creano grandi benefici per gli altri. Jack Ma è l'uomo più ricco della
Cina, con una fortuna di 38,8 miliardi di dollari. È diventato così ricco perché
ha fondato Alibaba e altre aziende di successo, che soddisfano i bisogni di
centinaia di milioni di suoi concittadini.
I RICCHI CREANO BENEFICI PER LA SOCIETÀ NEL SUO COMPLESSO. Una
rapida occhiata alla classifica dei miliardari di tutto il mondo stilata da
Forbes permette di constatare che quasi tutti sono diventati ricchi come
imprenditori, oppure perché hanno fatto crescere e migliorare le aziende fondate
dai loro genitori. La gran parte dei dieci uomini più ricchi del mondo è
rappresentata da imprenditori che si sono fatti da sé. Jeff Bezos, il primo
della lista, con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari, è diventato
ricco in modo simile a quello di Jack Ma, ossia tramite l'e-commerce. Bill
Gates, al secondo posto in ordine di ricchezza (dopo avere occupato per lungo
tempo il vertice della classifica), non ha accumulato i suoi miliardi
sottraendoli ai poveri, ma offrendo qualcosa al mondo. E con questo non intendo
alludere ai miliardi donati dalla Fondazione di Bill Gates alle più svariate
cause filantropiche, bensì al software, come i programmi inclusi in Microsoft
Office, utilizzati ogni giorno da innumerevoli utenti. Larry Ellison, al quinto
posto nella lista di Forbes, ha costruito la propria ricchezza sul suo software
per i database per la gestione delle relazioni delle aziende con i clienti. Al
settimo posto c'è invece Mark Zuckerberg, che ha sviluppato l'idea alla base di
Facebook, che oggi ha 2,5 miliardi di utenti in tutto il modo. Larry Page e
Sergey Brin, rispettivamente al tredicesimo e al quattordicesimo posto della
classifica, sono diventati ricchi per aver sviluppato il motore di ricerca di
maggior successo del pianeta, ossia Google.
LA MENTALITÀ DELLA SOMMA ZERO DANNEGGIA LE PERSONE E LA SOCIETÀ.
Il concetto di somma zero non è solo sbagliato, ma ha anche ripercussioni
negative su tutti i suoi seguaci e sulla società nel suo complesso. Gli
psicologi hanno osservato che l'idea di somma zero rappresenta una delle
principali fonti di invidia. Chiunque sia convinto che l'unico modo per
arricchirsi sia quello di agire a spese degli altri sarà naturalmente portato a
invidiare i ricchi e a provare risentimento per la loro prosperità. La mentalità
a somma zero è inoltre alla base di quelle teorie socialiste che hanno prodotto
indicibili sofferenze per l'umanità negli ultimi cento anni e passa. Bertolt
Brecht, l'autore della poesia che ho citato poc'anzi, non era solo un poeta, era
anche un comunista che adorava Iosif Stalin. Chiunque creda che sia possibile
arricchirsi solo a spese degli altri ha creato un ostacolo al proprio successo.
Persone oneste convinte che i ricchi siano tutti dei mascalzoni non si
sforzeranno mai di migliorare il proprio stato. La fede nella somma zero opera
come una barriera psicologica inconscia alla creazione di ricchezza e le persone
prive di scrupoli morali che pensano in termini di somma zero possono
addirittura indirizzarsi alla criminalità. In tutto il mondo, le prigioni sono
piene di gente che credeva di potersi arricchire solo a spese degli altri. I
fatti, come dimostra l'esempio delle vicende economiche cinesi, ci raccontano
una storia completamente diversa. I più grandi successi economici arrivano
quando si capisce che, anziché danneggiare la società, tutti traggono vantaggi
quando qualcuno si arricchisce - anche enormemente - per le sue attività
imprenditoriali.
Qualcuno la notizia la dà, la maggior parte dei giornalisti la
fa. Io le notizie le cerco e le raccolgo, senza metter bocca. Sarà poi il
lettore a estrapolarne la verità.
Imparare ad imparare. Ci ho messo anni a capire l’importanza del
significato di questa frase. L’arroganza e la presunzione giovanile dapprima me
lo ha impedito. Condita da una buona dose di conformismo. Poi con il passare del
tempo è arrivata la saggezza.
Capire di dover capire significa non muoversi a casaccio, senza
una meta, senza un fine, senza un programma. Capire di dover capire significa
chiedersi che senso ha ogni passo che ci indicano di compiere e che compiamo,
ogni prova che superiamo, ogni giorno che spendiamo insieme a delle persone.
Quante volte approcciamo un problema con la reale convinzione di risolverlo con
indicazioni di altri, senza chiederci se davvero esiste una strada differente
per arrivare ad una conclusione sensata.
Ecco, capire di dover capire. Non muoversi a caso, per sentito
dire, parlando con le persone sbagliate, non valutando attentamente ogni passo
che si deve compiere. Per fare questo dobbiamo essere pronti ad “imparare ad
imparare” ovvero lasciare da parte nozioni acquisite e preconcetti e ad aprirci
al nuovo.
Imparare ad imparare significa creare un percorso.
Serve leggere libri? Se la risposta è positiva dobbiamo adottare
un metodo per selezionare quali libri leggere perché la mole dei libri in
circolazione è tale che non potremmo reggere il passo, ne, tantomeno, compararne
logica e verità.
Come era ieri, è oggi e sarà domani.
Libro di Qoelet. Prologo:
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è
vanità.
Quale utilità ricava l’uomo da tutto l’affanno per cui fatica
sotto il sole?
Una generazione va, una generazione viene ma la terra resta
sempre la stessa.
Il sole sorge e il sole tramonta, si affretta verso il luogo da
dove risorgerà.
Il vento soffia a mezzogiorno, poi gira a tramontana; gira e
rigira e sopra i suoi giri il vento ritorna.
Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno:
raggiunta la loro mèta, i fiumi riprendono la loro marcia.
Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il
motivo. Non si sazia l’occhio di guardare né mai l’orecchio è sazio di udire.
Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà; non c’è
niente di nuovo sotto il sole.
C’è forse qualcosa di cui si possa dire: «Guarda, questa è una
novità»? Proprio questa è gia stata nei secoli che ci hanno preceduto.
Non resta più ricordo degli antichi, ma neppure di coloro che
saranno si conserverà memoria presso coloro che verranno in seguito.
Art. 104, comma 1, della Costituzione italiana cattocomunista.
La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da
ogni altro potere. (.)
La magistratura per la destra è un Ordine (come acclarato
palesemente), per la sinistra è un Potere (da loro dedotto dalla distinzione "da
ogni altro potere").
Autonomia dei Magistrati: autogoverno con selezione e formazione
per l’omologazione, nomine per la conformità e controllo interno per l’impunità.
Affinchè, cane non mangi cane.
Indipendenza dei Magistrati: decisioni secondo equità e legalità,
cioè secondo scienza e coscienza. Ossia: si decide come cazzo pare, tanto il
collega conferma.
Non è importante sapere quanto la democrazia rappresentativa
costi, ma quanto essa rappresenti ed agisca nel nome e per conto dei
rappresentati.
Il nuovo comunistambientalismo combatte una battaglia
retrograda, coinvolgendo le menti vergini degli studenti che assimilano tutto
quanto la scuola di regime gli propini.
L'intento è quello di far regredire una civiltà secolare,
sviluppata con conquiste sociali ed economiche.
Il progresso tecnologico ed industriale irrinunciabile è basato
sullo sfruttamento delle risorse. Le auto per spostarci, il benessere con gli
elettrodomestici e le forme di comunicazione.
Il progresso tecnologico ed industriale ha prodotto benessere,
con lavoro e sviluppo sociale, con parificazione dei censi.
Il Benessere ha fatto proliferare l’umanità.
L'uguaglianza sociale ha portato allo sviluppo sociale con svago
e divertimento con il turismo e lo sfruttamento dell'ambiente.
Per gli ambiental-qualunquisti o populisti ambientali il
progresso va cancellato. La popolazione mondiale ridimensionata.
Si torna alla demografia latente e gli spostamenti a piedi,
nemmeno a cavallo, perchè gli animali producono biogas. Oltretutto, per questo
motivo, non si possono allevare gli animali. La nuova religione è il veganismo.
Si comunicherà con le nuvole di fumo. E si torna nelle grotte
dove fa fresco l'estate e ci si sta caldi e riparati d'inverno.
Inoltre bisogna che la foresta ed i boschi invadano la terra.
Pari passo a pale eoliche e campi estesi di pannelli solari. La natura e
l’energia alternativa al primo posto, agli animali (all'uomo per ultimo) quel
che resta. Vuoi mettere la difesa di un nido di uccello palustre, rispetto alla
creazione di posti di lavoro con un villaggio turistico eco-sostenibile sulla
costa? E poi il business delle rinnovabili come si farà?
Come sempre i massimalisti dell'ecologia non mediano: o è bianco
o è nero. Per loro è inconcepibile l'equilibrio tra progresso e rispetto della
natura e degli affari.
Avv. Mirko
Giangrande:
Produci?
Tasse!
Lavori? Tasse!
Compri? Tasse!
Vendi? Tasse!
Studi? Tasse!
Inventi?
Tasse!
Erediti?
Tasse!
Muori? Tasse!
Non fai nulla?
Sussidio!!!
Affidati
alla sinistra.
Dove c'è
l'affare lì ci sono loro: i sinistri e le loro associazioni. E solo loro sono
finanziate.
La lotta
alla mafia è un business con i finanziamenti pubblici e l'espropriazione
proletaria dei beni.
I mafiosi
si inventano, non si combattono.
L'accoglienza dei migranti è un business con i finanziamenti pubblici.
Accoglierli
è umano, incentivare le partenze ed andarli a prendere è criminale.
L'affidamento dei minori è un business con i finanziamenti pubblici.
Tutelare
l’infanzia è comprensivo. Toglierli ai genitori naturali e legittimi a scopo di
lucro è criminale.
L'aiuto
alle donne vittime di violenza è un business con i finanziamenti pubblici.
Sorreggere
le donne, vittime di violenza è solidale. Inventare le accuse è criminale.
Noi non siamo poveri. Ci vogliono poveri. Non siamo in
democrazia. Siamo in oligarchia politica ed economica.
Perchè i regimi cosiddetti democratici ci vogliono poveri? Per
incentivare lo schiavismo psicologico che crea il potere di assoggettamento.
Nessun regime capitalistico o socialista agevola il progresso economico delle
classi più abbienti e numerose, che nelle cosiddette democrazie rappresentative
sono indispensabili alla creazione ed al mantenimento del Potere.
Il Regime capitalista è in mano a caste e lobby che pongono
limiti e divieti al libero accesso ed esercizio di professioni ed imprese.
Il regime socialista è in mano all'élite politica che pone limiti
alla ricchezza personale.
Tutti i regimi, per la loro sopravvivenza, aborrano la democrazia
diretta e l'economia diretta. Infondono il culto della rappresentanza politica e
della mediazione economica. Agevolano familismo, nepotismo e raccomandazioni.
Muhammad Yunus, l’economista bengalese settantottenne, Nobel per
la pace nel 2006, che con l’invenzione del microcredito in 41 anni ha cambiato
l’esistenza di milioni di poveri portandoli a una vita dignitosa, non ha avuto
esitazioni, giovedì 17 maggio 2018 all’Auditorium del grattacielo di Intesa San
Paolo a Torino, nell’indicare la via possibile verso l’impossibile: eliminare la
povertà. E contestualmente la disoccupazione e l’inquinamento. Come riferisce
Mauro Fresco su Vocetempo.it il 24 maggio 2018, tutto il sistema economico
capitalistico, nell’analisi di Yunus, deve essere riformato. A partire
dall’educazione e dall’istruzione, immaginate per plasmare persone che ambiscono
a un buon lavoro, a essere appetibili sul mercato; ma l’uomo non deve essere
educato per lavorare, per vendere se stesso e i propri servizi, deve essere
formato alla vita; l’uomo non deve cercare lavoro, ma creare lavoro, senza
danneggiare altri uomini e l’ambiente. Perché ci sono i poveri, si domanda
Yunus, perché la gente rimane povera? Non sono gli individui che vogliono essere
poveri, è il sistema che genera poveri. Ci stiamo avviando al disastro, sociale
e ambientale: oggi, otto persone possiedono la ricchezza di un miliardo di
individui, questi scenari porteranno, prima o poi, a uno scenario violento:
dobbiamo evitarlo. La civiltà è basata sull’ingordigia. Dobbiamo invece mettere
in atto la transizione verso la società dell’empatia.
Yunus ha dimostrato, con il microcredito prima e con la Grameen
Bank poi, che quella che a economisti e banchieri sembrava un’utopia
irrealizzabile è invece un’alternativa concreta, che dal Bangladesh si è via via
allargata a più di 100 Paesi, Stati Uniti ed Europa compresi. Con ironia,
considerando la sede che lo ospitava, Yunus ha ricordato che, quando qualcuno
gli ribadiva che un progetto non era fattibile, «studiavo come si sarebbe
comportata una banca e facevo esattamente il contrario». Fantasia, capacità di
rischiare e, soprattutto, conoscenza e fiducia nell’umanità, in particolare
nelle donne, sono i segreti che hanno permesso di dar vita a migliaia di
attività imprenditoriali, ospedali, centrali fotovoltaiche, sempre partendo dal
basso e da progettualità diffuse. L’impresa sociale, che ha come obiettivo
coprire i costi e reinvestire tutti profitti senza distribuire dividendi,
sostiene Yunus, è l’alternativa possibile e molto concreta per vincere «la sfida
dei tre zeri: un futuro senza povertà, disoccupazione e inquinamento», titolo
anche del suo ultimo lavoro pubblicato da Feltrinelli. L’impresa sociale può
permettersi di produrre a prezzi molto più bassi, non ha bisogno di marketing
pervasivo, campagne pubblicitarie continue, packaging attraente per invogliare
il consumatore. Così anche le "verdure brutte", quel 30 per cento di produzione
agricola che l’Europa butta perché di forma ritenuta non consona per essere
proposta al consumatore – «la carota storta, la patata gibbosa, la zucchina
biforcuta una volta tagliate non sono più brutte» ha ricordato sorridendo Yunus
– possono essere utilizzate da un’impresa sociale e messe in vendita per essere
cucinate e mangiate.
«Il reddito di cittadinanza per tutti? È questo che intendiamo
per dignità della persona? Ai poveri dobbiamo permettere un lavoro dignitoso, la
carità non basta».
Il premio Nobel Yunus: "Il reddito di cittadinanza rende più
poveri e nega la dignità umana". Scrive il HuffPost il 13 maggio 2018.
L'economista ideatore del microcredito intervistato dalla Stampa: "I salari
sganciati dal lavoro rendono l'uomo un essere improduttivo e senza creatività".
"Il reddito di cittadinanza rende più poveri, non è utile a chi è povero e a
nessun altro, è una tipica idea di assistenzialismo occidentale e nega la
dignità umana". Parola di Muhammad Yunus, economista e banchiere bengalese che
ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 per aver ideato e creato la "banca
dei poveri". In un'intervista a La Stampa, l'inventore del microcredito boccia
tout court il caposaldo del programma M5S: "I salari sganciati dal lavoro
rendono l'uomo un essere improduttivo, ne cancellano la vitalità e il potere
creativo".
Secondo Yunus l'Europa ha un grande limite. "L'Asia avrebbe
bisogno di molte cose che in Europa ci sono e ci sono da tanto tempo, ma trovo
che da voi ci sia un pensiero unico che limita gli slanci. Mi spiego meglio: le
società europee sono ossessionate dal lavoro, tutti devono trovare un lavoro,
nessuno deve rimanere senza lavoro, le istituzioni si devono preoccupare che i
cittadini lavorino... Invece in Asia la famiglia è il luogo più importante e non
c'è questo pensiero fisso del lavoro: esiste una sorta di mercato informale, in
cui gli uomini esercitano loro stessi come persone. Penso che la lezione
positiva che viene dall'Asia sia quella di ridisegnare il sistema finanziario
attuale, privilegiando la dignità delle persone e il valore del loro tempo".
Durissimo il giudizio sul reddito di cittadinanza. "è la
negazione dell'essere umano, della sua funzionalità, della vitalità, del potere
creativo. L'uomo è chiamato a esplorare, a cercare opportunità, sono queste che
vanno create, non i salari sganciati dalla produzione, che per definizione fanno
dell'uomo un essere improduttivo, un povero vero".
Noi abbiamo una Costituzione comunista immodificabile con
democrazia rappresentativa ad economia capitalista-comunista e non liberale.
I veri liberali adottano l'economia diretta con la libera impresa
e professione. Lasciano fare al mercato con la libera creazione del lavoro e la
preminenza dei migliori.
I veri democratici adottano la democrazia diretta per il loro
rappresentanti esecutivi, legislativi e giudiziari, e non quella mediata, come
la democrazia rappresentativa ad elevato astensionismo elettorale, in mano ad un
élite politica e mediatica.
Ci vogliono poveri e pure fiscalmente incu…neati.
Quanto pesa il cuneo fiscale sui salari in Italia? E in
Europa? Nell'ultimo anno la busta paga di un
lavoratore medio (circa 30 mila euro lordi) era tassata del 47,9 per cento.
Quindi su 100 euro di lordo in busta paga, a un lavoratore italiano medio arriva
un netto di 52,1 euro. Quasi la metà, scrive l'Agi.
Che cos’è il cuneo fiscale e quanto pesa in Italia. Il cuneo
fiscale – in inglese Tax wedge – è definito dall’Ocse (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico) come «il rapporto tra l’ammontare delle
tasse pagate da un singolo lavoratore medio (una persona single con guadagni
nella media e senza figli) e il corrispondente costo totale del lavoro per il
datore».
Nella definizione dell’Ocse sono comprese oltre alle tasse in
senso stretto anche i contributi previdenziali. Quindi se per un datore il costo
del lavoratore è pari a 100, il cuneo fiscale rappresenta la porzione di quel
costo che non va nelle tasche del dipendente ma nelle casse dello Stato. Nel
caso dei contributi, i soldi raccolti dallo Stato vengono poi restituiti al
lavoratore sotto forma di pensione (ma, come spiega l’Inps, nel nostro sistema
“a ripartizione” sono i lavoratori attualmente in attività a pagare le pensioni
che vengono oggi erogate: non è che il pensionato incassi quanto lui stesso ha
versato nel corso della propria vita, come se avesse un conto personale e
separato presso l’Inps).
Secondo il più recente rapporto dell’Ocse Taxing Wages 2019 –
pubblicato l’11 aprile 2019 – nel 2018 in Italia la busta paga di un lavoratore
medio (circa 30 mila euro lordi) era tassata del 47,9 per cento. Quindi su 100
euro di lordo in busta paga, a un lavoratore italiano medio arriva un netto di
52,1 euro. Quasi la metà. Ma come siamo messi in Europa da questo punto di
vista?
La situazione in Europa. Il rapporto dell’Ocse Taxing
Wages 2019 contiene anche una classifica dei suoi Stati membri, in base al peso
del cuneo fiscale. Andiamo a vedere come si posizionano l’Italia e il resto
degli Stati Ue presenti in classifica. Roma arriva terza, con il 47,9 per cento.
Davanti ha il Belgio, primo in classifica con un cuneo fiscale (e contributivo)
pari al 52,7 per cento, e la Germania con il 49,5 per cento. Subito sotto al
podio si trova la Francia, con il 47,6 per cento, appaiata con l’Austria.
Seguono poi Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Svezia, Lettonia e Finlandia.
Gli altri Stati comunitari grandi e medio-grandi sono nettamente più in basso in
classifica: la Spagna è sedicesima nella Ue con il 39,6 per cento, la Polonia
ventesima con il 35,8 per cento, e il Regno Unito ventitreesimo con il 30,9 per
cento. Londra è poi, dei Paesi Ue che sono anche membri dell’Ocse, quello con il
cuneo fiscale minore.
Altri Paesi Ocse. In fondo alla classifica dell’Ocse non troviamo
nessuno Stato dell’Unione europea. La percentuale più bassa è infatti attribuita
al Cile, appena il 7 per cento di cuneo fiscale. Davanti, staccati, arrivano poi
Nuova Zelanda (18,4) e Messico (19,7). Degli Stati europei, ma non Ue, quello
con la percentuale più bassa è la Svizzera, con un cuneo fiscale del 22,2 per
cento. Gli Stati Uniti, infine, hanno un cuneo pari al 29,6 per cento. La media
Ocse è del 36,1 per cento.
Conclusione. In Italia il cuneo fiscale è pari al 47,9 per cento.
Questa è la terza percentuale più alta tra i Paesi dell’Ocse. Davanti a Roma si
trovano solamente Berlino e Bruxelles.
E la chiamano Democrazia…
"In fila per tre", dall'album "Burattino senza fili" di Edoardo
Bennato. Testo
Presto vieni qui ma su non fare così
ma non li vedi quanti altri bambini
che sono tutti come te
che stanno in fila per tre
che sono bravi e che non piangono mai...
E' il primo giorno però domani ti abituerai
e ti sembrerà una cosa normale
fare la fila per tre, risponder sempre di sì
e comportarti da persona civile...
Vi insegnerò la morale e a recitar le preghiere
e ad amare la patria e la bandiera
noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori
e discendiamo dagli antichi romani...
E questa stufa che c'è basta appena per me
perciò smettetela di protestare
e non fate rumore e quando arriva il direttore
tutti in piedi e battete le mani...
Sei già abbastanza grande
sei già abbastanza forte
ora farò di te un vero uomo
ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore
ti insegnerò ad ammazzare i cattivi...
E sempre in fila per tre marciate tutti con me
e ricordatevi i libri di storia
noi siamo i buoni perciò abbiamo sempre ragione
e andiamo dritti verso la gloria...
Ora sei un uomo e devi cooperare
mettiti in fila senza protestare
e se fai il bravo ti faremo avere
un posto fisso e la promozione...
E poi ricordati che devi conservare
l'integrità del nucleo famigliare
firma il contratto non farti pregare
se vuoi far parte delle persone serie...
Ora che sei padrone delle tue azioni
ora che sai prendere le decisioni
ora che sei in grado di fare le tue scelte
ed hai davanti a te tutte le strade aperte...
Prendi la strada giusta e non sgarrare
se no poi te ne facciamo pentire
mettiti in fila e non ti allarmare
perché ognuno avrà la sua giusta razione...
A qualche cosa devi pur rinunciare
in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere
perciò adesso non recriminare
mettiti in fila e torna a lavorare...
E se proprio non trovi niente da fare
non fare la vittima se ti devi sacrificare
perché in nome del progresso della nazione
in fondo in fondo puoi sempre emigrare...
Scandalo è l’inciampo che capita ma solo quando viene
scoperto. Pubblicato mercoledì, 24 luglio 2019
su Corriere.it. Prendiamoci un momento di riflessione, allontaniamo l’oggetto
che stiamo osservando, per coglierne meglio il profilo e la struttura, facciamo
professione di umiltà, evitando di dare per acquisito e scontato il significato
di parole che maneggiamo con tanta superficialità e leggerezza. Oggi conviene
fermarsi un momento a ragionare su «scandalo». Parola di apparente semplicità,
scandalo offre una genealogia chiara, dal padre latino scandălum, al nonno greco
skandalon, nel significato di ostacolo, insidia, inciampo. Ai nostri occhi il
significato si è affinato, concentrandosi sull’azione immorale o illegale che
crea un turbamento, aggravato se i protagonisti sono personaggi noti. La prima
considerazione su questa parola è senz’altro legata al turbamento che provoca.
Questo infatti è essenziale, ma si manifesta solo quando la malefatta in
questione viene conosciuta. Rubare è un reato per la legge, un’azione
riprovevole per la morale, un peccato per i credenti. Ma diventa uno scandalo
solo se ti scoprono. Comprensibile quindi che questo particolare «inciampo» sia
protagonista di innumerevoli modi di dire, a cominciare da «essere la pietra
dello scandalo», nel senso di essere il primo a dare cattivo esempio; «dare
scandalo», essere protagonisti di atteggiamenti riprovevoli (vedete come torna
l’aspetto pubblico); «essere motivo di scandalo», come sopra; «gridare allo
scandalo», alzare i commenti additando un comportamento che si condanna. Esiste
poi l’uso della parola come espressione di riprovazione e sdegno: per cui quel
film o quel libro che si reputano particolarmente brutti o offensivi, ai nostri
occhi sono «uno scandalo». L’aspetto pubblico dello scandalo l’ha legato da
sempre alla notorietà dei protagonisti (dal pettegolezzo agli aspetti più seri)
e a quel mondo di illegalità legato alla politica, alla gestione (o mala
gestione) della cosa pubblica che ci riguarda tutti. È il caso delle inchieste
sulle tangenti pagate a politici e amministratori infedeli rispetto al loro
mandato e ai processi che ne sono scaturiti. Scandali che hanno preso i nomi più
diversi: il più noto è Tangentopoli, termine coniato a Milano nel 1992 per
descrivere un diffuso sistema di corruzione. Ora se Tangentopoli è una parola
arditamente composta col suffissoide -poli per indicare la «città delle
tangenti» l’uso giornalistico successivo è tutto da ridere: in parole come
sanitopoli o calciopoli il suffissoide -poli non significa più «città» ma
semplicemente «corruzione». Abbiamo visto come scandalo si porti dietro, dal
momento della sua rivelazione, un condiviso moto di sdegno. Ma i motivi che
spingono l’opinione pubblica a sdegnarsi non sono affatto sempre gli stessi.
Cambiano i costumi, cambia (per fortuna, in molti casi) la morale, cambiano i
motivi che la disturbano. Cambia la percezione stessa dei comportamenti che
danno scandalo. Per esempio, il 24 luglio 1974 la Corte Suprema degli Stati
Uniti sentenziò all’unanimità che il Presidente Richard Nixon non aveva
l’autorità per trattenere i nastri della Casa Bianca sullo scandalo Watergate e
gli intimò di consegnarli al procuratore speciale che indagava sul caso. Quei
nastri dimostrarono che Richard Nixon aveva mentito, circostanza considerata
intollerabile per l’opinione pubblica americana e che portarono il Presidente
degli Stati Uniti a dimettersi il 9 agosto successivo.
A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva
"quantistica". Libro di Roberto Bin edizione 2014 pp.
114, Franco Angeli Editore. Ci può essere una teoria dell’interpretazione
giuridica che riduca la discrezionalità dei giudici? Migliaia di libri sono
stati scritti per elaborare teorie, regole e principi che dovrebbero arginare
l’inevitabile discrezionalità degli interpreti delle leggi e garantire un certo
grado di oggettività. Questo libro, rivolto agli operatori del diritto e a tutti
i lettori colti, suggerisce un’altra strada.
Presentazione del volume. La discrezionalità del giudice
nell'applicazione delle leggi è un problema noto a tutti i sistemi moderni,
specie ora che i giudici si trovano ogni giorno ad applicare direttamente
principi tratti dalla Costituzione e persino da altri ordinamenti. Sempre più
spesso le valutazioni del giudice sembrano prive di briglie, libere di svolgersi
secondo convinzioni personali, piuttosto che nell'alveo dei criteri fissati dal
legislatore. Ogni sistema giuridico ha il suo metodo per scegliere e istituire i
giudici, ma in nessun sistema è ammesso che essi operino in piena libertà,
liberi di creare diritto a loro piacimento. Il legislatore è l'unica autorità
che può vantare una piena legittimazione democratica, per cui ogni esercizio di
potere pubblico che non si leghi saldamente alle sue indicazioni appare
arbitrario e inaccettabile. Migliaia di libri sono stati scritti per elaborare
teorie, regole e principi che dovrebbero arginare l'inevitabile discrezionalità
degli interpreti delle leggi e garantire un certo grado di oggettività. Ma la
fisica quantistica ci suggerisce di procedere per altra via, di inseguire altri
obiettivi e di accettare una visione diversa della verità oggettiva.
Roberto Bin si è formato nell'Università di Trieste e ha
insegnato in quella di Macerata. Attualmente è ordinario di Diritto
costituzionale nell'Università di Ferrara. È autore di alcuni fortunati manuali
universitari e di diversi libri e saggi scientifici.
Affidati
alla sinistra.
Dove c'è
l'affare li ci sono loro: i sinistri.
La lotta
alla mafia è un business con i finanziamenti pubblici e l'espropriazione
proletaria dei beni.
I mafiosi
si inventano, non si combattono.
L'accoglienza dei migranti è un business con i finanziamenti pubblici.
Accoglierli
è umano, andarli a prendere è criminale.
L'affidamento dei minori è un business con i finanziamenti pubblici.
Toglierli
ai genitori naturali e legittimi è criminale.
Il Civil Law, ossia il nostro Diritto, è l’evoluzione
dell’intelletto umano ed ha radici antiche, a differenza del Common Law dei
paesi anglosassoni fondato sull’orientamento politico momentaneo.
Il Diritto Romano, e la sua evoluzione, che noi applichiamo nei
nostri tribunali contemporanei non è di destra, né di centro, né di sinistra.
L’odierno diritto, ancora oggi, non prende come esempio l’ideologia
socialfasciocomunista, né l’ideologia liberale. Esso non prende spunto
dall’Islam o dal Cristianesimo o qualunque altra confessione religiosa.
Il nostro Diritto è Neutro.
Il nostro Diritto si affida, ove non previsto, al comportamento
esemplare del buon padre di famiglia.
E un Buon Padre di Famiglia non vorrebbe mai che si uccidesse un
suo figlio: eppure si promuove l’aborto.
E un Buon Padre di Famiglia vorrebbe avere dei nipoti, eppure si
incoraggia l’omosessualità.
E un Buon Padre di Famiglia vorrebbe difendere l’inviolabilità
della sua famiglia, della sua casa e delle sue proprietà, eppure si agevola
l’invasione dei clandestini.
E un Buon Padre di Famiglia vorrebbe che la Legge venisse
interpretata ed applicata per soli fini di Giustizia ed Equità e non per
vendetta, per interesse privato o per scopi politici.
Mi spiace. Io sono un evoluto Buon Padre di Famiglia.
L'Astensionismo al voto ed i fessi e gli indefessi della
sinistra: La Democrazia è cosa mia...
Maledetta ideologia comunista. Con tutti i problemi che
attanagliano l'Italia, i sinistri, ben sapendo che nessun italiano più li
voterà, pensano bene di farci invadere per raggranellare dai clandestini i voti
che, aggiunti a quelle delle altre minoranze LGBTI, gli permettono di mantenere
il potere.
I berlusconiani e la cosiddetta Destra, poi, per ammaliare
l'altra sponda elettorale, scimmiottano rimedi che nulla cambiano in questa
Italia che è tutta da cambiare. Da vent'anni denuncio quelle anomalie del
sistema, che in questi giorni escono fuori con gli scandali riportati dalle
notizie stampa. Tutte quelle mafie insite nel sistema.
Si fa presto a dire liberali, dove liberali non ce ne sono. Se ci
fossero cambierebbero le cose in modo radicale, partendo dalla Costituzione
Catto comunista, fondata sul Lavoro e non sulla Libertà. Libertà, appunto,
bandiera dei liberali.
Nei momenti emergenziali in tutti gli altri Paesi v'è un intento
comune, anche se solo in apparenza. Politica e media accomunati da un interesse
supremo. Invece, in Italia, ci sono sempre i distinguo, usati dall'estero contro
noi stessi per danneggiarci sull'export, dando un'immagine distorta e
denigratoria. Così come fanno i polentoni italiani rispetto al Sud Italia,
disinformazione attuata dai media nordisti e dai giornalisti masochisti e
rinnegati meridionali. In una famiglia normale si è sempre solidali nei momenti
del bisogno e traspare sempre un'apparente unità. Solo in Italia i Caini hanno
la loro rilevanza mediatica, facendoci apparire all'estero come macchiette da
deridere ed oltraggiare.
Gli italiani voltagabbana. Al tempo del fascismo: tutti fascisti.
Dopo la guerra: tutti antifascisti.
Prima di Tangentopoli: tutti democristiani e Socialisti. Dopo
Mani Pulite: tutti comunisti.
E il perché lo ha spiegato cinquecentosei anni fa Niccolò
Machiavelli in un passaggio del Principe: «El populo, vedendo non poter
resistere a' grandi, volta la reputazione ad uno, e lo fa principe, per essere
con la sua autorità difeso». Ecco quello che vogliono gli italiani. Vogliono
qualcuno che li salvi, che li assista, che li difenda. Ed al contempo il popolo
italiano ha l' attitudine a diffidare del Governo, a non parlarne mai bene, e
tuttavia ad affidarsene, non avendo la forza di fare da sé, e di aspettarsi che
il governo si occupi di ogni cosa e risolva ogni cosa. Si buttano
immancabilmente a obbedire - questa è di Giuseppe Prezzolini - al prestigio
personale e alle capacità di interessare sentimentalmente o materialmente la
folla. E come si erano incapricciati, così si annoiano e poi si imbestialiscono,
perché infine nessuno è capace di salvargliela la pelle. Lo diceva il più bravo
di tutti: l'adulatore sarà il calunniatore.
In questo momento è bene ricordare la teoria politica di Cicerone
(106 a.C.43)
1 il povero lavora
2 il ricco sfrutta il povero
3 il soldato li difende tutti e due
4 il contribuente paga per tutti e tre
5 il vagabondo si riposa per tutti e quattro
6 l’ubriacone beve per tutti e cinque
7 il banchiere li imbroglia tutti e sei
8 l’avvocato li inganna tutti e sette
9 il medico li accoppa tutti e otto
10 il becchino li sotterra tutti e nove
11 il politico campa alle spalle di tutti e dieci.
Il grande filosofo e uomo politico romano con la sua sagacia e
ironia ha in poche ma efficaci parole, riassunto l’opinione che molti oggi hanno
della politica.
E nel caso la teoria politica non fosse sua, allora la faccio
mia.
Dunque, è questa vita irriconoscente che ha bisogno del mio
contributo ed io sarò sempre disposto a darlo, pur nella indifferenza,
insofferenza, indisponenza dei coglioni.
Anzichè far diventare ricchi i poveri con l'eliminazione di caste
(burocrati parassiti) e lobbies (ordini professionali monopolizzanti), i
cattocomunisti sotto mentite spoglie fanno diventare poveri i ricchi. Così è da
decenni, sia con i governi di centrodestra, sia con quelli di centrosinistra.
L’Italia
invasa dai migranti economici con il benestare della sinistra. I Comunisti hanno
il coraggio di cantare con i clandestini: “. ..una mattina mi son svegliato ed
ho trovato l’invasor…” Bella Ciao
Quel che si
rimembra non muore mai. In effetti il fascismo rivive non negli atti di singoli
imbecilli, ma quotidianamente nell’evocazione dei comunisti.
«È un paese
così diviso l’Italia, così fazioso, così avvelenato dalle sue meschinerie
tribali! Si odiano anche all’interno dei partiti, in Italia. Non riescono a
stare insieme nemmeno quando hanno lo stesso emblema, lo stesso distintivo,
perdio! Gelosi, biliosi, vanitosi, piccini, non pensano che ai propri interessi
personali. Alla propria carrieruccia, alla propria gloriuccia, alla propria
popolarità di periferia. Per i propri interessi personali si fanno i dispetti,
si tradiscono, si accusano, si sputtanano... Io sono assolutamente convinta che,
se Usama Bin Laden facesse saltare in aria la torre di Giotto o la torre di
Pisa, l’opposizione darebbe la colpa al governo. E il governo darebbe la colpa
all’opposizione. I capoccia del governo e i capoccia dell’opposizione, ai propri
compagni e ai propri camerati. E detto ciò, lasciami spiegare da che cosa nasce
la capacità di unirsi che caratterizza gli americani. Nasce dal loro
patriottismo.» — Oriana Fallaci, La Rabbia e l'Orgoglio
I fratelli
coltelli del Socialismo:
I
Comunisti-Stalinisti per l’apologia dello statalismo extraterritoriale
(mondialismo);
I
Fascisti-Leninisti-Marxisti come classisti-nazionalisti (sovranismo).
TIRANNIDE indistintamente appellare si debbe ogni qualunque
governo, in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi, può farle,
distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle, sospenderle; od anche
soltanto deluderle, con sicurezza d'impunità. E quindi, o questo infrangi-legge
sia ereditario, o sia elettivo; usurpatore, o legittimo; buono, o tristo; uno, o
molti; a ogni modo, chiunque ha una forza effettiva, che basti a ciò fare, è
tiranno; ogni società, che lo ammette, è tirannide; ogni popolo, che lo
sopporta, è schiavo. Vittorio Alfieri (1790).
Se a destra son coglioni sprovveduti, al centro son marpioni, a
sinistra “So camburristi”. Ad Avetrana, come in tutto il sud Italia c’è un
detto: “si nu camburrista”. "Camburrista" viene dalla parola italiana "camorra"
e non assume sempre il significato di "mafioso, camorrista" ma soprattutto di
"persona prepotente, dispettosa, imbrogliona, che raggira il prossimo, che
impone il suo volere direttamente, o costringendo chi per lui, con violenza,
aggressività, perseveranza, pur essendo la sua volontà espressione del torto
(non della ragione) del singolo o di una ristretta minoranza chiassosa ed
estremamente visibile.
Nella sua canzone "La razza in estinzione" (2001), l'artista
italiano Giorgio Gaber (Milano, 1939 - Montemagno di Camaiore, 2003) critica
tutto e tutti e afferma: "la mia generazione ha perso".
La Razza In Estinzione testo Album: La Mia Generazione Ha Perso.
Non mi piace la finta allegria
non sopporto neanche le cene in compagnia
e coi giovani sono intransigente
di certe mode, canzoni e trasgressioni
non me ne frega niente.
E sono anche un po' annoiato
da chi ci fa la morale
ed esalta come sacra la vita coniugale
e poi ci sono i gay che han tutte le ragioni
ma io non riesco a tollerare
le loro esibizioni.
Non mi piace chi è troppo solidale
e fa il professionista del sociale
ma chi specula su chi è malato
su disabili, tossici e anziani
è un vero criminale.
Ma non vedo più nessuno che s'incazza
fra tutti gli assuefatti della nuova razza
e chi si inventa un bel partito
per il nostro bene
sembra proprio destinato
a diventare un buffone.
Ma forse sono io che faccio parte
di una razza
in estinzione.
La mia generazione ha visto
le strade, le piazze gremite
di gente appassionata
sicura di ridare un senso alla propria vita
ma ormai son tutte cose del secolo scorso
la mia generazione ha perso.
Non mi piace la troppa informazione
odio anche i giornali e la televisione
la cultura per le masse è un'idiozia
la fila coi panini davanti ai musei
mi fa malinconia.
E la tecnologia ci porterà lontano
ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano
c'è di buono che la scuola
si aggiorna con urgenza
e con tutti i nuovi quiz
ci garantisce l'ignoranza.
Non mi piace nessuna ideologia
non faccio neanche il tifo per la democrazia
di gente che ha da dire ce n'è tanta
la qualità non è richiesta
è il numero che conta.
E anche il mio paese mi piace sempre meno
non credo più all'ingegno del popolo italiano
dove ogni intellettuale fa opinione
ma se lo guardi bene
è il solito coglione.
Ma forse sono io che faccio parte
di una razza
in estinzione.
La mia generazione ha visto
migliaia di ragazzi pronti a tutto
che stavano cercando
magari con un po' di presunzione
di cambiare il mondo
possiamo raccontarlo ai figli
senza alcun rimorso
ma la mia generazione ha perso.
Non mi piace il mercato globale
che è il paradiso di ogni multinazionale
e un domani state pur tranquilli
ci saranno sempre più poveri e più ricchi
ma tutti più imbecilli.
E immagino un futuro
senza alcun rimedio
una specie di massa
senza più un individuo
e vedo il nostro stato
che è pavido e impotente
è sempre più allo sfascio
e non gliene frega niente
e vedo anche una Chiesa
che incalza più che mai
io vorrei che sprofondasse
con tutti i Papi e i Giubilei.
Ma questa è un'astrazione
è un'idea di chi appartiene
a una razza
in estinzione.
Classifica popoli più ignoranti al mondo, Italia prima in
Europa, scrive Alessandro Cipolla sumoney.it il 23
Agosto 2018. Secondo l’annuale classifica di IPSOS Mori sull’ignoranza dei
popoli, l’Italia risulta essere la dodicesima al mondo e la prima in Europa.
Continuano a non sorridere le classifiche all’Italia. Dopo quella
sulla corruzione redatta da Transparency International che ci vede al 54° posto
(tra le peggiori in Europa), anche sul tema dell’ignoranza il Bel Paese occupa
una posizione poco onorevole. Ma veramente gli italiani sono un popolo di
ignoranti? La storia in teoria ci insegnerebbe il contrario, ma ogni anno la
classifica stilata da IPSOS Mori ci vede ai primi posti di questa speciale
graduatoria che si basa sulla distorta percezione della realtà che ci circonda.
Italia nazione più ignorante d’Europa. Ogni anno IPSOS Mori,
importante azienda inglese di analisi e ricerca di mercato, stila puntualmente
una classifica su quelli che sarebbero i popoli più ignoranti al mondo chiamata
“Perils of Perception”, letteralmente “Pericoli della Percezione”. L’indagine si
basa su delle interviste a campione a 11.000 persone per ogni nazione, alle
quali vengono sottoposte delle domande su delle statistiche comuni che
riguardano il proprio paese. Per esempio nella ricerca del 2017, l’ultima
pubblicata, veniva chiesto se gli omicidi nel proprio paese fossero aumentati o
diminuiti rispetto al 2000. Oppure se gli attacchi terroristi siano aumentati
dopo l’11 Settembre o quanta gente soffra di diabete. In base al grado di errore
nel dare le risposte, IPSOS Mori stila la sua classifica che nel 2014 ci vedeva
come il popolo più ignorante al mondo. In quella del 2017 invece l’Italia è al
dodicesimo posto, prima tra le nazioni europee.
Una percezione distorta della realtà. Leggendo la classifica e
guardando i criteri di indagine, si capisce che non si deve confondere il
termine “ignorante” con poco istruito o analfabeta, ma invece che ignora la
realtà che lo circonda. Il termine “misperceptions” infatti con cui viene
presentata la classifica generale significa “percezione erronea”. Gli italiani
quindi secondo IPSOS Mori non conoscono a sufficienza quello che realmente
accade nel proprio paese. Prendiamo a esempio la domanda sugli omicidi che
rispetto al 2000 sono diminuiti in Italia del 39%. Per il 49% degli intervistati
invece il numero sarebbe aumentato, per il 35% sarebbe lo stesso mentre solo
l’8% ha risposto in maniera giusta. Non è un caso che, stando ai numeri forniti
dal Viminale a ferragosto, i reati nel nostro paese sono in diminuzione così
come gli sbarchi degli immigrati, ma al contrario la percezione di insicurezza e
l’idea della “invasione” prendono sempre più piede tra gli italiani. Nell’epoca
delle fake news gli italiani quindi sembrerebbero conoscere sempre meno cosa
succede nel proprio paese, una situazione che poco si addice a un popolo che con
la sua intelligenza ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del mondo. Mala
tempora currunt.
Bisogna studiare.
Bisogna cercare le fonti credibili ed attendibili per poter
studiare.
Bisogna studiare oltre la menzogna o l’omissione per poter
sapere.
Bisogna sapere il vero e non il falso.
Bisogna non accontentarsi di sapere il falso per esaudire le
aspirazioni personali o di carriera, o per accondiscendere o compiacere la
famiglia o la società.
Bisogna sapere il vero e conoscere la verità ed affermarla a chi
è ignorante o rinfacciarla a chi è in malafede.
Studiate “e conoscerete la verità, e la verità vi renderà liberi”
(Gesù. Giovanni 8:31, 32).
Studiare la verità rende dotti, saggi e LIBERI!
Non studiare o non studiare la verità rende schiavi, conformi ed
omologati.
E ciò ci rende cattivi, invidiosi e vendicativi.
Fa niente se studiare il vero non è un diritto, ma una conquista.
Vincere questa guerra dà un senso alla nostra misera vita.
LE IDEOLOGIE ANTIUOMO.
SOCIALISMO:
(Lenin diceva che il comunismo è socialismo più
elettrificazione).
Lavoro ed assistenzialismo, ambiente, libertà sessuale e
globalizzazione sono i miti dei comunisti. Moralizzatori sempre col ditino
puntato
Dio, Patria e Famiglia sono i miti dei fascisti. Oppressori.
Sovranismo e populismo sono i miti dei leghisti.
Assistenzialismo, populismo e complottismo sono i miti dei 5
stelle.
LIBERALISMO (LIBERISMO):
Egoismo e sopraffazione sono i miti dei liberali.
ECCLESISMO:
Il culto di Dio e della sua religione è il mito degli
ecclesiastici.
MONARCHISMO:
Il culto del Sovrano.
Nessuna di queste ideologie è fattrice rivoluzionaria con
l'ideale della Libertà, dell'Equità e della Giustizia.
Per il Socialismo le norme non bastano mai per renderti infernale
la vita, indegna di essere vissuta.
Per il Liberalismo occorrono poche norme anticoncorrenziali per
foraggiare e creare l'elìte.
Per Dio bastano 10 regole per essere un buon padre di famiglia.
Per il sovrano basta la sua volontà per regolare la vita dei
sottoposti.
Noi, come essere umani, dovremmo essere regolati dal diritto
naturale: Libertà, Equità e Giustizia.
Liberi di fare quel che si vuole su se stessi e sulla propria
proprietà.
Liberi di realizzare le aspettative secondo i propri meriti e
capacità.
Liberi di rispettare e far rispettare leggi chiare che si contano
su due mani: i 10 comandamenti o similari. Il deviante viene allontanato.
Il Papa: per eliminare la fame nel mondo non bastano gli slogan.
Francesco ha inaugurato il Consiglio dei governatori del Fondo delle Nazioni
Unite per lo sviluppo agricolo a Roma (Ifad) e incontra una delegazione di
popolazioni indigene, scrive il 14/02/2019 Iacopo Scaramazzi su La Stampa. Il
Papa ha caldeggiato lo «sviluppo rurale» per combattere la fame e la povertà,
sottolineando la necessità di «garantire che ogni persona e ogni comunità
possano utilizzare le proprie capacità un modo pieno, vivendo così una vita
umana degna di tale nome», e facendo appello affinché i popoli e le comunità
siano «responsabili della proprio produzione e del proprio progresso» poiché
«quando un popolo si abitua alla dipendenza, non si sviluppa».
Questo vale per tutte quelle categorie di lavoratori che
protestano per avere aiuti e sostegno anticoncorrenziale che porta al demerito
improduttivo. E vale anche per i meridionali d’Italia. Insistere nel pretendere
aiuto e non far nulla per migliorarsi.
L’assistenzialismo socialista ha prodotto gli statali, che dalla
loro privilegiata posizione improduttiva, impongono stili di vita utopistici e
demagogici. Questi dipendenti pubblici, spesso scolastici o sanitari, da
capipopolo, fomentano le masse per inibire l’industrializzazione sostenibile e
lo sviluppo turistico tollerabile, che portano sviluppo economico e sociale, in
nome di un fantomatico ecologismo talebano, per poi costringer le masse
ideologizzate, paradossalmente, ad essere costrette ad emigrare in posti
altamente inquinati, o a villeggiare in posti meno allettanti.
Papa Francesco: "È il lavoro a dare speranza, non
l'assistenzialismo", scrive il 15 giugno 2018 La Repubblica. "La speranza in un
futuro migliore passa sempre dalla propria attività e intraprendenza, quindi dal
proprio lavoro, e mai solamente dai mezzi materiali di cui si dispone. Non vi è
alcuna sicurezza economica, né alcuna forma di assistenzialismo, che possa
assicurare pienezza di vita e realizzazione". Lo ha detto papa Francesco
nell'udienza con i Maestri del Lavoro. "Non si può essere felici - ha aggiunto
Bergoglio - senza la possibilità di offrire il proprio contributo, piccolo o
grande, alla costruzione del bene comune". Per questo "una società che non si
basi sul lavoro, che non lo promuova, e che poco si interessi a chi ne è
escluso, si condannerebbe all'atrofia e al moltiplicarsi delle disuguaglianze".
Mentre la società che cerca di mettere a frutto le potenzialità di ciascuno è
quella che "respirerà davvero a pieni polmoni, e potrà superare gli ostacoli più
grandi, attingendo a un capitale umano pressoché inesauribile, e mettendo ognuno
in grado di farsi artefice del proprio destino".
La dittatura dell’ignoranza. «Uno
uguale uno» significa annullare la competenza. E si finisce come in
Venezuela..., scrive Francesco Alberoni, Domenica 10/02/2019 su Il Giornale.
L'altra sera ho assistito ad un dibattito televisivo che mi ha molto
impressionato. Non dirò dove l’ho visto, ma sarebbe potuto avvenire su qualunque
rete. Erano presenti quattro persone, due grandi giornalisti esperti di economia
e due donne (ma potevano essere due uomini) che non ne sapevano niente,
assolutamente niente. Il risultato è stato che le persone che non sapevano
niente sono riuscite a surclassare, rendere muti, quelli che sapevano. In che
modo? Gridando le loro stupidaggini come verità incontrovertibili e scartando
tutte le obiezioni serie con un gesto di rifiuto. Poi citavano fatti
inesistenti, cifre inventate, con la sicurezza dogmatica che solo l’ignorante
fanatico può avere. Ripetevano slogan detti dai loro capi, luoghi comuni che
circolano su internet dove ciascuno racconta le frottole che vuole. Ed ho
pensato che il popolo da solo non può governarsi perché da solo finisce in balia
di demagoghi spregiudicati, di fanatici, talvolta di squilibrati e viene
istupidito con menzogne, false notizie. Come è successo col comunismo, col
nazismo e col fascismo. Mi viene in mente il fascismo quando il Duce chiedeva:
«Volete burro o cannoni?» e la gente rispondeva ottusamente «Cannoni» o, alla
domanda «Volete la vita comoda?» rispondeva «No!». Ed è successo lo stesso
quando la folla gridava «Barabba» al posto di Gesù Cristo, o quella che
applaudiva quando ghigliottinavano Lavoisier, il padre della chimica moderna. Il
popolo ha bisogno di gente che sa, di studiosi, di giornalisti, di politici
esperti che insegnano a ragionare e garantiscono una informazione corretta.
Allora il popolo può decidere liberamente. Ma non può farlo quando viene
informato da gente che non sa, che mente. Pericle aveva saggiamente evitato la
guerra con Sparta, ma dopo la sua morte, il popolo ateniese seguì gli esaltati
che la scatenarono e Atene fu sconfitta. Noi oggi in Italia non siamo in una
situazione diversa. Si è diffusa l’idea che «uno è uguale a uno» cioè che abbia
lo stesso valore l’idea del più ignorante rispetto a chi sa. E si è prodotta una
confusione mentale pericolosa. Sono le situazioni in cui i Paesi prendono strade
folli, e vanno in malora come è successo in Venezuela.
Oltretutto in tv o sui giornali non si fa informazione o cultura,
ma solo comizi propagandistici ideologici.
Se questi son giornalisti...
Da Striscia La Notizia il 25 settembre 2020. Caro Dago, una
regola scolpita nei sacri testi dell’esame di Stato dei giornalisti impone di
citare sempre le fonti. A meno che non si tratti del TG1. Ieri sera, nel
telegiornale delle 20, nelle immagini che corredavano il servizio sull’esame
tarocco di Suarez a Perugia, è stato inserito un post ironico che Striscia aveva
pubblicato sui suoi profili social martedì 22 settembre intorno alle 13.30.
Peccato che “Rai mani di forbice” abbia tagliato dall’immagine trasmessa ogni
riferimento a Striscia (il credito, in gergo tecnico). Il paradosso è che per
far sparire le tracce del furto abbiano dovuto ingrandire talmente l’immagine da
quasi decapitare l’incolpevole Suarez.
Io, senza
alcun Potere di intervento, non posso dare aspettative. Tantomeno non posso
smuovere le acque con i fari mediatici, che a me mancano.
Io non sono un
giornalista, che si deve attenere alla verità, attinenza e continenza ed
all’interesse pubblico. Ergo, non posso e non voglio pubblicare inediti, pur
potendo pubblicare le stesse denunce penali o altri atti pubblici pubblicabili.
Non è la prima volta che il beneficiario, ingrato, si è rivoltato contro ed ha
chiesto l’anonimato, o con minacce, il ritiro del pubblicato per paura di
ritorsioni a lui rivolte.
Come
sociologo, al fine di studio o di discussione, per critica storica o per
inchiesta, posso approfondire e comparare un caso ad altri casi già trattati,
per elevarli ad anomalia del sistema. Questi casi, con me, hanno una notorietà
che ad essi in origine manca e comunque creo un precedente utile a tutti.
In questo caso
i soggetti originali non possono impedirne la pubblicazione, né il pubblicato
può essere da loro ritirato.
In conclusione
posso dire che non vi è alcun legame con le parti e la pubblicazione, credibile,
attendibile, affidabile ed incontestabile, avviene per amor di Verità.
E’ una cautela
legale e di opportunità al fine di tutelarmi dai mitomani e dai potenti.
In un mio saggio sulla mafia mi è sembrato opportuno integrare,
quanto già ampiamente scritto sul tema, con una tesi-articolo pubblicato su "La
Repubblica" da parte di un'autrice poco nota dal titolo "La Mafia Sconosciuta
dei Basilischi". Dacchè mercoledì 16 gennaio 2019 mi arriva una e-mail di
diffida di questo tenore: qualche giorno fa mi sono resa conto che senza nessuna
tipologia di autorizzazione Lei ha fatto confluire il mio abstract pubblicato da
la Repubblica ad agosto 2017, in un suo libro "La mafia in Italia" e forse anche
in una seconda opera. Le ricordo che a norma dell'art. 70, comma 1 della Legge
sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o
di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati
per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali." NB. In
dottrina si evidenzia che “per uso di critica” si deve intendere l’utilizzazione
oggettivamente finalizzata ad esprimere opinioni protette ex art. 21 e 33 della
Costituzione e non, invece, l’utilizzazione funzionale allo svolgimento di
attività economiche ex art. 41 Cost. La sua opera essendo caratterizzata da fini
di lucro, (viene venduta al pubblico ad uno specifico prezzo) rientra a pieno in
un'attività economica. L'art 70 ut supra è, pertanto, pienamente applicabile al
caso del mio abstract, non rientrando neanche nel catalogo di articoli a
carattere "economico, politico o religioso", poichè da questi vengono escluse
"gli articoli di cronaca od a contenuto culturale, artistico, satirico, storico,
geografico o scientifico ", di cui all'art 65 della medesima legge (secondo
un'interpretazione estensiva della stessa), la cui riproduzione può avvenire in
"altri giornali e riviste, ossia in veicoli di informazione diretti ad un
pubblico generalizzato e non a singole categorie di utenti – clienti
predefinite." Pertanto La presente è per invitarLa ad eliminare nel più breve
tempo possibile il mio abstract dalla sua opera (cartecea e digitale), e laddove
sia presente, anche da altri eventuali suoi libri, e-book e cartacei, onde
evitare di dover adire le apposite sedi giudiziarie per tutelare il mio Diritto
d'Autore e pedissequamente richiedere il risarcimento dei danni.
La mia risposta: certamente non voglio polemizzare e non ho alcun
intendimento a dissertare di diritto con lei, che del diritto medesimo ne fa una
personalissima interpretazione, non avendo il mio saggio alcun effetto anche
potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione rispetto al suo articolo. Nè
tantomeno ho interesse a mantenere il suo articolo nei miei libri di interesse
pubblico di critica e di discussione. Libri a lettura anche gratuita, come lei
ha constatato, avendo trovato il suo articolo liberamente sul web. Tenuto conto
che altri sarebbero lusingati nell’essere citati nelle mie opere, e in migliaia
lo sono (tra i più conosciuti e celebrati), e non essendoci ragioni di utilità
per non farlo, le comunico con mia soddisfazione che è stata immediatamente
cancellata la sua tesi dai miei saggi e per gli effetti condannata all’oblio.
Saggi che continuamente sono utilizzati e citati in articoli di stampa, libri e
tesi di laurea in Italia ed all’estero. E di questo ne sono orgoglioso, pur non
avendone mai data autorizzazione preventiva. Vuol dire che mi considerano degno
di essere riportato e citato e di questo li ringrazio infinitamente.
La risposta piccata è stata: Guardi mi sa che parliamo due lingue
diverse. Non ho dato nessuna interpretazione mia personale del diritto, ma come
può notare dalla precedente mail, mi sono limitata a riportare il tenore
letterale della norma, che lei forse ignora. Io credo che molte persone, i cui
elaborati sono stati interamente riprodotti nei suoi testi, non siano
assolutamente a conoscenza di quello che lei ha fatto. Anche perché sono persone
che conosco direttamente e con le quali ho collaborato e collaboro tutt'ora. Di
certo non sarà lei attraverso l'estromissione (da me richiesta) dalle sue
"opere" a farmi cadere in qualsivoglia oblio, poiché preferisco continuare a
collaborare con professionisti (quali ad esempio Bolzoni) che non mettono in
vendita libri che non sono altro che un insieme di lavori di altri, come fa lei,
ma che come me continuano a studiare ed analizzare questi fenomeni con
dedizione, perizia e professionalità. Ma non sto qui a disquisire e ad entrare
nel merito di determinate faccende che esulano la questio de quo. Spero che si
attenga a quanto scritto nella precedente mail.
A questo preme puntualizzare alcuni aspetti.
Il mio utilizzo dei
contenuti soddisfa i requisiti legali del fair use o del fair dealing ai sensi
delle leggi vigenti sul copyright. Le norme nazionali ed internazionali mi
permettono di manifestare il proprio pensiero, anche con la testimonianza di
terzi e a tal fine fare copie singole di parti di opere per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico.
Molti moralizzatori, sempre col ditino puntato, pretendono di
avere il monopolio della verità. Io che non aspiro ad essere come loro (e di
fatto sono orgoglioso di essere diverso) mi limito a riportare i comizietti, le
prediche ed i pistolotti di questi, contrapponendo gli uni agli altri. A tal
fine esercito il mio diritto di cronaca esente da mie opinioni. D'altronde tutti
i giornalisti usano riportare gli articoli di altri per integrare il loro o per
contestarne il tono o i contenuti.
Sono Antonio Giangrande autore ed editore di
centinaia di libri.
Io sono un giurista ed un blogger d’inchiesta. Io esercito il mio
diritto di cronaca e di critica. Diritto di cronaca, dico, che non ha alcuna
limitazione se non quella della verità, attinenza-continenza, interesse
pubblico. Diritto di cronaca su Stampa non periodica. Per gli effetti ho diritto
di citazione con congruo lasso di tempo e senza ledere la concorrenza. All’uopo
ho scritto decine di libri con centinaia di pagine cadauno, basandomi su
testimonianze e documenti credibili ed attendibili, rispettando il diritto al
contraddittorio, affrontando temi suddivisi per argomento e per territorio,
aggiornati periodicamente. Libri a lettura anche gratuita. Non esprimo opinioni
e faccio parlare i fatti e gli atti con l’ausilio di migliaia di terzi,
credibili e competenti, che sono ben lieti di essere, pubblicizzati, riportati e
citati nelle mie opere. Opere che continuamente sono utilizzati e citati da
terzi in articoli di stampa, libri e tesi di laurea in Italia ed all’estero. E
di questo ne sono orgoglioso, pur non avendone mai data autorizzazione
preventiva. Vuol dire che mi considerano degno di essere riportato e citato e di
questo li ringrazio infinitamente. Libri a lettura anche gratuita. Il mio
utilizzo dei contenuti soddisfa i requisiti legali del fair use o del fair
dealing ai sensi delle leggi vigenti sul copyright. Le norme nazionali ed
internazionali mi permettono di manifestare il proprio pensiero, anche con la
testimonianza di terzi e a tal fine fare copie singole di parti di opere per
ricerca e studio personale o a scopo culturale o didattico.
Io sono un giurista ed un blogger d’inchiesta. Opero nell’ambito
dell’art. 21 della Costituzione che mi permette di esprimere liberamente il mio
pensiero. Nell’art. 65 della legge n. 633/1941 il legislatore sancisce la
libertà di utilizzazione, riproduzione o ripubblicazione e comunicazione al
pubblico degli articoli di attualità, che possiamo considerare come sinonimo di
cronaca, in altre riviste o giornali. Distinta dalla mera cronaca è l’inchiesta
giornalistica, la quale parte da fatti di cronaca per svolgere un’attività di
indagine, c.d. “indagine giornalistica”, con la quale il professionista si
informa, chiede chiarimenti e spiegazioni. Questa attività rientra nel c.d.
“giornalismo investigativo” o “d’inchiesta”, riconosciuto dalla Cassazione nel
2010 come “la più alta e nobile espressione dell’attività giornalistica”,
perché consente di portare alla luce aspetti e circostanze ignote ai più e di
svelare retroscena occultati, che al contempo sono di rilevanza sociale. A
seguito dell’attività d’indagine, il giornalista svolge poi l’attività di studio
del materiale raccolto, di verifica dell’attendibilità di fonti non generalmente
attendibili, diverse dalle agenzie di stampa, di confronto delle fonti. Solo al
termine della selezione del materiale conseguito, il giornalista inizia a
scrivere il suo articolo. (Cass., 9 luglio 2010, n. 16236, in Danno e resp.,
2010, 11, p. 1075. In questa sentenza la Corte Suprema precisa che “Con tale
tipologia di giornalismo (d’inchiesta), infatti, maggiormente, si realizza il
fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla
raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto
di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per
sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche notevoli, per il
rilievo pubblico delle stesse”).
Io sono un
sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza censura od
omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio personale o a
scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della Legge sul
diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per
uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."
L’autore ha il
diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo
(art. 12 comma 2
Legge sul Diritto d’Autore).
La legge stessa però fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto
d’autore per esigenze di pubblica informazione, di libera
discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio. Si tratta
di limitazioni all’esercizio del diritto di autore, giustificate da un interesse
generale che prevale sull’interesse personale dell’autore.
L'art. 10
della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del 1978)
Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza degli
ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le seguenti
regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente
accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste
periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni
siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Ai sensi
dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e notizie è
lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti
in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in
quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La
libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di riassumere citare o
anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica, discussione o
insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o didattica abbia
finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e perciò i frammenti
riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con i diritti di
utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera parzialmente riprodotta"
(Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
La dottrina e
la giurisprudenza interpretano tassativamente, restrittivamente e non
analogicamente tale articolo, al pari delle altre fattispecie di libere
utilizzazioni. Ciò non toglie che la norma possa essere interpretata
estensivamente (in tal senso dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente
unanime).
Secondo il
parere dell'Avv. Giovanni D'Ammassa, su Dirittodautore.it, limiti individuati
dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane alla facoltà di citazione ex art.
70
Legge sul Diritto d’Autore
sono i seguenti:
la sussistenza
della finalità di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica;
l’opera
critica deve avere fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera
citata, e non deve essere succedanea dell’opera o delle sue utilizzazioni
derivate. La ricorrenza dello scopo di critica non è pregiudicata dal fatto che
la citazione sia fatta nella realizzazione di un’opera immessa sul mercato a
pagamento;
l’utilizzazione dell’opera deve essere solo parziale e mai integrale, deve
avvenire nell’ambito delle finalità tassativamente indicate e nella misura
giustificata da tali finalità;
l’utilizzazione non deve essere concorrenziale a quella posta dal titolare dei
diritti, non deve avere un rilievo economico tale da poter pregiudicare gli
interessi patrimoniali dell’autore o dei suoi aventi causa. A questo proposito
va ricordato che il concetto di concorrenza espresso dall’art. 70
Legge sul
Diritto d’Autore
è ben più
ampio e diverso dal concetto di concorrenza sleale espresso dall’art. 2598 cod.
civ.: l’assenza dell’elemento della concorrenza è condizione perché possa
parlarsi di libera utilizzazione dell’opera. Una recente dottrina sostiene che
bisogna avere riguardo esclusivamente alla portata della utilizzazione in
relazione alla sua capacità di incidere sulla vita economica dell’opera
originale; da ciò la valorizzazione dell’assenza di concorrenza dell’opera
citante con i diritti di utilizzazione economica sull’opera citata, in modo da
consentire anche citazioni integrali dell’opera dell’ingegno purché non si
pongano in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’opera;
devono essere
effettuate le menzioni d’uso (indicazione del titolo dell’opera da cui è tratta
la citazione, del nome dell’autore e dell’editore);
infine si
sostiene che l’interpretazione di tale articolo deve tenere conto anche del
progresso tecnologico. È indubbio che l’art. 70
Legge sul Diritto d’Autore
sia applicabile anche in caso di messa a disposizione online delle opere.
Secondo l'Avv.
Alessandro Monteleone, su Altalex.com, tale requisito postula che
l’utilizzazione dell’opera non danneggi in modo sostanziale uno dei mercati
riservati in esclusiva all’autore/titolare dei diritti: non deve pertanto
influenzare l’ammontare dei profitti di tipo monopolistico realizzabili
dall’autore/titolare dei diritti. Secondo VALENTI, in particolare, il carattere
commerciale dell’utilizzazione e, soprattutto, l’impatto che l’utilizzazione può
avere sul mercato – attuale o potenziale – dell’opera protetta sono elementi
determinanti nel verificare se l’utilizzazione possa considerarsi libera o non
concreti invece violazione del diritto d’autore. Potrebbe ad esempio costituire
concorrenza alla utilizzazione economica la riproduzione che, ancorché parziale,
svii i potenziali acquirenti dall’acquistare l’originale perché avente ad
oggetto le parti di maggiore interesse. Interessante è la pronuncia della Corte
di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.01.2007 n° 149: Con l’espressione "a
fini di lucro" contenuta nella fattispecie criminosa di cui all’art. 171 ter
della legge sul diritto d’autore (L. 633/41) deve intendersi "un fine di
guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte
dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di
altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero
risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o
altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica
da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti
l’abuso". Lo ha precisato la Sezione Terza penale della Cassazione, con la
sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007, estensibile all'art. 70.
Io sono un
Segnalatore di illeciti (whistleblower). La normativa italiana utilizza
l'espressione segnalatore o segnalante d'illeciti a partire dalla cosiddetta
"legge anti corruzione" (6 novembre 2012 n. 190). Italia. L'art. 1, comma 51
della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato per la prima volta nella
legislazione italiana la figura del whistleblower, con particolare riferimento
al "dipendente pubblico che segnala illeciti", al quale viene offerta una
parziale forma di tutela. Negli Stati Uniti la prima legge in tema fu il False
Claims Act del 1863, che protegge i segnalatori di illeciti
da licenziamenti ingiusti, molestie e declassamento professionale, e li
incoraggia a denunciare le truffe assicurando loro una percentuale sul denaro
recuperato. Del 1912 è il Lloyd–La Follette Act, che garantisce agli impiegati
federali il diritto di fornire informazioni al Congresso degli Stati Uniti
d'America. Nel 1989 è stato approvato il Whistleblower Protection Act, una legge
federale che protegge gli impiegati del governo che denunciano illeciti,
proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti dalla divulgazione
dell'illecito.
Io sono un
Aggregatore di contenuti tematici di ideologia contrapposta con citazione della
fonte, al fine del diritto di cronaca e di discussione e di critica dei
contenuti citati.
Giornali
online senza licenza: indagato manager di Data Stampa.
Pubblicato
venerdì, 24 gennaio 2020 su Corriere.it da Virginia Picollillo. Violazione del
diritto d’autore: è l’accusa contestata a Massimo Scambelluri, il presidente del
Consiglio di amministrazione di “Data Stampa”, società che vende la rassegna
stampa quotidiana per clienti privati e istituzionali. La procura di Roma aveva
aperto un’inchiesta dopo la denuncia di alcuni quotidiani che lamentavano di non
aver mai dato il consenso e dunque senza aver concesso la licenza di utilizzo,
vendita e diffusione dei contenuti protetti da copyright . La Guardia di Finanza
ha verificato come la società ogni giorno dia ai propri clienti 21 quotidiani,
italiani e internazionali, consentendo l’accesso con l’utilizzo di password
rilasciate dalla stessa “Data Stampa” sia alla versione cartacea, sia facendo
scaricare le pagine in formato pdf. Sul sito della società è specificato che tra
i clienti ci sono la presidenza della Repubblica, il Senato e la Camera, il Csm,
la Banca d’Italia, l’Agenzia delle entrate, la Polizia di Stato, il ministero
dell’Interno, l’Arma e la Rai. Istituzione che pagano un abbonamento all’azienda
ed è proprio questo ad aver convinto alcuni gruppi editoriali e testate - tra
cui La Stampa, la Repubblica e il Messaggero - a presentare la denuncia. Data
Stampa ha anche un contenzioso civile con la Fieg, la federazione editori di
giornali, proprio per le rassegne stampa.
Da Data
Stampa: DIRITTO D’AUTORE NON APPLICABILE ALLE RASSEGNE STAMPA. Il 12 giugno
2019, con sentenza n. 3931/2019, la Corte d’Appello di Roma, rigettando
l’appello di Fieg e Promopress contro la sentenza n. 816/2017 del 18 gennaio
2017, ha legittimato l’attività svolta da Data Stampa fin dal 1981. La richiesta
di Fieg era di inibire l’attività dei rassegnatori, chiedendo loro inoltre un
risarcimento danni per l’uso che i rassegnatori fanno dei loro articoli,
ritenendo che anche alle rassegne stampa dovesse essere applicato il principio
del diritto d’autore. La Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi in favore di
Data Stampa, ha confermato “con forza” il principio della libera riproducibilità
degli articoli di giornale nelle rassegne stampa. Ora le aspettative di Data
Stampa sono riposte nel Parlamento, che potrebbe regolare la materia nell’ambito
del riordino del settore dell’editoria affidato agli Stati Generali, il termine
dei cui lavori è previsto intorno alla metà del prossimo mese di ottobre. Una
vittoria che, dopo il successo ottenuto due anni e mezzo fa da Data Stampa nel
primo grado di giudizio, ci spinge a guardare al futuro con rinnovata fiducia,
nella ferma convinzione che la libertà d’impresa e d’informazione vada difesa
sempre, contro ogni azione arbitraria posta in essere al di fuori di un quadro
normativo certo. La posizione di Data Stampa al riguardo, giova ricordarlo, è
sempre rimasta immutata: Data Stampa auspica che venga approvato un quadro
normativo fatto di regole certe e rispettose delle legittime esigenze di tutti
gli operatori del settore, e non imposte unilateralmente.
“ Orbene la
ratio dell’art 65 è quella di accrescere la circolazione dell’informazione, come
si risulta evidente:
Dalla natura
degli scritti di cui la norma consente la riproduzione (gli articoli di
attualità, appunto che hanno eminente valore informativo)
Dalla natura
del mezzo di riproduzione (giornali, riviste o strumenti di radiodiffusione che
ancora una volta hanno finalità essenzialmente informative).
Così stando le
cose non può essere allora negata la possibilità di riprodurre anche nelle
rassegne stampa gli articoli di attualità, giacchè anche alle rassegne stampa
deve essere riconosciuta una finalità sicura finalità informativa, anche se
diretta a volte e soddisfare interessi di particolari categorie di soggetti,
informazione questa tuttavia non per ciò solo meno meritevole di tutela
costituzionale. In definitiva, l’art. 65 va interpretato in base al canone di
interpretazione estensiva fondato sulla ratio della norma, nel senso che esso al
di là delle espresse previsioni letterali, ben può includere, tra gli strumenti
informativi su cui si possono liberamente riprodursi gli articoli di giornale,
anche la rassegna stampa…”
Dr Luigi Amicone, sono il dr Antonio Giangrande. Il soggetto da
lei indicato a Google Libri come colui che viola il copyright di “Qualcun
Altro”. Così come si evince dalla traduzione inviatami da Google. “Un sacco di
libri pubblicati da Antonio Giangrande, che sono anche leggibile da Google
Libri, sembrano violare il copyright di qualcun altro. Se si controlla, si
potrebbe scoprire che sono fatti da articoli e testi di diversi giornalisti. Ha
messo nei suoi libri opere mie, pubblicate su giornali o riviste o siti web. Per
esempio, l'articolo pubblicato da Il Giornale il 29 maggio 2018 "Il serial
Killer Zodiac ... ". Sembra che abbia copiato l'intero articolo e incollato sul
"suo" libro. Sembra che abbia pubblicato tutti i suoi libri in questo modo. Puoi
chiedergli di cambiare il suo modo di "scrivere"? Grazie”.
Mi vogliono censurare su Google.
Premessa: Ho scritto centinaia di saggi e centinaia di migliaia
di pagine, affrontando temi suddivisi per argomento e per territorio, aggiornati
periodicamente. Libri a lettura anche gratuita. Non esprimo opinioni e faccio
parlare i fatti e gli atti con l’ausilio di terzi, credibili e competenti, che
sono ben lieti di essere riportati e citati nelle mie opere. Opere che
continuamente sono utilizzati e citati in articoli di stampa, libri e tesi di
laurea in Italia ed all’estero. E di questo ne sono orgoglioso, pur non avendone
mai data autorizzazione preventiva. Vuol dire che mi considerano degno di essere
riportato e citato e di questo li ringrazio infinitamente. Libri a lettura anche
gratuita. Il mio utilizzo dei contenuti soddisfa i requisiti legali del fair use
o del fair dealing ai sensi delle leggi vigenti sul copyright. Le norme
nazionali ed internazionali mi permettono di manifestare il proprio pensiero,
anche con la testimonianza di terzi e a tal fine fare copie singole di parti di
opere per ricerca e studio personale o a scopo culturale o didattico.
Reclamo: Non si chiede solo di non usare i suoi articoli, ma si
pretende di farmi cambiare il mio modo di scrivere. E questa è censura.
Ho diritto di citazione con congruo lasso di tempo e senza ledere
la concorrenza.
Io sono un giurista ed un giornalista d’inchiesta. Opero
nell’ambito dell’art. 21 della Costituzione che mi permette di esprimere
liberamente il mio pensiero. Nell’art. 65 della legge n. 633/1941 il legislatore
sancisce la libertà di utilizzazione, riproduzione o ripubblicazione e
comunicazione al pubblico degli articoli di attualità, che possiamo considerare
come sinonimo di cronaca, in altre riviste o giornali. Distinta dalla mera
cronaca è l’inchiesta giornalistica, la quale parte da fatti di cronaca per
svolgere un’attività di indagine, c.d. “indagine giornalistica”, con la quale il
professionista si informa, chiede chiarimenti e spiegazioni. Questa attività
rientra nel c.d. “giornalismo investigativo” o “d’inchiesta”, riconosciuto dalla
Cassazione nel 2010 come “la più alta e nobile espressione dell’attività
giornalistica”, perché consente di portare alla luce aspetti e circostanze
ignote ai più e di svelare retroscena occultati, che al contempo sono di
rilevanza sociale. A seguito dell’attività d’indagine, il giornalista svolge poi
l’attività di studio del materiale raccolto, di verifica dell’attendibilità di
fonti non generalmente attendibili, diverse dalle agenzie di stampa, di
confronto delle fonti. Solo al termine della selezione del materiale conseguito,
il giornalista inizia a scrivere il suo articolo. (Cass., 9 luglio 2010, n.
16236, in Danno e resp., 2010, 11, p. 1075. In questa sentenza la Corte Suprema
precisa che “Con tale tipologia di giornalismo (d’inchiesta), infatti,
maggiormente, si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro
intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie
destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli
organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di
tematiche notevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”).
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i
posteri, senza censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per
ricerca e studio personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art.
70, comma 1 della Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o
di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali."
Io sono un Segnalatore di illeciti (whistleblower). La normativa
italiana utilizza l'espressione segnalatore o segnalante d'illeciti a partire
dalla cosiddetta "legge anti corruzione" (6 novembre 2012 n. 190). Italia.
L'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato per la
prima volta nella legislazione italiana la figura del whistleblower, con
particolare riferimento al "dipendente pubblico che segnala illeciti", al quale
viene offerta una parziale forma di tutela. Negli Stati Uniti la prima legge in
tema fu il False Claims Act del 1863, che protegge i segnalatori di illeciti
da licenziamenti ingiusti, molestie e declassamento professionale, e li
incoraggia a denunciare le truffe assicurando loro una percentuale sul denaro
recuperato. Del 1912 è il Lloyd–La Follette Act, che garantisce agli impiegati
federali il diritto di fornire informazioni al Congresso degli Stati Uniti
d'America. Nel 1989 è stato approvato il Whistleblower Protection Act, una legge
federale che protegge gli impiegati del governo che denunciano illeciti,
proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti dalla divulgazione
dell'illecito.
Io sono un Aggregatore di contenuti tematici di ideologia
contrapposta con citazione della fonte, al fine del diritto di cronaca e di
discussione e di critica dei contenuti citati.
Quando parlo di aggregatore di contenuti non mi riferisco a colui
che, per profitto, riproduce tout court integralmente, o quasi, un post o un
articolo. Costoro non sono che volgari “produttori” di plagio, pur citando la
fonte. Ci sono Aggregatori di contenuti in Italia, che esercitano la loro
attività in modo lecita, e comunque, verosimilmente, non contestata dagli autori
aggregati e citati.
Vedi Giorgio dell’Arti su “Cinquantamila.it”. LA STORIA
RACCONTATA DA GIORGIO DELL'ARTI. “Salve. Sono Giorgio Dell’Arti. Questo sito è
riservato agli abbonati della mia newsletter, Anteprima. Anteprima è la spremuta
di giornali che realizzo dal lunedì al venerdì la mattina all’alba, leggendo i
quotidiani appena arrivati in edicola. La rassegna arriva via email agli utenti
che si sono iscritti in promozione oppure in abbonamento qui o sul
sito anteprima.news”.
Oppure come fa Dagospia o altri siti di informazione online, che
si limitano a riportare quegli articoli che per motivi commerciali o di
esclusività non sono liberamente fruibili. Dagospia si definisce "Risorsa
informativa online a contenuto generalista che si occupa di retroscena. È
espressione di Roberto D'Agostino". Sebbene da alcuni sia considerato un sito
di gossip, nelle parole di D'Agostino: «Dagospia è un bollettino d'informazione,
punto e basta».
Addirittura il portale web “Newsstandhub.com” riporta tutti gli
articoli dei portali di informazione più famosi con citazione della fonte, ma
non degli autori. Si presenta come: “Il tuo centro edicola personale dove poter
consultare tutte le notizia contemporaneamente”.
Così come il sito web di Ristretti.org o di Antimafiaduemila.com,
o dipressreader.com.
Così come fanno alcuni giornali e giornalisti. Non fanno
inchieste o riportano notizie proprie. Ma la loro informazione si basa su su
articoli di terzi. Vedi “Il giornale” o “Libero Quotidiano” o Il Corriere del
Giorno o il Sussidiario, o twnews.it/it-news.
Io esercito il mio diritto di cronaca e di critica. Diritto di
cronaca, dico, che non ha alcuna limitazione se non quella della verità,
attinenza-continenza, interesse pubblico. Diritto di cronaca su Stampa non
periodica.
Che cosa significa "Stampa non periodica"?
Ogni forma di pubblicazione una tantum, cioè che non viene
stampata regolarmente (è tale, ad esempio, un saggio o un romanzo in forma di
libro).
Stampa non periodica, perché la Stampa periodica è di pertinenza
esclusiva della lobby dei giornalisti, estensori della pseudo verità, della
disinformazione, della discultura e dell’oscurantismo.
Con me la cronaca diventa storia ed allora il mio diritto di
cronaca diventa diritto di critica storica.
NB. In dottrina si evidenzia che “per uso di critica” si deve
intendere l’utilizzazione oggettivamente finalizzata ad esprimere opinioni
protette ex art. 21 e 33 della Costituzione. Con me la cronaca diventa storia ed
allora il mio diritto di cronaca diventa diritto di critica storica. La critica
storica può scriminare la diffamazione. Cassazione penale, sez. V, sentenza
10/11/2016 n° 47506. L'esercizio del diritto di critica può, a certe condizioni,
rendere non punibile dichiarazioni astrattamente diffamatorie, in quanto lesive
dell'altrui reputazione. Resoconto esercitato nel pieno diritto di Critica
Storica. La critica storica può scriminare la diffamazione. Cassazione penale,
sez. V, sentenza 10/11/2016 n° 47506. La ricerca dello storico, quindi, comporta
la necessità di un’indagine complessa in cui “persone, fatti, avvenimenti,
dichiarazioni e rapporti sociali divengono oggetto di un esame articolato che
conduce alla definitiva formulazione di tesi e/o di ipotesi che è impossibile
documentare oggettivamente ma che, in ogni caso debbono trovare la loro base in
fonti certe e di essere plausibili e sostenibili”. La critica storica, se da una
parte può scriminare la diffamazione. Cassazione penale, sez. V, sentenza
10/11/2016 n° 47506, dall'altra ha funzione di discussione: "Il riassunto, la
citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione
al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei
limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera".
Io sono il segnalatore di illeciti (whistleblower) più ignorato
ed oltre modo più perseguitato e vittima di ritorsioni del mondo. Ciononostante
non mi batto per la mia tutela, in quanto sarebbe inutile dato la coglionaggine
o la corruzione imperante, ma lotto affinchè gli altri segnalatori, che
imperterriti si battono esclusivamente ed inanemente per la loro bandiera, non
siano tacciati di mitomania o pazzia. Dimostro al mondo che le segnalazioni sono
tanto fondate, quanto ignorate od impunite, data la diffusa correità o ignoranza
o codardia.
Segnalatore di illeciti. Da
Wikipedia, l'enciclopedia libera. Il segnalatore o segnalante di illeciti, anche
detto segnalatore o segnalante di reati o irregolarità (termine reso a volte
anche con la parola anglosassone e specificatamente dell'inglese
americano whistleblower) è un individuo che denuncia pubblicamente o riferisce
alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di
un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni o denunce
possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia
di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche
situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. Tali soggetti
possono denunciare le condotte illecite o pericoli di cui sono venuti a
conoscenza all'interno dell'organizzazione stessa, all'autorità giudiziaria o
renderle pubbliche attraverso i media o le associazioni ed enti che si occupano
dei problemi in questione. Spesso i segnalatori di illeciti, soprattutto a causa
dell'attuale carenza normativa, spinti da elevati valori di moralità e
altruismo, si espongono singolarmente a ritorsioni, rivalse, azioni vessatorie,
da parte dell'istituzione o azienda destinataria della segnalazione o singoli
soggetti ovvero organizzazioni responsabili e oggetto delle accuse, venendo
sanzionati disciplinarmente, licenziati o minacciati fisicamente.
La normativa italiana utilizza
l'espressione segnalatore o segnalante d'illeciti a partire dalla cosiddetta
"legge anti corruzione" (6 novembre 2012 n. 190). In inglese viene invece
utilizzata la parola whistleblower, che deriva dalla frase to blow the whistle,
letteralmente «soffiare il fischietto», riferita all'azione dell'arbitro nel
segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione
illegale. Il termine è in uso almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield
News-Journal (Ohio). L'origine dell'espressione whistleblowing è tuttavia ad
oggi incerta, sebbene alcuni ritengano che la parola si riferisca alla pratica
dei poliziotti inglesi di soffiare nel loro fischietto nel momento in cui
avessero notato la commissione di un crimine, in modo da allertare altri
poliziotti e, in modo più generico, la collettività. Altri ritengono che si
richiami al fallo fischiato dall'arbitro durante una partita sportiva. In
entrambi i casi, l'obiettivo è quello di fermare un'azione e richiamare
l'attenzione. La locuzione «gola profonda» deriva da quella inglese Deep
Throat che indicava l'informatore segreto che con le sue rivelazioni alla stampa
diede origine allo scandalo Watergate.
Definizione. Il segnalatore di illeciti è quel soggetto che,
solitamente nel corso della propria attività lavorativa, scopre e denuncia fatti
che causano o possono in potenza causare danno all'ente pubblico o privato in
cui lavora o ai soggetti che con questo si relazionano (tra cui ad esempio
consumatori, clienti, azionisti). Spesso è solo grazie all'attività di chi
denuncia illeciti che risulta possibile prevenire pericoli, come quelli legati
alla salute o alle truffe, e informare così i potenziali soggetti a rischio
prima che si verifichi il danno effettivo. Un gesto che, se opportunamente
tutelato, è in grado di favorire una libera comunicazione all'interno
dell’organizzazione in cui il segnalatore di illeciti lavora e conseguentemente
una maggiore partecipazione al suo progresso e un'implementazione del sistema di
controllo interno. La maggior parte dei segnalatori di illeciti sono "interni" e
rivelano l'illecito a un proprio collega o a un superiore all'interno
dell'azienda o organizzazione. È interessante esaminare in quali circostanze
generalmente un segnalatore di illeciti decide di agire per porre fine a un
comportamento illegale. C'è ragione di credere che gli individui sono più
portati ad agire se appoggiati da un sistema che garantisce loro una
totale riservatezza.
La tutela giuridica nel mondo. La protezione riservata ai
segnalatori di illeciti varia da paese a paese e può dipendere dalle modalità e
dai canali utilizzati per le segnalazioni.
Italia. L'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha
disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana la figura
del whistleblower, con particolare riferimento al "dipendente pubblico che
segnala illeciti", al quale viene offerta una parziale forma di
tutela. Nell'introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell'articolo 2043 del codice civile italiano, il pubblico dipendente che
denuncia all'autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta,
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia. Inoltre, nell'ambito del procedimento
disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Si è tuttavia
precisato che, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, con conseguente
indebolimento della tutela dell'anonimato. L'eventuale adozione di misure
discriminatorie deve essere segnalata al Dipartimento della funzione
pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione
nella quale le discriminazioni stesse sono state poste in essere. Infine, si è
stabilito che la denuncia è sottratta all'accesso previsto dalla legge 7 agosto
1990, n. 241; tali disposizioni pongono inoltre delicate problematiche con
riferimento all'applicazione del codice in materia di protezione dei dati
personali. Nel 2014 ulteriori rafforzamenti della posizione del segnalatore di
illeciti sono stati discussi con iniziative parlamentari, nella XVII
legislatura. In ordine alla possibilità di incentivarne ulteriormente
l'emersione con premi, l'ordine del giorno G/1582/83/1 - proposto in commissione
referente del Senato - è stato accolto come raccomandazione; invece, è stato
dichiarato improponibile l'emendamento che, tra l'altro, puniva con una
contravvenzione chi ne rivelasse l'identità. Nel 2016 la Camera dei deputati,
nell'approvare la proposta di legge n. 3365-1751-3433-A, «ha scelto, tra
l'altro, la tecnica della "novella" del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165» per introdurre una disciplina di tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto
di lavoro. Il testo pende al Senato come disegno di legge n. 2208 Il decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 90 afferma che - a decorrere dal 4 luglio 2017,
data di entrata in vigore del predetto decreto - i soggetti destinatari della
disposizioni ivi contenute (tra i quali intermediari finanziari iscritti
all'Albo Unico, società di leasing, società di factoring, ma anche dottori
commercialisti, notai e avvocati) sono obbligati a dotarsi di un sistema di
segnalazione di illeciti, l'istituto di derivazione anglosassone per le
segnalazioni interne di violazioni.
Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti la prima legge in tema
fu il False Claims Act del 1863, che protegge i segnalatori di illeciti
da licenziamenti ingiusti, molestie e declassamento professionale, e li
incoraggia a denunciare le truffe assicurando loro una percentuale sul denaro
recuperato. Del 1912 è il Lloyd–La Follette Act, che garantisce agli impiegati
federali il diritto di fornire informazioni al Congresso degli Stati Uniti
d'America. Nel 1989 è stato approvato il Whistleblower Protection Act, una legge
federale che protegge gli impiegati del governo che denunciano illeciti,
proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti dalla divulgazione
dell'illecito.
Non si è colti, nè ignoranti: si è nozionisti, ossia:
superficiali.
Nozionista è chi studia o si informa, o, più spesso, chi
insegna o informa gli altri in modo nozionistico.
Nozionista è:
chi non approfondisce e rielabora criticamente la massa di
informazioni e notizie cercate o ricevute;
chi si ferma alla semplice lettura di un tweet da 280
caratteri su twitter o da un post su Facebook condiviso da pseudoamici;
chi restringe la sua lettura alla sola copertina di un libro;
chi ascolta le opinioni degli invitati nei talk show
radio-televisivi partigiani;
chi si limita a guardare il titolo di una notizia riportata su
un sito di un organo di informazione.
Quel mondo dell'informazione che si arroga il diritto
esclusivo ad informare in virtù di un'annotazione in un albo fascista.
Informazione ufficiale che si basa su news partigiane in ossequio alla linea
editoriale, screditando le altre fonti avverse accusandole di fake news.
Informazione o Cultura di Regime, foraggiata da Politica e
Finanza.
Opinion leaders che divulgano fake news ed omettono le
notizie. Ossia praticano: disinformazione, censura ed omertà.
Nozionista è chi si abbevera esclusivamente da mass media ed
opinion leaders e da questi viene influenzato e plasmato.
Censura da
Amazon libri. Del Coronavirus vietato scrivere.
"Salve, abbiamo rivisto le informazioni che ci hai fornito e
confermiamo la nostra precedente decisione di chiudere il tuo account e di
rimuovere tutti i tuoi libri dalla vendita su Amazon. Tieni presente che, come
previsto dai nostri Termini e condizioni, non ti è consentito di aprire nuovi
account e non riceverai futuri pagamenti royalty provenienti dagli account
aggiuntivi creati. Tieni presente che questa è la nostra decisione definitiva e
che non ti forniremo altre informazioni o suggeriremo ulteriori azioni
relativamente alla questione. Amazon.de".
Amazon chiude
l’account del saggista Antonio Giangrande, colpevole di aver rendicontato sul
Coronavirus in 10 parti.
La chiusura
dell’account comporta la cancellazione di oltre 200 opere riguardante ogni tema
ed ogni territorio d’Italia.
Opere
pubblicate in E-book ed in cartaceo.
La pretestuosa
motivazione della chiusura dell’account: “Non abbiamo ricevuto nessuna prova del
fatto che tu sia il titolare esclusivo dei diritti di copyright per il libro
seguente: Il Coglionavirus. Prima parte. Il Virus.”
A loro non è
bastato dichiarare di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e di tutti
i libri pubblicati sul mio account Amazon.
A loro non è
bastato dichiarare che sul mio account Amazon non sono pubblicate opere con Kdp
Select con diritto di esclusiva Amazon.
A loro non è
bastato dichiarare altresì di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio account Google, ove si potrebbero trovare le
medesime opere pubblicate su Amazon, ma solo in versione e-book.
A loro
interessava solo chiudere l’account per non parlare del Coronavirus.
A loro
interessava solo chiudere la bocca ad Antonio Giangrande.
Che tutto ciò
sia solo farina del loro sacco è difficile credere.
Il fatto è che
ci si rivolge ad Amazon nel momento in cui è impossibile trovare un editore che
sia disposto a pubblicare le tue opere.
Opere che,
comunque, sono apprezzate dai lettori.
Ergo: Amazon,
sembra scagliare la pietra, altri nascondono la mano.
Il Diritto di Citazione e la Censura dei
giornalisti. Il Commento di
Antonio Giangrande.
Sono Antonio Giangrande autore ed editore di
centinaia di libri. Su uno di questi “L’Italia dei Misteri” di centinaia di
pagine, veniva riportato, con citazione dell’autore e senza manipolazione e
commenti, l’articolo del giornalista Francesco Amicone, collaboratore de “Il
Giornale” e direttore di Tempi. Articolo di un paio di pagine che parlava del
Mostro di Firenze ed inserito in una più ampia discussione in contraddittorio.
L’Amicone, pur riconoscendo che non vi era plagio, criticava l’uso del copia
incolla dell’opera altrui. Per questo motivo ha chiesto ed ottenuto la
sospensione dell’account dello scrittore Antonio Giangrande su Amazon, su Lulu e
su Google libri. L’intero account con centinai di libri non interessati alla
vicenda. Google ed Amazon, dopo aver verificato la contronotifica hanno
ripristinato la pubblicazione dei libri, compreso il libro oggetto di
contestazione, del quale era stata l’opera citata e contestata. Lulu, invece,
ha confermato la sospensione.
L’autore ed editore Antonio Giangrande si
avvale del Diritto di Citazione. A norma dell'art. 70, comma 1 della Legge sul
diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per
uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."
Nei libri di Antonio Giangrande, per il
rispetto della pluralità delle fonti in contraddittorio per una corretta
discussione, non vi è plagio ma Diritto di Citazione.
Il Diritto di Citazione è il Diritto di
Cronaca di un’indagine complessa documentale e testimoniale senza manipolazione
e commenti con di citazione di opere altrui senza lesione della concorrenza con
congruo lasso di tempo e pubblicazione su canali alternativi e differenti agli
originali.
Il processo a Roberto Saviano per “Gomorra” fa
precedente e scuola: si condanna l’omessa citazione dell’autore e non il copia
incolla della sua opera.
Vedi Giorgio dell’Arti su “Cinquantamila.it”.
LA STORIA RACCONTATA DA GIORGIO DELL'ARTI. “Salve. Sono Giorgio Dell’Arti.
Questo sito è riservato agli abbonati della mia
newsletter, Anteprima. Anteprima è la spremuta di giornali che realizzo dal
lunedì al venerdì la mattina all’alba, leggendo i quotidiani appena arrivati in
edicola. La rassegna arriva via email agli utenti che si sono iscritti in
promozione oppure in abbonamento qui o sul sito anteprima.news”.
Oppure come fa Dagospia o altri siti di
informazione online, che si limitano a riportare quegli articoli che per motivi
commerciali o di esclusività non sono liberamente fruibili. Dagospia si
definisce "Risorsa informativa online a contenuto generalista che si occupa di
retroscena. È espressione di Roberto D'Agostino". Sebbene da alcuni sia
considerato un sito di gossip, nelle parole di D'Agostino: «Dagospia è un
bollettino d'informazione, punto e basta».
Addirittura il portale web “Newsstandhub.com”
riporta tutti gli articoli dei portali di informazione più famosi con citazione
della fonte, ma non degli autori. Si presenta come: “Il tuo centro edicola
personale dove poter consultare tutte le notizia contemporaneamente”.
Così come il sito web di Ristretti.org o di
Antimafiaduemila.com, o di pressreader.com.
Così come fanno alcuni giornali e giornalisti.
Non fanno inchieste o riportano notizie proprie. Ma la loro informazione si basa
anche su commento di articoli di terzi. Vedi “Il giornale” o “Libero Quotidiano”
o Il Corriere del Giorno o il Sussidiario, o twnews.it/it-news, ecc.
Comunque,
nonostante la sua opera sia stata rimossa, Francesco Amicone, mi continua a
minacciare: “Domani vaglierò se inviare una email a tutti gli editori
proprietari degli articoli che lei ha inserito - non si sa in base a quale nulla
osta da parte degli interessati - nei suoi numerosi libri. La invito - per il
suo bene - a rimuovere i libri dalla vendita e a chiedere a Google di non
indicizzarli, altrimenti è verosimile che gli editori le chiederanno di pagare.”
Non riesco a
capire tutto questo astio nei miei confronti. Una vera e propria
stolkerizzazione ed estorsione. Capisco che lui non voglia vedere il suo lavoro
richiamato su altre opere, nonostante si evidenzi la paternità, e si attivi a
danneggiarmi in modo illegittimo. Ma che si impegni assiduamente ad istigare gli
altri autori a fare lo stesso, va aldilà degli interessi personali. E’ una vera
è propria cattiva persecuzione, che costringerà Google ed Amazon ad impedire che
io prosegui la mia attività, e cosa più importante, impedisca centinaia di
migliaia di lettori ad attingere in modo gratuito su Google libri, ad
un’informazione completa ed alternativa.
E’ una vera è
propria cattiva persecuzione e della quale, sicuramente, ne dovrà rendere
conto.
La vicenda merita un approfondimento del tema
del Diritto di Citazione.
Il processo a Roberto Saviano per “Gomorra” fa
precedente e scuola.
Alcuni giornalisti contestavano a Saviano
l’uso di un copia incolla di alcuni articoli di giornale senza citare la fonte.
Da Wikipedia: Nel 2013 Saviano e la casa
editrice Mondadori sono stati condannati in appello per plagio. La Corte
d'Appello di Napoli ha riconosciuto che alcuni passaggi dell'opera Gomorra (lo
0.6% dell'intero libro) sono risultate un'illecita riproduzione del contenuto di
due articoli dei quotidiani locali Cronache di Napoli e Corriere di Caserta,
modificando così parzialmente la sentenza di primo grado, in cui il Tribunale
aveva rigettato le accuse dei due quotidiani e li aveva anzi condannati al
risarcimento dei danni per aver "abusivamente riprodotto" due articoli di
Saviano (condanna, questa, confermata in Appello). Lo scrittore e la Mondadori
in Appello sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni,
patrimoniali e non, per 60mila euro più parte delle spese legali. Lo scrittore
ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza e la Suprema Corte ha
confermato in parte l'impianto della sentenza d'Appello e ha invitato alla
riqualificazione del danno al ribasso, stimando 60000 euro una somma eccessiva
per articoli di giornale con diffusione limitatissima. La condanna per plagio
nei confronti di Saviano e della Mondadori è stata confermata nel 2016 dalla
Corte di Appello di Napoli, che ha ridimensionato il danno da risarcire da
60.000 a 6.000 euro per l'illecita riproduzione in Gomorra di due articoli di
Cronache di Napoli e per l'omessa citazione della fonte nel caso di un articolo
del Corriere di Caserta riportato tra virgolette.
Conclusione: si condanna l’omessa citazione
dell’autore e non il copia incolla della sua opera.
Cosa hanno in comune un giurista ed un
giornalista d’inchiesta; un sociologo e un segnalatore di illeciti
(whistleblower); un ricercatore o un insegnante e un aggregatore di contenuti?
Essi si avvalgono del Diritto di Citazione. A
norma dell'art. 70, comma 1 della Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la
citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione
al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei
limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o
di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali."
Cassazione penale, sez. V, sentenza 10/11/2016
n° 47506, dall'altra ha funzione di discussione: "Il riassunto, la citazione o
la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera".
Il Diritto di Citazione è il Diritto di
Cronaca di un’indagine complessa documentale e testimoniale senza manipolazione
e commenti con di citazione di opere altrui senza lesione della concorrenza con
congruo lasso di tempo e pubblicazione su canali alternativi e differenti agli
originali.
Il Diritto di Citazione si svolge su Stampa
non periodica. Che cosa significa "Stampa non periodica"?
Ogni forma di pubblicazione una tantum, cioè
che non viene stampata regolarmente (è tale, ad esempio, un saggio o un romanzo
in forma di libro).
Il diritto di cronaca su Stampa non periodica
diventa diritto di critica storica.
NB. In dottrina si evidenzia che “per uso di
critica” si deve intendere l’utilizzazione oggettivamente finalizzata ad
esprimere opinioni protette ex art. 21 e 33 della Costituzione. Con me la
cronaca diventa storia ed allora il mio diritto di cronaca diventa diritto di
critica storica. La critica storica può scriminare la diffamazione. Cassazione
penale, sez. V, sentenza 10/11/2016 n° 47506. L'esercizio del diritto di critica
può, a certe condizioni, rendere non punibile dichiarazioni astrattamente
diffamatorie, in quanto lesive dell'altrui reputazione. Resoconto esercitato nel
pieno diritto di Critica Storica. La critica storica può scriminare la
diffamazione. Cassazione penale, sez. V, sentenza 10/11/2016 n° 47506. La
ricerca dello storico, quindi, comporta la necessità di un’indagine complessa in
cui “persone, fatti, avvenimenti, dichiarazioni e rapporti sociali divengono
oggetto di un esame articolato che conduce alla definitiva formulazione di tesi
e/o di ipotesi che è impossibile documentare oggettivamente ma che, in ogni caso
debbono trovare la loro base in fonti certe e di essere plausibili e
sostenibili”. La critica storica, se da una parte può scriminare la
diffamazione. Cassazione penale, sez. V, sentenza 10/11/2016 n° 47506,
dall'altra ha funzione di discussione: "Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera".
L’art. 21 della Costituzione permette di
esprimere liberamente il proprio pensiero. Nell’art. 65 della legge l. n.
633/1941 il legislatore sancisce la libertà di utilizzazione, riproduzione o
ripubblicazione e comunicazione al pubblico degli articoli di attualità, che
possiamo considerare come sinonimo di cronaca, in altre riviste o giornali.
Distinta dalla mera cronaca è l’inchiesta giornalistica, la quale parte da fatti
di cronaca per svolgere un’attività di indagine, c.d. “indagine giornalistica”,
con la quale il professionista si informa, chiede chiarimenti e spiegazioni.
Questa attività rientra nel c.d. “giornalismo investigativo” o “d’inchiesta”,
riconosciuto dalla Cassazione nel 2010 come “la più alta e nobile espressione
dell’attività giornalistica”, perché consente di portare alla luce aspetti e
circostanze ignote ai più e di svelare retroscena occultati, che al contempo
sono di rilevanza sociale. A seguito dell’attività d’indagine, il giornalista
svolge poi l’attività di studio del materiale raccolto, di verifica
dell’attendibilità di fonti non generalmente attendibili, diverse dalle agenzie
di stampa, di confronto delle fonti. Solo al termine della selezione del
materiale conseguito, il giornalista inizia a scrivere il suo articolo. (Cass.,
9 luglio 2010, n. 16236, in Danno e resp., 2010, 11, p. 1075. In questa sentenza
la Corte Suprema precisa che “Con tale tipologia di giornalismo (d’inchiesta),
infatti, maggiormente, si realizza il fine di detta attività quale prestazione
di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di
notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso
gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza
di tematiche notevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”).
A norma dell'art. 70, comma 1 della Legge sul
diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per
uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché
non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."
La normativa italiana utilizza l'espressione
segnalatore o segnalante d'illeciti a partire dalla cosiddetta "legge anti
corruzione" (6 novembre 2012 n. 190). Italia. L'art. 1, comma 51 della legge 6
novembre 2012, n. 190 ha disciplinato per la prima volta nella legislazione
italiana la figura del whistleblower, con particolare riferimento al "dipendente
pubblico che segnala illeciti", al quale viene offerta una parziale forma di
tutela. Negli Stati Uniti la prima legge in tema fu il False Claims
Act del 1863, che protegge i segnalatori di illeciti da licenziamenti ingiusti,
molestie e declassamento professionale, e li incoraggia a denunciare le truffe
assicurando loro una percentuale sul denaro recuperato. Del 1912 è il Lloyd–La
Follette Act, che garantisce agli impiegati federali il diritto di fornire
informazioni al Congresso degli Stati Uniti d'America. Nel 1989 è stato
approvato il Whistleblower Protection Act, una legge federale che protegge gli
impiegati del governo che denunciano illeciti, proteggendoli da eventuali azioni
di ritorsione derivanti dalla divulgazione dell'illecito.
Quando si parla di aggregatore di
contenuti non mi riferisco a colui che, per profitto, riproduce tout court
integralmente, o quasi, un post o un articolo. Costoro non sono che volgari
“produttori” di plagio, pur citando la fonte. Ci sono Aggregatori di contenuti
in Italia, che esercitano la loro attività in modo lecita, e comunque,
verosimilmente, non contestata dagli autori aggregati e citati.
Vedi Giorgio dell’Arti su “Cinquantamila.it”.
LA STORIA RACCONTATA DA GIORGIO DELL'ARTI. “Salve. Sono Giorgio Dell’Arti.
Questo sito è riservato agli abbonati della mia
newsletter, Anteprima. Anteprima è la spremuta di giornali che realizzo dal
lunedì al venerdì la mattina all’alba, leggendo i quotidiani appena arrivati in
edicola. La rassegna arriva via email agli utenti che si sono iscritti in
promozione oppure in abbonamento qui o sul sito anteprima.news”.
Oppure come fa Dagospia o altri siti di
informazione online, che si limitano a riportare quegli articoli che per motivi
commerciali o di esclusività non sono liberamente fruibili. Dagospia si
definisce "Risorsa informativa online a contenuto generalista che si occupa di
retroscena. È espressione di Roberto D'Agostino". Sebbene da alcuni sia
considerato un sito di gossip, nelle parole di D'Agostino: «Dagospia è un
bollettino d'informazione, punto e basta».
Addirittura il portale web “Newsstandhub.com”
riporta tutti gli articoli dei portali di informazione più famosi con citazione
della fonte, ma non degli autori. Si presenta come: “Il tuo centro edicola
personale dove poter consultare tutte le notizia contemporaneamente”.
Così come il sito web di Ristretti.org o di
Antimafiaduemila.com, o di pressreader.com.
Così come fanno alcuni giornali e giornalisti.
Non fanno inchieste o riportano notizie proprie. Ma la loro informazione si basa
anche su commento di articoli di terzi. Vedi “Il giornale” o “Libero Quotidiano”
o Il Corriere del Giorno o il Sussidiario, o twnews.it/it-news, ecc.
Diritto di citazione. Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera. Il diritto di citazione (o diritto di corta citazione) è
una forma di libera utilizzazione di opere dell'ingegno tutelate da diritto
d'autore. Infatti, sebbene l'autore detenga i diritti d'autore sulle proprie
creazioni, in un certo numero di circostanze non può opporsi alla pubblicazione
di estratti, riassunti, citazioni, proprio per non ledere l'altrui diritto di
citarla. Il diritto di citazione assume connotazioni diverse a seconda delle
legislazioni nazionali.
La Convenzione di Berna. L'articolo 10 della Convenzione di
Berna, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza degli ordinamenti
internazionali, prevede il diritto di citazione con le seguenti regole: Articolo
10
1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi
dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per
quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o
artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni,
emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale
utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea
precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.
Le singole discipline.
Stati Uniti. Negli Stati Uniti è il titolo 17 dello United States
Code che regola la proprietà intellettuale. Il fair use, istituto di più largo
campo applicativo, norma generalmente anche ciò che nei paesi continentali
europei è chiamato diritto di citazione.
Italia. L'art. 70, Legge 22 aprile 1941 n. 633 (recante norme
sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) dispone che «Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o
di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati
per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e
purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.». Con il
decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 è stata introdotta l'espressione di
comunicazione al pubblico, per cui il diritto è esercitabile su ogni mezzo di
comunicazione di massa, incluso il web. Con la nuova formulazione c'è una più
netta distinzione tra le ipotesi in cui “il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera" viene effettuata per uso di critica o
di discussione e quando avviene per finalità didattiche o scientifiche: se
effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve
inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
L'orientamento giurisprudenziale formatosi in Italia sul vecchio testo dell'art.
70 è stato in genere di restringerne la portata. In seguito a successive
modifiche legislative, è stata fornita tuttavia una diversa interpretazione
della normativa attualmente vigente, in particolare con la risposta ad
un'interrogazione parlamentare nella quale il senatore Mauro Bulgarelli chiedeva
al Governo di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto
del fair use. Il governo ha risposto che non è necessario intervenire
legislativamente in quanto già adesso l'articolo 70 della Legge sul diritto
d'autore va interpretato alla stregua del fair use statunitense. A parere del
Governo il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, ha reso l'articolo 70
della legge sul diritto d'autore sostanzialmente equivalente a quanto previsto
dalla sezione 107 del copyright act degli Stati Uniti. Sempre secondo il
Governo, sono quindi già applicabili i quattro elementi che caratterizzano
il fair use:
finalità e caratteristiche dell'uso (natura non commerciale,
finalità educative senza fini di lucro);
natura dell'opera tutelata;
ampiezza ed importanza della parte utilizzata in rapporto
all'intera opera tutelata;
effetto anche potenzialmente concorrenziale dell'utilizzazione.
Sempre a parere del governo, la normativa italiana in materia del
diritto d'autore risulta già conforme non solo a quella degli altri paesi
dell'Europa continentale ma anche a quello dei Paesi nei quali vige il copyright
anglosassone.
A rafforzare il diritto di corta citazione è nuovamente
intervenuto il legislatore, che all'articolo 70 della legge sul diritto d'autore
ha aggiunto il controverso comma 1-bis, secondo il quale «è consentita la libera
pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e
musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo
nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro [...]». La norma,
tuttavia, non ha ancora ricevuto attuazione, non essendo stato emanato il
previsto decreto ministeriale. Altre restrizioni alla riproduzione libera vigono
nella giurisprudenza italiana, come, per esempio, quelle proprie all'assenza
di libertà di panorama.
Francia. In Francia la materia è regolata dal Code de la
propriété intellectuelle.
Unione europea. L'Unione europea ha emanato
la direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001 che i singoli Paesi hanno applicato
alla propria legislazione. Il parlamento europeo nell'approvare la
direttiva Ipred2, in tema di armonizzazione delle norme penali in tema di
diritto d'autore, ha approvato anche l'emendamento 16, secondo il quale gli
Stati membri provvedono a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la
riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini
di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di
copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, non sia qualificato
come reato. Nel vincolare gli stati membri ad escludere la responsabilità
penale, l'emendamento si accompagnava alla seguente motivazione: la libertà di
stampa deve essere protetta da misure penali. Professionisti quali i
giornalisti, gli scienziati e gli insegnanti non sono criminali, così come i
giornali, gli istituti di ricerca e le scuole non sono organizzazioni criminali.
Questa misura non pregiudica tuttavia la protezione dei diritti, in quanto è
possibile il risarcimento per danni civili.
Citazioni di opere letterarie. La regolamentazione giuridica
delle opere letterarie ha una lunga tradizione. La citazione deve essere breve,
sia in rapporto all'opera da cui è estratta, sia in rapporto al nuovo documento
in cui si inserisce. È necessario citare il nome dell'autore, il suo copyright e
il nome dell'opera da cui è estratta, per rispettare i diritti morali
dell'autore. In caso di citazione di un'opera tradotta occorre menzionare anche
il traduttore. Nel caso di citazione da un libro, oltre al titolo, occorre anche
menzionare l'editore e la data di pubblicazione. La citazione non deve far
concorrenza all'opera originale e deve essere integrata in seno ad un'opera
strutturata avendo una finalità. La citazione inoltre deve spingere il lettore a
rapportarsi con l'opera originale. Il carattere breve della citazione è lasciato
all'interprete (giudice) ed è perciò fonte di discussione. Nell'esperienza
francese, quando si sono posti limiti quantitativi, sono stati proposti come
criterio i 1.500 caratteri. Le antologie non sono giuridicamente collezioni di
citazioni ma delle opere derivate che hanno un loro particolare regime di
autorizzazione, regolato in Italia dal secondo comma dell'articolo 70. Le misure
della lunghezza dei brani sono fissati dall'art 22 del regolamento e l'equo
compenso è fissato secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma di detto
articolo.
Citare, non copiare! Attenzione ai testi altrui.
Scrive il 2 Giugno 2016 Chiara Beretta Mazzotta. Citare è sempre possibile,
abbiamo facoltà di discutere i contenuti (libri, articoli, post…) e di
utilizzare parte dei testi altrui, ma quando lo facciamo non dobbiamo violare i
diritti d’autore. Citare o non citare? Basta farlo nel modo corretto! Si
chiama diritto di citazione e permette a ciascuno di noi di utilizzare e
divulgare contenuti altrui senza il bisogno di chiedere il permesso all’autore o
a chi ne detiene i diritti di commercializzazione. Dobbiamo però rispettare le
regole. Ogni testo – articoli, libri e anche i testi dal carattere non
specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) come le
mail… – beneficia di tutela giuridica. La corrispondenza, per esempio, è
sottoposta al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione
previsto dagli articoli 616 e 618 del codice penale. Le opere creative sono
tutelate dalla normativa del diritto d’autore e non possono essere copiate o
riprodotte (anche in altri formati o su supporti diversi), né è possibile
appropriarsi della loro paternità. Possono, però, essere “citate”.
È consentito il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti d’opera, per scopi di critica…L’art. 70, Legge 22 aprile 1941
n. 633 (recante norme sulla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio) dispone che «il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti d’opera, per scopi di critica, di discussione
ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e
purché non costituiscono concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera».
Vale a dire che – a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento
– la legge (art. 70 l. 633/41) consente il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o parti di opere letterarie. Lo scopo deve essere
divulgativo (e non di lucro o meglio: il testo citato non deve fare concorrenza
all’utilizzazione economica dell’opera stessa).
Dovete dichiarare la fonte: il nome dell’autore, l’editore, il
giornale, il traduttore, la data di pubblicazione. Per rispettare il diritto di
citazione dovete dichiarare la fonte: il nome dell’autore, l’editore, il
giornale, il traduttore, la data di pubblicazione. Quindi, se per esempio state
facendo la recensione di un testo, il diritto di citazione vi consente di
“copiare” una piccola parte di esso (il diritto francese prevede per esempio
1500 caratteri; in assoluto ricordate che la brevità della citazione vi tutela
da eventuali noie) purché diciate chi lo ha scritto, chi lo ha pubblicato, chi
lo ha tradotto e quando. Nessun limite di legge sussiste, invece, per la
riproduzione di testi di autori morti da oltre settant’anni (questo in Italia e
in Europa; in Messico i diritti scadono dopo 100 anni, in Colombia dopo 80 anni
e in Guatemala e Samoa dopo 75 anni, in Canada dopo 50; in America si parla di
95 anni dalla data della prima pubblicazione). Se volete citare un articolo,
avete il diritto di riassumere il suo contenuto e mettere tra virgolette qualche
stralcio purché indichiate il link esatto (non basta il link alla home della
testata, per dire). Va da sé che no, non potete copia-incollare un intero pezzo
mettendo un semplice collegamento ipertestuale! Questo lo potete fare solo se
siete stati autorizzati. Tantomeno potete tradurre un articolo uscito sulla
stampa estera o su siti stranieri. Per pubblicare un testo tradotto dovete
infatti essere stati autorizzati. Quindi, se incappate in rete in un post di
vostro interesse che non vi venga in mente di copiarlo integralmente indicando
solo un link. Aggregare le notizie, copiandole totalmente, anche indicando la
fonte, non è legale: è necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto. E
poi, oltre a non rispettare le leggi del diritto d’autore, fate uno sgarbo ai
motori di ricerca che penalizzano i contenuti duplicati.
Prestate cura anche ai tweet, agli status e a tutto ciò che
condividete in rete. E se scoprite un plagio in rete? Dal 2014 non c’è più
bisogno di ricorrere alla magistratura. Cioè non c’è più bisogno di un processo,
né di una denuncia alle autorità (leggi qui). C’è infatti una nuova procedura
“accelerata”, introdotta con il recente regolamento Agcom, e potete avviare la
pratica direttamente in rete facendo una segnalazione e compilando un modulo
(per maggior informazioni su come denunciare una violazione leggi la guida:
“Come denunciare all’Acgom un sito per violazione del diritto d’autore”).
Volete scoprire se qualcuno rubacchia i vostri contenuti? Basta
utilizzare uno tra i tanti motori di ricerca atti allo scopo. Per
esempio Plagium. È sufficiente copiare e incollare il testo e analizzare le
corrispondenze in rete. Spesso, ahimè, ne saltano fuori delle belle… Mi
raccomando, prestate cura anche ai tweet, agli status e a tutto ciò che
condividete in rete. Quando fate una citazione – che si tratti di una grande
poetessa o dell’ultimo cantante pop – usate le virgolette e mettete il nome
dell’autore e del traduttore. È una questione di rispetto oltre che legale. E se
volete essere presi sul serio, fate le cose per bene.
LO SPAURACCHIO DELLA CITAZIONE DI OPERA ALTRUI.
Avvocato Marina Lenti Marina Lenti su diritto d'autore. A volte mi capita di
rispondere a dei quesiti postati su Linkedin e siccome quello che segue ricorre
spesso, colgo l’occasione per trattarlo,in maniera molto elementare (niente
legalese! ), anche in questa sede. Si tratta di una delle maggiori
preoccupazioni di chi scrive: la citazione. Può trattarsi della citazione di una
dichiarazione rilasciata da qualcuno, oppure la citazione di un titolo di un
libro o di un film, o similia. Spesso gli autori sono paralizzati perché pensano
che ogni volta sia necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti connessi
alla dichiarazione o all’opera citata. Ovviamente non è così perché, in tal caso
si arriverebbe alla paralisi totale e tutta una serie di generi morirebbe:
manualistica, saggistica, biografie… Bisogna ricordare sempre che il diritto
d’autore, oltre a proteggere la proprietà intellettuale, deve contemperare anche
l’esigenza collettiva di poter usare materiale altrui, a certe condizioni, in
modo da creare materiale nuovo, anche sulla base di quello vecchio, che
arricchisca ulteriormente la collettività. E’ per questo che si ricorre al
concetto di fair use, che nella nostra Legge sul Diritto d’Autore si ritrova al
primo comma dell’art. 70: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica
dell’opera”.
In aggiunta, il concetto è più chiaramente formulato
nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche, cui l’Italia aderisce, all’art. 10 comma 1: “Sono lecite le
citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico,
nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di
rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente
ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo”.
Dunque, non c’è bisogno di autorizzazioni se, per esempio, se in
un dialogo, un personaggio riferisce all’altro di aver letto il libro X, o aver
visto il film Y, o aver letto l’intervista rilasciata dal personaggio famoso Z.
Diverso sarebbe, ovviamente, se ci si appropriasse del personaggio X dell’altrui
opera Y per farlo agire nella propria (e se state pensando alle fan fiction,
ebbene sì, a stretto rigore le fan fiction sono illegali, solo che alcuni
autori, come J.K. Rowling, le tollerano finché restano sul web e sono messe a
disposizione gratuitamente; altri, come Anne Rice, le combattono invece in tutti
i modi). Lo stesso vale se si riporta la dichiarazione di un’intervista, oppure
un brano di un’altrui opera. In questo caso basterà citare in nota la fonte:
nome dell’autore, titolo dell’intervista/opera, data, numeri di riferimento (a
seconda della pubblicazione), editore, anno. Oltretutto, riportare la fonte dà
maggiore autorevolezza alla vostra opera perché dimostra che le citazioni
riportate non sono "campate in aria". Ovviamente la citazione deve constare di
qualche frase, non di mezza intervista o mezzo libro, altrimenti va da sé l’uso
non sarebbe più "fair", cioè "corretto".
Bisogna tuttavia fare attenzione al contenuto di ciò che si cita,
per non rischiare di incorrere in altri possibili problemi legali diversi dalle
violazioni del diritto d’autore: se, ad esempio, si cita una dichiarazione di
terzi che accusa la persona X di essere colpevole di un reato e questa
dichiarazione è priva di fondamento (perché, ad esempio, non c’è stata una
sentenza di condanna), ovviamente potrà essere ritenuto responsabile della
diffamazione alla stregua della fonte usata.
Il concetto di fair use, a differenza che in Italia, è stato
oggetto di elaborazione giurisprudenziale molto sofisticata in Paesi come
l’America. Magari in un prossimo post esamineremo i quattro parametri di
riferimento elaborati dai giudici statunitensi per discernere se, in un dato
caso, si verta effettivamente in tema di fair use. Tuttavia, nonostante questa
lunga elaborazione, va tenuto presente che si tratta sempre di un terreno molto
scivoloso, che ha volte ha dato luogo pronunciamenti contraddittori.
La riproduzione e citazione di articoli giornalistici.
Di Alessandro Monteleone.
La normativa.
La materia trova disciplina nei seguenti testi di legge: art. 10,
comma 1, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche (ratificata ed eseguita con la L. 20 giugno 1978, n. 399); artt. 65 e
70, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche “Legge sul Diritto
d’Autore”).
L’opera giornalistica.
Come noto, l’opera giornalistica che abbia il requisito
della creatività è tutelata dall’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore. Il
quotidiano (ovvero il periodico) è considerato pacificamente opera “collettiva”,
in merito alla quale valgono le seguenti considerazioni. In base al combinato
disposto degli artt. 7 e 38, Legge sul Diritto d’Autore l’editore deve essere
considerato l’autore dell’opera. L’editore – salvo patto contrario – ha il
diritto di utilizzazione economica dell’opera prodotta “in considerazione del
fatto che […] è il soggetto che assume su di sé il rischio della pubblicazione e
della messa in commercio dell’opera provvedendovi per suo conto ed a sue spese”.
L’editore è titolare “dei diritti di cui all’art. 12 l.d.a. (prima pubblicazione
dell’opera e sfruttamento economico della stessa). E ciò senza alcun bisogno di
accertare […] un diverso modo ovvero una distinta fonte di acquisto del diritto
sull’opera componente, rispetto a quello sull’opera collettiva”, inoltre “il
diritto dell’editore si estende a tutta l’opera, ma includendone le parti”.
Disciplina normativa in materia di citazione e riproduzione di
articoli giornalistici.
Con riferimento alla possibilità di riprodurre articoli
giornalistici in altre opere si osserva quanto segue:
La Convenzione di Berna contiene una clausola generale che
disciplina la fattispecie della citazione di un’opera già resa accessibile al
pubblico. In particolare, in base all’art. 10 della Convenzione di Berna, la
libertà di citazione incontra quattro limiti specifici:
1) l’opera deve essere stata resa lecitamente accessibile al
pubblico;
2) la citazione deve avere carattere di mero esempio a supporto
di una tesi e non deve avere come scopo l’illustrazione dell’opera citata;
3) la citazione non deve presentare dimensioni tali da consentire
di supplire all’acquisto dell’opera;
4) la citazione non deve pregiudicare la normale utilizzazione
economica dell’opera e arrecare un danno ingiustificato agli interessi legittimi
dell’autore. Per essere lecite, altresì, le citazioni devono essere contenute
nella misura richiesta dallo scopo che le giustifica e devono essere corredate
dalla menzione della fonte e del nome dell’autore.
Art. 10, Convenzione di Berna: “1)Sono lecite le citazioni tratte
da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di
articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a
condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella
misura giustificata dallo scopo. 2) Restano fermi gli effetti della legislazione
dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o
stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere
letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante
pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché
una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura
giustificata dallo scopo. 3) Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli
alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome
dell'autore”.
Con riferimento alla normativa nazionale l’art. 65, Legge sul
Diritto d’Autore recita testualmente: “Gli articoli di attualità di carattere
economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico
in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la
fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato […]”.
L’articolo appena citato è considerato in dottrina una norma
eccezionale non suscettibile di applicazione analogica con riguardo al carattere
degli articoli, pertanto, l’elencazione sopra proposta ha natura tassativa. (R.
Valenti, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza).
Si deve comunque evidenziare che una parte della dottrina (R. Valenti, nota a
Trib. Milano, 13 luglio 2000, in Aida, 2001, 772, 471) ritiene che una corretta
interpretazione dell’art. 65, Legge sul Diritto d’Autore porti a ritenere lecita
solo la riproduzione di articoli di attualità a carattere politico, economico e
religioso (con esclusione pertanto degli articoli di cronaca od a contenuto
culturale, artistico, satirico, storico, geografico o scientifico) che avvenga
in altri giornali e riviste, ossia in veicoli di informazione diretti ad un
pubblico generalizzato e non a singole categorie di utenti – clienti
predefinite.
Ulteriore disciplina è dettata nell’art. 70, Legge sul Diritto
d’Autore che fa salva la libera riproduzione degli articoli giornalistici, a
prescindere dall’argomento trattato, purché sussista una finalità di critica,
discussione od insegnamento. Questa norma dà prevalenza alla libera
utilizzazione dell’informazione, proteggendo la forma espressiva e lasciando
libera la fruibilità dei concetti. Art. 70 LdA: “1. Il riassunto, la citazione o
la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi se effettuati per uso di critica odi discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o
di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. E' consentita la libera
pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e
musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo
nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o
scientifico di cui al presente comma 2. Nelle antologie ad uso scolastico la
riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale
fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la
citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di
traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta”.
In dottrina si evidenzia che “per uso di critica” si deve
intendere l’utilizzazione oggettivamente finalizzata ad esprimere opinioni
protette ex art. 21 e 33 della Costituzione e non, invece, l’utilizzazione
funzionale allo svolgimento di attività economiche ex art. 41 Cost. (R. Valenti,
cit.). Secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie anche questa norma
ha carattere eccezionale e si deve interpretare restrittivamente. (Da ultime
Cass. 2089/1997 e 11143/1996. L’art. 70, Legge sul Diritto d’Autore richiede
inoltre che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di
opera e la loro comunicazione al pubblico”, perché siano leciti, “non
costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera [citata]”. Tale
requisito postula che l’utilizzazione dell’opera non danneggi in modo
sostanziale uno dei mercati riservati in esclusiva all’autore/titolare dei
diritti: non deve pertanto influenzare l’ammontare dei profitti di tipo
monopolistico realizzabili dall’autore/titolare dei diritti. Secondo VALENTI, in
particolare, il carattere commerciale dell’utilizzazione e, soprattutto,
l’impatto che l’utilizzazione può avere sul mercato – attuale o potenziale –
dell’opera protetta sono elementi determinanti nel verificare se l’utilizzazione
possa considerarsi libera o non concreti invece violazione del diritto d’autore.
Infine, il terzo comma dell’art. 70, Legge sul Diritto d’Autore richiede che “il
riassunto, la citazione o la riproduzione” siano “sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se
si tratti di traduzione, del traduttore qualora tali indicazioni figurino
sull'opera riprodotta”.
In considerazione di ciò, la mancata menzione degli elementi
succitati determina una violazione del diritto di paternità dell’opera
dell’autore, risarcibile in quanto abbia determinato un danno patrimoniale al
titolare del diritto.
Conclusioni. La lettura combinata
degli artt. 65 e 70, Legge sul Diritto d’Autore porta a ritenere che, per citare
o riprodurre lecitamente un articolo giornalistico in un’altra opera, debbano
ricorrere i seguenti presupposti:
1) art. 65, LdA (limite contenutistico): nel caso di riproduzione
di articoli di attualità che abbiano carattere economico, politico o
religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, tale riproduzione può
avvenire liberamente purchè non sia stata espressamente riservata e vi sia
l’indicazione della fonte da cui sono tratti, della data e del nome dell’autore,
se riportato;
2) art. 70, LdA (limite teleologico e dell’utilizzazione
economica): la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di
critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti
giustificati da tali fini e purchè non costituiscano concorrenza
all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta. In relazione ai
singoli articoli, quindi, l’editore potrà far valere l’inapplicabilità dell’art.
65 LdA tutte le volte in cui “il titolare dei diritti di sfruttamento –
dell’articolo riprodotto – se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la
utilizzazione” apponendovi un’espressa dichiarazione di riserva.
IL DIRITTO D’AUTORE TRA IL DIRITTO DI CRONACA E LA CREAZIONE
LETTERARIA.
Diritto d'autore e interesse generale. Contemperare l’esigenza
collettiva di poter usare materiale altrui in modo da creare materiale nuovo,
anche sulla base di quello vecchio, che arricchisca ulteriormente la
collettività. Opera letteraria - giornalistica, fonte di informazione e di
cronaca. Diritti costituzionalmente garantiti, senza limitazione dall'art 21
della Costituzione italiana: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.»
Questa libertà è riconosciuta da tutte le
moderne costituzioni.
Ad questa libertà è inoltre dedicato l'articolo
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: Art. 19: Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
La libertà di espressione è sancita anche dall'art. 10
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale
diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Tesi di Laurea di Rosalba Ranieri. Pubblicato da Studio Torta
specializzato in proprietà intellettuale.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA. TESI DI LAUREA IN
DIRITTO COMMERCIALE. IL DIRITTO D’AUTORE TRA IL DIRITTO DI CRONACA E LA
CREAZIONE LETTERARIA: IL CASO “GOMORRA” RELATORE: Ch.issima Prof. Emma Sabatelli
LAUREANDA Rosalba Ranieri.
La maggior parte delle persone comuni, non giuristi, quando
pensano al diritto d’autore hanno un’idea precisa: basandosi sui fatti di
cronaca, ritengono che il diritto d’autore tuteli quel cantante o autore famosi
ai quali è stata rubata o copiata l’idea della propria canzone o del proprio
libro. Tuttavia questa è una visione alquanto semplicistica.
Sfogliando qualsiasi manuale di diritto industriale o
un’enciclopedia giuridica veniamo a sapere che: “il diritto d’autore è quel
complesso di norme che tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo
riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative,
l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e, da ultimo, i
programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma
di espressione, attraverso il riconoscimento all’autore dell’opera di una serie
di diritti, sia di carattere morale che patrimoniale”. Dunque, del diritto
d’autore non dobbiamo avere una visione riduttiva, come la si aveva in passato,
in quanto il diritto d’autore ha un campo d’azione molto più ampio di quanto si
possa ad un primo approccio immaginare. Si può ben pensare che in passato, a
fronte delle rudimentali scoperte e conoscenze nei diversi settori in cui oggi
opera, il diritto d’autore tutelava parzialmente l’autore, poiché solo gli
scrittori di opere letterarie potevano esser lesi nel diritto esclusivo di usare
economicamente la propria opera con la riproduzione non autorizzata della stessa
a mezzo della stampa.
É dunque l’invenzione della stampa che fa sorgere l’esigenza di
un diritto d’autore, che nasce prima in Inghilterra con il “Copyright Act”, la
legge sul copyright (il diritto alla copia) della regina Anna del 1709; poi
negli Stati Uniti, ispirati dalla legge inglese, con la legge federale del 1790
e poi in Francia con le leggi post-rivoluzionarie del 1791-1793, nelle quali si
riconoscono per la prima volta i diritti morali dell’autore. Solo
successivamente gli altri Stati europei, come l’Italia, adotteranno una legge a
tutela del diritto d’autore. Tuttavia, prima di queste leggi, il diritto
d’autore inizia a formarsi già nel mondo antico. Infatti nell’Antica Grecia non
c’erano specifiche disposizioni legislative, perciò le opere letterarie erano
liberamente riproducibili, ma veniva condannata l’appropriazione indebita della
paternità. A Roma, invece, si distingueva il diritto di proprietà immateriale
dell’autore (corpus mysticum), creatore ed inventore dell’opera, dal diritto di
possesso materiale del bene del libraio e dell’editore (corpus mechanicum),
essendo questi ultimi che possedevano materialmente i supporti contenenti le
opere. Perciò, il diritto romano riconosceva i diritti patrimoniali soltanto ai
librai e agli editori, perché una volta che l’opera fosse stata pubblicata
(mediante una lettura in pubblico e la diffusione di manoscritti) i diritti
venivano traslati sulla cosa materiale, invece agli autori riconosceva altri
diritti quali: il diritto di non pubblicare l’opera, il diritto di mantenere
l’opera inedita ed altri diritti inerenti la paternità. Con la caduta
dell’Impero Romano, la cultura si rifugia presso i monasteri; infatti i monaci
amanuensi, avendo a disposizione numerosi volumi, iniziarono a ricopiarne
manualmente il contenuto presso vaste sale illuminate: le scriptoria. Poco tempo
dopo nacquero le prime Università (a Bologna, Pisa, Parigi…) e di conseguenza la
cultura non fu più di esclusivo appannaggio dei religiosi, ma anche dei laici.
Molti uomini ricchi del Quattrocento si interessarono alla lettura soprattutto
di testi religiosi, giuridici, scientifici, ma anche di romanzi. La diffusione
della cultura e l’aumento della domanda di copie di testi letterari portò ad un
mercato del libro, che permetteva ottime possibilità di guadagno, allorché fu
inventata la tecnica, che avrebbe consentito la riproduzione dell’opera in
maniera più rapida, più economica, e meno faticosa su centinaia o migliaia di
copie. Nel 1455 nacque la stampa a caratteri mobili ad opera del tedesco
Johannes Gutenberg e con essa nasce l’interesse di tutelare i testi e gli autori
che li producevano. È con l’avvento della stampa che l’autore è riconosciuto
come titolare di privilegi di stampa, che in passato erano concessi solo agli
editori. Questo sistema resse fino al XVIII sec., fino alla produzione di leggi
più organiche sul diritto d’autore. Dunque, si può affermare che il diritto
d’autore in senso moderno nasce con l’invenzione della stampa e dalla necessità
di dare tutela alle sole opere letterarie ed artistiche che possono essere
prodotte a mezzo della stampa. Successivamente, esso fu esteso anche ad altre
tipologie di opere, che possono essere prodotte con mezzi diversi dalla stampa.
Il diritto d’autore si sviluppa al progredire della scienza e della tecnologia e
questo ha reso ancora più ampio il margine del suo utilizzo; difatti, il diritto
d’autore è oggi “un istituto destinato a proteggere opere eterogenee (opere
letterarie, artistiche, musicali, banche dati, software e design)”, dunque anche
opere digitali e multimediali, create con programmi di computer. Da qui emerge
la difficoltà di delineare una nozione di opera dell’ingegno, tutelata dal
diritto d’autore.
Inoltre, il diritto d’autore riconosce una pluralità di diritti
(Si tratta del diritto esclusivo di riproduzione dell’opera e del diritto
esclusivo degli autori di comunicare l’opera al pubblico “qualunque ne sia il
modo o la forma” (con la rappresentazione, l’esecuzione e la diffusione a
distanza)) e facoltà agli autori e diverse tecniche di protezione tanto da
rendere difficile anche definirne unitariamente il contenuto. Tuttavia, è
possibile ravvisare dei caratteri e dei requisiti comuni alle opere eterogenee,
facendole rientrare nelle norme che tutelano il diritto d’autore, così come è
possibile ravvisare degli interessi ben precisi che la legge del diritto
d’autore tutela, come: l’interesse collettivo a favorire ed incentivare la
produzione di opere dell’ingegno attraverso la libera circolazione delle idee e
delle informazioni e l’interesse individuale, propriamente dell’autore, a godere
del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera per conseguire un
profitto dall’utilizzazione di essa e a godere dei diritti morali, mediante i
quali si tutela la personalità dell’autore.
LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI La capacità
dell’opera creativa di suscitare interesse non solo in delimitati ambiti
territoriali ha fatto sì che non si potesse prevedere una tutela limitata nello
spazio, bensì una tutela universale (L’interesse di conoscere o avere tra le
mani un’opera d’ingegno non si limita ai soli cittadini del territorio in cui
l’autore abbia inventato la sua creazione), che permettesse la diffusione e
l’utilizzo economico dell’opera anche al di là dei confini di uno Stato. Per
queste ragioni sono state elaborate Convenzioni internazionali multilaterali in
materia di diritto d’autore e dei diritti connessi, le quali hanno portato uno
stravolgimento della previgente disciplina (Fino al 1993, anno in cui entrò in
vigore il Trattato CE, oggi Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
vigeva il principio di territorialità, in base al quale il nostro ordinamento
rinviava alla legge dello Stato nel quale l’opera era utilizzata o era destinata
ad essere utilizzata. In tal modo, il diritto italiano accordava protezione
soltanto alle opere dei cittadini italiani o alle opere di autori stranieri che
fossero state pubblicate o realizzate per la prima volta in territorio italiano.
Inoltre, fino al 1993, vigeva il principio di reciprocità, superato dalle
Convenzioni internazionali attualmente in vigore, secondo il quale in Italia si
sarebbero potute tutelare altre opere di stranieri, solo in quanto lo Stato di
appartenenza dello straniero accordasse la stessa protezione concessa ai propri
cittadini alle opere dei cittadini italiani), ma hanno garantito ai cittadini di
ciascuno Stato contraente la possibilità di godere di una tutela uniforme. La
Convenzione più importante in ordine di tempo è la Convenzione d’Unione di Berna
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata nel 1886 a Berna
e modificata nelle successive conferenze diplomatiche, alla quale ha aderito il
maggior numero di Stati. Da ricordare è anche: la Convenzione universale sul
diritto d’autore, firmata nel 1952 a Ginevra da parte degli Stati che non
avevano firmato la Convenzione di Berna, tra questi in primis gli Stati Uniti
d’America; la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, firmata nel 1961 a Roma; I trattati dell’OMPI sul diritto
d’autore e sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi, firmati nel 1996 a
Ginevra, volti ad integrare le lacune delle precedenti Convenzioni. Queste
Convenzioni non solo obbligano gli Stati firmatari a rispettare il principio di
assimilazione o del trattamento nazionale, secondo il quale gli Stati devono
accordare ai cittadini degli Stati contraenti la stessa protezione riconosciuta
ai propri cittadini, ma, in aggiunta, prevedono anche una protezione minima
specifica e comune per colmare le tutele insufficienti delle leggi nazionali.
Nel nostro Stato il diritto d’autore è regolato tanto dalle Convenzioni appena
richiamate, alle quali ha aderito l’Italia, quanto dal Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea in tema di non discriminazione, di libera
circolazione dei prodotti e dei servizi e di tutela della concorrenza; dalle
Direttive comunitarie emanate in materia di diritto d’autore e anche dalla l. 22
aprile 1941, n. 633 (La l. n. 633/1941 è stata novellata ripetutamente dal
nostro legislatore per dare attuazione alle direttive comunitarie, in ragione
dell’obbligo di adeguamento alla normativa comunitaria, che incombe su tutti gli
Stati aderenti all’ UE.) e dagli artt. 2575- 2583 c.c., che hanno recepito la
codificazione normativa del Droit d’auteur francese sancita nella legge del
19/24 luglio 1793 (La legge francese sul diritto d’autore del 1793, intitolata
“Droit de proprieté des auteurs”, modificata il 3 agosto 2006, è tutt’ora
vigente in Francia). Dunque, ci si può domandare per quale ragione una materia
così consolidata, come è attualmente la tutela del diritto d’autore, sia oggetto
di questa ricerca e, come si è già anticipato, la risposta al quesito risiede
nel caso giudiziario “Gomorra”, alquanto recente, che ha suscitato un notevole
interesse non solo tra i giuristi ma anche tra i meri lettori del libro.
Analizzando il caso concreto è possibile scorgere una serie di questioni e di
profili rilevanti sul piano giuridico, che incidono addirittura sull’esito della
controversia giudiziaria, mettendo in crisi l’efficacia della tutela, che non
sono regolati precisamente dal legislatore e sui quali dottrina e giurisprudenza
non hanno raggiunto, ancora oggi, orientamenti pacifici. In altre parole, il
caso giudiziario “Gomorra” può essere utilizzato come la cartina tornasole con
la quale verificare l’effettiva efficacia degli strumenti posti a tutela del
diritto d’autore.
(Il caso concreto applicato al tema trattato della
riproduzione di un opera con doverosa citazione dell'autore e dell'editore, al
netto nella menzione sul Plagio, ossia mancanza di citazione, nota dell'autore.)
Il Convenuto. Aspetto quantitativo ed incidentale:
Dunque, i convenuti respingono le doglianze della parte attrice asserendo in
primo luogo che le similitudini tra gli articoli di giornale e il libro sono
dovute all’identità delle fonti consultate dai giornalisti e dall’autore (forze
dell’ordine e investigatori) e che gli articoli di giornale rappresentano una
componente qualitativamente e quantitativamente irrilevante del libro: poche
pagine rispetto alle trecentotrenta dell’intero.
La Corte. Creazione di opera letteraria atipica. Accostamento
di generi diversi: il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica, il pamphlet,
utilizzando fonti di dominio pubblico al di là dello spazio temporale congruo,
senza conseguire alcun “atto contrario agli usi onesti in materia
giornalistica”.
Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di
proprietà industriale ed intellettuale sentenza n. 773, 7 luglio 2010. Il
Tribunale di Napoli respinge la domanda della parte attrice, fondando la
decisione sulle seguenti ragioni di fatto e di diritto:
1) L’opera “Gomorra” non può essere considerata un “saggio” ma
“neppure tutt’altro, un’opera di fantasia” ma essa deve essere ricondotta al
genere “romanzo no fiction, dedicato al fenomeno camorristico, contenenti ampi
riferimenti alla realtà campana”. In particolare “Gomorra” costituisce “un
accostamento di generi diversi: il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica,
il pamphlet”. Il suo carattere creativo emerge dall’originale combinazione delle
vicende criminali del fenomeno camorristico, peraltro non esaminate in maniera
organica, né secondo criteri, che avrebbero invece caratterizzato un’opera di
genere saggistico. In esso fatti di cronaca vengono mescolati “con le vicende e
le sensazioni personali dell’autore”, dal che deriva la nettissima distanza
dell’opera “dalla mera cronaca giornalistica degli avvenimenti, da cui pure
muove l’autore, e che trova puntuale riscontro nello stesso testo dell’opera”.
Delineato, dunque, il genere letterario di appartenenza dell’opera di Saviano,
il Tribunale esclude la violazione dell’art. 65 della legge sul diritto d’autore
in quanto la norma richiede, perché ci sai plagio, “un ambito di riferimento
omogeneo”, che non ricorre nel caso di specie, perché gli articoli di giornale
sono stati utilizzati da Saviano mesi dopo la loro pubblicazione sulla testata
giornalistica ed impiegati in un ambito e con uno scopo diverso: differentemente
dal giornale con il quale si propone di dare informazioni contingenti, il libro
di Saviano intende approfondire e riflettere sul fenomeno camorristico, trattato
nel suo libro. (L’opera diventa di pubblico dominio quando decadono i diritti di
sfruttamento economico della stessa oppure quando decorre il tempo massimo di
tutela stabilito dall’ordinamento, il quale solitamente scade dopo settant’anni
dalla morte dell’autore, ma vi sono altri casi in cui il termine è diverso, come
ad esempio per le opere collettive, nelle quali vi rientrano i giornali, le
riviste, le enciclopedie, i cui diritti di sfruttamento economico dell’opera
scadono dopo settant’anni dalla pubblicazione, ma i diritti del singolo autore
seguono la regola generale. L’opera di pubblico dominio può liberamente essere
pubblicata, riprodotta, tradotta, recitata, comunicata, diffusa, eseguita, ecc…,
ma i diritti morali devono essere sempre rispettati.)
2) L’opera “Gomorra” non promuove la critica o la discussione sul
contenuto degli articoli e ciò viene confermato dalla “scrittura tesa e
volutamente poco attenta ai dettagli” dell’autore. Pertanto, il Tribunale di
Napoli esclude la violazione dell’art. 70 l. n. 633/1941, che richiede “la
menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore e dell'editore, qualora
tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”, in quanto il riferimento alla
norma risulta “del tutto incongruo”.
3) L’autore ha utilizzato fonti di dominio pubblico senza
conseguire alcun “atto contrario agli usi onesti in materia giornalistica” e ciò
esclude la violazione dell’art. 101 l. n. 633/1941. (L’art. 101 l. n. 633/1941
così recita “La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia
effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte”).
La Corte d'Appello. Distinzione di Articoli di giornale:
Cronaca; Opinione; Intervista. La rilevanza dello spazio temporale. Prevalenza
dell'interesse pubblico su quello privato.
Corte d'Appello di Napoli - Sezione specializzata in materia
d'impresa. Sentenza 4135/2016 del 26 settembre 2016, pubblicata il 21 novembre
2016 RG 4692/2015 repert n. 4652/2016 del 21/11/2016.
Gli articoli di giornali e le riviste rientrano a pieno titolo
tra le opere protette dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3 l. n. 633/1941.
Sull’assunto non può sorgere alcun dubbio, non solo a causa della lettera della
norma, ma anche perché bisogna distinguere le tipologie di articoli: l’articolo
di cronaca, l’articolo d’opinione e l’intervista.
Il primo dà notizie di un avvenimento di attualità in modo
obiettivo; perciò il cronista deve riferire l’accaduto, senza inserire alcun
commento sulla vicenda.
Il secondo contiene non solo informazioni e riferimenti
all'attualità, ma anche l'opinione del giornalista su una determinata questione
di costume, di cronaca, culturale, ecc…
L’intervista, infine, è il resoconto di un dialogo tra
l’intervistatore e la persona intervistata. Tuttavia, l’articolo di giornale,
oltre ad avere carattere informativo, legato ai fatti di cronaca, può avere
anche contenuti descrittivi e narrativi. In esso, infatti, il giornalista può
inserire una propria visione ideologica, politica, culturale, sulla notizia in
questione. A fronte di tale classificazione si esclude che gli articoli di
cronaca possano essere plagiati a differenza di quanto avviene per gli articoli
di giornale.
Le norme del diritto d’autore in tema di libere utilizzazioni
sono del tutto eccezionali e ciò esclude che gli articoli di giornale tutelati
possano essere riprodotti, citati o sunteggiati al di fuori dei rigorosi limiti
in esse posti, nonché in assenza delle condizioni da esse previste. (...) É pur
vero che, trascorso un certo spazio temporale dall’originaria pubblicazione
della notizia, il fatto diventa notorio e non vi è alcuna violazione del diritto
d’autore, se si utilizzano informazioni diffuse; tuttavia, rilevano le modalità
con le quali le informazioni vengono usate. (...) È assolutamente fondato che
nessuno ha il monopolio delle informazioni afferenti a fatti noti ed
oggettivamente accaduti e che nessuno può subordinare all’obbligo di citazione
la riproduzione o comunicazione di un’informazione, ma è pur vero che l’articolo
di giornale può non essere solo informativo, come l’articolo di cronaca, quando
non si limita ad esporre i fatti così come sono accaduti nella realtà, ma è
connotato da una parte descrittiva e narrativa, che rende l’opera creativa e
tutelata dal diritto d’autore. (...)
Gli articoli 657 , 708 e 1019 l. n. 633/1941 prevedono dei limiti
ai diritti patrimoniali dell’autore, non anche a quelli morali, in quanto
consentono la riproduzione, la comunicazione al pubblico, il riassunto, la
citazione ecc… di opere per favorire l’informazione pubblica, la libera
discussione delle idee, la diffusione della cultura e di studio, che prevalgono
sull’interesse personale dell’autore. (L’art. 65 l. n. 633/1941 così recita “Gli
articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati
nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del
pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali,
anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata
espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la
data e il nome dell'autore, se riportato”. 8L’art. 70 l. n. 633/1941 così recita
“Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la
loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali”).
Corte di Cassazione. Prima sezione civile. Sentenza n.
12314/1015. L'originalità e creatività dell'opera creata con l'ausilio di
articoli di giornale.
(...)La violazione del diritto d’autore non si ha solo
nell’ipotesi di integrale riproduzione dell’opera altrui ma anche nel caso di
mera contraffazione e, dunque, nel caso di riproduzione indebita di alcune parti
dell’opera, nelle quali si ravvisano “i tratti essenziali che caratterizzano
l’opera anteriore”. "Cass., 5 luglio 1990, n. 7077, in Giur. it., 1991, p. 47".
Su questo punto la Cassazione si è più volte pronunciata (Cass., 5 luglio 1990,
n. 7077, in Giur. it., 1991, p. 47. 12 Cass., 27 ottobre 2005, n. 20925, in Foro
it. 2006, p. 2080; conf. Cass., 5 luglio 1990, n. 9139, in Giust. civ., 1991, p.
152), sostenendo che sia opportuno distinguere la riproduzione abusiva in senso
stretto dalla contraffazione e dall’elaborazione creativa perché la prima
consiste nella “copia integrale e pedissequa dell’opera altrui”; la seconda
nella riproduzione non integrale ma sostanziale dell’opera, in quanto ci sono
poche differenze e di mero dettaglio; la terza, invece, consiste in un’opera
originale, in quanto si connota per l’apporto creativo del suo autore ed è,
pertanto, meritevole di tutela, ex art. 4 l. n. 633/1941. (...)
Conclusioni.
Tuttavia, è certo che gli articoli di giornale e “Gomorra”
seguono scopi distinti, infatti, con i primi si informa e si danno informazioni
contingenti, invece, con il secondo si segue il fine di approfondire e di
indurre il lettore alla riflessione sul fenomeno criminale denominato camorra.
La forma e la struttura espositiva dell’opera permettono di riflettere su un
altro punto nevralgico della vicenda, che vede, ancora una volta, opinioni
contrastanti tra la dottrina e la giurisprudenza: l’articolo di giornale rientra
tra le opere protette dal diritto d’autore? Risponde al quesito sia l’art. 3 l.
n. 633/1941, che annovera tra le opere tutelate dal diritto d’autore anche gli
articoli pubblicati su giornali e sulle riviste, sia la distinzione tra
l’articolo di cronaca e l’articolo d’opinione. Come si può leggere nel Cap. III,
par. 3.1, l’articolo di cronaca non può essere plagiato, in quanto, per
definizione, si limita a narrare i fatti così come sono accaduti, nella loro
successione cronologica, senza che vi ricorrano i requisiti che un’opera
protetta dal diritto d’autore debba avere per legge. Tali requisiti sono
elencanti nel Cap III, par. 3.1. L’articolo di opinione, invece, non è una mera
elencazione, bensì, un’esposizione di fatti con terminologie e prospettive
proprie del giornalista, correlate, in taluni casi, dalle opinioni di chi
scrive. In essi, dunque, il giornalista racconta i fatti in modo creativo,
suggerendo un’impronta personale, tali da ricondurli direttamente a se stesso,
cosicché è possibile che vi siano articoli scritti da giornalisti diversi, che,
seppure raccontano gli stessi fatti, non incorrono nel plagio. Gli articoli di
opinione possono, dunque, essere oggetto di plagio. In conclusione, l’articolo
di giornale, che ricorre nel caso giudiziario in esame, non è assimilabile ad un
articolo di cronaca, così come delineato nel Cap. I, par. 1.3, e, colta questa
differenza, non si può negare che l’articolo di giornale sia un’opera protetta
dal diritto d’autore. Tuttavia, è bene chiarire che riconoscere come meritevoli
di tutela gli articoli di giornale, nei limiti appena chiariti, non significa
attribuire l’esclusiva dell’informazione al giornalista e alla testata
giornalistica presso la quale costui lavora, in quanto il singolo giornalista
non può essere l’unico legittimato a dare informazioni. Se così fosse, si
riconoscerebbe il monopolio dell’informazione a favore della testata
giornalista, che per prima ha dato la notizia, in contrasto con il principio
fondamentale di libertà d’espressione, sancito nell’art. 21 della Costituzione.
Sul punto si rinvia al Cap. III, par. 3.2.
Non sempre è sufficiente riconoscere fra le opere protette dal
diritto d’autore gli articoli di giornale perché essi possano esser tutelati
efficacemente dal diritto d’autore. Infatti, come dimostra il caso esaminato, la
prospettiva assunta per l’analisi della controversia può indurre il giudice a
mettere in secondo piano gli articoli rispetto il libro. Più precisamente, il
giudice avrebbe potuto escludere il plagio, se, durante il confronto delle due
opere letterarie, ne avesse enfatizzato il suo carattere originale e creativo,
rispetto alla conformazione delle notizie di cronaca contenute nell’opera.
Assumere questa prospettiva, in cui il libro diventa il termine di paragone
prevalente, significa non dare la giusta rilevanza agli articoli di giornale nel
giudizio di plagio. Rileverebbe unicamente che gli articoli di giornale occupino
un esiguo numero di pagine del libro e, poiché rappresentano una piccola parte,
si escluderebbe, a priori, che un’opera alla stregua di “Gomorra” possa essere
un’opera plagiaria. Pertanto, la quantità delle pagine del libro, nelle quali
sono riportati gli articoli di giornale, non ritengo sia una ragione valida per
escludere il plagio. Assumere, invece, la prospettiva opposta, nella quale gli
articoli di giornale diventano il primo termine di paragone, consente di
rilevare il plagio, se quest’ultimi sono riprodotti nel libro con la stessa
forma e la stessa struttura espositiva dei giornalisti e senza che ne venga
citata la fonte. In queste disposizioni normative, la legge speciale sul diritto
d’autore ammette la libera pubblicazione o comunicazione al pubblico e la libera
citazione delle opere protette dal diritto d’autore, affinché, in tal modo, si
permetta la diffusione delle informazioni, del sapere e della cultura. Tuttavia,
tale interesse generale non deve ledere i diritti d’autore, ma deve realizzarsi
nel rispetto delle norme, sancite dal legislatore. Per impedire che si
violassero i diritti d’autore, si è attributo alle norme che sanciscono la
libera utilizzazione dell’opera protetta il carattere eccezionale. Ciò significa
che esse si applicano secondo le modalità e nei casi espressamente previsti dal
legislatore e che non sono suscettibili di applicazione analogica; pertanto, non
è possibile applicare queste norme a casi diversi da quelli delineati dal
legislatore. Dunque, le utilizzazioni devono avvenire mediante la citazione
della fonte, della data e dell’autore - le c.d. menzioni d’uso - con le quali si
riconosce che “una certa opera o parte di essa è frutto del lavoro di un 91
altro autore, così da evitare di essere accusati di plagio se si attinge da un
testo altrui”. Se consideriamo il caso di specie, le menzioni d’uso mancano nel
libro “Gomorra”. Invece, l’art. 65 l. n. 633/1941, che ritengo applicabile al
caso “Gomorra”, resta, tuttavia, inosservato nell’esecuzione dell’opera.
Pertanto, sarebbe bastato riportare la fonte, perché venisse riconosciuta
infondata l’accusa rivolta nei confronti di Saviano. In tal modo, l’autore, non
solo sarebbe stato scagionato da ogni accusa di plagio, ma avrebbe arricchito il
suo lavoro di ricerca sui fatti raccontati, avrebbe permesso ai lettori di
approfondire gli avvenimenti e, allo stesso tempo, il suo libro non sarebbe
stato meno interessante. Dunque, la Corte non riconosce i presupposti in virtù
dei quali è ammessa dal giudice in primo grado la libera riproduzione delle
notizie contenute negli articoli, in quanto esclude che le vicende narrate negli
articoli di Libra siano divenute di pubblico dominio e ritiene irrilevante che
Saviano abbia riprodotto gli articoli nella sua opera a distanza di tempo.
L’opera diventa di pubblico dominio quando decadono i diritti di sfruttamento
economico della stessa oppure quando decorre il tempo massimo di tutela
stabilito dall’ordinamento, il quale solitamente scade dopo settant’anni dalla
morte dell’autore, ma vi sono altri casi in cui il termine è diverso, come ad
esempio per le opere collettive, nelle quali vi rientrano i giornali, le
riviste, le enciclopedie, i cui diritti di sfruttamento economico dell’opera
scadono dopo settant’anni dalla pubblicazione, ma i diritti del singolo autore
seguono la regola generale. L’opera di pubblico dominio può liberamente essere
pubblicata, riprodotta, tradotta, recitata, comunicata, diffusa, eseguita, ecc…,
ma i diritti morali devono essere sempre rispettati. I primi due gradi di
giudizio Il Tribunale di Napoli respinge la domanda della parte attrice,
fondando la decisione sulle seguenti ragioni di fatto e di diritto: 1) L’opera
“Gomorra” non può essere considerata un “saggio” ma “neppure tutt’altro,
un’opera di fantasia” ma essa deve essere ricondotta al genere “romanzo no
fiction, dedicato al fenomeno camorristico, contenenti ampi riferimenti alla
realtà campana”. In particolare “Gomorra” costituisce “un accostamento di generi
diversi: il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica, il pamphlet”. Il suo
carattere creativo emerge dall’originale 16 combinazione delle vicende criminali
del fenomeno camorristico, peraltro non esaminate in maniera organica, né
secondo criteri, che avrebbero invece caratterizzato un’opera di genere
saggistico. In esso fatti di cronaca vengono mescolati “con le vicende e le
sensazioni personali dell’autore”, dal che deriva la nettissima distanza
dell’opera “dalla mera cronaca giornalistica degli avvenimenti, da cui pure
muove l’autore, e che trova puntuale riscontro nello stesso testo dell’opera”.
Delineato, dunque, il genere letterario di appartenenza dell’opera di Saviano,
il Tribunale esclude la violazione dell’art. 65 della legge sul diritto d’autore
in quanto la norma richiede, perché ci sai plagio, “un ambito di riferimento
omogeneo”, che non ricorre nel caso di specie, perché gli articoli di giornale
sono stati utilizzati da Saviano mesi dopo la loro pubblicazione sulla testata
giornalistica ed impiegati in un ambito e con uno scopo diverso: differentemente
dal giornale con il quale si propone di dare informazioni contingenti, il libro
di Saviano intende approfondire e riflettere sul fenomeno camorristico, trattato
nel suo libro. 2) L’opera “Gomorra” non promuove la critica o la discussione
sul contenuto degli articoli e ciò viene confermato dalla “scrittura tesa e
volutamente poco attenta ai dettagli” dell’autore. Pertanto, il Tribunale di
Napoli esclude la violazione dell’art. 70 l. n. 633/1941, che richiede “la
menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore e dell'editore, qualora
tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”, in quanto il riferimento alla
norma risulta “del tutto incongruo”. 3) L’autore ha utilizzato fonti di dominio
pubblico senza conseguire alcun “atto contrario agli usi onesti in materia
giornalistica” e ciò esclude la violazione dell’art. 101 l. n. 633/1941.
IL DIRITTO D’AUTORE NELL’OPERA GIORNALISTICA. I CARATTERI
DELL’OPERA PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE. Sarebbe
utopistico credere che qualsiasi opera possa esser protetta dal diritto
d’autore; infatti, lo sono solo le opere che hanno una serie di caratteri di
fondo ben fissati da parte del legislatore. Pertanto, in presenza di opere nelle
quali si ravvisano determinati requisiti si applica la disciplina concernente il
diritto d’autore e le tutele previste al suo autore o ad altri soggetti, diversi
da quest’ultimo, lesi nei loro diritti patrimoniali e morali. Si potrebbe
pensare erroneamente che la ricorrenza delle medesime caratteristiche includa
nella tutela del diritto d’autore solo opere omogenee, ma in realtà si tratta di
una nozione così di ampio respiro da consentire ad opere diversificate ed
eterogenee di rientrare comunque nella tutela del diritto d’autore. In essa
rientrano, infatti, le opere letterarie, artistiche e musicali tradizionali, le
banche di dati, il software e il design. Analizzare i caratteri dell’opera
protetta dal diritto d’autore, dunque, diventa importante per comprendere in
quali casi l’autore gode di determinati diritti e quando può agire a tutela di
essi.
L’opera dell’ingegno umano. Il primo carattere che deve ricorrere
affinché l’opera sia protetta dal diritto d’autore è quello di “opera
dell’ingegno umano”. Si tratta di una nozione legislativa che si ricava dagli
artt. 1 e 2 della l. n. 633/1941, nei quali rispettivamente si definiscono e si
classificano le opere oggetto del diritto d’autore; esse sono il frutto di una
“creazione intellettuale”, che si realizza a fronte dell’attività
dell’intelletto umano di ideazione ed esecuzione materiale dell’opera. Dunque il
concetto di creazione intellettuale é così ampio ed elastico da consentire
addirittura di comprendere opere che appartengono a campi e categorie
fenomenologiche diverse, come la letteratura, la musica, le arti figurative,
l’architettura, il teatro e la cinematografia, le quali, seppure si avvalgono di
mezzi espressivi differenti tra loro, allo stesso tempo presentano come primo
carattere di fondo l’essere un’opera derivante dall’attività dell’ingegno umano.
Il carattere rappresentativo: la forma interna e la forma esterna
Un requisito che ricorre nelle opere oggetto di tutela del diritto d’autore è il
carattere rappresentativo, al quale Paolo Auteri attribuisce un significato:
l’opera è destinata a “rappresentare, con qualsiasi mezzo di espressione (parola
scritta o orale, disegni e immagini, fisse o in movimento, suoni, ma anche il
movimento del corpo e qualsiasi altro segno), fatti, conoscenze, idee, opinioni
e sentimenti; e ciò essenzialmente allo scopo di comunicare con gli altri”. In
parole più semplici, l’opera deve avere una forma “percepibile” e non rimanere a
livello di mero pensiero; ovviamente, se così fosse, la semplice idea astratta,
che non è idonea a rappresentare con organicità idee e sentimenti, non potrebbe
essere oggetto di tutela. Questo carattere è sancito a livello internazionale
nell’art. 9 n.2 dell’Accordo TRIPs, il quale protegge la forma espositiva con
cui l’opera appare, ad es: l’insieme di parole e frasi (c.d. forma esterna); la
struttura espositiva, ad es: l’organizzazione del discorso, la scelta e la
sequenza degli argomenti, le prospettive adottate, ecc... (c.d. forma interna),
e non il contenuto di conoscenze, informazioni, idee, fatti, teorie in quanto
tali e a prescindere dal modo in cui sono scelti, esposti e coordinati.
(L’Accordo TRIPs, “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights” (in italiano, Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di
proprietà intellettuale), è un trattato internazionale promosso
dall'Organizzazione mondiale del commercio, al fine di fissare i requisiti e le
linee guida che le leggi dei paesi aderenti devono rispettare per tutelare la
proprietà intellettuale. L’art. 9 n.2 dell’Accordo TRIPs così recita: “La
protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i
procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali”.
29 La distinzione tra forma esterna, forme interna e contenuto è stata elaborata
sin dall’inizio del secolo scorso ad opera di un autorevole giurista tedesco, il
Kohler, e viene seguita dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti. Essa è stata
fortemente criticata da più parti, tanto dalla dottrina, rappresentata da Piola
Caselli in Italia e da Ulmer in Germania, che dalla parte minoritaria della
giurisprudenza. Si è contestato, in breve, il fondamento teorico della tesi di
Kohler e la difficoltà, se non l’impossibilità, di distinguere tali tre elementi
a livello pratico. Inoltre, ci sono state pronunce di merito, come ad esempio la
sentenza del Tribunale di Milano del 11 marzo 2010, dalle quali emerge che non
sempre il contenuto è irrilevante ai fini del riconoscimento del plagio.
Infatti, è possibile distinguere le idee diffuse nella cultura comune dalle idee
innovative, che non appartengono al pensiero comune e che possono essere
ricondotte ad un autore in particolare. Secondo tali pronunce giurisprudenziali,
l’utilizzo del primo tipo di idee in un’opera dell’ingegno non produrrebbe
plagio purché le idee vengano rielaborate in modo originale, invece l’utilizzo
del secondo tipo di idee, anche se espresse in forma diversa, difficilmente
escluderebbero il plagio).
Il carattere creativo: originalità e novità. Il carattere
creativo è un criterio espressamente richiesto dal legislatore, negli artt. 1 l.
n. 633/1941 e 2575 c.c., affinché l’opera sia protetta dal diritto d’autore. In
dottrina tale carattere non è definito in termini omogenei. Su questo punto, la
dottrina è divisa: una opinione predilige il criterio della c.d. “creatività
oggettiva” 30 , secondo il quale è creativa “l’opera dotata di caratteristiche
materiali, oggettive appunto, tali da distinguerla da tutti i lavori ad essa
preesistenti” 31 ; l’altra, invece, sostiene il criterio della c.d. “creatività
soggettiva”32 , secondo il quale è creativa l’opera che riflette la personalità
dell’autore e il suo modo personale di rappresentare ed esprimere fatti, idee e
sentimenti, tale da renderla “direttamente riconducibile al suo autore” (c.d.
individuabilità rappresentativa). In merito alla creatività soggettiva, la
dottrina ha individuato due profili del carattere creativo: l’originalità e la
novità. L’originalità consiste nel risultato di un’elaborazione intellettuale
che riveli la personalità dell’autore, indipendentemente dalle dimensioni e
dalla complessità del contenuto dell’opera, il quale può anche essere modesto e
semplice o appartenere al patrimonio comune. Dunque sarebbero originali tutte
quelle opere che, seppure appaiano molto simili tra loro, hanno un taglio o una
prospettiva che le rende “frutto di una elaborazione autonoma del loro autore”.
Invece la novità si ha quando sono nuovi o inediti gli “elementi essenziali e
caratterizzanti” dell’opera, senza che la novità sia assoluta o diventi
creazione. Infatti nuove non sono solo le opere che si basano su un’idea che non
ha precedenti, ma anche quelle che rielaborano elementi di opere preesistenti
con forme o mezzi di espressione innovativi, tali da distinguerle dalle opere
precedenti (c.d. novità in senso oggettivo). L’orientamento che ha riscontrato
il maggior successo nelle pronunce giurisprudenziali è quello della “creatività
soggettiva”.
La compiutezza espressiva. Un altro requisito posto dalla legge
per la tutela dell’opera dell’ingegno è quello della c.d. “compiutezza
espressiva”, definita dalla dottrina come “l’idoneità a soddisfare l’esigenza
estetica, emotiva o informativa, del fruitore di un determinato evento
creativo”. Così come asserito da Kevin de Sabbata, tale nozione è assolutamente
opinabile e non vi è ancora una pronuncia giurisprudenziale o uno studio
dottrinale, che sia pervenuta ad attribuirle un significato stabile e chiaro.
Motivo per il quale si ravvisa una difficoltà di applicazione del principio,
seppure risulterebbe rilevante per la risoluzione di casi giudiziari di plagio
parziale.
La pubblicazione dell’opera. Diversamente da quanto si possa
pensare, il diritto d’autore non protegge solo le opere già pubblicate e già
immesse nel mercato ma anche quelle non pubblicate e non note al pubblico, le
c.d. opere inedite. Infatti, la Suprema Corte, riprendendo gli artt. 6 l. n.
633/1941 e 2575 c.c., ha ribadito che il diritto d’autore ha origine nel momento
della mera creazione dell’opera, che costituisce un atto giuridico in senso
stretto, e non al seguito del conseguimento di formalità, come gli adempimenti
di deposito e di registrazione dell’opera . Nel 2012 i giudici di legittimità
hanno escluso definitivamente che l’opera debba costituire “una sorgente di
utilità” ai fini di tutela, potendo, dunque, essere oggetto di tutela anche
prima della pubblicazione.
IL DIRITTO D’AUTORE E IL DIRITTO D’INFORMAZIONE E DI CRONACA.
Dato per scontato che il diritto d’autore tuteli, ai sensi dell’art.1 l. n.
644/1941 e dell’art. 2575 c.c., le opere caratterizzate da requisiti di fondo
delineati nel paragrafo precedente, possiamo asserire che tali caratteri
ricorrono nell’opera giornalistica e che, pertanto, anche gli articoli di
giornale sono tutelati dal diritto d’autore. Estendere la disciplina del diritto
d’autore all’articolo di giornale comporta, come conseguenza inevitabile, che le
norme a tutela dell’autore possano incidere sull’esercizio dell’attività di
comunicazione e di informazione sociale, che si promuove con l’opera
giornalistica. Il diritto d’autore e il diritto d’informazione e di cronaca
possono entrare addirittura in conflitto tra loro, perché, da un lato vi è
l’interesse di tutelate i diritti patrimoniali e morali dell’autore con la
limitazione della libera divulgazione delle opere protette e, dall’altro lato vi
è l’interesse generale alla diffusione di informazioni esatte su fatti rilevanti
e di interesse generale. Diventa, dunque, necessario approfondire i profili di
rilevo costituzionale sui quali può incidere il diritto d’autore, quali il
diritto 61 d’informazione e il diritto di cronaca, per poter comprendere come
essi si conciliano tra loro. Il diritto d’informazione è un diritto fondamentale
delle persone, che è compreso, assieme al diritto d’opinione e di cronaca, nella
libertà di manifestazione del proprio pensiero, sancita a livello nazionale
dall’art. 21 della Costituzione e a livello sovranazionale dall’art. 19 della
“Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e dall’art.10 co. 1, della
“Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali” , che consiste “nella libertà di esprimere le proprie idee e di
divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari”, senza porre limiti in
merito ai mezzi di espressione e in merito agli scopi, circostanze, contenuti da
esprimere, ecc… Il diritto d’informazione ha una duplice profilo: quello attivo
consiste nel diritto di informare e di diffondere notizie; invece, quello
passivo consiste nel diritto di essere informati, sempre che l’informazione sia
“qualificata e caratterizzata (…) dal pluralismo delle fonti da cui attingere
conoscenze e notizie”. In conseguenza del diritto di essere informati è fatto
divieto, ai sensi dell’art. 21, co. 2, Cost., di sottoporre la stampa a
controlli preventivi. Nel nostro ordinamento è dunque, vietata la possibilità di
sottoporre la divulgazione dell’informazione ad autorizzazioni o censure, al
fine di evitare manipolazioni della notizia e compromettere il diritto della
collettività a ricevere corrette informazioni. Il diritto dei cittadini ad
essere informati si esercita mediante il diritto di cronaca, definito dalla
giurisprudenza come “il diritto di raccontare, tramite mezzi di comunicazione di
massa, accadimenti reali in considerazione dell’interesse che rivestono per la
generalità dei consociati”. Dunque, l’informazione viene comunicata e diffusa
per mezzo dell’esercizio del diritto di cronaca, il quale incontra una serie di
limiti per evitare che l’esercizio di questo diritto possa ledere altri diritti
inviolabili. Infatti l’art. 21 co. 3 Cost., sancisce il limite del rispetto del
“buon costume”, generalmente inteso come il rispetto del “pudore sessuale”. Si
tratta, però, di un concetto sprovvisto di una definizione normativa e, dunque,
di un significato stabile, ma a ciò sopperiscono il legislatore e
l’interpretazione giurisprudenziale, tenendo conto dell’evoluzione dei costumi.
Ad esempio, la legge sulla stampa n. 47 del 1948, ha stabilito che é contrario
al “buon costume” la pubblicazione di contenuti impressionanti e
raccapriccianti, che provocano turbamento del “comune sentimento della morale o
l’ordine familiare”. Tuttavia, tanto la giurisprudenza che il legislatore nelle
altre brache del diritto ammettono ulteriori limiti, quando l’esercizio del
diritto d’informazione, o più in generale del diritto d’espressione, potrebbe
ledere altri diritti della persona costituzionalmente tutelati ed inderogabili,
quali, ad esempio il diritto alla privacy o alla riservatezza, al nome,
all’immagine, alla dignità della persona e ai diritti dell’autore, riconosciuti
dalla legge sul diritto d’autore. A tal proposito, la giurisprudenza, a più
riprese, ha individuato una serie di requisiti, che il giornalista deve
rispettare per garantire un equo bilanciamento del diritto di cronaca con altri
diritti inviolabili, che potenzialmente possono entrarvi in conflitto. Per
quanto riguarda il bilanciamento degli interessi dell’autore alla tutela dei
suoi diritti patrimoniali e morali con gli interessi della collettività alla
diffusione delle informazioni e delle notizie è intervenuta la Corte
Costituzionale con la sentenza 12 aprile 1973, n. 38, nella quale ha affermato
che le norme del diritto d’autore, rapportate all’informazione giornalistica,
non contrastano con i principi costituzionali perché non limitano in alcun modo
la “libera estrinsecazione e manifestazione del pensiero” e non “assoggettano la
stampa ad autorizzazioni o censure”, ma, piuttosto, “tutelano l'utilizzazione
economica del diritto d'autore e sono dirette ad assicurare la prova e a
determinare l'indisponibilità della cosa, sia per preservarla da distruzione o
alterazione, sia per assicurare l'attribuzione dell'opera all'avente diritto,
sia per impedire ulteriori danni derivanti da violazione del diritto di autore”.
Infatti, il legislatore garantisce il diritto d’informazione e il diritto di
cronaca, ammettendo la libera utilizzazione dell’opera protetta purché si
seguano i fini esplicitamente delineati nell’art. 70 l. n. 633/1941 – per uso di
critica o di discussione, insegnamento o ricerca scientifica – e purché tale
utilizzazione non costituisca una forma di concorrenza economicamente rilevante.
La ratio della norma si rinviene nelle esigenze di progresso e diffusione della
cultura e delle scienze. La questione, però, non è pacifica perché, se da un
lato la Corte Costituzionale afferma che la tutela del diritto d’autore non può
limitare la libera manifestazione del pensiero, dall’altro, alcuni giudici di
merito, di fronte al caso concreto, ritengono che il diritto di cronaca non
possa incidere sull’estensione del diritto d’autore, in quanto, a tale
proposito, nessun limite è previsto espressamente dalla legge. Di conseguenza,
nei fatti la delimitazione reciproca dei due diritti è rimessa al prudente
apprezzamento dei giudici di merito.
L’OPERA GIORNALISTICA. Sulla base
degli argomenti esposti in precedenza si può, dunque affermare che anche l’opera
giornalistica è tutelata dal diritto d’autore, essendo una creazione
intellettuale, la quale deriva dall’esercizio del diritto d’informazione e di
cronaca. Infatti, l’art. 3 l. n. 633/1941 annovera i giornali e le riviste tra
le c.d. opere collettive, che sono “costituite dalla riunione di opere o di
parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della
scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico,
didattico, religioso, politico ed artistico”, ma non informativo. In effetti,
l’opera giornalistica é il frutto di una molteplicità di apporti creativi di
diversi autori, coordinati e selezionati dal direttore della testata
giornalistica. Dunque, in tale opera si possono distinguere due distinti livelli
creativi: quello dei singoli giornalisti, che contribuiscono a comporre l’opera,
e quello del direttore, che provvede a progettare l’opera complessiva, a
scegliere e coordinare i contributi, ad organizzare e dirigere l’attività
creativa dei collaboratori. Una volta rilevata questa duplice creatività, sorge
spontaneo domandarsi come il legislatore tuteli tali opere. Ciò che potrebbe
risultare complesso è stato, invece, risolto con estrema facilità dal
legislatore, il quale ha riconosciuto come meritevole di tutela non la
creatività dei singoli giornalisti, bensì quella del direttore che, mediante
l’attività di scelta, di coordinamento e di organizzazione dei contributi,
realizza l’opera complessiva: l’opera giornalistica. È sulla base di questa
prospettiva che ben si spiegano gli artt. 7 e 38 l. n. 633/1941. L’art. 7 l. n.
633/1941 riconosce come autore delle opere collettive “chi ha diretto e
organizzato la creazione dell’opera stessa”. Pertanto, rivestendo il ruolo di
autore dell’opera giornalistica, il direttore del giornale può, ex art. 41 l. n.
633/1941, “introdurre nell’articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma
che sono richieste dalla natura e dai fini del giornali”, le quali, se sono
sostanziali, possono essere apportate solo con il consenso dell’autore, sempre
che questi sia reperibile; altrimenti, ex art. 9 dal Contratto Nazionale di
Lavoro Giornalistico (FNSI – FIEG 1 aprile 2013 – 31 marzo 2016), “l’articolo
non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza
l’assenso del giornalista”. Normalmente gli articoli che, a giudizio del
direttore, rivestono particolare importanza sono pubblicati con la firma
dell’autore, invece quelli meno rilevanti possono essere riprodotti anche senza
l’indicazione del nome dell’autore. Solo se non compare la firma dell’autore, il
direttore della testata giornalistica non solo può modificare ed integrare
l’articolo di giornale ma anche sopprimerlo e non pubblicarlo. L’art. 38 l. n.
633/1941 attribuisce il diritto di utilizzazione economica dell’opera
all’editore, salvo patto contrario, senza precludere ai singoli collaboratori di
utilizzare la propria opera separatamente, purché si rispettino gli accordi
intercorsi fra i collaboratori e l’editore, nei quali sono precisati i limiti e
le condizioni dell’utilizzazione separata dei contributi dei singoli, a
salvaguardia dello sfruttamento dell’opera collettiva. Sostanzialmente l’art. 38
l. n. 633/1941 attribuisce lo sfruttamento economico dell’opera all’editore, nel
rispetto dei principi fondamentali, ai sensi degli artt. 12 e ss. l. n.
633/1941, e allo stesso tempo garantisce il diritto ai giornalisti di utilizzare
il proprio articolo separatamente dall’opera complessiva, senza pregiudicare il
diritto di sfruttamento economico esclusivo dell’editore sull’opera collettiva.
Infatti, il legislatore, nell’art. 42 l. n. 633/1941, assicura all’autore
dell’articolo di giornale pubblicato in un’opera collettiva il diritto di
riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, in altre riviste o
giornali, purché “indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione”. Alla regola dell’art. 38 l. n. 633/1941, il legislatore ammette
una sola eccezione, fissata nel successivo art. 39, secondo la quale l’autore
può riacquistare il diritto di disporre liberamente dell’opera al ricorrere di
due condizioni: 1) quando il giornalista è estraneo alla redazione del giornale,
non ha un accordo contrattuale con la testata giornalistica, ma ha invitato
l’articolo al giornale perché venisse riprodotto in esso; 2) quando il
giornalista non ha ricevuto notizia dell’accettazione entro un mese dall’invio o
la riproduzione dell’articolo non è avvenuta entro sei mesi dalla notizia
dell’accettazione.
LA RIPRODUZIONE E LA CITAZIONE DELL’ARTICOLO DI GIORNALE
NELL’OPERA LETTERARIA. Talvolta un libro nasce
dall’esigenza di voler raccontare una storia, frutto della fantasia dell’autore,
basata su fatti realmente accaduti. Infatti, molto spesso leggiamo libri con
riferimenti a persone esistenti o a fatti realmente accaduti. Per scrivere un
libro basato su fatti già accaduti e magari notori, lo scrittore deve informarsi
servendosi di giornali, riviste e altro materiale, reperibile in qualsiasi modo.
Così l’autore può ricostruire gli accadimenti e assumere informazioni
dettagliate, utili per il proprio libro. Questa attività di ricerca e
informazione risulta di grande importanza, in quanto, solo di seguito ad essa,
lo scrittore inizierà a scrivere il suo libro. Però lo scrittore deve estrarre
dalle fonti le informazioni utili e rielaborarle in modo creativo. Se, invece,
si limita ad un lavoro di “copia e incolla”, corre il rischio di ledere il
diritto d’autore. Una volta chiarito che, gli articoli di giornale e l’opera
giornalistica nel suo insieme sono tutelati dal diritto d’autore, cosa succede
se ad esser riprodotto senza citazione della fonte e dell’autore in un’opera
letteraria, come è accaduto nel caso di specie “Gomorra”, sia un articolo di
giornale? Per rispondere al quesito è necessario esaminare il contenuto degli
artt. 65, 70 e 101 l. n. 633/1941, in materia di eccezioni e limitazioni del
diritto d’autore.
Gli articoli di attualità. Nell’art.
65 della legge 53 il legislatore sancisce la libertà di utilizzazione,
riproduzione o ripubblicazione e comunicazione al pubblico degli articoli di
attualità, che possiamo considerare come sinonimo di cronaca, in altre riviste o
giornali, quando ricorrono tre requisiti:
1) che si tratti di articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, o altri materie dello stesso genere. Sul punto la dottrina
è divisa, perché, da una parte c’è chi sostiene che sia lecita la riproduzione
di articoli di attualità specificamente indicati dal legislatore (a carattere
politico, economico e religioso), con l’esclusione degli articoli di cronaca a
contenuto culturale, artistico, satirico, storico, geografico o scientifico,
mentre dall’altra parte c’è chi farientrare queste ultime fattispecie di
articoli tra “gli altri materiali dello stesso carattere”; (L’art. 65 della l.
n. 633/1941 così recita “Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico
in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o
l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichi la fonte
da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato”).
2) che siano pubblicati in riviste o in giornali;
3) che la riproduzione o l’utilizzazione non sia espressamente
riservata, ovvero quando manchi l’indicazione, anche in forma abbreviata, delle
parole “riproduzione riservata” o di altre espressioni dal significato analogo,
all’inizio o alla fine dell’articolo, secondo quanto prevede l’art. 7 del
regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore, approvato con il
R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. È necessario a questo punto fare una
puntualizzazione, perché potrebbe intendersi erroneamente il significato
dell’espressione “libera utilizzazione”. La libera utilizzazione consiste nella
riproduzione o comunicazione al pubblico dell’opera senza il consenso
dell’autore, ma nel rispetto di determinati adempimenti, fissati dalla legge,
come l’indicazione della fonte da cui sono tratti, la data e il nome
dell’autore, se riportato. Tali formalità devono essere adempiute anche
nell’ipotesi, delineata dall’art. 65 co. 2 l. n. 633/1941, di riproduzione o
comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti, utilizzati in occasione
di avvenimenti di attualità per fini informativi e di cronaca, fatta eccezione
del caso di impossibilità di conoscere la fonte e il nome dell’autore. (“La
riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato”). La norma in esame è eccezionale e non suscettibile
di applicazione analogica, ragione per la quale la libera utilizzazione non si
estende alle rassegne-stampa; infatti, la riproduzione di queste ultime deve
sempre essere effettuata con il consenso dei titolari dei diritti.
La libertà di citazione. Prima della
legge italiana sul diritto d’autore, la libertà di citazione è stata regolata
dall’art. 10 della Convenzione d’Unione di Berna, il quale riporta pressoché il
contenuto fissato nell’art. 70 l. n. 633/1941. Il legislatore italiano non ha
provveduto, come previsto dalla norma internazionale, a chiarire espressamente
che l’opera citata debba esser stata pubblicata e che la citazione debba avere
un carattere di mero esempio e supporto di una tesi e non lo scopo di illustrare
l’opera citata. (L’art. 10 della Convezione di Berna così recita “Sono lecite le
citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico,
nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di
rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente
ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. Restano fermi gli effetti
della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi
stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente
opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante
pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché
una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura
giustificata dallo scopo. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea
precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore”.
56 La Convenzione d’Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche fu firmata nel 1886 a Berna e ratificata ed eseguita in Italia con la
legge 20 giugno 1978, n. 399. Sul punto si rinvia al Cap I, par. 1.2.).
Infatti, nell’art. 70 della legge italiana sul diritto d’autore (
L’art. 70 l. n. 633/1941 così recita “Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico
sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o
di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità
illustrative e per fini non commerciali”) il legislatore italiano si è limitato
a sancire il libero riassunto, la citazione o la riproduzione dell’opera e la
loro comunicazione al pubblico, purché:
1) vi ricorra una finalità di critica, discussione, insegnamento
o ricerca scientifica, così da garantire l’informazione e la diffusione della
cultura, in quanto si permette la libera fruibilità dei concetti esposti
nell’opera. La dottrina precisa che si ha “uso di critica”, quando
l’utilizzazione è finalizzata ad esprimere opinioni protette dagli artt. 21 e 33
Cost.;
2) l’opera critica abbia fini autonomi e distinti da quelli
dell’opera citata e non sia succedanea dell’opera o delle sue utilizzazioni
derivate;
3) l’utilizzazione non sia di dimensioni tali da supplire
all’acquisto dell’opera, pertanto l’utilizzazione non debba essere
concorrenziale a quella posta dal titolare dei diritti e idonea a danneggiare
gli interessi patrimoniali esclusivi dell’autore o del titolare di diritti; 4)
siano rispettate le menzioni d’uso, quali l’indicazione del titolo dell’opera da
cui è tratta la citazione o la riproduzione, il nome dell’autore e dell’editore.
Dottrina e giurisprudenza concordano che anche questa disposizione normativa sia
del tutto eccezionale, cosicché non può essere applicata per analogia, ma deve
essere interpretata restrittivamente.
Informazioni e notizie giornalistiche.
L’art. 101, infine, tutela le informazioni e le notizie giornalistiche,
stabilendo che sono liberamente riproducibili altrove, purché non si ricorra ad
“atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e (…) se ne citi la
fonte”. In questo primo comma, il legislatore non ha definito gli atti contrari,
ma ha fatto rinvio alle regole di correttezza professionale, fissate nel codice
deontologico dell’attività giornalistica, lasciando al giudice il compito di
decidere, in merito ai casi concreti per i quali è chiamato a giudicare, se quel
comportamento è scorretto o meno. (L’art. 101 co. 1 l. n. 633/1941 sancisce che
“La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata
con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e
purché se ne citi la fonte”). Tuttavia, il legislatore colma la genericità del
primo comma con il secondo, nel quale specifica alcuni comportamenti che, senza
alcun dubbio, costituiscono atti di concorrenza sleale: per esempio, la
riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di
informazioni distribuiti dalle agenzie, prima che siano trascorse sedici ore
dalla diramazione del bollettino stesso a coloro che ne hanno diritto, oppure
prima che l’editore autorizzato abbia pubblicato la notizia; il c.d.
“parassitismo giornalistico”, che si ha nel caso in cui il giornalista scorretto
effettua la riproduzione o la radiodiffusione sistematica di informazioni e
notizie, attingendo da altri giornali o fonti, che svolgono un’attività
giornalistica a fine di lucro. Tutte queste pratiche scorrette sono sanzionate
dalla legge con l’arresto dell’attività di concorrenza, con la rimozione degli
effetti dell’illecito, con la condanna al risarcimento dei danni e la
pubblicazione della sentenza. (L’art. 101 co. 2 l. n. 633/1941 così recita “Sono
considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza
autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie
giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla
diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in
un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte
dell'agenzia. A tal fine, affinché le agenzie abbiano azione contro coloro che
li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti
dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; b) la riproduzione
sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di
lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di
radiodiffusione”).
CRONACA, INDAGINE GIORNALISTICA E ANALISI SOCIALE.
Quando accade un fatto di rilievo pubblico, un ruolo fondamentale
è svolto dal cronista, il quale giunge presso il luogo del fatto per raccontare
gli avvenimenti così come accadono, nella loro precisa successione cronologica,
realizzando un’attività di testimonianza diretta o indiretta. Distinta dalla
mera cronaca è l’inchiesta giornalistica, la quale parte da fatti di cronaca per
svolgere un’attività di indagine, c.d. “indagine giornalistica”, con la quale il
professionista si informa, chiede chiarimenti e spiegazioni. Questa attività
rientra nel c.d. “giornalismo investigativo” o “d’inchiesta”, riconosciuto dalla
Cassazione nel 2010 come “la più alta e nobile espressione dell’attività
giornalistica”, perché consente di portare alla luce aspetti e circostanze
ignote ai più e di svelare retroscena occultati, che al contempo sono di
rilevanza sociale. A seguito dell’attività d’indagine, il giornalista svolge poi
l’attività di studio del materiale raccolto, di verifica dell’attendibilità di
fonti non generalmente attendibili, diverse dalle agenzie di stampa, di
confronto delle fonti. Solo al termine della selezione del materiale conseguito,
il giornalista inizia a scrivere il suo articolo. (Cass., 9 luglio 2010, n.
16236, in Danno e resp., 2010, 11, p. 1075. In questa sentenza la Corte Suprema
precisa che “Con tale tipologia di giornalismo (d’inchiesta), infatti,
maggiormente, si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro
intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie
destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli
organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di
tematiche notevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”). Dunque, appare
evidente che, diversamente dal giornalismo tradizionale, il quale attinge le
notizie da fonti ufficiali e istituzionali perché si dia informazione sui fatti,
il giornalismo d’inchiesta impiega mesi e mesi per sviluppare e preparare
un’indagine giornalistica in quanto approfondisce aspetti e circostanze su fatti
socialmente rilevanti, così da indurre il lettore a riflettere e formare la
propria opinione, seppure diversa da quella letta sul giornale. L’inchiesta,
pertanto, mette in rilievo problemi sociali o vicende politiche attuali e
consente di compiere un’analisi sociale. L’inchiesta e la cronaca sono tipologie
giornalistiche che si distinguono da “Gomorra”, la quale è a tutti gli effetti
un’opera letteraria, che racchiude diversi generi, come “il romanzo, il saggio,
la cronaca giornalistica, il pamphlet”. Dunque, accanto alla cronaca
giornalistica, che consiste nel narrare fatti realmente accaduti “secondo la
successione cronologica, senza alcun tentativo di interpretazione o di critica
degli avvenimenti”, vi è il romanzo, un componimento letterario in prosa, di
ampio sviluppo, frutto della creazione fantastica dell’intelletto dell’autore;
il saggio, un componimento relativamente breve, nel quale l’autore “tratta con
garbo estroso e senza sistematicità argomenti vari (di letteratura, di
filosofia, di costume, ecc.), rapportandoli strettamente alle proprie esperienze
biografiche e intellettuali, ai propri estri umorali, alle proprie idee o al
proprio gusto”; e per finire il pamphlet, definito come un “breve scritto di
carattere polemico o satirico”.
Io sono un
Aggregatore di contenuti di ideologia contrapposta con citazione della fonte.
Il World Wide
Web (WWW o semplicemente "il Web") è un mezzo di comunicazione globale che gli
utenti possono leggere e scrivere attraverso computer connessi a Internet,
scrive Wikipedia. Il termine è spesso erroneamente usato come sinonimo di
Internet stessa, ma il Web è un servizio che opera attraverso Internet.
La storia del World Wide Web è dunque molto più breve di quella di Internet:
inizia solo nel 1989 con la proposta di un "ampio database intertestuale con
link" da parte di Tim Berners-Lee ai propri superiori del CERN; si sviluppa in
una rete globale di documenti HTML interconnessi negli anni novanta; si evolve
nel cosiddetto Web 2.0 con il nuovo millennio. Si proietta oggi, per iniziativa
dello stesso Berners-Lee, verso il Web 3.0 o web semantico.
Sono passati
decenni dalla nascita del World Wide Web. Il concetto di accesso e condivisione
di contenuti è stato totalmente stravolto. Prima ci si informava per mezzo dei
radio-telegiornali di Stato o tramite la stampa di Regime. Oggi, invece,
migliaia di siti web di informazione periodica e non, lanciano e diffondono un
flusso continuo di news ed editoriali. Se prima, per la carenza di informazioni,
si sentiva il bisogno di essere informati, oggi si sente la necessità di cernere
le news dalle fakenews, stante un così forte flusso d’informazioni e la facilità
con la quale ormai vi si può accedere.
Oggi abbiamo
la possibilità potenzialmente infinita di accedere alle informazioni che ci
interessano, ma nessuno ha il tempo di verificare la veridicità e la fondatezza
di quello che ci viene propinato. Tantomeno abbiamo voglia e tempo di cercare
quelle notizie che ci vengono volutamente nascoste ed oscurate.
Quando parlo
di aggregatori di contenuti non mi riferisco a coloro che, per profitto,
riproducono integralmente, o quasi, un post o un articolo. Costoro non sono
che volgari “produttori” di plagio, pur citando la fonte. E contro questi ci
sono una legge apposita (quella sul diritto d’autore, in Italia) e una
Convenzione Internazionale (quella di Berna per
la protezione delle opere letterarie e artistiche). Tali norme vietano
esplicitamente le pratiche di questi aggregatori.
Ci sono
Aggregatori di contenuti in Italia, che esercitano la loro attività in modo
lecita, e comunque, verosimilmente, non contestata dagli autori aggregati e
citati.
Vedi Giorgio dell’Arti su “Cinquantamila.it”. LA STORIA
RACCONTATA DA GIORGIO DELL'ARTI. “Salve. Sono Giorgio Dell’Arti. Questo sito è
riservato agli abbonati della mia newsletter, Anteprima. Anteprima è la spremuta
di giornali che realizzo dal lunedì al venerdì la mattina all’alba, leggendo i
quotidiani appena arrivati in edicola. La rassegna arriva via email agli utenti
che si sono iscritti in promozione oppure in abbonamento qui o sul
sito anteprima.news.
Oppure come fa Dagospia o altri siti di informazione online, che
si limitano a riportare quegli articoli che per motivi commerciali o di
esclusività non sono liberamente fruibili.
Dagospia. Da
Wikipedia. Dagospia è una pubblicazione web di rassegna stampa e retroscena su
politica, economia, società e costume curata da Roberto D'Agostino, attiva dal
22 maggio 2000. Dagospia si definisce "Risorsa informativa online a contenuto
generalista che si occupa di retroscena. È espressione di Roberto
D'Agostino". Sebbene da alcuni sia considerato un sito di gossip, nelle parole
di D'Agostino: «Dagospia è un bollettino d'informazione, punto e basta». Lo
stile di comunicazione è volutamente chiassoso e scandalistico; tuttavia
numerosi scoop si sono dimostrati rilevanti esatti. L'impostazione grafica della
testata ricorda molto quella del news aggregator americano Drudge Report, col
quale condivide anche la vocazione all'informazione indipendente fatta
di scoop e indiscrezioni. Questi due elementi hanno contribuito a renderlo un
sito molto popolare, specialmente nell'ambito dell'informazione italiana: il
sito è passato dalle 12 mila visite quotidiane nel 2000 a una media di 600 mila
pagine consultate in un giorno nel 2010. A partire da febbraio 2011 si finanzia
con pubblicità e non è necessario abbonamento per consultare gli archivi. Nel
giugno 2011 fece scalpore la notizia che Dagospia ricevesse 100 mila euro
all'anno per pubblicità all'Eni grazie all'intermediazione del faccendiere Luigi
Bisignani, già condannato in via definitiva per la maxi-tangente Enimont e di
nuovo sotto inchiesta per il caso P4. Il quotidiano la Repubblica, riportando le
dichiarazioni di Bisignani ai pubblici ministeri sulle soffiate a Dagospia, la
definì “il giocattolo” di Bisignani. Dagospia ha querelato la Repubblica per
diffamazione.
Popgiornalismo. Il caso e la post-notizia. Un libro di Salvatore
Patriarca. Con le continue trasformazioni dell’era digitale, diventa sempre più
urgente mettere a punto dinamiche comunicative che sappiano muoversi con la
stessa velocità con la quale viaggia la trasmissione dei dati e che,
soprattutto, riescano a sviluppare capacità connettive in grado di ricomprendere
un numero sempre maggiore di dati-fatti-informazioni. Partendo dal fenomeno
giornalistico rappresentato da Dagospia – il sito di Roberto D’Agostino che ha
saputo cogliere, sin dagli albori, le possibilità offerte dal mezzo digitale –
il libro analizza i caratteri di una nuova forma giornalistica, il
popgiornalismo. Al centro di questa recente declinazione informativa non c’è più
la notizia ma la post-notizia, la necessità cioè di lavorare sulle connessioni e
sugli effetti che ogni nuovo fatto, evento o dato determina. Da qui ne
conseguono i tre tratti essenziali dell’approccio popgiornalistico: la
“leggerezza” pesante dell’informazione, la conoscenza del quotidiano come opera
aperta e la libera responsabilità del lettore.
Addirittura il
portale web “Newsstandhub.com” riporta tutti gli articoli dei portali di
informazione più famosi con citazione della fonte, ma non degli autori. Si
presenta come: “Il tuo centro edicola personale dove poter consultare tutte le
notizia contemporaneamente”.
Così come il
sito web di Ristretti.org o di Antimafiaduemila.com.
Diritto di
cronaca, dico, che non ha alcuna limitazione se non quella della verità,
attinenza-continenza, interesse pubblico. Diritto di cronaca su Stampa non
periodica.
Che cosa significa "Stampa non periodica"?
Ogni forma di
pubblicazione una tantum, cioè che non viene stampata regolarmente (è tale, ad
esempio, un saggio o un romanzo in forma di libro).
Stampa non
periodica, perché la Stampa periodica è di pertinenza esclusiva della lobby dei
giornalisti, estensori della pseudo verità, della disinformazione, della
discultura e dell’oscurantismo.
Con me la
cronaca diventa storia ed allora il mio diritto di cronaca diventa diritto di
critica storica.
La critica
storica può scriminare la diffamazione. Cassazione penale, sez. V, sentenza
10/11/2016 n° 47506. L'esercizio del diritto di critica può, a certe condizioni,
rendere non punibile dichiarazioni astrattamente diffamatorie, in quanto lesive
dell'altrui reputazione.
Resoconto esercitato nel pieno diritto di Critica Storica. La
critica storica può scriminare la diffamazione. Cassazione penale, sez. V,
sentenza 10/11/2016 n° 47506.
La ricerca
dello storico, quindi, comporta la necessità di un’indagine complessa in cui
“persone, fatti, avvenimenti, dichiarazioni e rapporti sociali divengono oggetto
di un esame articolato che conduce alla definitiva formulazione di tesi e/o di
ipotesi che è impossibile documentare oggettivamente ma che, in ogni caso
debbono trovare la loro base in fonti certe e di essere plausibili e
sostenibili”.
La critica
storica, se da una parte può scriminare la diffamazione. Cassazione penale, sez.
V, sentenza 10/11/2016 n° 47506, dall'altra ha funzione di discussione: "Il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera".
Certamente le mie opere nulla hanno a che spartire con le opere
di autori omologati e conformati, e quindi non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera altrui. Quindi questi sconosciuti
condannati all'oblio dell'arroganza e della presunzione se ne facciano una
ragione.
Ed anche se fosse che la mia cronaca, diventata storia, fosse
effettuata a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo che
dovrebbe inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali è
pienamente compiuto, essendo io autore ed editore medesimo delle mie opere e la
divulgazione è per mero intento di conoscenza e non per fini commerciali, tant’è
la lettura può essere gratuita e ove vi fosse un prezzo, tale è destinato per
coprirne i costi di diffusione.
Valentina Tatti Tonni soddisfatta su Facebook il 20 gennaio 2018
". "Ho appena saputo che tre dei miei articoli pubblicati per "Articolo 21" e
"Antimafia Duemila" sono stati citati nel libro del sociologo Antonio
Giangrande che ringrazio. Gli articoli in questione sono, uno sulla
riabilitazione dei cognomi infangati dalle mafie (ripreso giusto oggi da
AM2000), uno sulla precarietà nel giornalismo e il terzo, ultimo pubblicato in
ordine di tempo, intitolato alla legalità e contro ogni sistema criminale".
Linkedin lunedì 28 gennaio 2019 Giuseppe T. Sciascia ha inviato
il seguente messaggio (18:55)
Libro. Ciao! Ho trovato la citazione di un mio pezzo nel tuo
libro. Grazie.
Citazione: Scandalo molestie: nuove rivelazioni bomba, scrive
Giuseppe T. Sciascia su “Il Giornale" il 15 novembre 2017.
Facebook-messenger 18 dicembre 2018 Floriana Baldino ha inviato
il seguente messaggio (09.17)
Buon giorno, mi sono permessa di chiederLe l'amicizia perchè con
piacevole stupore ho letto il mio nome sul suo libro.
Citazione: Pronto? Chi è? Il carcere al telefono, scrive il 6
gennaio 2018 Floriana Bulfon su "La Repubblica". Floriana Bulfon - Giornalista
de L'Espresso.
Facebook-messenger 3 novembre 2018 Maria Rosaria Mandiello ha
inviato il seguente messaggio (12.53)
Salve, non ci conosciamo, ma spulciando in rete per curiosità, mi
sono imbattuta nel suo libro-credo si tratti di lei- "abusopolitania: abusi sui
più deboli" ed ho scoperto con piacere che lei m ha citata riprendendo un mio
articolo sul fenomeno del bullismo del marzo 2017. Volevo ringraziarla, non è da
tutti citare la foto e l'autore, per cui davvero grazie e complimenti per il
libro. In bocca a lupo per tutto! Maria Rosaria Mandiello.
Citazione: Ragazzi incattiviti: la legge del bullismo, scrive
Maria Rosaria Mandiello su "ildenaro.it" il 24 marzo 2017.
NON CI SI PUO’ SOTTRARRE ALLE CRITICHE ONLINE.
Tribunale di Roma (N. R.G. 81824/2018 Roma, 1 febbraio 2019
Presidente dott. Luigi Argan): non ci si può sottrarre alle critiche online,
scrive Guido Scorza 28 febbraio 2019 su l'Espresso. In un’epoca nella quale la
libertà di parola, specie online, sembra condannata a dover sistematicamente
cedere il passo a altri diritti e a contare davvero poco, un raggio di libertà,
arriva dal Tribunale di Roma che, nei giorni scorsi, ha rispedito al mittente le
domande di un chirurgo plastico che aveva chiesto, in via d’urgenza, ai Giudici
di ordinare a Google di sottrarre il proprio studio dalle recensioni del
pubblico o, almeno, di cancellare quattro commenti particolarmente negativi
ricevuti da pazienti e amici di pazienti. Secondo la prima sezione del
Tribunale, infatti, il diritto di critica viene prima dell’interesse del singolo
a non veder la propria attività professionale compromessa da qualche recensione
negativa e nessuno ha diritto, nel momento in cui esercita un’attività
professionale o commerciale, a pretendere di essere sottratto al rischio che
terzi, ovviamente dicendo la verità e facendolo in maniera educata, lo
critichino. E questo, secondo i Giudici, è quanto accaduto nel caso in
questione. Il chirurgo in questione non può né pretendere che Google rinunci a
mettere a disposizione degli utenti un servizio che consente, tra l’altro, la
raccolta di “recensioni” sulla propria attività né che non consenta agli utenti
di pubblicare commenti negativi o che cancelli quelli pubblicati. Ma non basta.
Il Tribunale di Roma mette nero su bianco un principio tanto semplice quanto
spesso ignorato: non può toccare a Google sorvegliare che i propri utenti non
pubblichino recensioni negative perché Google non ha, né può avere, alla stregua
della disciplina europea della materia, alcun obbligo generale di sorveglianza
sui contenuti pubblicati da terzi. Google – e il Giudice lo scrive con
disarmante chiarezza – ha il solo obbligo di rimuovere un contenuto quando la
sua pubblicazione sia accertata come illecita da un Giudice e la notizia gli sia
comunicata. E a leggere l’Ordinanza con la quale il Giudice ha respinto le
domande d’urgenza proposte dal chirurgo vien davvero da pensare che tutti
dovremmo iniziare a imparare ad accettare le critiche con spirito costruttivo e
come stimolo a far meglio in futuro anziché investire ogni energia nel tentativo
– vano, fortunatamente, in questa vicenda – di condannare all’oblio le opinioni
di chi, su di noi, si è fatto, a torto o a ragione, ma dicendo la verità,
un’idea che semplicemente non ci piace. Che un professionista, in piena società
dell’informazione, davanti a un cliente – per di più suo paziente – che pubblica
critiche del tipo “lavoro mal fatto, senza impegno e senza amore per la sua
professione” o “Pessimo, assolutamente non idoneo a trattamenti di chirurgia
estetica”, anziché fare autocritica non trovi niente di meglio da fare che
correre davanti a un Giudice a domandare di trattare le parole altrui come carta
straccia, da gettare di corsa nel tritacarta, è circostanza preoccupante.
Probabilmente la volatilità tecnologica dei bit ci ha persuasi che le opinioni,
le parole e le idee del prossimo valgano poco per davvero. Bene, dunque, hanno
fatto i Giudici a ricordare che la critica è costituzionalmente garantita e che
ci vuol ben altro che il rammarico di un chirurgo per qualche recensione poco
lusinghiera – peraltro tra tante altre positive – per pretendere di veder
cancellate, a colpi di spugna, le opinioni altrui.
·
La Credibilità.
Caratteristiche della credibilità di una persona.
Da Pensiero Critico.
Cos'è la credibilità. Quando ci troviamo di fronte a una persona
elaboriamo sempre un giudizio sulla sua credibilità, e spesso siamo indotti a
pensare che essa sia una proprietà intrinseca di quella persona. Secondo il
sociologo Guido Gili (2005, La credibilità) la riflessione psicologica e
sociologica contemporanea ha modificato questa prospettiva, proponendo che la
credibilità sia qualcosa che viene riconosciuto dagli altri, anche se essa non
può prescindere da qualità effettivamente possedute da quella persona. Ecco la
definizione data da Gili (p.4): La credibilità è sempre una relazione tra
emittente e ricevente/pubblico, per cui una credibilità universale ed un
discredito universale sono i poli estremi di un continuum sul quale si collocano
concretamente tante forme e modi diversi di credibilità. Spesso chi è credibile
presso un interlocutore o un pubblico non lo è nello stesso modo e per le stesse
ragioni presso un altro, come mostra, in modo estremo ed evidentissimo, il caso
di molti leader carismatici. Per i loro seguaci rappresentano delle personalità
eccezionali, dotate di qualità quasi sovrumane e di una credibilità illimitata;
per gli altri possono apparire come degli esaltati, dei pazzi o dei criminali.
Il punto chiave. La credibilità non è una caratteristica
intrinseca della fonte, ma è una relazione. (Guido Gili).
La credibilità è soggettiva. La credibilità che attribuiamo a una
persona non è "oggettiva" ma "soggettiva": dipende da come la nostra mente è
fatta in termini di ricordi, emozioni, esperienze, capacità logiche, ecc. Il
problema della credibilità di una persona non si pone nei rapporti di
familiarità perchè le lunghe frequentazioni permettono di maturarla e
sperimentarla nel tempo (anche la familiarità, comunque, non è esente da rischi
perchè espone alla manipolazione). Il problema della credibilità di una persona
si pone soprattutto nelle relazioni caratterizzate da livelli crescenti di
estraneità e talvolta richiede, affinchè una relazione possa iniziare,
una anticipazione di credibilità.
Nel valutare le condizioni per accordare tale anticipazione entra
in gioco il concetto di fiducia. Nel valutare le condizioni per accordare tale
anticipazione entra in gioco il concetto di fiducia che è complementare alla
credibilità, nel senso che si può parlare di fiducia solo quando l'altra persona
è libera di tradirla (non vincolata da norme o imposizioni). Come ha scritto il
sociologo Niklas Luhman (Le strategie della fiducia, Einaudi pp.131-132)"la
fiducia non nasce da un pericolo intrinseco ma dal rischio. [...] Ciò che
determina il rischio è un calcolo puramente interiore delle condizioni esterne.
[...]". Vi sono molti concetti legati alla credibilità (affidabilità,
attendibilità, reputazione, ecc.) dei quali è opportuno conoscere le proprietà e
individuare le differenze.
Credibilità dei politici italiani. Credibilità del ruolo e
credibilità nel ruolo. Quando comunichiamo non siamo quasi mai individui
generici ma, la maggior parte delle volte, ci portiamo dietro un ruolo specifico
riconosciuto dalla società: padre, insegnante, medico, manager, politico,
operaio, ecc. I diversi ruoli professionali posseggono già, di per sè, una
credibilità riconosciuta: la credibilità del ruolo che influenza positivamente o
negativamente la nostra percezione dell'altro. Insieme a questo tipo di
credibilità ve ne è però uno più pertinente alla persona che stiamo valutando ed
è la credibilità nel ruolo. Essa equivale al modo in cui quella specifica
persona interpreta quel ruolo, con i suoi personali pregi e difetti. Questi due
tipi di credibilità si influenzano e, di solito, se si ha un ruolo socialmente
credibile si tende a interpretarlo in modo da rafforzarlo. Talvolta ciò non
accade: ad esempio in Italia, negli ultimi anni, il patrimonio di credibilità
del ruolo politico è stato sperperato da comportamenti personali discutibili sul
piano etico (vedere ad esempio: G.Stella, S.Rizzo, La Casta - Perchè i politici
italiani continuano a essere intoccabili 2007 Rizzoli). Dunque, a fronte del
discredito della credibilità del ruolo, i politici (se sono eticamente dotati),
dovranno impegnarsi di più nella loro credibilità nel ruolo per sperare che
l'altro tipo di credibilità possa essere recuperato.
Radici della credibilità. Secondo Gili (p.7) le radici della
credibilità, che i riceventi cercano nelle persone, sono tre:
radice cognitiva: è la competenza o qualifica riconosciuta
di esperto.
radice etico-normativa: è la condivisione di valori percepiti
(pregiudizi inclusi).
radice affettiva: è la condivisione emotiva di appartenenza (a un
gruppo, un'associazione, un partito, ecc).
Verifica della credibilità di una persona sul Web. Il web offre
la possibilità di verificare rapidamente la credibilità di una persona (la sua
reputazione), attraverso: i commenti postati sui blog/forum, le menzioni
ricevute da altri soggetti, le immagini postate sui social networks, ecc. Questa
possibilità può diventare un rischio per chi pubblica incautamente informazioni
che lo riguardano, perchè spesso esistono scostamenti tra l'identità personale e
l'identità digitale della stessa persona, dovuti al modo in cui
la personalità dell'individuo viene "costruita" in rete. Tale problema ha dato
luogo alla creazione di una nuova figura professionale: quella dell'"online
reputation manager". Naturalmente ciò riguarda soprattutto le persone che hanno
una immagine pubblica da difendere, ma ciò diventerà una necessità anche per le
persone comuni. Quando la credibilità online di una persona viene danneggiata
(dai suoi comportamenti reali o da quelli di altri) esiste la possibilità che
essa si rivolga a un servizio di ricostruzione della propria reputazione
digitale. Alle persone "normali", consigliamo di attuare i consigli suggeriti
dall'articolo "Google e web, come gestire la reputazione online". Per chi
volesse fare qualcosa in più Susan Adams ha pubblicato su Forbes sei utili
consigli per gestire la propria reputazione online nel seguente articolo: "6
Steps To Managing Your Online Reputation". Esistono peraltro servizi rivolti a
persone che hanno molto da nascondere e desiderano rifarsi una verginità online,
ad esempio i politici: ecco un esempio di azienda che offre una "web reputation
per politici" che li "ripulisce" prima di affrontare una campagna elettorale.
Monitoraggio online. Esistono servizi di "ricostruzione" della
reputazione online in grado di innalzare fittiziamente la credibilità di
soggetti che hanno molto da nascondere. Ciò rende più faticosa la valutazione
della credibilità online di coloro che hanno le risorse per accedere a tali
servizi, quali: politici, imprenditori, aziende, ecc.
Patologie della credibilità. Generalmente, se nel corso della
nostra vita abbiamo vissuto in ambienti con buone relazioni interpersonali,
tendiamo ad accordare alla "gente" una fiducia generalizzata. L'influsso
esercitato dal sistema mediatico sul singolo individuo dipende non solo
dall'efficacia comunicativa dei media, ma anche dalla vulnerabilità del
singolo. La mancanza di fiducia o l'eccesso di fiducia rientrano tra le
patologie della credibilità, e si collocano ai due estremi dell'asse della
fiducia. In tali patologie le persone possono avere un atteggiamento di sospetto
generalizzato o, all'opposto, un atteggiamento di credulità senza limiti.
I vari gradi della fiducia si trovano tra due estremi: il
sospetto generalizzato e la credulità senza limiti.
Teoria della coltivazione (dei telespettatori).
Eccesso di sospetto. Nella costruzione della fiducia, in mancanza
di situazioni di familiarità, influiscono anche le rappresentazioni della
società offerte dai mezzi di comunicazione di massa, ad esempio l'esposizione
alla violenza nelle fiction in TV (più che nelle news). Secondo una ricerca
pionieristica di George Gerbner (1976), la violenza in TV produce la convinzione
che anche nella propria realtà sociale vi sia violenza e che esista un'alta
probabilità di rimanerne vittima. Gerbner propose una teoria (Cultivation
theory) nella quale la Televisione, anzichè essere una occasione di riflessione
sul mondo reale, può sostituirsi alla realtà nelle persone che si espongono per
molte ore al giorno ai suoi programmi. Secondo questa teoria le persone vengono
"coltivate" fin dall'infanzia ad accettare storie, preferenze, messaggi dalla TV
anzichè dalle persone reali del loro ambiente sociale. La teoria della
coltivazione ha ricevuto molte critiche per le modalità di svolgimento delle
interviste ma, nonostante ciò, rimane un'ipotesi sociale che mantiene un elevato
grado di credibilità.
Eccesso di credulità. Riguardo alla credulità fanno riflettere i
metodi usati da Kevin.D. Mitnick, un famoso hacker statunitense, per carpire
informazioni riservate (L'arte dell'inganno, 2002 Feltrinelli). Mitnick ha
dimostrato che l'anello debole della sicurezza dei sistemi informatici (anche i
più sofisticati) non è di natura tecnologica ma è il fattore umano. Egli
riusciva a procurarsi le informazioni più riservate semplicemente...
chiedendole, cioè sfruttando la credulità delle persone. Egli aveva la capacità
di rendersi credibile a interlocutori che non aveva mai visto nè sentito prima.
Questa capacità è stata chiamata ingegneria sociale (social engineering) e
consiste nel raccogliere informazioni sulla vittime (spesso per telefono) per
poi arrivare all'attacco vero e proprio (di solito di natura informatica).
L'ingegneria sociale impiega metodi quali: nascondere la propria identità,
mentire, ingannare, rendersi credibili e sfrutta alcune tendenze generali
dell'essere umano: il desiderio di rendersi utile, la tendenza alla credulità,
la paura di mettersi nei guai (se non rispondono alle richieste). Nel suo libro
Mitnick, che ora fa il consulente di sicurezza alle aziende, descrive nel
dettaglio in che modo vengono effettuati i tentativi di manipolazione e come
imparare a difendersi.
·
L’Involuzione
sociale e politica. Dal dispotismo all’illuminismo, fino all’oscurantismo.
Non è importante sapere quanto la democrazia rappresentativa
costi, ma quanto essa rappresenti ed agisca nel nome e per conto dei
rappresentati.
Dispotismo:
dispotismo (raro despotismo) s. m. [der. di despota e dispotico]. – Governo
esercitato da una sola persona o da un ristretto gruppo di persone in modo
assolutistico e arbitrario, senza alcun rispetto per la legge. In particolare e
detto Dispotismo illuminato, quello dei sovrani riformatori del 18° secolo,
ispirato alle teorie politiche e filosofiche dell’illuminismo francese
(esaltazione della Ragione, accettazione dell’assolutismo come forma di governo,
ecc.). In senso estensivo e figurativo: autorità che si esercita in modo
prepotente, oppressivo; atteggiamento ispirato a estremo autoritarismo, a
noncuranza o a disprezzo degli altrui diritti.
La teoria
di Montesquieu: Lo Stato e la suddivisione dei poteri.
La moderna
teoria della separazione dei poteri viene tradizionalmente associata al nome
di Montesquieu. Il filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato
nel 1748, fonda la sua teoria sull'idea che "Chiunque abbia potere è portato ad
abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti [...]. Perché non si possa
abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il potere". Individua,
inoltre, tre poteri (intesi come funzioni) dello Stato - legislativo, esecutivo
e giudiziario - così descritti: "In base al primo di questi poteri,
il principe o il magistrato fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e
corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo, fa la pace o la guerra,
invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni.
In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti dei privati", perché “una
sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica”. L'idea che la divisione
del potere sovrano tra più soggetti sia un modo efficace per prevenire abusi è
molto antica nella cultura occidentale: già si rinviene nella riflessione
filosofica sulle forme di governo della Grecia classica, dove il
cosiddetto governo misto era visto come antidoto alla possibile degenerazione
delle forme di governo "pure", nelle quali tutto il potere è concentrato in un
unico soggetto. Platone, nel dialogo La Repubblica, già parlò di indipendenza
del giudice dal potere politico. Aristotele, nella Politica, delineò una forma
di governo misto, da lui denominata politìa (fatta propria poi anche da Tommaso
d'Aquino), nella quale confluivano i caratteri delle tre forme semplici da lui
teorizzate (monarchia, aristocrazia, democrazia); distinse, inoltre, tre momenti
nell'attività dello Stato: deliberativo, esecutivo e giudiziario. Polibio,
nelle Storie, indicò nella costituzione di Roma antica un esempio di governo
misto, in cui il potere era diviso tra istituzioni democratiche (i comizi),
aristocratiche (il Senato) e monarchiche (i consoli). Nel XIII secolo Henry de
Bracton, nella sua opera De legibus et consuetudinibus Angliæ, introdusse la
distinzione tra gubernaculum e iurisdictio: il primo è il momento "politico"
dell'attività dello Stato, nel quale vengono fatte le scelte di governo,
svincolate dal diritto; il secondo è, invece, il momento "giuridico", nel quale
vengono prodotte e applicate le norme giuridiche, con decisioni vincolate al
diritto (che, secondo la concezione medioevale, è prima di tutto diritto di
natura e consuetudinario). È però con John Locke che la teoria della separazione
dei poteri comincia ad assumere una fisionomia simile all'attuale: i pensatori
precedenti, infatti, pur avendo individuato, da un lato, diverse funzioni dello
Stato e pur avendo sottolineato, dall'altro lato, la necessità di dividere il
potere sovrano tra più soggetti, non erano giunti ad affermare la necessità di
affidare ciascuna funzione a soggetti diversi. Locke, nei Due trattati sul
governo del 1690, articola il potere sovrano in potere legislativo, esecutivo
(che comprende anche il giudiziario) e federativo (relativo alla politica estera
e alla difesa), il primo facente capo al parlamento e gli altri due
al monarca (al quale attribuisce anche il potere, che denomina prerogativa, di
decidere per il bene pubblico laddove la legge nulla prevede o, se necessario,
contro la previsione della stessa).
La Teoria
di Voltaire: Tolleranza e Libertà di manifestazione del pensiero.
La libertà
di esprimere le proprie convinzioni e le proprie idee è una delle libertà più
antiche, essendo sorta come corollario della libertà di religione, rivendicata
dai primi scrittori cristiani nel corso del II-III secolo e, successivamente,
durante i conflitti tra cattolici e protestanti (XVI-XVII secolo). D’altra
parte, essa è stata sollecitata anche dai grandi teorici della libertà di
ricerca scientifica (basti pensare a Cartesio o a Galileo) e della libertà
politica (ad esempio, Milton), nonché, successivamente, dagli stessi filosofi
del XVIII e del XIX secolo (Voltaire, Fichte, Bentham, Stuart Mill). Va detto,
comunque, che soltanto in alcuni documenti costituzionali si parla di libertà di
manifestazione del pensiero (art. 8 Cost. Francia 1848; art. 21 Cost.), laddove
in altri testi si preferisce utilizzare l’espressione libertà di opinione (art.
11 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese 1789; art. 8
Cost. Francia 1814; art. 7 Cost. Francia 1830; tit. VI, art. IV, par. 143, Cost.
Francoforte 1849; art. 118 Cost. Germania 1919; art. 5 Legge fondamentale
Germania 1949; art. 20 Cost. Spagna 1978; art. 16 Cost. Svizzera 1999), libertà
di parola (I emendamento Cost. U.S.A. 1787) o libertà di stampa (art. 18 Cost.
Belgio 1831; art. 28 Statuto albertino).
La Teoria di
Voltaire. Voltaire non credeva che la Francia (e in generale ogni nazione) fosse
pronta a una vera democrazia: perciò, non avendo fiducia nel popolo (a
differenza di Rousseau, che credeva nella diretta sovranità popolare), non
sostenne mai idee repubblicane né democratiche; benché, dopo la morte, sia
divenuto uno dei "padri nobili" della Rivoluzione, celebrato dai rivoluzionari,
è da ricordare che alcuni collaboratori e amici di Voltaire finirono vittime
dei giacobini durante il regime del Terrore, tra essi Condorcet e Bailly). Per
Voltaire, chi non è stato "illuminato" dalla ragione, istruendosi ed elevandosi
culturalmente, non può partecipare al governo, pena il rischio di finire
nella demagogia. Ammette comunque la democrazia rappresentativa e la divisione
dei poteri proposta da Montesquieu, come realizzate in Inghilterra, ma non
quella diretta, praticata a Ginevra. Nel Trattato sulla tolleranza il filosofo
denuncia le conseguenze dell’intolleranza e si scaglia, in particolare, contro
il cristianesimo. Secondo Voltaire bisogna abbandonare il fanatismo delle
religioni storiche e abbracciare unicamente una religione razionale che si basi
sull’obbedienza a Dio e sull’esercizio del bene. Essere tolleranti significa,
per Voltaire: accettare la diversità e le comuni fragilità, rifiutare la tortura
e la pena di morte e abbracciare una fede pacifista e cosmopolita. L'idea di
tolleranza di Voltaire. Tutta la polemica di Voltaire contro le ingiustizie
sociali, la superstizione, il fanatismo è esemplificata nella sua difesa del
principio della tolleranza. Nella sua opera più importante, il Trattato sulla
tolleranza, infatti, il filosofo parte da un fatto di cronaca (un processo
concluso con la condanna a morte di un protestante di Tolosa) per denunciare
globalmente le conseguenze dell’intolleranza, ed in particolare si scaglia
contro il cristianesimo. «I cristiani sono i più intolleranti degli uomini»,
o «la nostra (religione, n.d.r) è senza dubbio la più ridicola, la più assurda e
la più assetata di sangue mai venuta a infettare il mondo» scrive. Ma la sua
requisitoria è diretta contro tutte le religioni storiche che hanno tradito il
loro comune nucleo razionale, fatto di alcuni principi semplici e universalmente
condivisi e, attraverso l’istituzione di dogmi e riti particolari, si sono
macchiate di ogni tipo di crimine (dalle guerre alle persecuzioni). Abbandonare
dunque il dogmatismo e abbracciare una religione spogliata dei suoi
tratti esteriori e deleteri perché: «il deista non appartiene a nessuna di
quelle sette che si contraddicono tutte… egli parla una lingua che tutti i
popoli intendono… egli è persuaso che la religione non consiste né nelle
opinioni di una metafisica incomprensibile, né in vane cerimonie, ma
nell’adorazione e nella giustizia. Fare il bene è il suo culto: obbedire a Dio è
la sua dottrina». L’uomo deve accettare la diversità, i diversi punti di vista,
in quanto, secondo Voltaire, essere tolleranti significa accettare le comuni
fragilità: «Siamo tutti impastati di debolezze e errori: perdoniamoci
reciprocamente le nostre sciocchezze, è la prima legge di natura… Chiunque
perseguiti un altro suo fratello, perché non è della sua opinione, è un
mostro». La tolleranza deve animare qualunque tipo di potere politico
e Voltaire si scaglia, quindi, anche contro l’uso della tortura e della pena di
morte. Allo stesso modo attacca l’uso della religione per giustificare le guerre
e rigetta il nazionalismo in nome di una fede cosmopolita. La celebre frase:
«Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo
diritto a dirlo», a cui è legato indissolubilmente il nome di Voltaire, in
realtà non fu mai pronunciata dal filosofo. Appartiene, infatti, ad una saggista
(Evelyne Beatrice Hall) che scrisse e ricostruì la vita e le opere di Voltaire.
Ciononostante, sicuramente le prese di posizione del filosofo in merito non
scarseggiarono e, anche nella sua vita privata, soffriva profondamente delle
conseguenze dell’intolleranza degli uomini. Ogni anno, infatti, dedicava un
giorno al lutto e all’astensione da qualunque attività: il 24 agosto,
anniversario della notte di San Bartolomeo (una strage compiuta nel 1572 dalla
fazione cattolica ai danni dei calvinisti parigini), si dice che aggiornasse la
sua casistica dei morti nelle persecuzioni religiose arrivando a contarne 24/25
milioni. Ma la sua personalità non fu esente da contraddizioni: si batteva
contro le guerre e il pacifismo ma faceva affari lucrosi nel campo dei
rifornimenti all’esercito; era un paladino della tolleranza ma intrattenne degli
accesissimi diverbi con l’illuminista Rousseau che screditavano la validità di
tale principio; infine, celebri furono le prese di posizione sull’inferiorità
degli africani rispetto a scimmie e elefanti, oltre che all’uomo bianco.
Voltaire e l'illuminismo oscurato dalle catastrofi.
Commentando il terremoto di Lisbona del 1755 il filosofo rifletteva sui limiti
della ragione umana. Dino Cofrancesco, Sabato 11/04/2020 su Il Giornale. Mentre
nel mondo infuria il Covid-19, rileggersi Voltaire, come faceva il compianto
Piero Ostellino nei suoi ultimi anni, può essere un tonico per l'intelligenza e
un richiamo alla virile accettazione della realtà. Voltaire, è noto, rimase,
come i suoi contemporanei del resto - philosophes e uomini comuni - sconvolto
dal terremoto di Lisbona che nel 1755 provocò vittime e macerie non solo in
Europa ma, altresì, in Africa (nel regno di Fez). Nella sola capitale del
Portogallo crollarono ottanta edifici su cento e morirono sessantamila persone
su duecentomila. Il terribile evento ispirò al filosofo un poema di struggente
bellezza, Le désastre de Lisbonne (1756) che più di altri scritti, non meno
famosi, compendia la sua visione del mondo, della natura, degli uomini, di Dio.
Principe indiscusso dell'età dei Lumi, Voltaire è sempre meno letto o, almeno,
se ne conoscono alcune opere teatrali (sia pure indirettamente, ad esempio,
Semiramide, che ispirò il melodramma di Gioacchino Rossini, o Alzira, messa in
musica da Giuseppe Verdi), l'evergreen Trattato sulla tolleranza o il
celeberrimo Dizionario filosofico. Della sua vastissima produzione filosofica e
letteraria, però, si sa ormai poco. Per questo si è grati a Domenico Felice -
uno dei maggiori studiosi italiani di Voltaire e di Montesquieu - per aver
distillato il meglio delle riflessioni voltairiane sulla condizione umana in un
voluminoso ma godibilissimo Taccuino di pensieri. Vademecum per l'uomo del terzo
millennio (Mimesis, con una sobria e illuminante Prefazione di Ernesto Ferrero).
Gli ideari non sostituiscono la lettura diretta delle opere di un autore ma
attivano l'attenzione su quelle che interessano di più e di cui spesso non si
era nemmeno sentito parlare. In riferimento al tema della catastrofe che da mesi
occupa le prime pagine dei giornali, il Taccuino può costituire un'ottima guida
al Disastro di Lisbona, nel senso che ci permette di inquadrarne il messaggio
nel più vasto ambito dell'etica di Voltaire. Innanzitutto ci fa capire che il
suo illuminismo non ha nulla a che vedere con «le magnifiche sorti e
progressive» su cui ironizzava il nostro Leopardi. Per Voltaire la ragione non è
la pietra filosofale che rende immortali, onniscienti e dominatori delle forze
avverse di natura, ma è il bastone che permette all'umanità sofferente di non
inciampare nelle passioni perverse, nelle superstizioni, nelle tirannidi che
aggiungono ai mali che già ci ritroviamo quelli dovuti alla nostra insipienza.
«Se questo è il migliore dei mondi possibili, che mai saranno gli altri?», dirà
Candido, il più famoso dei suoi personaggi. «Dai più piccoli insetti sino al
rinoceronte e all'elefante - si legge in Prendere partito - la Terra non è altro
che un vasto campo di guerre, di imboscate, di carneficina, di distruzione; non
vi è animale che non abbia la sua preda e che, per catturarla, non impieghi
l'equivalente dell'astuzia e della ferocia con cui l'esecrabile ragno cattura e
divora l'innocente mosca». Eppure queste considerazioni che sembrano
preleopardiane non gli impediscono di prendere «il partito dell'umanità» contro
quel «sublime misantropo» che è Pascal. L'uomo, obietta al filosofo, «non è un
enigma. L'uomo appare al suo posto nell'ambito della natura: superiore agli
animali ai quali è simile per gli organi, inferiore ad altri esseri ai quali
probabilmente somiglia per il pensiero. Egli è, come tutto ciò che vediamo, un
misto di bene e di male, di piacere e di dolore. È dotato di passioni per agire,
e di ragione per governare le proprie azioni. Se l'uomo fosse perfetto, sarebbe
Dio, e i pretesi contrasti, che voi chiamate contraddizioni, sono gli
ingredienti necessari che costituiscono quel composto che è l'uomo, il quale è
ciò che deve essere». Ma come è lontano da Pascal, così Voltaire lo è da
Rousseau il quale, in una lettera dell'agosto 1756, sempre parlando di Lisbona,
lo accusava di ateismo e di non considerare che «questo universo materiale non
deve essere più caro al suo Autore di un solo essere che pensa e sente. Ma il
sistema di questo universo che produce, conserva e perpetua tutti gli esseri che
pensano e sentono, gli deve essere più caro di uno solo di questi esseri. Può
dunque, nonostante la sua bontà, o piuttosto grazie alla sua bontà, sacrificare
qualcosa della felicità degli individui alla conservazione del tutto». Sembra
quasi che nella lettera Rousseau anticipi i temi dell'ecologismo contemporaneo:
a Lisbona «dovete convenire che non era stata la natura a raccogliere là
ventimila case dai sei ai sette piani, e che se gli abitanti di quella grande
città fossero stati distribuiti in modo più uniforme e in abitazioni più
piccole, il disastro sarebbe stato minore, e forse non vi sarebbe stato». Ma
Voltaire, critico implacabile sia dell'ottimismo razionalistico di Leibniz e di
Alexander Pope, sia di quello preromantico di Rousseau, non trovava nessuna
ragione - dal peccato originale, al quale non credeva, all'ordine immutabile
dell'universo - per consolarsi delle tante vittime innocenti del terremoto. E
scrive: «La natura è muta e la s'interroga invano/ si ha bisogno di un Dio che
parli al genere umano/ Solo lui può spiegare il suo disegno/ consolare il
debole, illuminare l'ingegno». E tuttavia questa sensibilità che fa di Voltaire
più il figlio di Montaigne che il padre di Condorcet si traduce in un
atteggiamento stoico che lo porta - allontanandolo dal trionfalismo
illuministico - a una sorta di etica del destino. «Come voi - scrive ad Allamand
nel dicembre 1755 - ho pietà dei Portoghesi, ma gli uomini si procurano più male
gli uni agli altri sul loro piccolo mucchio di fango di quanto faccia loro la
natura. Le nostre guerre massacrano più uomini di quel che ne inghiottono i
terremoti. Se a questo mondo fosse da temere soltanto la sorte di Lisbona, ci si
troverebbe ancora abbastanza bene». La ragione ci serve per evitare il peggio,
non certo per costruire una città dell'uomo immune da ogni imperfezione. Per
questo Robespierre si oppose alla traslazione al Pantheon dei suoi resti
mortali.
La Teoria
di Rousseau: La democrazia diretta come contratto sociale e la capacità del
popolo libero a gestirla.
A livello politico Rousseau parte da un presupposto sociologico: lo Stato
moderno che sta nascendo e la borghesia che continua a governare stanno
diventando incompatibili tra loro, scrive F Occhetta. Così per dare un senso
all’uomo e alla società ritiene utile partire da un’ipotesi logica che, pur non
essendosi realizzata nella storia, ne costituisce il fondamento. Il punto di
partenza è costituito, secondo lo schema classico del giusnaturalista laico,
dallo stato di natura, che costituisce lo scenario a partire dal quale è
possibile interpretare la storia stessa. I processi politici e i sistemi
istituzionali sono per Rousseau il modo di «governare» cittadini, che
associandosi perdono la loro bontà naturale. Cultura e natura sono in tensione
nel pensiero del ginevrino. L’immagine che usa è quella di un’arma pericolosa in
mano a un bambino, per questo nei suoi scritti si incontra spesso una
proporzione: l’uomo di natura sta alla bontà come l’uomo civilizzato sta alla
corruzione. Gli uomini di natura possiedono solo due princìpi anteriori alla
loro ragione: l’amore di sé e la pietà mentre l’uomo sociale è egoista e solo,
il desiderio di apparire migliore degli altri lo porta ad essere invidioso e
falso. Nello stato di natura, però, si radica un’altra contraddizione. Se, per
gli illuministi la natura rappresentava un oggetto che la ragione analizzava
«per Rousseau la natura rappresenta invece una realtà che non va vivisezionata
con la ragione, ma prima di tutto amata e compresa col sentimento». La priorità
del cuore sulla ragione, che porta a riconoscere la natura come buona, faranno
di Rousseau un «illuminista pre-romantico». Basta poco però per perdere
questo status ideale. Appena l’uomo isolato incontra altri uomini per
associarsi, perde la sua bontà ed è costretto a fondare un patto iniquo. Questa
svolta nella storia dell’umanità è per Rousseau la nascita della proprietà, che
egli considera il vero male della storia e definisce con la nota immagine del
palo: «Il giorno in cui un uomo ha piantato un palo e ha detto “questo è mio”,
е gli altri
uomini sono stati cosi ingenui da non strappare quel palo, dicendo “non c’è
né mio né tuo”, in quel momento è cominciata la degenerazione della Storia». Le
dottrine comuniste esaspereranno questa posizione. Se la natura umana è stata
corrotta dallo sviluppo della civiltà e in particolare dall’introduzione della
proprietà privata, ci chiediamo: come può essere rieducato l’uomo alla libertà?
Qui tocchiamo un punto decisivo: «Per Rousseau la libertà non può che essere
sociale: l’uomo è libero solo tra uomini liberi. La liberazione dell’uomo non
può che essere frutto di un impegno solidale.
Е la socialità
che, secondo Rousseau, va riscoperta attraverso l’educazione, costituisce il
primo dover essere dell’uomo. La libertà
е l’uguaglianza ne
costituiscono i frutti preziosi».
In verità nel pensiero di Rousseau ciò che salva è una solitudine radicale: «Il
“selvaggio” non tiene in alcun conto gli sguardi degli altri sa essere felice
indipendentemente dagli altri e vive in se stesso. “L’uomo civilizzato” vive
proiettato sempre fuori di sé, nell’opinione degli altri e deriva dagli altri la
stessa coscienza della propria esistenza». Ma se gli uomini non si stimano né si
aiutano, non si riconoscono reciproci e perdono la loro felicità incontrandosi,
su che cosa basano la loro convivenza? Questi presupposti di natura
antropologica e sociologica iniziano qui a creare problemi. Ritenere che la
società sia la causa dei contrasti tra gli uomini (e non l’effetto) significa
ritenere che le ineguaglianze date dalle diverse capacità e dall’appartenenza
sociale prendono il posto dell’uguaglianza dello stato di natura. Ma c’è di più:
«Le differenze naturali si trasformano in disuguaglianze morali e al tempo
stesso gli uomini si riconoscono come individui. Per mezzo dell’opinione degli
altri acquistiamo un’identità personale, ma diventiamo anche schiavi
dell’opinione». La via d’uscita è di carattere morale e risiede nella capacità
che ciascuno dovrebbe avere di rieducarsi alla libertà, facendo nascere il
contratto sociale che è un «dover essere della coscienza», un’esigenza
deontologica capace di recuperare i valori perduti dello stato di natura, quando
l’uomo era buono. Ma c’è di più. Gli studi di questi ultimi anni dedicati al
profilo psicologico del pensiero di Rousseau sostengono — con le dovute riserve
— che la sua solitudine, il suo narcisismo e il suo masochismo siano stati le
cause che lo portarono a teorizzare il «buon selvaggio» — figura letteraria già
presente nel pensiero di Montaigne —, vittima innocente della società, e
l’Emilio, la vittima innocente dell’educazione. In verità l’attualità del suo
pensiero tocca il significato filosofico della «volontà generale» che è chiamata
a guidare lo Stato per conseguire il bene comune. Secondo Rousseau la sovranità
si poteva esprimere soltanto in un corpo collettivo, inalienabile e
indivisibile. In questo meccanismo logico risiede l’ideologia democratica di
Rousseau. Quali sono le condizioni che devono sussistere per far sì che uno
Stato sia democratico? Lo Stato diventa nel pensiero di Rousseau la via di
uscita politica per porre rimedio ai due grandi male sociali: quello di
incontrare altri uomini in società e quello della disuguaglianza creata dalla
proprietà privata. Il problema è dunque politico, e non antropologico. Il male
non è mai all’interno dell’uomo ma nelle strutture politiche, che devono quindi
essere riformate e cambiate. Non occorre una conversione morale e una nuova
auto-comprensione dell’umano, ma è necessaria la trasformazione delle strutture
politiche. In questa visione si concentra tutta la debolezza della proposta
politica di Rousseau. La dimensione religiosa che potrebbe cambiare il cuore
dell’uomo, insegnargli a distinguere il bene dal male e a conoscere Dio, per
Rousseau deve essere invece legata alla politica che diventa per l’uomo la vera
religione. Sono dunque le strutture politiche che dovrebbero essere «convertite»
per espellere il male dalla storia, non gli uomini che le governano. Costruire
lo Stato dunque diventa per il pensiero del ginevrino un atto religioso che non
tocca il cuore del cittadino. Per questo alcuni studiosi sono inclini a ritenere
che Rousseau secolarizzi il pensiero teologico introducendo l’idea di democrazia
moderna. La democrazia, che si fonda sul contratto sociale, diventa in Rousseau
lo strumento di redenzione e liberazione dal male; i cittadini non cedono la
loro libertà e i loro diritti a un sovrano come riteneva Hobbes, ma alla
collettività che li farà ritrovare insieme a tutti gli altri cittadini. Così la
democrazia è per Rousseau quella forma di Stato in cui il popolo è allo stesso
tempo sovrano e suddito. Per realizzare questa intuizione la sovranità deve
essere esercitata direttamente dal popolo tramite procedure che garantiscano il
principio di l’autodeterminazione dei singoli che devono realizzare il programma
definito dall’interesse generale. L’ambito si sposta dal teologico al
teleologico. In origine c’è una situazione buona (lo stato di natura), segue una
caduta (la nascita della proprietà), ne consegue che per redimersi l’uomo deve
far nascere lo Stato democratico. Della redenzione non ha bisogno l’uomo, perché
è buono, ma la politica, perché il male della storia, che si radica nella
proprietà, appartiene alla sfera giuridica. Proprio qui però si radica la
seconda contradizione del suo pensiero: tutti possono esercitare i diritti di
tutti; e se questi non sono concordi? Che cos’è in realtà la «volontà generale»
su cui si sono fondate le moderne democrazie? È formalmente la guida dello Stato
democratico, quella che il bene comune della collettività e che si distingue
dalla volontà di tutti. La maggioranza va distinta dalla minoranza e la sua
volontà coincide tendenzialmente con la volontà generale. Questa è rappresentata
della «classe media», non da intendere come la classe borghese, ma quella che in
una votazione si determina togliendo le parti estreme. L’interpretazione di
questa scelta ha portato ad applicazioni storiche opposte: il pensiero liberal
democratico ha fatto coincidere la volontà della maggioranza con la volontà
generale; i totalitarismi e le dittature come quelle di Napoleone e di Marx,
hanno ritenuto che la volontà generale venisse intuita da personalità
carismatiche. Nel pensiero di Rousseau è mancato un ponte che collegasse la vita
privata dell’uomo, la dimensione, per lui importante, della coscienza e dei
buoni sentimenti, con la costruzione della città. È forse questa l’urgenza di
cui hanno bisogno le moderne democrazie per riformarsi. A questo riguardo
diventano preziosi due insegnamenti del ginevrino. Il primo è contenuto
nell’Emilio, quando Rousseau ricorda che si può vivere in due modi, recitando
una parte e privandosi di vivere autenticamente, come fanno gli attori di
teatro; oppure vivere e lasciarsi vivere come in una festa quando ciascuno
diventa se stesso. Il fine della politica poi lo richiama nella sua Lettera a
d’Alambert: «Possano i giovani trasmettere ai loro discendenti le virtù, la
libertà, la pace che hanno ricevuto dai loro padri!». «La ricerca del proprio
vantaggio a spese degli altri è qualche volta temperata dalla pena che proviamo
nel vedere gli altri soffrire. Prima che l’amor proprio sia interamente
sviluppato, la pietà naturale agisce come un freno all’ardore con cui gli uomini
perseguono il proprio benessere […].
La teoria di Cesare Beccaria: Certezza del Diritto e Pene certe,
ma non crudeli.
Scritto da Library.weschool.com. L’Illuminismo lombardo, in stretto rapporto
con quello francese ma consapevolmente non rivoluzionario e di orientamento
moderato, si sviluppa nell’alveo del riformismo di Maria Teresa d’Austria
(1717-1780) e Giuseppe II (1741-1790). I punti caratterizzanti sono allora
quellli del riordino generale del sistema economico-giuridico del tempo (in
accordo con le necessità della nascente borghesia imprenditoriale, e contro
l’immobilisimo del sistema aristocratico), la polemica contro la tradizione
culturale dei secoli passati, l’idea che gli intellettuali debbano collaborare
attivamente al progresso collettivo della società. In ambito letterario,
rilevante è la preferenza per toni sobri ed eleganti, in reazione agli eccessi
della poetica barocca; tra i nomi più direttamente avvicinabili a questi
propositi riformistici, ci sono sicuramente Giuseppe Parini (1729-1799; si pensi
all’ode La caduta o al poemetto Il Giorno), le commedie teatrali di
Goldoni (1807-1793), le tragedie di Alfieri (1749-1803). I maggiori esponenti
dell’Illuminismo lombardo sono innanzitutto, oltre a Cesare Beccaria, i
fratelli Alessandro (1741-1816) e Pietro Verri (1728-1797) attivi animatori di
battaglie amminsitrative e legislative e della vita culturale milanese. Due gli
organi per sostenere questo disegno di riforma civile: da un lato l’Accademia
dei Pugni, istituzione culturale fondata a Milano nel 1761 dei fratelli Verri,
Beccaria ed altri intellettuali illuminati milanesi che si fa portavoce di un
gusto moderno, anticonvenzionale ed antitradizionalista; dall’altro il periodico
«Il Caffè» (1764-1766) che, ispirandosi all’inglese «Spectator», diffonde gli
ideali dell’Illuminismo, come quando sostiene la necessità di una nuova lingua
dell’uso, agile e moderna, sull’esempio dei principali modelli
europei.Particolare risalto per l’Illuminismo italiano ha l’esperienza
letteraria, culturale e politico-economica di Cesare Beccaria. Di famiglia di
recente nobiltà, Beccaria studia presso i gesuiti e in seguito si diploma in
diritto a Pavia, e, dopo essere divenuto membro dell’Accademia dei pugni,
pubblica nel 1764 il saggio Dei delitti e delle pene, composto sulla spinta e
l’attiva collaborazione dell’amico Pietro Verri. In pochi anni, grazie anche ad
una traduzione in francese del 1766, l’opera conquista fama in tutta Europa,
tanto di divenire un punto di riferimento anche per gli illuministi francesi,
nella cui corrente di riflessione sui fondamenti del diritto moderno (si pensi a
Montesquieu e alla teoria di divisione dei poteri, Helvétius, Rousseau e il
suo Contratto sociale) i Dei delitti e delle pene si inserisce pienamente. In
seguito al successo dell’opera Beccaria si reca a Parigi con Alessandro Verri
per stringere i rapporti con i philosophes, ma, sopraffatto dalla nostalgia,
l’autore resta nella capitale francese solo qualche settimana per poi tornare in
Italia, provocando reazioni derisorie e una brusca rottura nel rapporto con
Pietro Verri. Mentre Dei delitti e delle pene si diffonde per il mondo, a Milano
Beccaria vive in solitudine, dedicandosi all’insegnamento di economia e
collaborando con il governo austriaco per un disegno di riforma fiscale.
Beccaria muore nel 1794. Tra le sue opere ricordiamo anche Del disordine e de’
rimedi delle monete nello stato di Milano nel 1762 (1762), primo scritto
pubblicato che suscita svariate polemiche; le Ricerche intorno alla natura dello
stile (1770), legate alle riflessioni sull’incivilimento della società, in cui
collega lo studio dello “stile” alla scienza dell’uomo, rifacendosi al sensismo;
e gli Elementi di economia politica, raccolta delle sue lezioni, pubblicata
postuma nel 1804. La portata rivoluzionaria del saggio di Beccaria Dei delitti e
delle pene (1764) è giustificata dal fatto che questo scritto getta alcune basi
fondamentali del diritto moderno. Dei delitti e delle pene nasce all’interno del
clima dell’Accademia dei Pugni, su espressa indicazione di Pietro Verri, che
mette ampiamente mano alla prima stesura sia correggendola sia modificandone
l’assetto. L’ordinamento finale dell’opera sarà ulteriormente modificato da
André Morrellet (1727-1819), in occasione della traduzione francese due anni
dopo la prima pubblicazione. L’opera, sull’onda di quei principi filosofici ed
etici riscontrabili in Montesquieu e Rousseau, si sviluppa come
un’articolata riflessione sulla natura e i principi della punizione inferta
dalla legge a chi abbia commesso qualche reato: Beccaria tematizza quindi non
sul rapporto causale tra “delitto” e “pena”, ma sulla natura filosofica e sul
concetto stesso di “pena” all’interno di una società umana. Beccaria ritiene
infatti che la vita associata sia rivolta al conseguimento della felicità del
maggior numero di aderenti al “contratto sociale” e che le leggi siano la
condizione fondante di questo patto; dati questi presupposti è evidente che le
peneservano a rafforzare e garantire queste stesse leggi, ed è sulle pene e
sulla loro applicazione che si concentra quindi l’opera di Beccaria. Scrive così
nell’introduzione all’opera: Le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di
uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di
alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da
un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le
azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista:
la massima felicità divisa nel maggior numero. Le pene sono dunque finalizzate
sia adimpedire al colpevole di infrangere nuovamente le leggi, sia a distogliere
gli altri cittadini dal commettere colpe analoghe. Le pene vanno allora scelte
proporzionatamente al delitto commesso e devono riuscire a lasciare
un’impressione indelebilenegli uomini senza però essere eccessivamente
tormentose o inutilmente severe per chi le ha violate. Il tema si lega
strettamente al decadimento della giustizia al tempo dell’autore, ancora legata
all’arretrata legislazione di Giustiniano (il Corpus iuris civilis del VI secolo
d.C.) e alla sua revisione per mano di Carlo V (1500-1558). La proposta
riformistica di Beccaria vuole abolire abusi ed arbitri dipendenti,
nell’amministrazione della giustizia, dalla ristretta mentalità aristocratica
dei detentori del potere; secondo la prospettiva “illuminata” dell’autore una
gestione più moderna del problema giudiziario non potrà che favorire, oltre che
la tutela dei diritti individuali, anche il progresso dell’intera società (come
nel caso delle osservazioni sulla segretezza dei processi o sul fatto che il
sistema giudiziario presupponga la colpevolezza e non l’innocenza
dell’imputato). La portata rivoluzionaria del discorso di Beccaria si evince in
particolar modo dal discorso sulle torture, intese come uno strumento inefficace
e perverso per ottenere un’illusione di verità; essendo il colpevole tale solo
dopo la sentenza, le torture, utilizzate comumente come mezzo finalizzato alla
confessione, sono inutili e illegittime e rischiano di assolvere coloro che,
essendo più robusti di costituzione riescono a resistervi, e condannare
innocenti dal fisico più debole. L’esito dunque della tortura è un affare di
temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua
robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico
scioglierebbe meglio che un giudice questo problema. Inoltre l’innocente è messo
dalla tortura in una situazione peggiore di quella del reo, in quanto il
secondo, se resiste, è dichiarato innocente, mentre il primo anche se è
riconosciuto tale avrà comunque dovuto subire una tortura immeritata.
Altrettanto centrale è il discorso sulla pena di morte, alla cui origine
Beccaria non riesce a trovare un qualche fondamento di diritto. Evidente è che
non può essere un potere dato dal contratto sociale, perché nessuno aderirebbe a
un patto che dà agli altri il potere di ucciderlo. Oltre a questa considerazione
Beccaria nota anche che l’esistenza della pena di morte non ha mai impedito che
venissero commessi quegli stessi crimini per cui altri venivano giustiziati.
Infatti fa più impressione vedere un uomo che paga per la sua avventatezza, che
vedere uno spettacolo che indurisce ma non per questo corregge: Non è utile la
pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la
necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi
moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero
esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e con
formalità. Dati questi presupposti Beccaria parte dal principio che non sia
l’intensità della pena a far effetto sull’immaginazione degli uomini, quanto la
sua durata ed estensione. La pena non dev’essere cioè terribile e breve,
quanto certa, implacabile ed infallibile. Inoltre la misura dei delitti deve
essere il danno arrecato alla società e non l’intenzione, che varia in ciascun
individuo, e scopo della pena deve essere sempre la prevenzione dei delitti.
L’illuminato pensiero di Cesare Beccaria. IL TRATTATO DEI DELITTI E DELLE PENE,
segna l’inizio della moderna storia del diritto penale. Saggio scritto
dall’illuminista milanese Cesare Beccarla (1738-1794) tra il 1763 e il 1764, in
cui l’autore si pone delle domande circa le pene allora in uso. scritto da
G.M.S. il 3 Settembre 2016 su Umsoi. Nonostante il notevole successo e la vasta
eco in tutta Europa (la zarina Caterina II di Russia mise in pratica i princìpi
fondamentali della riforma giudiziaria in esso proposta, mentre nel Granducato
di Toscana venne perfino abolita la pena di morte), nel 1766 il libro venne
incluso nell’indice dei libri proibiti a causa della distinzione che vi si
ritrova tra reato e peccato. L’autore afferma, infatti, che il reato è un danno
alla società, a differenza del peccato, che, non essendolo, può essere
giudicabile e condannabile solo da Dio. Alla base di questa distinzione sta la
tesi secondo cui l’ambito in cui il diritto può intervenire legittimamente non
attiene alla coscienza morale del singolo. Inoltre, per Beccarla non è
“l’intensione” bensì “l’estensione” della pena a poter esercitare un ruolo
preventivo dei reati, motivo per cui, fra l’altro, esprime un parere negativo
nei confronti della pena capitale, comminando la quale afferma che lo Stato, per
punire un delitto, ne compie uno a sua volta. E il diritto di “questo” Stato,
che altro non è che la somma dei diritti dei cittadini, non può avere tale
potere: nessuna persona, infatti, darebbe il permesso ad altri di ucciderla.
Riprendendo i concetti roussoviani, Beccaria contrappone al principio del
vecchio diritto penale “è punito perché costituisce reato” il nuovo principio “è
punito perché non si ripeta”. Il delitto viene separato dal “peccato” e dalla
“lesa maestà” e si trasforma in “danno” recato alla comunità. Sulla base della
teoria contrattualistica, egli arriva a sostenere che, essendo il delitto una
violazione dell’ordine sociale stabilito per contratto (e non per diritto
divino), la pena è un diritto di legittima autodifesa della società e deve
essere proporzionata al reato commesso. Le leggi devono in primo luogo essere
chiare (anche nel senso di accessibili a tutti, cioè scritte nella lingua
parlata dai cittadini) e non soggette all’arbitrio del più forte; non è giusto
pertanto infierire con torture, umiliazioni e carcere preventivo prima di aver
accertato la colpevolezza. Un uomo i cui delitti non sono stati provati va
ritenuto innocente. L’accusa e il processo devono essere pubblici, con tanto di
separazione tra giudice e pubblico ministero e con la presenza di una giuria.
(Tuttavia per il Beccaria legittimo “interprete” della legge è solo il sovrano;
il giudice deve solo esaminare se le azioni dei cittadini sono conformi o meno
alla legge scritta). La stessa pena di morte va abolita in quanto nessun uomo ha
il diritto, in una società basata sul contratto fra persone eguali, di disporre
della vita di un altro suo simile. E’ impossibile allontanare i cittadino
dall’assassinio ordinando un pubblico assassinio. Occorre che i cittadini siano
messi in condizione di comportarsi nel migliore dei modi. La condanna capitale
rende inoltre irreparabile un eventuale errore giudiziario. Il vero freno della
criminalità non è la crudeltà delle pene, ma la sicurezza che il colpevole sarà
punito.
I tre
filosofi dell'Illuminismo.
Da Comprensivocesari.edu.it. Charles de Montesquieu, un illuminista
aristocratico, era favorevole a una monarchia costituzionale, sul modello di
quella inglese. Egli sosteneva che i tre poteri dello Stato, cioè il potere
legislativo (di fare le leggi), esecutivo (di applicarle) e giudiziario (di
giudicare chi non le rispetta) non devono essere concentrati nelle mani di una
sola persona. Per garantire la libertà politica ed evitare che pochi pravalgano
su molti, è necessario che i tre poteri restino divisi e indipendenti. Questo
principio, detto della separazione dei poteri, è accolto oggi dalle costituzioni
di quasi tutti i Paesi. In Italia, ad esempio, il potere legislativo spetta al
parlamento, cioè a rappresentanti del popolo liberamente eletti; il potere
esecutivo al governo; quello giudiziario alla magistratura, costituita
dall'insieme dei giudici. Per Jean-Jacques Rousseau, un filosofo di Ginevra, il
potere dello Stato, cioè la sovranità, il potere di comandare, appartiene
interamente al popolo, che è l'unico sovrano. Il principio della sovranità
popolare, sta alla base delle moderne democrazie. Nelle democrazie moderne, come
l'Italia, la sovranità popolare viene esercitata indirettamente attraverso i
rappresentanti (deputati e senatori che formano il parlamento) scelti dal popolo
e prende il nome di democrazia rappresentativa. Voltaire, il più famoso dei
filosofi illuministi, non riponeva nel popolo alcuna fiducia ed era disposto ad
accettare il governo di un sovrano assoluto, a patto che questi si dimostrasse
"illuminato" e si lasciasse guidare non dal capriccio, ma dalla ragione,
preoccupandosi dell'efficienza dello stato e del benessere dei sudditi. Molti
sovrani europei sembrarono sensibili alle idee illuministe e attuarono nei loro
Stati importanti riforme. Il loro sistema di governo prende il nome di
dispotismo illuminato.
Il dispotismo illuminato. Le idee degli illuministi furono
accolte da molti sovrani europei, come Federico II di Prussia, Maria Teresa
d'Austria, la zarina Caterina II di Russia e, in Italia, Leopoldo, granduca di
Toscana e Carlo III di Borbone, re di Napoli. Nella seconda metà del Settecento
questi "despoti" (sovrani) introdussero delle riforme, cioè dei cambiamenti che
avevano lo scopo di migliorare il loro Stato, rendendolo più efficiente e
moderno. In Toscana, ad esempio, il granduca Leopoldo abolì la tortura e la pena
di morte. Alcuni sovrani si preoccuparono di modernizzare l'agricoltura e
combatterono l'analfabetismo, favorendo l'istituzione di scuole pubbliche laiche
(cioè non religiose), tanto che l'istruzione pubblica ebbe un grande sviluppo.
Questi "despoti illuminati" non cessarono di essere sovrani assoluti e spesso si
proposero, molto più che il benessere dei sudditi, l'aumento del proprio potere
ai danni della nobiltà e del clero, ossia i ceti privilegiati. Le idee
illuministe si diffondono anche in Italia In Italia i centri illuministi più
attivi furono due: Napoli e Milano. A Milano fu pubblicato un giornale
intitolato "Il caffè", perchè si voleva che avesse sulla società lo stesso
effetto stimolante che ha la bevanda sull'organismo umano. Del gruppo milanese
faceva parte il marchese Cesare Beccaria, che nel 1764 pubblicò il saggio Dei
delitti e delle pene, l'opera più importante e più famosa dell'Illuminismo
italiano, in cui l'autore dimostrava l'inutilità della tortura e della pena di
morte. Presto tradotto in molte lingue, il saggio contribuì a far modificare le
leggi e i procedimenti giudiziari in alcuni Stati, fra cui il granducato di
Toscana e l'impero austriaco.
Montesquieu, Rousseau e Voltaire - Storia e politica.
Appunto di Filosofia che spiega e mette a confronto le varie
idee politiche e etiche di tre esponenti dell'illuminismo: Montesquieu, Rousseau
e Voltaire in relazione al clima storico. Elisa P. su skuola.net.
Montesquieu, Rousseau e Voltaire - Storia e politica. Gli
illuministi erano grandi ammiratori del sistema liberale inglese, proponendolo
come modello nel loro programma di riforme politiche per la Francia:
- libertà religiosa;
- Libertà di stampa;
- Abolizione dei privilegi fiscali;
- Limitazione dell'assolutismo regio.
VOLTAIRE - "Lettere filosofiche" (1734). Egli aveva fatto
conoscere in Francia il sistema parlamentare inglese, rendendosi conto che la
società civile francese era più arretrata di quella inglese e che l'eccessivo
indebolimento della monarchia potesse degenerare in anarchia; Voltaire inoltre
riponeva scarsa fiducia nelle masse popolari, poichè riteneva fossero soggette
al dominio dell'ignoranza e della superstizione; per questo motivo un monarca
assoluto, ma illuminato, poteva essere il migliore garante del rinnovamento
della società. Egli identificava come possibili monarchi illuminati Federico
II e Caterina di Russia.
ROUSSEAU. Rousseau aveva fatto inizialmente parte del movimento
degli illuministi, ma a partire dal "Discorso sulle scienze e sulle arti" (1750)
se ne era progressivamente allontanato. Nella sua opera egli respingeva l'idea
di progresso e incivilimento (progresso verso migliori condizioni materiali di
vita e costumi più raffinati e umani) e la contrapponeva con la visione di
un'austera comunità repubblicana, nella quale le virtù morali e politiche
contavano di più delle scienze, della tecnica e degli artificiosi raffinamenti
dei costumi. Nel 1762 il filosofo pubblicò la sua opera politica più celebre e
discussa "Il contratto sociale"; in esso proponeva un modello di Stato in cui il
sovrano fosse tutto il popolo e le leggi derivassero dalla volontà generale del
popolo. Inoltre Rousseau elabora il concetto di sovranità popolare che si
riferiva alla capacità degli individui di cogliere l'unico interesse generale,
liberandosi quindi dei loro egoismi. In un simile Stato gli organi del Governo
erano al servizio dell' intera comunità. Venne anche elaborata anche la
definizione di Stato democratico, in cui la proprietà privata doveva essere
subordinata all'interesse generale.
MONTESQUIEU - "Lo spirito delle leggi" (1748). Montesquieu compì
un esame comparativo delle diverse forme di Governo (repubblica, monarchia,
dispotismo). Secondo lui il sistema di leggi di ciascun Paese ha uno spirito
(logica interna); le leggi non sono solo il prodotto del legislatore, ma sono i
rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose. Egli voleva appurare se
in Francia erano in atto processi che stavano trasformando la monarchia in
dispotismo, questi processi dovevano essere fermati finchè si era in tempo;
il dispotismo appariva a Montesquieu come una forma di Governo
tipica dei Paesi asiatici, dove era agevolato da tre fattori:
- l'enorme estensione;
- La fitta popolazione;
- La relativa semplicità delle strutture sociali.
Quando tra l'autorità del sovrano e la massa dei sudditi non
esistono corpi intermedi dotati di autonomia, il dispotismo è
un' evoluzione inevitabile. Tra le forze sociali intermedie, Montesquieu dava
importanza a quelle magistrature supreme che erano i parlamentari. Nel momento
in cui queste forze prendessero ogni potere, la monarchia sarebbe degenerata nel
dispotismo; Montesquieu giudicava poco adatta per la Francia la forma di governo
repubblicana; lo spirito repubblicano poteva solo realizzarsi in comunità
territorialmente e demograficamente limitate, come Sparta e Roma nell'
antichità. Dell'Inghilterra bisognava imitare la divisione dei poteri (la
potenza statale così distribuita non sarebbe stata esposta al rischio
dell'assolutismo) in tre funzioni diverse:
- la legislazione (Parlamento, l'emanazione di leggi generali);
- Il Governno (re e Governo, eseguire le leggi e occuparsi
dell'alta politica);
- L'amministrazione della Giustizia;
La magistratura sarà pienamente indipendente dal potere del
Governo, senza che nessuno dei tre poteri cerchi di usurpare le funzioni altrui,
auspicava quindi una monarchia costituzionale.
Illuministi a confronto: Rousseau e Montesquieu.
Giada.cofano (Medie Superiori) scritto il 12.04.17 su scuola.repubblica.it.
L'illuminismo è un movimento di pensiero nato in Francia nel '700, sviluppatosi
poi nel corso del secolo nel resto dell'Europa. Gli illuministi, collaborano
insieme nello sviluppo delle idee, ma ognuno di loro pone un accento o una
particolare attenzione su un aspetto, che viene quindi sviluppato in modo
differente.
Rousseau, inizialmente faceva parte del movimento illuminista,
poi con la pubblicazione di "Discorso sulle scienze e sulle arti" nel 1750, se
ne allontana progressivamente. Sostiene che le arti e le scienze nascano da un
progressivo snaturamento della sensibilità primitiva e originale dell'uomo, con
conseguente negativo sugli esiti dell'evoluzione storica. Ogni passo verso la
civiltà comporta, nell'uomo, il nascere di bisogni artificiosi, che lo
distraggono dalle cose essenziali e autentiche. Rousseau, facendo emergere una
critica radicale, respinge l'idea di progresso e incivilimento e lo contrappone
con la visione di un'austera comunità repubblicana. Ne "Il contratto sociale",
propone un modello di Stato in cui il popolo è sovrano, e le leggi derivano
dalla volontà popolare. Gli individui così facendo si liberano dall'egoismo
tipico del loro essere, sviluppando nuove capacità collaborative nell'interesse
generale. La storia non era corruzione <>. Ma <>, fissando il vincolo della
proprietà privata, del possedere la terra, che in realtà, originariamente,
appartiene a tutti. La disuguaglianza tra gli individui deve essere risolta
attraverso la ridistribuzione delle ricchezze, quindi con la definizione di
leggi uguali per tutti ed uno Stato democratico.
Differente è invece la visione politica di Montesquieu, che
individua nella monarchia costituzionale, un governo in cui i poteri non si
sovrappongono, né entrano in contrasto tra loro. Attraverso un esame che compie
sulle diverse forme di governo, Montesquieu comprende come le leggi siano, il
risultato di una varietà di condizioni fisiche,meteorologiche, sociali e
storiche e non semplicemente il prodotto della ragione pura o dell'istituzione
arbitraria dei legislatori. Quindi il dispotismo che stava emergendo e
affermandosi in Francia, tipico dei Paesi orientali, andava fermato
tempestivamente. Il modello inglese che suggeriva la divisione dei poteri
diviene per l'illuminista la migliore soluzione governativa. In ogni Stato la
divisione consiste in <>. Non vi è libertà se questi tre poteri sono nelle mani
di uno solo, o dello stesso organismo. Seguirebbero mancanza di controllo e
abusi d'ogni tipo. Se il potere giudiziario è quello legislativo fossero uniti
<>. Il principio della conservazione dei poteri è ancora oggi valido, e per noi
contemporanei è una cosa scontata e ovvia. Ma nel '700 una tale riforma
costituiva una sorta di conquista del potere politico, economico ed ideologico,
da parte di una borghesia in fermento, cosciente della propria funzione sociale
propulsiva.
Montesquieu e Rousseau sono solo due dei tanti filosofi che in
questo periodo storico, hanno espresso le proprie tendenze e dottrine politiche:
al primo, teorico del liberalismo moderato, si contrappone il secondo, che
attraverso il suo "contratto sociale" ispirerà l'azione della borghesia
democratica.
Montesquieu, la libertà risiede nella separazione dei poteri.
Barbara Speca su rivoluzione-liberale.it il 17 Agosto 2011. Il viaggio alle
radici del Pensiero Liberale continua con Charles-Louis de Secondat, barone de
La Brède et de Montesquieu (1689-1755), un protagonista dell’Illuminismo europeo
nella prima metà del XVIII secolo che occupa, ancora oggi, una posizione di
straordinario rilievo nella storia del liberalismo soprattutto grazie al suo
capolavoro, lo Spirito delle Leggi, un’opera monumentale, frutto di quattordici
anni di lavoro e pubblicata anonimamente nella Ginevra di Jean-Jacques Rousseau,
nel 1748. Due volumi, trentadue libri, una vera e propria enciclopedia del
sapere politico e giuridico del Settecento, nonché un lavoro tra i maggiori
della storia del pensiero politico. Avversario di ogni forma di oppressione
dell’uomo sull’uomo, Montesquieu è il filosofo della moderazione e
dell’equilibrio. A lui viene attribuita la teoria della separazione dei poteri
che rappresenta uno dei princìpi necessari dello Stato di diritto e una
condizione oggettiva per l’esercizio della libertà che per Montesquieu è “Il
diritto di fare tutto quello che le leggi permettono”. Sulla base dell’esempio
costituzionale inglese, lo scrittore politico francese sostiene che l’unica
garanzia di fronte al dispotismo risiede nell’equilibrio costituzionale di cui
godono i paesi in cui i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono
nettamente separati e distinti, capaci di controllarsi a vicenda. “Quando nella
stessa persona o nello stesso corpo di magistratura, il potere legislativo è
unito al potere esecutivo, non esiste libertà; perché si può temere che lo
stesso monarca o lo stesso senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle
tirannicamente. E non vi è libertà neppure quando il potere giudiziario non è
separato dal potere legislativo o da quello esecutivo. Se fosse unito al potere
legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe
arbitrario: poiché il giudice sarebbe il legislatore. Se fosse unito al potere
esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe
perduto se un’unica persona o un unico corpo di notabili, di nobili o di popolo
esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le
risoluzioni pubbliche e quello di punire i delitti o le controversie dei
privati”. L’idea che la separazione del potere sovrano tra più soggetti sia una
maniera efficace per impedire abusi affonda le sue radici nella tradizione
filosofica della Grecia classica. Platone ne La Repubblica sostiene l’autonomia
del giudice dal potere politico. Aristotele, nella Politica, delinea una forma
di governo misto denominata politìa, una condizione di equilibrio tra oligarchia
e democrazia, o meglio, una democrazia temperata dalla oligarchia. Aristotele,
per di più, distingue tre momenti nell’attività dello Stato: deliberativo,
esecutivo e giudiziario. In tempi più recenti, nella seconda metà del Seicento,
John Locke sostiene la necessità di affidare ciascuna funzione a soggetti
diversi. Montesquieu apre però la strada alla politica moderna, perfezionando la
teoria della separazione dei poteri già presente in Locke. Il giurista francese
trasforma la sua ricerca scientifica e sociologica in un programma morale e
politico: come strutturare un sistema di leggi che, nelle condizioni storiche
date, produca il massimo di libertà.“La libertà politica è quella tranquillità
di spirito che la coscienza della propria sicurezza dà a ciascun cittadino; e
condizione di questa libertà è un governo organizzato in modo tale che nessun
cittadino possa temere un altro”. Si può definire libera solo quella
costituzione in cui nessun governante possa abusare del potere a lui affidato.
Per contrastare tale abuso bisogna far sì che “il potere arresti il potere”,
cioè che i tre poteri fondamentali siano affidati a mani diverse, in modo che
ciascuno di essi possa impedire all’altro di oltrepassare il proprio limite,
degenerando in tirannìa. La riunione di questi poteri nelle stesse mani, siano
esse quelle del popolo o del despota, annullerebbe la libertà perché
distruggerebbe la “bilancia dei poteri” che costituisce l’unica salvaguardia o
“garanzia” costituzionale in cui risiede la libertà effettiva dei cittadini.
Secondo Montesquieu“Una sovranità indivisibile e illimitata è sempre
tirannica” e il dispotismo, anche se rappresenta una forma “naturale” di
governo, è il pericolo supremo da evitare, in quanto una sola persona “senza né
leggi né impedimenti trascina tutto e tutti dietro la sua volontà e i suoi
capricci”. Montesquieu struttura un metodo di interpretazione delle leggi in cui
scompare l’alternativa tra legge naturale universale e immutabile, di cui
avevano parlato i giusnaturalisti, e l’incertezza o l’arbitrarietà delle leggi
positive su cui, dai sofisti greci fino a Montaigne e Pascal, si basava il
dubbio scettico sulla stabilità della giustizia umana. Montesquieu cerca di
dimostrare come, nonostante la diversità e la complessità degli eventi, la
Storia abbia un ordine e manifesti l’azione di leggi costanti in grado di
superare i contrasti. Ogni Stato, a sua volta, ha le proprie leggi che non sono
mai casuali o arbitrarie, ma strettamente condizionate dalla natura dei popoli
stessi, dai loro costumi, dalla loro religione, addirittura dal clima.
Montesquieu sostiene però che sia possibile stabilire, metodologicamente, i
princìpi che regolano le leggi e ne determinano il carattere e la natura: le
leggi, cioè, non si formano a caso, o secondo il capriccio di qualche individuo,
ma seguono la direzione loro imposta da tutto un insieme di condizioni che è
compito dello studioso indagare. Lo “spirito” delle leggi corrisponde all’anima
dell’insieme di norme che regolano le relazioni umane nelle diverse società.
Poiché tali norme variano nei diversi popoli, non è possibile valutarle in
relazione a uno schema di princìpi dotati di validità assoluta, ma ne va
chiarita caso per caso la dinamica interna, facendo uso di criteri costanti
riconducibili all’esprit général che rappresenta il collante, il tessuto
connettivo di ogni sistema giuridico, un principio non naturale e statico ma
storicamente dinamico, di cui ogni legislatore deve tener conto. Il metodo di
Montesquieu presuppone che i fenomeni sociali possano essere spiegati con leggi
scientificamente rilevanti come quelle delle scienze naturali: le società umane,
al pari di ogni essere vivente, sono sottoposte all’azione che deriva
dall’intreccio delle situazioni e delle proprie caratteristiche fisiche e
spirituali. Montesquieu tenta di organizzare il Diritto in categorie semplici
alle quali ricondurre la grande varietà della struttura giuridica e sociale;
mette in luce il grande ruolo assunto dalla Storia ed infine, sul piano
politico, tenta di strutturare un modello pratico di società per salvaguardarla
dai regimi dispotici. Seguendo le orme del Saggio sul governo civile di Locke,
Montesquieu definisce le leggi “rapporti necessari che derivano dalla natura
delle cose” nonché manifestazione della ragione umana. In una società civile le
leggi fungono da elementi regolatori in grado di mediare le tendenze
individuali, in vista del perseguimento di un obiettivo comune. Dimostrato che
il mondo fisico come il mondo dell’intelligenza dipendono da rapporti intrinseci
alla loro stessa esistenza, Montesquieu esamina l’intreccio delle forze che
agiscono nelle varie società storiche per scoprire coerenze e discordanze delle
istituzioni e delle leggi rispetto alla loro essenziale necessità, al loro
“esprit”. Le leggi fondamentali dello Stato prescindono dal principio e dalla
natura del governo che per Montesquieu può essere repubblicano, monarchico o
dispotico, a seconda che vi prevalga il principio della virtù, dell’onore o
della paura. La stabilità dello Stato dipende dal principio del governo e si
basa sulla coerenza delle sue leggi. Nella situazione storica in cui le leggi si
dimostrino aberranti dall’esprit général che le ha determinate e le sorregge è
necessario individuare la natura e la ragioni dell’errore. Quando il principio
si corrompe, le migliori leggi diventano distruttive. Il principio della
democrazia, ad esempio, si corrompe quando la nazione perde lo spirito
d’uguaglianza o lo interpreta arbitrariamente. Nel suo capolavoro Montesquieu si
propone di estendere allo studio della società umana il metodo sperimentale per
fissare dei “princìpi” universali volti ad organizzare logicamente l’infinita
molteplicità delle usanze, delle norme giuridiche, delle credenze religiose,
delle forme politiche e per formulare, infine, leggi obiettive secondo le quali
si articola costantemente, sotto l’apparenza del caso, l’incostante
comportamento degli uomini. Non rifiuta la concezione machiavellica della
politica come forza, ma la integra con un’accurata analisi delle molteplici
“cause” – storiche, politiche, fisiche, geografiche e morali – che operano negli
eventi umani. Le leggi positive formulate da Montesquieu riguardano
principalmente: il diritto delle genti (leggi che regolano i rapporti esistenti
tra i vari stati); il diritto politico (leggi che regolano i rapporti tra Stato
e società civile); il diritto civile (leggi che regolano i rapporti tra i
componenti della società civile). Rinuncia comunque alla ricerca della miglior
forma di Stato, cara alla letteratura utopistica, e tenta di stabilire,
concretamente, le condizioni che garantiscono, nelle diverse forme di governo,
l’optimum della convivenza civile: la libertà. Il suo realismo e relativismo si
salda con un alto intento normativo: un invito alla razionalizzazione delle
leggi e delle istituzioni.
DA MARX ALLA RIFONDAZIONE. Giovanni
De Sio Cesari.
PREMESSA. Nel secolo scorso due grandi movimenti mondiali si sono
confrontati su tutti i piani possibili: il socialismo e il capitalismo. Il
socialismo (e il comunismo) parlava di uguaglianza, di giustizia sociale, di
solidarietà, era dalla parte dei poveri e degli oppressi; il capitalismo
(liberismo) invece esaltava la competizione, puntava sull'egoismo, era dalla
parte dei potenti. Per questo i giovani, i poeti, gli intellettuali, tutti
quelli che avevano a cuore le sorti dell'umanità inclinavano sempre verso il
socialismo. Tuttavia alla fine del secolo il capitalismo (liberismo) si è
dimostrato, potremmo dire “purtroppo”, la forma più adatta alla civiltà
industriale: il socialismo in parte è confluito nel capitalismo stesso e nella
sua manifestazione più coerente e radicale, il comunismo, si è dissolto. In
particolare il comunismo marxista è stato, in positivo o in negativo, il
protagonista della storia del secolo scorso: nel nostro secolo invece è sparito
come grande movimento storico anche nei paesi che si dicono ancora comunisti
(Cina, Viet-nam tranne forse Cuba e Nord Corea) ed è rimasto una aspirazione di
piccole minoranze politicamente ininfluenti. Almeno per le prossime generazioni
il socialismo può rimanere una bella e nobile ideale ma non ha nessuna
possibilità di realizzazione nella realtà nei fatti. Per un secolo quasi quindi
Marx è stato il punto sul quale il mondo si divideva fra quelli che lo
sostenevano e quelli che gli erano contrari: adesso il suo pensiero è fuori
della realtà politica ma può dare suggerimenti, spunti, idee. Succede per Marx
come per Mazzini o per Voltaire: ai loro tempi divisero il mondo ma ora sono un
patrimonio comune: non siamo più contro o a favore di Mazzini, come i nostri
antenati, ma giudichiamo storicamente Mazzini (e i liberali) insieme ai loro
avversari reazionari, qualche volta anche riabilitandoli (come i Borboni di
Napoli). Però Mazzini e gli illuministi furono dei vincitori nella storia nel
senso che le generazioni che vennero dopo di loro li acclamarono come propri
maestri: la storia invece ha dato torto a Marx: le statue di Mazzini sono ancora
ovunque ma non se ne vedono di Marx. Ma questo nulla toglie al fatto che il
pensiero di Marx rimane uno dei fondamenti della nostra cultura e della nostra
civiltà. Il termine di marxismo e di comunismo viene usato in molti significati
diversi e tutti validi e non ha senso parlare di "vero" comunismo contrapposto a
un "falso" comunismo: le parole importanti hanno sempre tanti significati
diversi e non vi è certo un copyright sul termine. Si definiscono comunisti e
marxisti Stalin e Troztski, Togliatti e i sessantottini, Mao e Deng Xiaoping,
(attuale dirigenza cinese ). Fondamentale è la distinzione poi fra pensiero
marxiano (proprio di Marx, d'altra parte con tante interpretazioni ) e il
marxismo (cioè il movimento che si fa ad esso, estremamente vario). In questa
lavoro intendiamo mostrare brevemente l’evoluzione dal pensiero proprio di Marx
fino a certe posizioni della cosi detta Sinistra Alternativa (S.A.) diffusa in
tutto il mondo occidentale che, benchè tagliata ormai fuori dalla possibilità di
governo, tuttavia mantiene un suo seguito vivace e attivo nella vita politica.
MARX : LA SCIENZA. La teoria di Marx non era un semplice
pauperismo, incentrato sulle idee di giustizia e umanità (socialismo utopistico)
ma voleva essere una disanima scientifica. La sua opera fondamentale venne
intitolata, non a caso. “il capitale” (non “il comunismo”) perchè Marx intendeva
mostrare, attraverso una analisi scientifica dell’economia capitalista che essa
necessariamente doveva dissolversi per le proprie contraddizione interne e
strutturali , non superabili. In sintesi, senza scendere nelle argomentazioni
tecniche, Marx legò la sua dottrina alla previsione "scientifica" che i ricchi
sarebbero stati sempre più pochi e sempre più ricchi (borghesi) e i poveri
sarebbero stati sempre più numerosi e sempre più poveri (proletari) con la
sparizione del ceto medio e dei lavoratori indipendenti. Ma questa previsione
non si è affatto verificata: anzi è avvenuto il contrario di quanto previsto da
Marx. In tutti i paesi capitalistici il ceto medio si è esteso fino a
comprendere la grande maggioranza della popolazione e i lavoratori indipendenti
sono sempre più numerosi di quelli dipendenti. Non esiste quindi una lotta del
proletariato contro la borghesia perchè le due classi, nel senso marxiano, non
esistono più. Le minoranze povere come gli emarginati, i giovani disoccupati, le
famiglie monoredditi, gli emigrati, sono cosa diversa dal proletariato marxiano.
I lavoratori non si identificano più con i salariati proletari di Marx: la
classe dei lavoratori ha cambiato profondamente i suoi i caratteri. In essa
confluiscono gli operai e gli impiegati, i dipendenti e gli autonomi, i
professionisti e gli artigiani e i piccoli imprenditori e anche i pensionati e
disoccupati: praticamente la classe lavoratrice si identifica con la nazione nel
suo insieme. Resterebbero fuori solo i grandi industriali: la lotta di classe
consisterebbe allora nella nazionalizzazioni delle grandi imprese: la cosa è
stata fatta nel passato e ha dato risultati cosi negativi e catastrofici che
tutti ora vogliono fare le privatizzazioni: non sarebbe certo nell'interesse
generale cioè dei lavoratori. La lotta di classe attualmente è un concetto privo
di significato. Il pensiero di Marx aveva una valore scientifico nel significato
moderno del termine cioè non nel senso di verità assoluta (come fu inteso nei
suoi tempi e dallo stesso Marx) ma di ipotesi che andava verificata nei fatti.
Nella scienza moderna, infatti, si riconosce che non si può giungere alla verità
ultima e definitiva dei fenomeni, alla essenza cioè come nella scienza antica ma
che le leggi scientifiche sono ipotesi che spiegano i fatti FINO AD ORA
osservati. Poichè nel caso di Marx la previsione si è dimostrata errata
evidentemente anche la teoria era errata, come avviene nel campo delle scienze.
Ma il fatto che le previsione non si siano verificate non toglie al fatto che la
teoria fosse scientifica: bisogna solo prendere atto che si tratta di una teoria
superata , “falsificata”, come si dice, dai fatti. Essa comunque conserva una
grande importanza culturale e costituisce pur sempre una delle componenti
fondamentali della cultura moderna.
SOCIALISMO REALE: LA RELIGIONE. E poi venne nel ‘17 la
Rivoluzione Bolscevica in Russia. In realtà si trattava di qualcosa di
profondamente diverso da quanto previsto “scientificamente” da Marx. Non si
trattava della crisi finale del capitalismo, dell’esplodere delle sua
contraddizioni perchè il capitalismo in Russia era appena appena ai primi passi
e l’economia era ancora sostanzialmente a carattere feudale. Non esisteva quindi
una proletariato nel senso marxiano del termine ma una sterminata moltitudine di
contadini intrinsecamente tradizionalisti, come avrebbe detto Marx. Soprattutto
non insorgeva, per il comunismo, il popolo nel suo complesso ma una minoranza
esigua di rivoluzionari di professione che affermavano, e credevano
effettivamente, di essere la autocoscienza del popolo. La caduta del capitalismo
era intesa da Marx come un processo spontaneo, irreversibile, sostanzialmente
pacifico che sarebbe avvenuto quando i tempi sarebbero stati maturi. Non a torto
si era detto che il “Capitale ” era il libro dei capitalisti: si aspettava il
crollo ma fino a che esso non sarebbe avvenuto il capitalista poteva
tranquillamente godersi la propria ricchezza fino al grande giorno della
Rivoluzione: i capitalisti potevano tranquillamente credere in Marx. Ma la
Rivoluzione Russa era qualcosa di radicalmente diverso. Tuttavia si affermò che
era una strada nuova, non prevista, si pensò anche che era un caso che la
Rivoluzione fosse scoppiata in Russia e ci si aspettava che essa fosse dilagata
rapidamente nel mondo capitalistico occidentale in America, in Inghilterra,
soprattutto nelle Germania della crisi del dopoguerra. Ma questo non avvenne:
alla fine degli anni 30 apparve chiaro ed evidente che la rivoluzione comunista
non si sarebbe estesa in tempi brevi fuori dalla Russia: di fatto essa poi si
estese a paesi poveri ed arretrati come la Cina. Invece in Russia si impiantò il
regime staliniano: si sospettavano dappertutto complotti capitalistici, spie
delle nemici, una città assediata che esigeva il massimo della disciplina,
monastica più che militare. Ma se i fatti avevano smentito la teoria scientifica
marxiana, Il marxismo allora divenne allora una religione, la più grande
religione del ‘900. Allora tanta parte dell’umanità credette veramente che il
regime sovietico avrebbe portato al mondo intero prosperità, giustizia pace. E
ci voleva davvero una grande fede per credere che dagli orrori staliniani
potesse nascere la società comunista prefigurata da Marx che è come dire che
l’inferno in terra avrebbe prodotto il paradiso in terra. Come pensare che un
regime che aveva provocato carestie spaventose, che aveva mandato a morte la
grande maggioranza dei propri stessi dirigenti in spaventosi processi farsa, che
dappertutto aveva sparso il terrore come nessun altro nella storia, era premessa
della liberta, della prosperità, della umanizzazione. Ma in tanti ci credettero
e i Don Peppone di tutto il mondo pensavano “ha da venì baffone” come di colui
che avrebbe finalmente estirpato dal mondo una volta per sempre la ingiustizia e
la povertà. E in tanti, in milioni, sacrificarono a questa fede terrena la loro
vita e anche la verità e l’evidenza. A un certo punto gli stessi regimi
comunisti si resero conto della impossibilita di raggiungere la società
preconizzata da Marx. Allora la prospettiva del comunismo marxiano viene
allontanato indefinitivamente nel tempo, diviene in pratica una richiamo teorico
ufficiale ma in realtà si abbandonò il progetto concreto di instaurarlo, almeno
in un futuro prevedibile. Si passa allora a quello che viene definito
“capitalismo di stato” e i paesi comunisti in qualche modo si omologano al resto
del mondo. L’evidenza e la verità erano divenute troppo forti perchè potessero
ancora essere ignorate. Crollò allora la fede nel socialismo reale degradato a
capitalismo di stato e il grande sogno del comunismo si spense lentamente nelle
masse di tutto il mondo, lasciando un grande vuoto. Il comunismo era
rappresentato da Stalin e Togliatti, Mao o i Kmer rossi, da quel terzo
dell’umanità che aveva abbracciato quel sistema che sembrava allargarsi all'Asia
tutta, all'Africa, all'America Latina: "le campagne che assediavano le
citta," si disse. Poi a un certo punto è stato detto che quello non era il
"vero" comunismo marxista, si e' parlato di "strappo" (nel 68), di "esaurimento
della spinta propulsiva". Poi quel sistema è imploso improvvisamente dappertutto
per decisone unanime degli stessi dirigenti (fatto forse unico nella storia) fra
la soddisfazione dei popoli. Nessuno si richiama ad esso ma si parla al più di
una rifondazione mentre invece il modello liberistico non solo ha vinto la sfida
ma ha preso dovunque il posto del comunismo (Cina, Russia, paesi dell'est).
LA RIFONDAZIONE : LA SETTA. Ma se i regimi comunisti ormai sono
spariti o quasi dalla storia quella antica religione del comunismo non è affatto
spenta: continua nei gruppi della Sinistra Alternativa, piccoli di numero ma
estremamente attivi sul piano ideologico e delle manifestazioni politiche. Già
negli anni 60, e poi soprattutto con la contestazione del 68, quaranta anni fa
ormai, si disse che non era finito il comunismo marxista ma solo una sua
deviazione che non aveva niente a che fare con il vero pensiero marxiano.
Infatti quando si dissolsero i miti comunisti, la maggioranza dei comunisti con
Berlinguer si posero come i “veri” democristiani (la definizione e’ di Pasolini)
cioè quelli che volevano realizzare quello che i democristiani avevano promesso
ma non realizzato e massima aspirazione il compromesso con DC stessa: la
democrazia borghese divenne allora la democrazia e basta, il capitalismo divenne
l’economia di mercato, e si fece lo strappo da "Mosca". Ma la minoranza
combattiva e motivata invece voleva rifondare il comunismo su nuove basi che non
fossero quelle del socialismo reale: continuò sempre a vagheggiare una società
alternativa ma in modo sempre più confuso e vago. L'esigenza della rifondazione
nasce dall'idea che il comunismo realizzato sia una cosa sostanzialmente diversa
da quello che Marx intendeva: si dice qualcosa di vero ma si pone anche una
grande questione che non può essere ignorata: perche mai tutti quelli che per
due generazioni hanno detto, e sono stati universalmente creduti, di seguire
Marx, perche mai tutti poi hanno costruito sistemi tanto diversi da quello
marxista? Perche erano tutti dei malvagi, dei traditori opportunisti, spie della
CIA? Chi mai ci crederebbero e comunque nello spirito di Marx sono le condizioni
materiali e non la moralità degli uomini a fare la storia. Non si accetta la
spiegazione più elementare: il pensiero di Marx era inattuabile e per questo chi
ha cercato ostinatamente di attuarlo ha costruito qualcosa di diverso, ha
creduto di portare il paradiso in terra ma ha invece costruito solo l'inferno in
terra. Quando vi era il grande partito comunista guidato da Togliatti, il
migliore, il discorso era chiaro: si contrapponeva alla democrazia borghese la
dittatura del proletariato, al capitalismo la economia pianificata, all’America
l’Unione Sovietica. L’alternativa attualmente proposta invece non si capisce
bene “cosa” sia, con quali “mezzi” attuarla (la rivoluzione e la via elettorale
sembrano ambedue escluse), soprattutto “quando” (non pare in questa
generazione). Alla fine raccoglie consensi da un piccolissimo gruppo di
appassionati e dai molti scontenti (voto di protesta). L’inquadramento della
realtà non corrispondono a quello della gente (cioè di quelli (nella stragrande
maggioranza) non particolarmente politicizzati): la gente ha il problema del
mutuo, della precarietà, dell’aumento degli alimentari e la S.A. parla di
Multinazionali, di Afganistan, della base di Vicenza, di fascismo. I modelli
cioè sono quelli di un altra società ALTERNATIVA e non corrispondono a quelli
della società attuale: in altre parole si tratta di una filosofia che vagheggia
una società che non esiste e non di un discorso politico che indica i mezzi per
operare in quella che c'è. I gruppi marxisti hanno quindi assunto l'aspetto di
una setta che va sempre più rimpicciolendosi ma che resiste, coraggiosa e
indomita. Come tutte le sette è chiusa in se, impermeabile al mondo esterno:
ritiene che tutti gli altri, il 98% delle persone non ha capito nulla o che è
corrotta, o che è succube di un inganno globale o della TV, che ogni avvenimento
si spiega con il complotto dei capitalisti e della Cia. Afferma che la fine del
mondo capitalistico è dietro l’angolo anche se poi se ne sposta continuamente la
data come fanno i testimoni di Geova, sulla fine del mondo. Anche le parole
assumono significati diversi da quelli comuni e compare un frasario oscuro,
incomprensibili ai non adepti. Non avendo quindi proposte proprie, concrete ed
effettive, ha sostenute le “buone” cause che però non c’entravano niente con il
comunismo: il pacifismo il divorzio, i gay, l’anti consumismo. Per colmo di
assurdo sostengono pure HAMAS che è quanto di più lontano si possa immaginare
dal comunismo e dalla sinistra in generale. Tuttavia i gruppi marxisti della
Sinistra Alternativa assolvono a una importante funzione nelle democrazie
occidentali in cui sono comunque inseriti e partecipi: rappresentano infatti la
voce dissenziente che mette in discussione i concetti dominanti, le prospettive
condivise, la direzione stessa verso cui corre la società. Costituiscono quindi
una riserva essenziale di pensiero critico che va oltre le prospettive immediate
e realizzabili, di tenere aperta cioè una alternativa logica alla necessita del
momento. Riveste cioè quelle caratteristiche che furono anche nella storia del
passato proprie delle sette alle quali si devono anche molti sviluppi della
civiltà e della cultura. Giovanni De Sio Cesari
La sinistra ha il buonismo ed il Politicamente Corretto su
immigrazione ed LGBTI, la destra il proibizionismo ed il punizionismo moralista
sul sesso e la droga. Il Giustizialismo per entrambi è per gli altri, il
garantismo per se stessi.
LA GUERRA ALLA CANAPA E IL POLITICALLY CORRECT DI DESTRA.
Dimitri Buffa il 3 giugno 2019 su opinione.it. Il politically correct è
un’invenzione della sinistra. Ma da tempo a destra viene scimmiottato. Basta
cambiare di segno alcuni tabù e il gioco è fatto. La sinistra ha il buonismo, la
destra il proibizionismo sulla droga e il punizionismo degli stili di vita. E
questo è il primo parallelo che salta agli occhi. In entrambi i casi si tratta
di cose stupide e poco pratiche. Dire “accogliamoli tutti” è altrettanto
velleitario che dire “facciamo la guerra alla canapa”. Anche quella senza
effetti stupefacenti. Ebbene, i rampanti nuovi “capitani” di questa destra che
legittimamente aspira al governo della nazione Italia, perché non prendono
esempio dai loro omologhi olandesi, come Geert Wilders, anche loro militanti
anti islam e anti immigrazione selvaggia, ma tutt’altro che irragionevoli
proibizionisti sulla canapa, light o hard che sia? Si parla dello “stato
spacciatore”, ma perché si concentra questa furia proibizionista su un prodotto
come la canapa che, con o senza il thc, rimane uno dei prodotti più innocui in
natura alla faccia dei finti studi di alcuni scienziati politicizzati che dai
tempi della Fini-Giovanardi sparano balle col cannone per dimostrare
l’indimostrabile? Non esiste in natura la possibilità di avere effetti letali
per ingestione o inalazione di cannabis. Mentre si può entrare in coma etilico
alla seconda bottiglia di vodka, per arrivare a una dose letale di thc
bisognerebbe mangiarsi in una botta sola qualche etto di resina di hashish. Ed
esistono maniere più comode per suicidarsi. Ma al di là dell’effetto dopante, la
canapa light dei negozi adesso di moda per la criminalizzazione propagandistica,
semplicemente vendono un prodotto senza alcuna attività dopante. Lo stato
spacciatore che vende alcool, sigarette e psicofarmaci perché dovrebbe menare
scandalo se permettesse la vendita della cannabis con il thc e tanto più quella
senza? Questo proibizionismo tutto centrato sulla canapa ricorda i primordi del
proibizionismo degli anni ’30 in America. Guidato dalla mafia italo americana.
Quando legavano il consumo da parte dei negri alla violenza sulle donne bianche
nei manifesti che imbrattavano la New York di Fiorello La Guardia. Avevano
appena perso la gallina dalle uova d’oro dell’alcool proibito su qualche altro
consumo di massa occorreva puntare. E si badi bene che la scelta cadde sulla
canapa proprio perché la fumavano tutti. Già negli anni ’30. Nel mondo c’è un
intero continente di assuntori di erba e hashish (le statistiche parlano di 300
milioni di persone) e con quelli la mafia fa i soldi. Tutto sommato eroina e
cocaina al consumo di massa non sono mai arrivate. Non a quei numeri comunque. E
i numeri che ogni anno la Direzione nazionale antimafia fornisce confermano
questo assunto. Anche se con la cocaina un enorme sforzo criminale in questo
senso è stato fatto dalla fine degli anni ’70 in poi. Parlare come fa Salvini
sulla canapa è anche fuorviante e pericoloso. Il messaggio che ogni droga è
uguale tende a livellare tutto verso il consumo più pericoloso delle droghe
pesanti. La propaganda è perniciosa e si rivolta sempre contro chi cavalca
queste bugie. Da ultimo la parabola di Gianfranco Fini - che voleva mettere in
carcere chi si faceva le canne e che rischia di finirci lui per riciclaggio
insieme a questo signor Corallo il cui padre in America viene segnalato come uno
dei boss del settore narco traffico - è molto significativa. Insomma si può
essere di destra, per legge e ordine, senza necessariamente avventurarsi con le
sirene del punizionismo moralista su sesso, droga e rock ‘n’ roll. I consumatori
di canapa indiana, leggera o hard che sia, non sono tutti tribù di “zecche” dei
centri sociali o apostoli dell’“accogliamoli tutti”. Ce ne sono milioni pure di
destra. Così come ci sono centinaia di migliaia di omosessuali che votano
Salvini. Perché allora regalare questa gente a una scialba a e opportunista
sinistra che cavalca tutto quello in cui non crede pur di raccattare voti?
Infine sulla cannabis light va fatta un’ulteriore riflessione, in attesa di
conoscere le motivazioni di questa sentenza che molto probabilmente non cambierà
nulla al di là di come è stata venduta dai servili mass media della tv pubblica
del “neo sovranismo de noantri” (si dice che il commercio non può continuare nel
dispositivo “a meno che la sostanza non abbia effetti droganti”, cioè
esattamente come è oggi, ndr): se un ragazzo oggi spinto dagli amici va in giro
a cercare cannabis non light ne trova quanta ne vuole anche sotto casa, visto
che il mercato è capillare e incontenibile. Se invece si accontentasse della
trasgressione “dethcizzata” dei negozi di cannabis light non sarebbe meglio?
Quelli che non possono bere il caffè da sempre si bevono il decaffeinato, non è
la stessa cosa? O si pensa di fare una cosa intelligente iniziando la battaglia
contro l’alcoolismo vietando le birre analcoliche?
Il problema della destra con la canapa è solo una idiozia
ideologica, un tabù, un politically correct all’incontrario. Si è rimasti col
cervello infantilista all’epoca in cui i compagni si facevano gli spinelli e
portavano i capelli lunghi e li si odiava per questo. E l’infantilismo della
politica sembra non evolvere mai verso la razionalità.
Il nuovo fascismo: Liberale, Antifascista ed Europeista.
Marco Gervasoni, 10 ottobre 2019 su Nicolaporro.it. Caro Nicola, oggi il mio
pezzo comincia a mo’ di lettera perché dobbiamo riconoscerci sconfitti. La
nostra battaglia per la libertà, di parola prima di tutto, condotta fin
dall’inizio da te, e da noi tutti, è persa. Me lo confermano due recenti fatti.
Uno, di cui scrive Azzurra Barbuto su Libero del’8 ottobre: un insegnante
livornese accusata di razzismo, e richiamata dai superiori, per aver proposto in
classe un’esercitazione in cui si contrapponevano le ragioni dei favorevoli a
quelle dei contrari all’immigrazione, senza prendere posizione. Come ha osato?
Sarebbe come se nella Germania nazista si fronteggiassero le ragioni dei nazisti
a quelle degli altri: l’accusa di essere ostile al Fuhrer sarebbe scattata
subito. O come se in uno qualsiasi dei regimi comunisti si opponessero le
ragioni del marxismo-leninismo a quelle degli altri: insegnante buttata fuori
subito in quanto “traditrice del popolo”. Secondo fatto, da La Verità del 9
ottobre: i verdi italiani, riunitisi in una cabina telefonica, chiedono
formalmente ai giornali e alle Tv di non ospitare le ragioni degli scienziati
negazionisti: quelli che non credono alla (balla) della emergenza climatica. Non
si capisce quale ritorsione i gretini nostrani minaccino, per i reprobi che
continuino a pubblicare, ad esempio, Franco Battaglia. Ma l’avvertimento è
lanciato. Di fronte a tutto ciò dobbiamo dichiararci sconfitti. E in nome del
“nuovo umanesimo” professato da Giuseppi e i suoi fratelli (nel doppio senso)
dobbiamo essere costruttivi. Ecco alcune proposte. Gli insegnanti di ogni grado,
dai nidi all’università, dovranno rispettare i valori del SELA (Stato Etico
Liberale Antifascista) che sono: 1) l’Antifascismo (che non abbisogna di
spiegazioni, esso è, come l’Essere parmenideo); 2) l’immigrazione è positiva e
gli immigrati (tutti profughi) sono intrinsecamente buoni, ci arricchiscono sia
materialmente che spiritualmente; 3) l’emergenza climatica è un dogma
inoppugnabile; 4) l’Europa è la nostra patria, le nazioni e i confini non
esistono, l’Euro ci ha reso tutti più ricchi e felici. Gli insegnanti sono
obbligati, al di là delle loro materie, a insistere sempre su questi valori e a
ribadirli durante le ore di lezione: quindi avremo la Letteratura Liberale, la
Matematica Liberale, il Disegno tecnico Liberale, la Musica liberale, e via
dicendo. Apposite ore saranno tuttavia riservate per l’insegnamento della MLAE
(Mistica Liberale Antifascista Europeista). Qualsiasi insegnante sia colto a
mettere in dubbio questi valori sarà immediatamente licenziato ed eventualmente
deferito al TDRLA (Tribunale per la Difesa della Razza Liberale Antifascista).
Sarà fatto divieto agli insegnanti di mettere in dubbio i valori del SELA anche
sui social, che saranno controllati da un‘apposita commissione del Ministero
della Educazione Liberale Europeista. Chiunque anche solo ponga un like su post
contrari ai valori del SELA sarà licenziato. Ma poiché il privato è pubblico e
il pubblico è privato, grazie ai sistemi di ricognizione facciale e alle
tecnologie introdotte dalla Cina comunista (un modello per il SELA),
l’insegnante sarà licenziato anche se dovesse dubitare dei valori Liberali
Antifascisti Europeisti in piscina o al bar. Sui pensieri, si sta lavorando, ma
anche qui con l’apporto di Pechino si stanno facendo passi avanti. Per quanto
riguarda invece i giornalisti, chiunque voglia scrivere su testate cartacee, on
line o in tv o in radio dovrà possedere la tessera dell’OGLE (Ordine dei
Giornalisti Liberali Europeisti). Qualsiasi giornale ospitasse pezzi scritti da
estranei all’Ordine sarà chiuso. Ogni pezzo sarà comunque preventivamente
controllato dal Ministero della Cultura Liberale Antifascista, ricordato più
speditamente come MINCULA (senza apostrofo). Il MINCULA provvederà, attraverso
appositi algoritmi, a modificare e a riscrivere pezzi che mettano in dubbio i
valori del SELA. E’ chiaro che alla quinta modifica di pezzo nel corso di un
mese, il MINCULA farà chiudere il giornale. Tutto questo, oltre che estremamente
Liberale Antifascista ed Europeista, mi sembra anche nuovo per il nostro paese.
O no? Marco Gervasoni, 10 ottobre 2019
GENERAZIONE Z 2. Carole Hallac
per “la Stampa”il 9 ottobre 2019. Addio Millennials. All' Advertising Week di
New York i riflettori sono puntati sui Gen Z, il gruppo demografico più
influente del pianeta, e che entro il 2020, rappresenterà 2.56 miliardi di
individui e conterà il 40% dei consumatori. Chi sono i Gen Z? Nati dopo il 1996,
sono la prima generazione di «social natives», e usano in maniera istintiva e
naturale i social media. Bombardati da continue informazioni, la curva per
attirare la loro attenzione è di soli otto secondi, ma possono guardare Netflix
per ore. Passano di media nove ore al giorno davanti allo schermo, quattro di
queste facendo diverse cose allo stesso tempo in quanto abilissimi al
multitasking. Per loro, mondo virtuale e quello reale sono realtà complementari,
e alcuni considerano Alexa parte della famiglia. Sono diffidenti verso la classe
dirigente, e più sovversivi dalle generazioni precedenti, capaci con un tweet di
mobilitare un boicottaggio o creare un movimento per una causa a cui credono. La
«we generation» I Gen Z si distinguono dai Millenials, considerati la
generazione dell'«io», per essere quella del «noi» e usano i social media per
creare comunità e non solo connessioni individuali. Pensano al noi in senso
globale, non solo al proprio cerchio di amicizie, e sono sensibili al benessere
collettivo. Negli Stati Uniti, il 51% appartiene a gruppi di minoranze, una
diversità che vogliono celebrare. Questo vale anche per l' orientamento
sessuale: solo due terzi si considera eterosessuale, e sin da piccoli, rigettano
la divisione binaria spronando Mattel a introdurre una bambola no gender. Hanno
a cuore l' eco sostenibilità, scegliendo brand e aziende che considerano etici
(70%), sia per gli acquisti che quando entrano nella forza lavoro. Desiderio di
autonomia Grazie all' uso delle risorse online, in particolare YouTube, i Gen Z
hanno l' abilità di auto educarsi e ritenere un grande numero di informazioni.
«Maturano sia fisicamente che mentalmente prima delle altre generazioni - spiega
Monica Dreger, VP di Mattel - e ora sono parte delle decisioni importanti in
famiglia, come l' acquisto di una casa o di una macchina». Il desiderio di
autonomia spinge molti a lasciare gli studi dopo il liceo o lanciare il proprio
business, e, sul lavoro, prediligono l' indipendenza mentre i Millennials
cercano la collaborazione.
Il rapporto con i social. Il 94% dei Gen Z usa almeno un canale
social, a cui quasi la metà ammette di essere costantemente connessa. In una
ricerca dell' agenzia Hill Holiday, è pero emerso che il numero di Gen Z cui i
social fanno sentire ansiosi, tristi o depressi, è in aumento (48% contro 41%
nel 2017). Molto più giovani stanno cercando di staccarsene temporaneamente (il
58% contro il 50% del 2017), e di questi, un terzo si è completamente
disconnesso. Tra le cause, la perdita di tempo, la negatività online, problemi
di stima e preoccupazioni sulla privacy. Si rileva un aumento di "Finsta", finti
profili Instagram in cui danno accesso a un numero ristretto di amici e sentono
meno pressioni di pubblicare immagini di una vita perfetta. Ciò nonostante, il
74% ritiene che i social abbiano più benefici che svantaggi, come l' abilità di
connettere con altri. Tra i canali in crescita, Tik Tok (40 milioni di utenti),
e la piattaforma di gaming Discord (250 millioni). Come conquistarli La parola
chiave per la Gen Z è l' autenticità. «I brand devono prendere sul serio il
messaggio che vogliono comunicare, non può essere solo di apparenza - spiega
Ziad Ahmed, fondatore ventenne di JUV Consulting, società di consulenza
focalizzata sulla Gen Z - Abbiamo un filtro naturale per l' inautenticità».
Vogliono sentirsi unici, scegliendo prodotti esclusivi, ad edizione limitata e
personalizzati, e amano lo shopping esperenziale, spingendo molti brand digitali
a creare negozi e pop up shop.
Greta Thunberg e Carola Rackete, ambientalisti e Ong fanno un
partito insieme. Gianluca Veneziani su Libero
Quotidiano il 6 Ottobre 2019. Tira una brutta aria in politica. Eravamo convinti
di aver visto il peggio con la nascita del governo giallorosso, i
grillo-comunisti al potere e la loro ideologia a metà tra Utopia e Incompetenza.
E invece, tenetevi forte, al peggio non c' è mai fine perché stanno arrivando i
gretini al seguito della Thunberg, il movimento dei Fridays For Future, ossia
del cazzeggio del venerdì per bigiare la scuola, che ora ha intenzione di
trasformarsi in un partito. Sì, ma mica un partito di periferia, buono a
candidarsi per le elezioni locali. No, un partito globale. Dopo il successo
avuto dalle piazzate dei ragazzini ecologisti in mezzo mondo, Greta & Co. sono
pronti a fare il grande passo, a scendere in politica, sfidando dall' interno
quel Palazzo che contestano, anzi aprendolo come una scatoletta di tonno, se non
fosse che questa espressione è già stata usata ed è un po' troppo poco
ecologista. Il Climate Party, il partito del Clima, cui darebbe vita la
Thunberg, intende superare i «partiti verdi e ambientalisti che si sono
impantanati nei giochi di potere dei parlamenti nazionali e regionali», si legge
su Italpress, e proporre «una piattaforma programmatica alle elezioni, comune in
tutti i Paesi occidentali», per dare vita - udite udite - a una «leadership
governativa internazionale».
CORSI E RICORSI. L' ultima volta che un partito ha avuto una
vocazione Internazionale è stata ai tempi del Partito comunista, e sappiamo come
è finita. I proletari di tutto il mondo non si sono uniti spontaneamente;
viceversa l' idea è stata imposta negli altri Paesi con esiti sanguinari. A
questo retaggio globalista i gretini associano il mito della democrazia diretta
e digitale, della E-democracy come a loro piace chiamarla. L' obiettivo
è portare in politica i cittadini comuni, gli adolescenti dell' antipolitica,
volti nuovi, candidi e quindi candidabili, facce pulite anche perché odiano
tanto lo smog e l' anidride carbonica. Ma il problema, oltre che anagrafico, è
di competenza: con quale esperienza, con quali conoscenze, con quali capacità di
leadership questi sbarbatelli andranno a comandare, per dirla con Rovazzi? Non
rischiamo una nuova accozzaglia di incapaci buttati lì nei Palazzi, mandati al
macello, e allo stesso tempo in grado di mandare in malora tutto l' Occidente?
Non bastavano i grillini, ora ci toccano pure i gretini. Il dramma è che alla
loro ingenuità sommano pretese smodate come quella di salvare il pianeta, con un
cocktail letale tra inettitudine e scarso senso della realtà. Questo Partito del
Clima intende addirittura sfidare le superpotenze del Male come Cina, Russia,
India, Pakistan, Iran, che «hanno anteposto gli interessi militari e nazionali
al rispetto dell' ambiente». Ma ve li vedete quattro adolescenti imberbi e una
paladina delle emissioni zero con le treccine far cambiare rotta a Putin, a Xi
Jinping, a Modi? Ah be', c'è Greta Thunberg, c'è il partito del Clima,
deindustrializziamo subito, torniamo a un' economia rurale Orsù, non fateci
ridere. Aggiungici poi l' ideologia dello sconfinamento. Perché tutto, secondo i
gretini, deve stare entro i parametri, i limiti (le emissioni, i consumi, lo
sfruttamento delle terre coltivate), tranne le nazioni che devono perdere i loro
confini e diventare globali. E qua l' ideologia di Greta si salda con quella di
Carola, con lo slogan No Borders, con l' essere cittadini del mondo, e non figli
di un luogo e di una storia. Soprattutto, però, quello che nausea è scoprire che
la partecipazione genuina, l' ambizione nobile a cambiare le coscienze dei
grandi del mondo, la battaglia senza doppi fini dei ragazzini si risolve, come
sempre, in scopi molto più meschini: l' obiettivo di far carriera, di essere
eletti e magari riuscire a occupare un giorno le stanze dei potenti.
COME FINIRÀ. Resta solo da capire chi guiderà, quali saranno i
colori e come si chiamerà ufficialmente questo partito del Clima. Per la
leadership Greta pare avvantaggiata, anche se al momento non può ancora eleggere
né essere eletta e quindi per un paio d' anni dovrà farsi aiutare da qualche
vicario. Per il colore, il verde sarebbe troppo sputtanato perché già utilizzato
dai Verdi e dalla Lega: i gretini farebbero meglio a utilizzare un colore
trasparente, come l' aria che vogliono respirare e come le loro idee, così
trasparenti da essere invisibili. Per il nome, si potranno sbizzarrire con le
sigle: Il Partito della Tripla Fi come Fridays For Future oppure C & G che non è
la versione tarocca di Dolce e Gabbana ma sono le iniziali di Carola e Greta.
Oh, però sti ragazzini devono fare in fretta. Nel 2030 il pianeta si estingue e,
se non scendono in campo ora, rischiano di essere morti prima ancora di essere
eletti. Gianluca Veneziani
LA SOLITA INVASIONE BARBARICA SABAUDA. (Ho scritto un saggio
dedicato)
·
Il lungo viaggio temporale in Italia.
Come si è formata l'identità italiana.
Viaggio nell'identità italiana: come si è formata e come si
modificherà ancora? Matteo Carnieletto, Domenica 13/12/2020 su Il Giornale.
"Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani". Questa frase è il sunto di un
pensiero ben più ampio di Massimo D'Azeglio, uno dei padri fondatori del nostro
Paese. A distanza di più di centocinquant'anni dalla nascità dello Stato
italiano - e il passaggio tra due guerre mondiali - è ormai chiaro quali sono i
confini e l'identità della nostro Stato. Un po' meno quella degli italiani, a
volte troppo distratti o addirittura non interessati alla propria identità. Ma
cosa definisce un italiano tale, dato che la sua identità è il frutto di un
continuo via vai di popoli e di culture? Il suo aspetto fisico? Solo in parte.
Se si visita M9, il museo del Novecento di Mestre nato anche grazie
all'intuizione di Cesare De Michelis, si scopre che siamo cambiati molto
rispetto ai nostri avi. Come spiega il museo, infatti, i cambiamenti tecnologici
degli ultimi anni hanno cambiato profondamente il nostro aspetto: "I
miglioramenti economici e sociali del XX secolo non hanno cambiato solo la
nostra vita: hanno trasformato anche il nostro corpo e i nostri lineamenti".
Grazie ad alcuni "specchi magici" presenti all'interno della struttura, possiamo
però vestire "i panni dei nostri antenati per vedere che aspetto avremmo avuto
se fossimo vissuti in epoche diverse". Scartato dunque l'aspetto fisico, in
continuo movimento, ci vuole ben altro per definire l'identità italiana. Come ci
spiega Luca Molinari, nuovo direttore scientifico di M9: "Il museo è aperto e
quasi i visitatori ci si perdono e si perdono all'interno del Novecento
italiano. La nostra è una mostra impegnativa a livello di attenzione, ma aiuta a
capire meglio chi siamo. Cosa determina la nostra identità? Ciò che mangiamo,
ciò che facciamo, ciò che produciamo, ma anche ciò che roviniamo, come il
paesaggio. M9 non è solo un museo di storia del Novecento – continua Molinari –
ma è anche un laboratorio del contemporaneo. Questo per me è centrale. Abbiamo
bisogno di immergere il museo nell’attualità: ovvero usare la storia del passato
prossimo per raccogliere le sfide di un tempo che sta vivendo una trasformazione
potente e drammatica”. In questa chiave il museo viene immaginato come “una casa
aperta per tutti” cioè come un luogo “dove sperimentare il futuro nel presente”.
Questa impostazione si traduce nel fatto che la mostra permanente dedicata alla
storia del Novecento, cuore del museo, ”verrà attraversata da un’attenzione
molto forte in termini di potenziamento per coinvolgere i bambini e le persone
con fragilità. Quello che vogliamo fare nei prossimi anni è generare un museo a
misura di bambini e fragilità”. Forse si può cominciare a tratteggiare il nostro
identikit partendo dalla cucina, il luogo per eccellenza di tutte le case
italiane. Dove ci si riunisce per mangiare, per bere un buon caffè e anche per
discutere. Ma con una particolarità, come scrive John Dickie, autore di Con
gusto. Storia degli italiani a tavola (Laterza): "Quando gli italiani mangiano i
loro alimenti tipici, nel piatto c'è sempre un ingrediente in più che un
forestiero non riesce a percepire: sembrerà retorico, ma questo ingrediente è
l'orgoglio di campanile". Perché la cucina italiana non cambia solamente nel
tempo, ma anche - e verrebbe quasi da dire soprattutto - nello spazio. "Perché
il cibo italiano, quando è al suo massimo, è carismatico" - afferma Dickie - "E
lo è per via di quel suo rapporto quasi poetico con il territorio e con
l'identità: gli italiani mangiano così bene perché la cucina rafforza in loro il
sentimento delle origini e dell'identità". Ora possiamo dire qualcosa di più
dell'identità italiana: essa è fatta di tante piccole patrie. Di tanti piccoli
orgogli locali, che si uniscono. "Quest’area tematica racconta l’evoluzione di
questo spazio domestico attraverso la ricostruzione di quattro cucine di epoche
diverse e le testimonianze di chi le ha abitate, evidenziando il ruolo
dell’alimentazione nella costruzione dell’identità italiana, dai prodotti che
hanno riempito l’immaginario e le pance dei nostri nonni sino alle nuove
abitudini indotte dallo sviluppo della moderna industria agroalimentare", si
legge sul sito del museo. Italia è anche la storia della sua politica,
soprattutto quella più tormentata del Novecento. È infatti la Prima guerra
mondiale a fare davvero gli italiani. È questo il momento in cui il siciliano
viene spedito sull'Adamello insieme al veneto e all'umbro che, forse, si
scoprono per la prima volta connazionali mentre imprecano contro chi li ha
spediti lì. Al freddo e sotto il tiro dei nemici. Gli italiani perdono questa
guerra fino a quando non capiscono, dopo la disfatta di Caporetto, che gli
austriaci possono penetrare nell'entroterra. È a quel punto che reagiscono. È a
quel punto che un giovane fante, Luigi Saccaro, pronuncia una frase che rimarrà
nella storia: "Fin qui è arrivato il nemico, ma di qui non si passa". Una frase
che riecheggia, anche se il fante italiano non poteva saperlo, quanto scritto
da G. K. Chesterton: "Un vero soldato non combatte perché ha davanti a sé
qualcosa che odia. Combatte perché ha dietro di sé qualcosa che ama". Anche
questo fa parte della nostra identità. Dopo la Prima guerra mondiale è stato il
momento del biennio rosso e poi del Fascismo, durato come noto un Ventennio. Uno
dei tratti distintivi di questo periodo sono le piazze piene, soprattutto negli
anni che Renzo De Felice definisce "del consenso". Per comprendere perché così
tanti italiani siano rimasti affascinati da Benito Mussolini bisogna proprio
partire da quelle piazze e provare ad ascoltare il Duce dalla mascella volitiva.
All'interno del museo è infatti presente un'area, chiamata L’arena politica, in
cui alcuni attori rimettono in scena alcuni tra i più importanti discorsi
politici del Novecento: "Nel Novecento comizi, manifestazioni, scioperi e cortei
costituiscono gli spazi, anche simbolici, del discorso e della vita politica,
sino a quando, alla fine del secolo, le arene virtuali degli studi televisivi e
dei social media si sovrappongono alle piazze, alle sedi delle istituzioni, alle
sezioni dei partiti. Il corso della storia politica nazionale è segnato
dall’intersezione tra la partecipazione delle masse e la presenza di leader
carismatici". E anche questo è uno dei tratti distintivi della nostra identità:
la passione per la politica e pure il vizio di cambiar bandiera, come disse
sir Winston Churchill: "Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di
fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure
questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti". L'Italia è il paese
di Don Camillo e Peppone, dei rossi contro i neri. Dove è possibile scannarsi -
e i fatti dall'8 settembre in poi e degli Anni di piombo sono lì a ricordarlo -
ma dove poi si può andare d'accordo su quanto di più importante, come
scrive Giovannino Guareschi: "Bisogna rendersi conto che, in quella fettaccia di
terra tre il fiume e il monte, possono succedere cose che da altre parti non
succedono. Cose che non stonano mai col paesaggio. E là tira un'aria speciale
che va bene per i vivi e per i morti, e là hanno un'anima anche i cani. Allora
si capisce meglio don Camillo, Peppone e tutta l'altra meranzia. E non ci si
stupisce che il Cristo parli e che uno possa spaccare la zucca a un altro, ma
onestamente, però: cioè senza odio. E che due nemici si trovino, alla fine,
d'accordo nelle cose essenziali. Perché è l'ampio, eterno respiro del fiume che
pulisce l'aria. (...) Ecco l'aria che si respira in quella fettaccia di terra
fuori mano: e si capisce facilmente cosa possa diventare laggiù la faccenda
della politica". Dopo mesi di stop dovuti all'emergenza Covid-19, il museo è
pronto a ripartire, come ha spiegato Michele Bugliesi, presidente
della Fondazione Venezia, più accogliente di prima: "In questi mesi di stop
abbiamo rivisto dalle fondamenta scopi, articolazioni e attività, e modello di
gestione di M9, ora siamo pronti. Vogliamo che sia una casa aperta per tutta la
città". Per questo sono stati preparati grandi investimenti per conquistare
giovani e adulti attraverso nuovi laboratori e per riuscire a intercettare anche
le comunità straniere presenti in Italia.
L'italiano che domò gli afghani: ecco chi era il terrore
dell'Asia. Una storia di avventura, sangue e guerra
che parte dal Regno delle Due Sicilie e finisce nell'antica Persia. Così Paolo
Avitabile divenne il più pericolo giustiziere delle rivolte afghane. Davide
Bartoccini, Giovedì 17/09/2020 su Il Giornale. Tra le vecchie storie che ancora
si raccontano in Afghanistan, la scacchiera di sabbia e sassi dove da oltre tre
secoli si disputa il “Grande Gioco” e noto per essere la "Tomba degli imperi", è
ben impressa nella memoria di quanti vi hanno transitato la storia del
generale Paolo Avitabile, un napoletano di umili origini, soldato di ventura e
ufficiale del Regno delle Due Sicilie, che arrivò nel vicino Oriente nel XIX
secolo, per rimanere nella leggenda come Abu Tabela, “il terrore afgano”. Nato
nel 1791 ad Agerola, altopiano che domina il mare tra Amalfi e Positano,
Avitabile entrò sotto le armi giovanissimo, per sfuggire alla povertà, e imparò
presto i segreti dell’arte militare che, oltre ai gradi di ufficiale, lo
avrebbero presto portato ad ammodernare e comandare due tra i grandi eserciti
d’Oriente. Dopo essere stato alle dipendenze delle Scià di Persia, raggiunse le
inospitali alture che dividevano l’Afghanistan dall’India (oggi Pakistan) nel
1835. Ben presto divenne governatore della regione strategica del Punjab -
crocevia fondamentale della “Via della Seta” e snodo fondamentale del Grande
Gioco che intratteneva spie e diplomatici inglesi e russi - ma soprattutto si
trasformò nello spauracchio di rivoltosi e criminali, data la sua inclinazione
naturale a divenire una sorta di Vlad di Valacchia - il famoso conte Dracula -
attraverso la sanguinaria pratica dell’impalamento, dell’impiccagione e dello
squartamento dei briganti. Metodi “sbrigativi”, certo, ma quanto mai efficaci.
Che gli costarono la fama di cruento e spietato despota, leggendario
protagonista di storie terribili che vengono ancora raccontate ai bambini dei
villaggi per intimorirli - "Se fai il cattivo di do' ad Avitabile", dicevano le
madri ai bambini, come fosse l'Uomo nero o il Babau. Ma che gli permisero di
mantenere il controllo dove nessun altro straniero era stato capace d’imporlo.
Si dice infatti che Avitabile, ingaggiato appositamente per governare i
territori separati dal Passo Khyber, si svegliasse ogni mattina con la ferma
convinzione che lasciar penzolare un brigante dalla forca o direttamente dal
minareto più alto della moschea di Peshawar avrebbe indotto gli altri a pensarci
due volte prima di agire contro il suo governatorato. Così facendo avrebbe,
presto o tardi, sedato scontri e disordini che infestavano quei luoghi dove
ormai le armate sikh, affidate al suo comando dal maharaja Ranjit Singh, lo
avevano già reso celebre con il nome di Abu Tabela. Un nome che ancora risuona
in quelle valli così distanti dalla Costiera. Un nome per sempre legato al
temibile "pragmatismo" del giustiziere di Pashawar che aveva ghermito i ribelli
pashtun facendoli uccidere davanti ai suoi occhi, mentre lui, impettito e
coperto di alamari, beveva caffè per colazione. Nella sua uniforme di
da ufficiale borbonico, con i suoi folti baffi imperiali, l'avventuriero
napoletano che faceva "un uso smodato dello champagne”, si era guadagnato il
grado di colonnello, il titolo di Kahn presso il regno di Persia, e la stima dei
britannici per aver tenuto lontani da quelle terre contese i russi. Da Peshawar
Avitabile controllava di fatto l’accesso al passo del Kyber, e con quello tutte
le zone strategiche per il primo conflitto anglo-afghano. Dopo una lunga
avventura alle porte dell’Asia, e accumulate ingenti ricchezze per i servigi
offerti ai regnanti di metà delle terre conosciute. Se ne tornò nella sua bella
Napoli, stabilendosi poi a Castellammare di Stabia. Nel 1844. Morì pochi anni
dopo in circostanze mai chiarite. Qualcuno mormora sia
stato avvelenato attraverso un piatto di agnello dalla sua giovanissima moglie,
già promessa ad un altro uomo. Qualcuno, per i “fumi emessi da una stufa”. Era
comunque l'inizio della primavera del 1850 quando spirò. Dopo aver investito
parte delle sue fortune nell'agricoltura e nell'allevamento di bestiame. Aveva,
tra le altre cose, incrociato delle vacca Jersey donategli dagli inglesi con le
vacche locali, dando vita a una nuova e apprezzata razza: le “agerolane”.
Nonostante una morte ridicola, in contraddizione con la
magnitudine della sue imprese, gli restava restava appuntata sul petto la
decorazione dell'Ordine del Leone e del Sole conferitagli dallo scià di Persia
Fath Ali Shah, e la Legion d’Onore, la più alta onorificenza di Francia,
conferitagli dal Re Luigi Filippo. Nel fodero portava ancora una sciabola
intarsiata d’oro, con fregi della Compagnia delle Indie e dell’Impero
britannico, che simboleggiava la gratitudine della Corona per essersi dimostrato
nel momento del bisogno un "gallant officer”. Sulla facciata del suo palazzo,
costruito con sterline inglesi, e caduto in rovina (per essere poi
sfacciatamente abbattuto nel ’37), restava invece un’incisione da lui molto
desiderata. “O beata solitudo, o sola beatitudo”. La solitudine forse, di chi
aveva ottenuto in grande successo dove tutti gli altri avevano e avrebbero
fallito - tra jihad, cariche di cavalleria e giochi di spie. Poiché dove non
riuscirono i generali britannici, gli eserciti della Russia zarista prima, e
sovietica poi, e financo gli astuti strateghi del Pentagono; era riuscito quel
solitario napoletano.
150 anni fa la Breccia di Porta Pia, ma è stata cancellata
ogni celebrazione. Gianfranco Spadaccia su Il
Riformista il 20 Settembre 2020. A centocinquant’anni dal 1870, quest’anno con
il 20 settembre celebriamo non una, ma due ricorrenze: da una parte la fine
dello Stato pontificio, che a lungo, al centro dell’Italia, era stato uno dei
principali ostacoli a qualsiasi progetto di unità e, insieme, il completamento
dell’Unità d’Italia con la presa di Roma e la sua elezione a capitale. Due
argomenti, due questioni storiche strettamente connesse, che ci spingono a
interrogarci sul nostro recente e breve passato nazionale, anche per meglio
comprendere i problemi del nostro difficile presente e soprattutto le
prospettive del nostro problematico futuro. Sulla prima questione, mi pare di
potere dire che essa sia stata se non chiusa, certamente in gran parte superata
dal Concilio Vaticano II e dagli sviluppi del cattolicesimo post conciliare,
che, voltando le spalle alla Chiesa del Sillabo, ha sempre più esplicitamente
riconosciuto come la breccia di Porta Pia abbia liberato anche la religione
cattolica dai condizionamenti di un potere temporale, che la allontanava dai
suoi compiti spirituali: riconoscimento non da poco ai nostri padri fondatori e
tardivo, anche se parziale, riconoscimento pure alle ragioni di Lutero. Se
questo non bastasse, è difficile per chiunque ignorare il forte
ridimensionamento che le pretese di ingerenza clericale nella vita politica e
legislativa dello Stato hanno subito con le sconfitte nei referendum del
1974 sul divorzio e del 1981 sull’interruzione volontaria della gravidanza. E
sarebbe ingiusto e superficiale sottovalutare l’orientamento complessivo
dell’attuale pontificato che, senza attenuare i principi della dottrina, sembra
aver assunto un atteggiamento assai diverso nei rapporti con lo Stato e la sua
legislazione da quello assunto della Chiesa di Ratzinger e del Cardinale
Ruini sulla fecondazione assistita, sulla ricerca scientifica e sul
riconoscimento delle unioni civili. Assai più importante è la seconda questione
storica connessa alla ricorrenza, quella che interroga direttamente lo Stato
italiano e l’Italia come comunità politica e come costruzione tuttora
incompiuta. Se infatti nella vita delle nazioni un secolo e mezzo è un tempo
assai breve, esso è tuttavia sufficiente per guardare indietro alla nostra
storia e cercare di capire le nostre debolezze e le nostre potenzialità, le
nostre possibilità e i nostri rischi. Io non sono uno spregiatore
del Risorgimento. Al contrario sono un ammiratore di quanti ne sono stati i
protagonisti e ho in orrore chiunque, cancellando Mazzini, Garibaldi, le quattro
giornate di Milano, la Repubblica Romana del 1849, la spedizione dei Mille,
pretenda di ridurlo solo a una guerra di conquista condotta della monarchia
sabauda. Non è stato così, è stato anche il frutto di una forte rivendicazione
nazionale che, dal nord al sud, coinvolse la maggioranza della borghesia
italiana, soprattutto nelle sue generazioni più giovani. Tuttavia è indubbio che
fra i grandi stati europei arrivammo a conquistare la nostra unità nazionale con
grande ritardo, creando uno stato molto debole, alle prese con una società
frammentata e divisa, e con una borghesia prevalentemente agraria, circondata da
plebi fortemente influenzate da un clero, che a lungo rifiutò di riconoscere la
legittimità del nuovo Stato. Confesso che mi sarei aspettato che, a partire
dall’indubbia crisi di identità e fiducia in se stessa che l’Italia sta
attualmente attraversando, si aprisse un dibattito in Parlamento e, se non
in Parlamento, nelle Università, nelle televisioni, sui maggiori quotidiani su
questo primo secolo e mezzo di storia italiana. Un dibattito che mettesse a
confronto la nostra attuale crisi con le numerose crisi del passato:
dall’autoritarismo di Crispi ai colpi di cannone contro le plebi
di Pelloux e Bava Beccaris, dall’illusione di affermare la nazione con avventure
coloniali fino al colpo di stato fascista che sospese e di fatto abrogò
lo Statuto albertino. Queste crisi interruppero ripetutamente negli ultimi
trenta anni dell’ottocento e nei primi venti del novecento lunghi periodi di
stabilità e, anche – penso a Giolitti, a Zanardelli, al giolittismo – positivi
periodi di riformismo e di tentativi di allargamento della base sociale dello
Stato fino al dialogo con il nascente partito socialista e al suffragio
universale. Quali sono le ragioni di questa instabilità democratica delle nostre
istituzioni, che in forme diverse si è ripetuta, dopo un lungo periodo di
stabilità, nella seconda parte della nostra storia, quella che dalla fine
della seconda guerra mondiale giunge fino a noi, prima con la crisi dei partiti
antifascisti (i cosiddetti partiti dell’arco costituzionale) e poi con la crisi
delle forze politiche che li avevano sostituiti nei primi anni ‘90: Berlusconi,
Forza Italia, Popolo della Libertà, Democratici di sinistra e Partito
democratico? Una risposta a questa domanda non può in nessun modo essere trovata
in ragioni di carattere antropologico, in base a una supposta diversità della
società italiana dalle altre società europee. Questo è un Paese che ha avuto
seicento mila morti durante la prima guerra mondiale e ha retto una prova
improba e durissima in quei quattro anni, a cui era del tutto impreparato. È un
Paese che ha avuto l’energia, la forza e la capacità di realizzare, dagli anni
Cinquanta agli anni Settanta, nell’arco di una generazione, una trasformazione
del sistema economico da prevalentemente agricolo a industriale, che altri paesi
hanno compiuto nell’arco di uno o due secoli. Basti pensare alle migrazioni
interne, che si sono sommate a quelle all’estero e che hanno trasferito il 40%
della popolazione dall’agricoltura all’industria, dal mezzogiorno al
settentrione, dalla campagna alle città. E allora forse la risposta va cercata
altrove: nella cultura della classe dirigente, non solo quella politica e
nell’incapacità di proseguire lungo la linea più vitale e più profetica del
nostro pensiero risorgimentale. Quello europeo e cosmopolitico, liberale e
federalista. L’Italia è uno Stato giovane, che nelle fasi di crisi si è
rifugiata in un nazionalismo reazionario e vittimistico, venato di patetiche
ambizioni coloniali e imperiali o di ossessive illusioni autarchiche. È stato
chiaro alla fine dell’800, dopo la I Guerra Mondiale con il fascismo, e anche in
questa crisi in cui vengono al pettine, sotto la spinta di fenomeni economici,
demografici e tecnologici di portata epocale, tutti i nodi legati alla debolezza
e all’insufficienza degli stati nazione, a partire da quelli più piccoli e
precari. Il nazionalismo in Italia non è stato l’effetto della incompletezza del
processo unitario – anche non solo per le crescenti differenze tra Nord e Sud –
ma è stato la causa dell’arretratezza e dei ritardi con cui l’Italia ha finito
per misurarsi con le sfide della politica e dell’economia contemporanea. Lo
stesso deve dirsi dell’altra faccia della medaglia nazionalista, che è quella
anti-europea e ostile a qualunque forma di integrazione politica e economica
internazionale. Proprio oggi, a 150 anni dal completamento dell’Unità, l’Italia
è tornata a inseguire le orme di un inesistente “nemico straniero” (in genere
europeo o occidentale) e a volgersi con fiducia e condiscendenza verso veri
avversari strategici, come la Cina e la Russia. Un’altra ragione politica dei
ritardi italiani è la sistematica scelta di soluzioni istituzionali
dell’ordinamento politico, che premiano i cambiamenti frequenti di alleanze e il
trasformismo anziché la governabilità di medio e lungo periodo, la ricerca di un
consenso immediato intorno a interventi improvvisati di carattere elettorale e
clientelare, a scapito di incisivi investimenti intorno a progetti efficaci di
riforma e di sviluppo. Forse la continuità di queste debolezze strutturali della
nostra cultura politica e della nostra democrazia parlamentare in momenti
diversi della nostra storia doveva spingerci a risposte meno autoassolutorie
delle responsabilità nazionali. Intendiamoci, esistono anche crisi epocali che
investono trasversalmente il mondo occidentale e quella che stiamo vivendo è
certo una di esse. Ma è del tutto evidente che il nostro sistema politico non ha
strumenti di resistenza e di stabilità e non ha gli anticorpi di cui dispongono
altri stati democratici d’Europa o d’oltre Atlantico. Quale migliore occasione,
per affrontare un simile dibattito, di quella offerta dalla ricorrenza dei 150
anni della nostra storia unitaria? E invece nessun dibattito, nessun
interrogativo. E per essere sicuri che nessuno li ponesse, è stata in pratica
cancellata la ricorrenza, silenziando ogni celebrazione.
Porta Pia, Roma completa il naufragio del Risorgimento,
iniziato nel 1860. Sergio Carli il 21 Settembre 2020
su Blitz Quotidiano. Porta Pia, i bersaglieri entrano a Roma. Il Piemonte
completa l’annessione dell’Italia e la fine del Risorgimento con Garibaldi a
Caprera. Porta Pia, il 20 settembre di 150 anni fa. Per la breccia passarono i
bersaglieri. L’Italia era nata male e la presa di Roma suggellò il fallimento
del Risorgimento. Il re a Garibaldi: fatti da parte. I Mille trattati come
ladri. La nave con Ippolito Nievo che portava i documenti dell’onestà
garibaldina affondata al largo di Capri. Il razzismo dei piemontesi e
l’ideologia della classe politica (dazi piemontesi applicati ovunque, dissennata
vendita dei beni demaniali e del clero) diedero il colpo di grazia al
Meridione, che già di suo, dopo secoli di sfruttamento, era in ginocchio. Allora
come oggi. Un anno prima lo scandalo della prima privatizzazione della storia
italiana, il monopolio dei tabacchi: il re sospettato di una mazzetta di 6
milioni (dell’epoca), mega insabbiamento. Nella biografia di Francesco Crispi,
Christopher Duggan ricostruisce il protoscandalo l’Italia. Poi venne Porta Pia,
la presa di Roma e il boom immobiliare. E anche la vergognosa Legge delle
Guarentige. Se l’Italia di oggi è così, molto ebbe inizio allora.
1. La ricostruzione di Wikipedia.
2. Repubblica. Porta Pia: Roma libera e italiana. Il 20 settembre
di 150 anni fa i bersaglieri di Cadorna entravano nella nuova capitale del
regno. Tre punti di vista su quel giorno.
3. Il Fatto. Vittorio Emiliani. I preti aspettavano i piemontesi
per la grande speculazione che ancora non si ferma. Lo scempio urbanistico nato
dalla Breccia poco Pia.
Presa di Roma. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. «La nostra
stella, o Signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna,
sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni genere di gloria, diventi la
splendida capitale del Regno Italico.» (Camillo Benso, conte di Cavour, discorso
al Parlamento del Regno di Sardegna 11 ottobre 1860). La presa di Roma, nota
anche come breccia di Porta Pia, fu l'episodio del Risorgimento che sancì
l'annessione di Roma al Regno d'Italia. Avvenuta il 20 settembre 1870, decretò
la fine dello Stato Pontificio quale entità storico-politica e fu un momento di
profonda rivoluzione nella gestione del potere temporale da parte dei papi.
L'anno successivo la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma (legge 3
febbraio 1871, n. 33). L'anniversario del 20 settembre è stato festività
nazionale fino al 1930, quando fu abolito a seguito della firma dei Patti
Lateranensi.
Le premesse. Il comandante delle truppe pontificie,
il badese Hermann Kanzler. Il comandante dell'esercito italiano,
generale Raffaele Cadorna. Il desiderio di porre Roma a capitale del nuovo Regno
d'Italia era già stato esplicitato da Cavour nel suo discorso al parlamento
italiano il 27 marzo 1861. Cavour prese poco dopo i contatti a Roma con Diomede
Pantaleoni, che aveva ampie conoscenze nell'ambiente ecclesiastico, per cercare
una soluzione che assicurasse l'indipendenza del papa. Il principio era quello
della "libertà assoluta della Chiesa" cioè la libertà di coscienza, assicurando
ai cattolici l'indipendenza del pontefice dal potere civile. Inizialmente si
ebbe l'impressione che questa trattativa non dispiacesse completamente a Pio
IX e al cardinale Giacomo Antonelli, ma questi dopo poco, già nei primi mesi del
1861, cambiarono atteggiamento e le trattative non ebbero seguito. Poco dopo
Cavour affermò in parlamento che riteneva «necessaria Roma all'Italia» e che
prima o poi Roma sarebbe stata la capitale, ma che per far questo era necessario
il consenso della Francia. Sperava che l'Europa tutta sarebbe stata convinta
dell'importanza della separazione tra potere spirituale e potere temporale e
quindi riaffermò il principio di «libera Chiesa in libero Stato». Cavour già
nell'aprile scrisse al principe Napoleone per convincere l'imperatore a togliere
da Roma il presidio francese che lì si trovava. Ricevette anche dal principe un
abbozzo di convenzione:
«Fra l'Italia e la Francia, senza l'intervento della corte di
Roma, si verrebbe a stipulare quanto segue:
1. La Francia, avendo messo il Santo Padre al coperto d'ogni
intervento straniero, ritirerebbe da Roma le sue truppe, in uno spazio di tempo
determinato, di 15 giorni o al più di un mese.
2. L'Italia prenderebbe impegno di non assalire ed eziandio di
impedire in ogni modo a chicchessia, ogni aggressione contro il territorio
rimasto in possesso del Santo Padre.
3. Il governo italiano s'interdirebbe qualunque reclamo contro
l'organamento di un esercito pontificio, anche costituito di volontari cattolici
stranieri, purché non oltrepassasse l'effettivo di 10 mila soldati, e non
degenerasse in un mezzo di offesa a danno del regno d'Italia.
4. L'Italia si dichiarerebbe pronta ad entrare in trattative
dirette con il governo romano, per prendere a suo carico la parte proporzionale
che le spetterebbe nella passività degli antichi stati della chiesa.» (in
Cadorna, La liberazione)
Il conte di Cavour vi acconsentiva in linea di massima, perché
sperava che la stessa popolazione romana avrebbe risolto i problemi senza
bisogno di repressioni da parte di governi stranieri, e che il Papa avrebbe
infine ceduto alle spinte unitarie. Le uniche riserve espresse riguardavano la
presenza di truppe straniere. La convenzione però non arrivò a conclusione per
la morte di Cavour, il 6 giugno del 1861. Bettino Ricasoli, successore di
Cavour, cercò di riaprire i contatti con il cardinale Antonelli già il 10
settembre 1861, con una nota in cui faceva appello «alla mente ed al cuore del
Santo Padre, perché colla sua sapienza e bontà, consenta ad un accordo che
lasciando intatti i diritti della nazione, provvederebbe efficacemente alla
dignità e grandezza della chiesa». Ancora una volta Antonelli e Pio IX si
mostrarono contrari. L'ambasciatore francese a Roma scrisse al suo ministro che
il cardinale gli aveva detto:
(FR) «Quant à pactiser avec les spoliateurs, nous ne le ferons
jamais.»
(IT) «Quanto a fare accordi con gli espropriatori, noi non lo
faremo mai» (Card. Antonelli)
Da quel momento ci fu uno stallo nelle attività diplomatiche,
mentre rimaneva viva la spinta all'azione di Garibaldi e dei mazziniani. Ci
furono una serie di tentativi tra cui quello più noto si concluse
all'Aspromonte ove i bersaglieri fermarono, dopo un breve conflitto a fuoco,
Garibaldi che stava risalendo la penisola con una banda di volontari diretto a
Roma. Agli inizi del 1863, il governo Minghetti riprese le trattative con
Napoleone III, ma dopo questi avvenimenti Napoleone pretese maggiori garanzie.
Si arrivò quindi alla convenzione di settembre 1864, un accordo con Napoleone
che prevedeva il ritiro delle truppe francesi, in cambio di un impegno da parte
dell'Italia a non invadere lo Stato Pontificio. A garanzia dell'impegno da parte
italiana, la Francia chiese il trasferimento della capitale da Torino ad
un'altra città, che sarebbe stata poi Firenze. Entrambe le parti espressero
comunque una serie di riserve, e l'Italia si riservava completa libertà d'azione
nel caso che una rivoluzione scoppiasse a Roma, condizioni che furono accettate
dalla Francia, che riconobbe in questo modo i diritti dell'Italia su Roma. Nel
settembre 1867 Garibaldi fece un nuovo tentativo sbarcando nel Lazio. In ottobre
i francesi sbarcarono a Civitavecchia e si unirono alle truppe pontificie
scontrandosi con i garibaldini. L'esercito italiano, in ottemperanza alla
Convenzione di settembre, non varcò i confini dello Stato Pontificio. Il 3
novembre i garibaldini furono sconfitti nella Battaglia di Mentana. Tornata la
pace, i soldati francesi, nonostante quanto previsto dalla Convenzione di
settembre, lasciarono una guarnigione di stanza nella fortezza di Civitavecchia
e due presidi, uno a Tarquinia e uno a Viterbo (in tutto 4.000 uomini)[3]. Il
ministro francese Eugène Rouher dichiarò al Parlamento francese:
(FR) «Que l'Italie peut faire sans Rome; nous déclarons qu'elle
ne s'emparera jamais de cette ville. La France ne supportera jamais cette
violence faite à son honneur et au catholicisme.»
(IT) «Che l'Italia può fare a meno di Roma; noi dichiariamo che
non si impadronirà mai di questa città. La Francia non sopporterà mai questa
violenza fatta al suo onore ed al cattolicesimo.» (Eugène Rouher)
L'8 dicembre 1869 il papa indisse a Roma il concilio
ecumenico Vaticano I volendo risolvere il problema dell'infallibilità papale,
questa decisione destò preoccupazione nella classe politica italiana per il
timore che servisse al Papa per intromettersi con maggior autorità negli affari
politici dello stato. Il 9 dicembre Giovanni Lanza, nel discorso di insediamento
alla presidenza della Camera dei deputati, dichiarò che «siamo unanimi a volere
il compimento dell'unità nazionale; e Roma, tardi o tosto, per la necessità
delle cose e per la ragione dei tempi, dovrà essere capitale d'Italia». Alla
fine del 1869 lo stesso Lanza, alla caduta del terzo gabinetto Menabrea, si
insediò come nuovo capo del Governo. Nel 1870 si propagarono nella penisola
diverse insurrezioni di matrice mazziniana. Tra le più note vi fu quella
di Pavia, dove il 24 marzo un gruppo di repubblicani assaltò una caserma. Il
caporale Pietro Barsanti, in servizio nella caserma ed anch'egli mazziniano,
rifiutò di reprimere i rivoltosi, contribuendo anzi a fomentare la rivolta.
Arrestato e negatagli la grazia sovrana, Barsanti fu giustiziato il 26 agosto
tra numerose polemiche. Lo stesso Giuseppe Mazzini, nel suo ultimo tentativo di
battere sul tempo la monarchia, partì per la Sicilia tentando di sollevare
un'insurrezione ma venne arrestato il 13 agosto 1870 e condotto in prigione
a Gaeta.
Il 15 luglio 1870 il governo di Napoleone III dichiarò guerra
alla Prussia (dichiarazione consegnata il 19). L'Italia decise di attendere lo
sviluppo della situazione. Il 2 agosto la Francia, desiderosa di ottenere
l'appoggio dell'Italia, avvertì il governo italiano che era disponibile a
ritirare le proprie truppe da Civitavecchia e dalla provincia di Viterbo. Il 20
agosto alla Camera furono presentate interpellanze da vari deputati, tra cui
il Cairoli e il Nicotera (della Sinistra), che chiesero di denunciare
definitivamente la Convenzione del 15 settembre e di muovere su Roma. Nella sua
risposta il governo ricordò che la Convenzione escludeva i casi straordinari e
proprio questa clausola aveva permesso a Napoleone III di intervenire a Mentana.
Nel frattempo comunque i francesi abbandonarono Roma. Il ritiro fu completato il
3 agosto 1870. Di nuovo si mosse la diplomazia italiana chiedendo una soluzione
della Questione romana. L'imperatrice Eugenia, che svolgeva in quel momento le
funzioni di reggente, inviò la nave da guerra Orénoque a stazionare davanti a
Civitavecchia. Quando le vicende della guerra franco-prussiana stavano già
volgendo al peggio per i francesi, Napoleone III inviò a Firenze il principe
Napoleone per chiedere direttamente a Vittorio Emanuele II un intervento
militare, ma, nonostante alcune pressioni in tal senso (in particolare del
generale Cialdini), la richiesta non ebbe seguito. Il 4 settembre 1870 cadeva
il Secondo Impero, e in Francia veniva proclamata la Terza Repubblica. Questo
stravolgimento politico aprì di fatto all'Italia la strada per Roma.
La preparazione diplomatica. Dopo Mentana, c'era stato uno stallo
nei rapporti tra Italia e Francia sulla questione romana. Poi, tra il 1868 ed il
1869 erano avvenuti numerosi contatti diplomatici tra Italia, Austria e Francia,
con l'obiettivo di stipulare un'alleanza in funzione antiprussiana, iniziativa a
cui aveva dato impulso il capo del governo austriaco Federico von Beust,
timoroso della crescente egemonia di Berlino sugli stati tedeschi, e disponibile
per raggiungere tale accordo anche a cedere il Trentino. Ma queste trattative
non avevano prodotto risultati perché in esse l'Italia aveva posto la questione
di Roma, scontrandosi con l'intransigenza della Francia. Il 29 agosto 1870 il
ministro degli affari esteri, il marchese Emilio Visconti Venosta, inviò al
ministro del Re a Parigi una lettera con cui espose i punti di vista del governo
italiano da rappresentare al governo francese. Visconti Venosta rileva come le
condizioni che hanno a suo tempo portato alla convenzione di settembre tra
Italia e Francia siano completamente cadute.
(FR) «Florence, 29 août 1870. Il Ministro degli Affari Esteri al
Ministro del Re a Parigi… Le but que le Gouvernement impérial poursuivait, celui
de faciliter une conciliation entre le Saint-Père, les Romains et l'Italie, dans
un sens conforme aux vues exprimées par l'Empereur dans sa lettre à M. de
Thouvenel du 26 mai 1862, a été non seulement manqué, mais même complètement
perdu par suite de circonstances sur lesquelles il serait inutile d'appuyer…»
(IT) «Firenze, 29 agosto 1870. … L'obiettivo che il Governo
imperiale ha perseguito, cioè di facilitare una conciliazione tra il Santo
Padre, i Romani e l'Italia, conformemente ai punti di vista espressi
dall'Imperatore nella sua lettera a M. de Thouvenel del 26 maggio 1862, è stato
non solo mancato, ma è addirittura completamente fallito a causa di circostanze
sulle quali è inutile insistere…» (Visconti Venosta, in R. Cadorna, La
liberazione di Roma, p. 331)
Lo stesso giorno Visconti Venosta diramò a tutti i rappresentanti
di Sua Maestà all'estero una lettera circolare con la quale si esponevano alle
potenze europee le garanzie che venivano offerte al Pontefice a tutela della sua
libertà; contemporaneamente si sottolineava l'urgenza di risolvere un problema
che, secondo l'opinione del governo italiano, non poteva essere rimandato. Il 7
settembre inviò un'altra lettera in cui le intenzioni del governo vengono
nuovamente esplicitate e le motivazioni rafforzate. L'8 settembre il ministro
del Re a Monaco, il genovese Giovanni Antonio Migliorati, risponde a Visconti
Venosta esponendo i risultati del colloquio con il conte di Bray: «Il Ministro
degli Affari Esteri mi disse che le basi che porrebbe l'Italia alla Santa Sede
... gli sembrerebbero tali da dover essere accettate da Roma...». Simili
considerazioni arrivano da Berna spedite da Luigi Melegari. Anche i
rappresentanti a Vienna, a Karlsruhe, presso il governo del Baden e a Londra
esprimono opinioni simili. L'unico governo che esita in qualche modo a prendere
posizione è quello di Bismarck che si trova a Parigi assieme al suo re, che in
questi giorni sta per essere incoronato imperatore. Solo il 20 settembre da
Berlino esprime una posizione di stretta non ingerenza. Jules Favre ministro del
nuovo governo francese invia il 10 settembre all'incaricato di Francia a Roma
un'indicazione in cui afferma che il governo francese «ne peut approuver ni
reconnaître le pouvoir temporel du Saint-Siège» («non può approvare né
riconoscere il potere temporale della Santa Sede»). Il 20 agosto il Cardinale
Segretario di Stato Antonelli a sua volta aveva inviato una richiesta ai governi
stranieri affinché si opponessero «alle violenze dal governo sardo minacciate».
La maggior parte dei governi si limitò a non rispondere, altri invece espressero
l'opinione che la cosa non li riguardava.
Preparativi militari. Il governo procedette alla costituzione di
un Corpo d'osservazione dell'Italia centrale. In questo contesto furono chiamate
sotto le armi anche le classi dei nati dal 1842 al 1845. Il 10 agosto il
ministro della guerra Giuseppe Govone convocò il generale Raffaele Cadorna cui
assegnò il comando del corpo con le seguenti disposizioni:
«1. Mantenere inviolata la frontiera degli stati pontifici da
qualunque tentativo d'irruzione di bande armate che tentassero di penetrarvi;
2. Mantenere l'ordine e reprimere ogni moto insurrezionale che
fosse per manifestarsi nelle provincie occupate dalle divisioni poste sotto a'
di Lei ordini;
3. Nel caso in cui moti insurrezionali avessero luogo negli stati
pontifici, impedire che si estendano al di qua del confine.»
Il dispaccio concludeva con: «La prudenza e l'energia altra volta
da Lei dimostrata in non meno gravi circostanze, danno sicuro affidamento, che
lo scopo che il governo si propone, sarà pienamente raggiunto.»
Oltre a Cadorna il governo nominò anche i comandanti delle tre
divisioni che costituivano il corpo d'armata nelle persone dei generali Emilio
Ferrero, Gustavo Mazè de la Roche e Nino Bixio. Cadorna sollevò subito i suoi
dubbi sulla presenza di Bixio, considerato troppo impetuoso e quindi inadatto ad
una missione che «richiedeva somma prudenza». Govone, che si ritirerà pochi
giorni dopo dal governo, accettò le opinioni di Cadorna e nominò al posto di
Bixio il generale Enrico Cosenz. Alla fine di agosto le tre divisioni furono
portate a cinque ed il comando di questi nuovi reparti fu affidato al
generale Diego Angioletti e a Bixio, richiamato, che non riscuoteva le simpatie
del comandante del Corpo. Il totale degli effettivi del Corpo arrivò a superare
le 50.000 unità. L'esercito pontificio, comandato dal generale Hermann Kanzler,
era costituito da 13.624 militari, di cui 8.300 regolari e 5.324 volontari. Gli
effettivi erano i seguenti:
Reggimenti italiani
1.863 Gendarmi pontifici, agli ordini del generale Evangelisti;
1.023 Squadriglieri di Provincia[11] (anch'essi agli ordini di
Evangelisti);
1.691 Fanti di Linea, al comando del colonnello Azzanesi;
1.174 Cacciatori, comandati dal tenente colonnello Sparagna;
567 Dragoni, agli ordini del colonnello Giovanni Lepri;
996 Artiglieri, comandati dal colonnello Caimi;
157 Genieri, agli ordini del colonnello Giorgio Lana e del
maggiore Francesco Oberholtzer, direttore dei lavori di fortificazione;
544 “sedentari” o truppe di guarnigione.
Reggimenti stranieri
3.040 Zuavi (il reggimento più numeroso, composto da quattro
battaglioni), al comando del colonnello svizzero Eugenie-Joseph Allet;
1.195 Carabinieri stranieri, in maggioranza tedeschi, agli ordini
dello svizzero Jeannerat;
1.089 uomini della Legione di Antibes, agli ordini di Perrault
(francesi).
Completavano la forza militare:
285 impiegati nei Servizi ausiliari e sanitari.
Il comandante era il generale Hermann Kanzler (badese),
coadiuvato dai generali De Courten (svizzero) e Zappi.. Kanzler riordinò
l'esercito pontificio disponendo il ripiegamento su Roma di tre guarnigioni su
quattro (Viterbo, Frosinone-Velletri e Tivoli). Soltanto ai presidi
di Civitavecchia (1000 uomini) e Civita Castellana (700 uomini) venne ordinato
di resistere in armi.
La lettera di Vittorio Emanuele II a Pio IX. L'8 settembre,
alcuni giorni prima dell'attacco, Gustavo Ponza di San Martino, senatore del
Regno, partì da Firenze per consegnare al papa una lettera autografa di
re Vittorio Emanuele II. L'indomani venne ricevuto dal cardinale Giacomo
Antonelli, il quale lo ammise alla presenza del pontefice. Nell'epistola
Vittorio Emanuele, che si rivolgeva al pontefice «con affetto di figlio, con
fede di cattolico, con lealtà di Re, con animo d'italiano», dopo aver paventato
le minacce del «partito della rivoluzione cosmopolita», esplicitava
«l'indeclinabile necessità per la sicurezza dell'Italia e della Santa Sede, che
le mie truppe, già poste a guardia del confine, debbano inoltrarsi per occupare
le posizioni indispensabili per la sicurezza di Vostra Santità e pel
mantenimento dell'ordine». La risposta del Papa fu rispettosa ma ferma: «Sire,
Il conte Ponza di San Martino mi ha consegnato una lettera, che a V. M. piacque
dirigermi; ma essa non è degna di un figlio affettuoso che si vanta di
professare la fede cattolica, e si gloria di regia lealtà. Io non entrerò nei
particolari della lettera, per non rinnovellare il dolore che una prima scorsa
mi ha cagionato. Io benedico Iddio, il quale ha sofferto che V. M. empia di
amarezza l'ultimo periodo della mia vita. Quanto al resto, io non posso
ammettere le domande espresse nella sua lettera, né aderire ai principii che
contiene. Faccio di nuovo ricorso a Dio, e pongo nelle mani di Lui la mia causa,
che è interamente la Sua. Lo prego a concedere abbondanti grazie a V. M. per
liberarla da ogni pericolo, renderla partecipe delle misericordie onde Ella ha
bisogno.» (Papa Pio IX, 9 settembre 1870)
Il 10 settembre il conte San Martino scrivendo da Roma al capo
del governo, Giovanni Lanza, descrisse i suoi incontri con il cardinale
Antonelli del giorno precedente e in particolare l'incontro con il Papa. Scrive
il conte: «… che sono stato dal Santo Padre, che gli ho consegnato la lettera di
Sua Maestà e la nota rimessami da V. Eccellenza […] Il Papa era profondamente
addolorato, ma non mi parve disconoscere che gli ultimi avvenimenti rendono
inevitabile per l'Italia l'azione su Roma […] Esso [il Papa] non la riconoscerà
legittima, protesterà in faccia al mondo, ma espresse troppo raccapriccio per le
carneficine francesi e prussiane, per non darmi a sperare che non siano i
modelli che vuol prendere […] fui fermo nel dirgli che l'Italia trova il suo
proposito di avere Roma, buono e morale […] Il Papa mi disse, leggendo la
lettera, che erano inutili tante parole, che avrebbe amato di meglio gli si
dicesse a dirittura che il governo era costretto di entrare nel suo Stato.»
(Ponza di San Martino)
Il conte di San Martino riferì verbalmente la frase pronunciata
da Pio IX: «Io posso cedere alla violenza, ma dare la mia sanzione a
un'ingiustizia, mai!» L'11 settembre l'inviato del re ritornò nella capitale.
Nello stesso giorno cominciarono le operazioni militari, senza la consegna di
una formale dichiarazione di guerra.
L'attacco allo Stato Pontificio. La breccia di Porta Pia, che
consentì l'annessione di Roma al Regno d'Italia, 21 settembre 1870. Il piano
d'invasione dell'esercito italiano prevedeva l'ammassarsi di cinque divisioni ai
confini dello Stato Pontificio in tre punti distinti:
A nord-est, presso Orvieto, vi era la II Divisione al comando del
generale Nino Bixio;
Ad est vi era il grosso dell'esercito (40 mila uomini su 50
mila), costituito da tre divisioni: l'XI, guidata dal generale Enrico Cosenz; la
XII, al comando del generale Gustavo Mazè de la Roche; la XIII, agli ordini del
generale Emilio Ferrero;
A sud, sulla vecchia frontiera napoletana, era stanziata la IX
Divisione, al comando del generale Diego Angioletti.
Si trattava in tutto di circa 50.000 uomini. Il comando supremo
delle operazioni era affidato al Luogotenente generale Raffaele Cadorna. Nino
Bixio avrebbe dovuto occupare Viterbo e, con l'aiuto della flotta, Civitavecchia
per poi dirigersi verso Roma. Il generale Angioletti, entrando da sud, avrebbe
occupato Frosinone e Velletri per poi convergere verso l'Urbe. Qui l'esercito si
sarebbe riunito per sferrare l'attacco finale. La sera del 10 settembre Cadorna
ricevette l'ordine di attraversare il confine pontificio tra le cinque
pomeridiane dell'11 ed entro le cinque antimeridiane del 12 settembre. Nel
pomeriggio del giorno 11, fu Nino Bixio ad entrare per primo nel territorio
dello Stato Pontificio: il generale avanzò verso Bagnorea (oggi Bagnoregio) e
Angioletti si diresse su Ceprano (poco più di 20 km da Frosinone). Gli ordini di
Kanzler, comandante dell'esercito pontificio, erano di resistere all'attacco
delle camicie rosse, ma in caso d'invasione dell'esercito sabaudo, l'ordine era
di ripiegare verso Roma. Così fecero gli Zuavi di stanza nelle località via via
occupate dall'esercito italiano. Il 12 settembre Kanzler dichiarava lo stato
d'assedio nell'Urbe. Bixio si mosse lungo la strada che scorre ad est del lago
di Bolsena attraversando Montefiascone per finire a Viterbo (in tutto circa
45 km). Gli Zuavi di stanza a Viterbo ripiegarono verso Civitavecchia, dove
giunsero il 14 settembre. Nel frattempo il generale Ferrero aveva occupato
Viterbo prima di Bixio che, pertanto, accelerò la marcia verso il porto di
Civitavecchia. La piazzaforte si era preparata per resistere a un lungo assedio.
Ma il comandante, il colonnello spagnolo Serra, la sera del 15 settembre si
arrese senza combattere. La mattina seguente la piazzaforte e il porto di
Civitavecchia furono occupati dall'esercito e dalla marina italiane. Negli
stessi giorni Angioletti prendeva possesso delle province di Frosinone e
Velletri: entrato in territorio pontificio il 12 settembre, occupò la città di
Frosinone il 13 e tre giorni dopo entrò in Velletri. Il Luogotenente generale
Cadorna, stanziato in Sabina, col grosso dell'esercito si diresse verso Roma
lungo la riva destra del Tevere, seguendo il tracciato della vecchia via
Salaria. Ricevette però l'ordine di non seguire una via diretta verso Roma.
Secondo il rapporto stilato dallo stesso Cadorna, "motivi politici" avrebbero
imposto di allungare la strada. Cadorna occupò alcuni centri minori,
come Rignano e Civita Castellana. Il 14 settembre le tre divisioni sotto il suo
comando si riunirono alla Giustiniana (circa 12 km a nord-ovest di Roma). Entro
due giorni furono raggiunte da Bixio e da Angioletti. Il 15 settembre Cadorna
inviò una lettera al generale Kanzler: gli chiese di acconsentire
all'occupazione pacifica della città. Kanzler rispose che avrebbe difeso Roma
con tutti i suoi mezzi a disposizione. Al generale Cadorna fu ordinato di
portarsi in prossimità delle mura romane evitando però momentaneamente qualsiasi
scontro con le truppe pontificie e attendere la negoziazione della resa. Il
piano d'attacco dell'esercito italiano prevedeva che Cosenz, Mazé de la Roche e
Ferrero avrebbero attaccato la cinta muraria che si dipana dal Tevere alla Via
Prenestina (da Porta del Popolo a Porta Maggiore). Angioletti avrebbe attaccato
il fianco sud mentre Bixio, proveniente da Civitavecchia, sarebbe entrato
a Trastevere. In caso di trattative infruttuose, l'esercito italiano avrebbe
fatto ricorso alla forza, evitando, tuttavia, di penetrare nella Città Leonina.
L'attacco alla città fu portato su diversi punti. Il cannoneggiamento delle mura
iniziò alle 5 di mattina del 20 settembre. Pio IX aveva minacciato
di scomunicare chiunque avesse comandato di aprire il fuoco sulla città. La
minaccia non sarebbe stata un valido deterrente per l'attacco, comunque l'ordine
di cannoneggiamento non giunse da Cadorna bensì dal capitano
d'artiglieria Giacomo Segre, giovane ebreo comandante della 5ª batteria del IX°
Reggimento, che dunque non sarebbe incorso in alcuna scomunica. Il primo punto a
essere bombardato fu Porta San Giovanni, seguito dai Tre Archi di Porta San
Lorenzo e da Porta Maggiore. Si udirono altri fragori dall'altra parte della
città: si trattava dell'azione diversiva della divisione Bixio, posizionata a
ridosso di San Pancrazio. Iniziarono i bombardamenti anche sul "vero fronte",
quello compreso tra Porta Salaria e Porta Pia. Furono le batterie 2º (capitano
Buttafuochi) e 8º (capitano Malpassuti) del 7º Reggimento di artiglieria di Pisa
ad aprire il fuoco alle 5:10 su Porta Pia. Poco dopo le ore 9 iniziò ad aprirsi
una vasta breccia a una cinquantina di metri alla sinistra di Porta Pia. Una
pattuglia di bersaglieri del 34º battaglione fu inviata sul posto a constatarne
lo stato. I comandanti d'artiglieria ordinarono di concentrare gli sforzi
proprio in quel punto (erano le 9:35). Dopo dieci minuti d'intenso fuoco, la
breccia era abbastanza vasta (circa trenta metri) da permettere il passaggio
delle truppe. Cadorna ordinò immediatamente la formazione di due unità di
assalto per penetrare nel varco, assegnandone il comando ai generali Mazé e
Cosenz: si trattava di un battaglione di fanteria[26] e di uno di bersaglieri,
accompagnati da alcuni carabinieri. Ma l'assalto non fu necessario: verso le ore
dieci, dal campo pontificio fu esposta la bandiera bianca. Mentre la resistenza
cessava a Porta Pia, la bandiera bianca fu issata lungo tutta la linea delle
mura. I generali Ferrero e Angeletti la rispettarono, invece Bixio continuò il
bombardamento per circa mezz'ora. Mazé e Cosenz proseguirono nel loro assalto;
le truppe italiane oltrepassarono la breccia di Porta Pia sparando e facendo
prigionieri. Dopo l'irruzione da parte delle truppe italiane dentro la cinta
muraria vi furono ancora scontri qua e là che si spensero in poche ore con la
resa chiesta dal generale Kanzler. La divisione Angioletti occupò Trastevere,
quella di Ferrero l'area compresa tra Porta San Giovanni, Porta Maggiore, Porta
San Lorenzo, via di San Lorenzo, Santa Maria Maggiore, via Urbana e via Leonina
fino a Ponte Rotto. Le truppe di Mazè si attestarono tra Porta Pia, Porta
Salaria e via del Corso occupando piazza Colonna, piazza di Termini e il Palazzo
del Quirinale. Quelle di Cosenz presidiarono piazza Navona e piazza del Popolo.
Per ordine di Cadorna, così come convenuto con il governo, non furono occupate
la Città Leonina, Castel Sant'Angelo e i colli Vaticano e Gianicolo. Alle 17:30
del 20 settembre Kanzler e Fortunato Rivalta (capo di Stato maggiore) firmarono
la capitolazione alla presenza del generale Cadorna. Una curiosità è che tra i
partecipanti all'evento vi fu anche lo scrittore e giornalista Edmondo De
Amicis, all'epoca ufficiale dell'esercito italiano che ha lasciato una
particolareggiata descrizione dell'evento nel libro Le tre capitali: «[...] La
porta Pia era tutta sfracellata; la sola immagine della Madonna, che le sorge
dietro, era rimasta intatta; le statue a destra e a sinistra non avevano più
testa; il suolo intorno era sparso di mucchi di terra; di materasse fumanti, di
berretti di Zuavi, d'armi, di travi, di sassi. Per la breccia vicina entravano
rapidamente i nostri reggimenti. [...]» Sullo scontro, invece, ci offre alcune
informazioni Attilio Vigevano che riferisce che mentre gli Zuavi
pontifici combattevano, prima della resa, molti di essi intonarono il loro canto
preferito, quello dei Crociati di Cathelineau: «Intonato dal sergente Hue, e
cantato da trecento e più uomini, l'inno echeggiò distinto per alcuni minuti; il
capitano Berger ne cantò una strofa ritto sulle rovine della breccia colla spada
tenuta per la lama e l'impugnatura rivolta al cielo quasi a significare che ne
faceva omaggio a Dio; presto però illanguidì e si spense nel ricominciato
stridore della fucilata, nel raddoppiato urlio, nel tumulto delle invettive»
(Attilio Vigevano, La fine dell'Esercito Pontificio, Albertelli, p. 571.)
Secondo la descrizione di Antonio Maria Bonetti (1849-1896),
caporale dei Cacciatori Pontifici: «Stavamo sulle righe, quando alcune voci
sulla Piazza di San Pietro gridarono: "Il Papa, il Papa!". In un momento,
cavalieri e pedoni, ufficiali e soldati, rompono le righe e corrono verso
l'obelisco, prorompendo nel grido turbinoso e immenso di: "Viva Pio IX, viva il
Papa Re!", misto a singhiozzi, gemiti e sospiri. Quando poi il venerato
Pontefice, alzate le mani al cielo, ci benedisse, e riabbassatele, facendo come
un gesto di stringerci tutti al suo cuore paterno, e quindi, sciogliendosi in
lacrime dirotte, si fuggì da quel balcone per non poter sostenere la nostra
vista, allora sì veruno più poté far altro che ferire le stelle con urla, con
fremiti ed esecrazioni contro coloro che erano stati causa di tanto cordoglio
all'anima di un sì buon Padre e Sovrano»
Condizioni di capitolazione. Il 21 settembre il generale Cadorna
prese possesso della città. Dal suo Quartier generale in Villa Patrizi ordinò
che tutta Roma, ad eccezione della Città Leonina, fosse evacuata dall'esercito
pontificio e occupata dagli italiani. Le truppe pontificie avrebbero ricevuto
l'onore delle armi ed i volontari sarebbero tornati alle proprie case[31]. Al
tramonto tutta Roma, ad eccezione della Città Leonina, era stata occupata dagli
italiani. Entro mezzogiorno del 21 i soldati pontifici lasciarono l'Urbe. Il
giorno stesso (21 settembre) il papa chiese al comandante italiano di entrare
nella Città Leonina allo scopo di prevenire i possibili disordini. Cadorna
avvisò il governo e ordinò alle sue truppe di procedere. Il 27 settembre
l'esercito italiano prese possesso anche di Castel Sant'Angelo e, da quel
momento, i possedimenti del Papa furono limitati al Vaticano. Pio IX decise di
non riconoscere la sovranità italiana su Roma. Il parlamento italiano, per
cercare di risolvere la questione, promulgò nel 1871 la Legge delle Guarentigie,
ma il Papa non accettò la soluzione unilaterale di riappacificazione proposta
dal governo e non mutò il suo atteggiamento. Questa situazione, indicata come
"Questione Romana", perdurò fino ai Patti Lateranensi del 1929. Il primo
francobollo a portare per il mondo la notizia dell'unificazione della nazione fu
il Vittorio Riquadrato, di cui è giunto perfettamente conservato un esemplare su
lettera timbrata proprio il 20 settembre 1870 a Roma.
Considerazioni sulle operazioni belliche. Nonostante l'importanza
storica dei fatti (la riunione di Roma all'Italia e la fine dello Stato
Pontificio), dal punto di vista militare l'operazione non fu di particolare
rilievo: infatti la assai debole resistenza opposta dall'esercito pontificio
(complessivamente 15.000 uomini, tra cui dragoni pontifici, volontari
provenienti per lo più da Francia, Austria, Baviera, Paesi
Bassi, Irlanda, Spagna, ma soprattutto Zuavi, al comando dal generale Kanzler)
ebbe soprattutto valore simbolico. Sulle ragioni per cui papa Pio IX non oppose
una ferma resistenza sono state fatte varie ipotesi: la più accreditata è quella
della rassegnazione della Santa Sede all'impossibilità di evitare la conquista
dell'Urbe da parte del contingente italiano. La volontà del Papa fu quindi di
mettere da parte ogni ipotesi di risposta militare all'attacco italiano. È
infatti noto che l'allora segretario di stato, il cardinale Giacomo Antonelli,
abbia dato ordine al generale Kanzler di ritirare le truppe entro le mura e di
limitarsi ad un puro atto di resistenza formale, quale poi fu quello opposto
alle truppe di Cadorna.
La prima amministrazione italiana di Roma. Il governo provvisorio
di Roma. I componenti della Giunta, oltre al presidente Michelangelo Caetani,
erano i seguenti: principe Francesco Pallavicini, Emanuele Ruspoli, dei principi
Ruspoli, duca Francesco Sforza Cesarini, principe Baldassarre Odescalchi,
Ignazio Boncompagni Ludovisi, dei principi di Piombino, avvocato Biagio Placidi,
avvocato Vincenzo Tancredi, avvocato Raffaele Marchetti, Vincenzo Tittoni,
Pietro Deangelis, Achille Mazzoleni, Felice Ferri, Augusto Castellani,
Alessandro Del Grande.
Il 23 settembre il generale Cadorna, che aveva ricevuto dal
governo italiano l'incarico di «promuovere la formazione della Giunta della
città di Roma», formò il governo provvisorio assegnandone la presidenza
a Michelangelo Caetani, duca di Sermoneta.[35] L'organismo, che aveva funzioni
simili a quelle dell'attuale giunta comunale, prese il nome di «Giunta
provvisoria di governo di Roma e sua provincia» e si insediò il giorno seguente
in Campidoglio.
Plebiscito di annessione del 2 ottobre 1870. Il governo del Regno
aveva "nei memorandum diramati all'estero", "proclamato il diritto dei romani di
scegliersi il governo che desideravano". Così come era stato fatto per le altre
province italiane, anche a Roma fu quindi indetto un referendum per sancire
l'avvenuta riunificazione della città con il Regno d'Italia. La formula
inizialmente proposta vedeva all'inizio del quesito proposto la formula «Colla
certezza che il governo italiano assicurerà l'indipendenza dell'autorità
spirituale del Papa, ...». Questa premessa fu poi giudicata inutile e la domanda
posta fu: «Desideriamo essere uniti al Regno d'Italia, sotto la monarchia
costituzionale del re Vittorio Emanuele II e dei suoi successori». Inizialmente
il governo a Firenze aveva esclusa dalla votazione la Città Leonina, che si
voleva lasciare sotto il controllo del Papa, ma le rimostranze di parte della
popolazione e la mancanza di interesse da parte del governo pontificio spinsero
le autorità locali a permettere anche agli abitanti di quel rione di partecipare
alla consultazione, seppure con un seggio posto oltre ponte Sant'Angelo.
Il plebiscito si svolse il 2 ottobre 1870, una domenica. I risultati videro
ufficialmente la schiacciante vittoria dei sì, 40.785, a fronte dei no che
furono solo 46. Il risultato complessivo nella provincia di Roma fu di 77.520
"sì" contro 857 "no". In tutto il territorio annesso i risultati furono 133.681
"sì" contro 1.507 "no". Tuttavia i dati non appaiono sorprendenti se si
considera la spinta delle schiere cattoliche all'astensionismo, talvolta attuata
anche con qualche stratagemma (ad esempio a Veroli il vescovo sceglie proprio il
2 ottobre per dispensare con solennità la Cresima). Ma l'invito all'astensione
non fu lungimirante: permise al governo italiano di ostentare la schiacciante
maggioranza dei sì, mentre il numero dei non votanti, per non parlare dei non
iscritti, rimase nell'ombra. A ricordo dell'inizio del moderno Stato
d'Italia come lo conosciamo oggi, il XX Settembre è riportato
nella toponomastica di molte città italiane. Effettuato il plebiscito, il
governo italiano si mosse con celerità per liquidare lo Stato Pontificio.
Il regio decreto 9 ottobre 1870, n° 5903, proclamò l'annessione
del Lazio all'Italia, e altri tre decreti di pari data istituirono
una luogotenenza generale affidandola al senatore e generale Alfonso La Marmora,
e accordarono le prime guarentigie per la persona del papa. Sei giorni dopo
il regio decreto 15 ottobre 1870, n°5929, introdusse la struttura amministrativa
del Regno programmando la creazione della Provincia di Roma per il successivo 5
novembre. Le elezioni amministrative furono indette per domenica 13 novembre,
mentre nelle due domeniche successive vennero celebrate in
tutta Italia le elezioni politiche anticipate dopo lo scioglimento della Camera
dei deputati voluto dal governo Lanza appositamente per dare rappresentanza alla
nuova provincia e far cogliere alla Destra storica il consenso generato dal
completamento dell'unità nazionale. Entrambi gli appuntamenti si posero in netto
contrasto col precedente plebiscito, dato che la vigente normativa (che
assegnava il diritto di voto in base al censo) ammise alle urne poco più di
diecimila persone in tutto il Lazio. Il quadro si completò col regio decreto 25
gennaio 1871, n° 26, che concluse il periodo straordinario della luogotenenza
con le nomine di Giuseppe Gadda a prefetto e di Francesco Pallavicini a sindaco
di Roma, ed infine con la legge del 3 febbraio 1871 che deliberò il
trasferimento della capitale da Firenze a Roma.
Ripercussioni internazionali. Il ministro degli Esteri italiano,
Visconti-Venosta, informò le cancellerie europee mentre la guerra
franco-prussiana proseguiva con l'assedio di Parigi da parte delle truppe
prussiane. Gli Stati europei non riconobbero ma accettarono l'azione italiana.
Già il 21 settembre il rappresentante del re a Monaco scriveva che il conte Otto
von Bray-Steinburg, ministro bavarese, avvertito degli avvenimenti gli aveva
espresso la sua soddisfazione che tutto si fosse svolto senza spargimento di
sangue. Launay da Berlino riportava il 22 settembre la posizione di neutralità
del governo di Otto von Bismarck. Il 21 settembre da Tours il "Ministro del Re",
cioè l'ambasciatore, in Francia, Costantino Nigra, inviava il seguente
messaggio: «Ho ricevuto stamane il telegramma col quale l'E. V. mi fece l'onore
di annunziarmi che le regie truppe sono entrate ieri a Roma, dopo una lieve
resistenza delle milizie straniere, che cessarono il fuoco dietro ordine del
Papa. Ho immediatamente comunicato questa notizia al signor Cremieux, membro del
Governo della difesa nazionale, Guardasigilli e Presidente della Delegazione
governativa stabilita in Tours. Il signor Cremieux mi ha espresso le sue vive
felicitazioni per fatto annunziatogli.» (Costantino Nigra)
Carlo Cadorna, fratello maggiore del generale, era ambasciatore
a Londra e nel dispaccio spedito il 22 settembre, parlò del lungo colloquio che
ebbe con il conte di Granville, ministro degli Esteri del
gabinetto Gladstone. Granville non fece commenti data la novità della notizia,
ma secondo Cadorna «la notizia che gli aveva data gli era riuscita gradita».
Questa impressione fu poi confermata in un altro telegramma spedito il 27, in
cui l'ambasciatore esprimeva la soddisfazione del ministro sulle modalità con
cui si erano svolti gli avvenimenti.
Reazioni del governo pontificio. A pochi giorni dalla presa di
Roma, il 1º novembre 1870 Pio IX emanò l'enciclica Respicientes ea nella quale
dichiarava "ingiusta, violenta, nulla e invalida" l'occupazione dei domini della
Santa Sede. Il cardinale Antonelli l'8 novembre diramò ai rappresentanti degli
stati stranieri una nota che attaccava Visconti Venosta ed in cui affermava:
«Quando con un cinismo senza esempio, si pone in ogni cale ogni principio di
onestà e giustizia, si perde il diritto di essere creduti». Pio IX si dichiarò
«prigioniero politico del Governo italiano». Lo Stato Italiano promulgò nel
maggio del 1871 la Legge delle guarentigie, con la quale assegnava alla Chiesa
l'usufrutto dei beni che ora appartengono alla Città del Vaticano, e si
conferivano al Papa una serie di garanzie circa la sua indipendenza. Tuttavia
tale compromesso non venne mai accettato né da Pio IX né dai suoi successori.
Nel 1874 Pio IX emanò il Non expedit, con cui vietò ai cattolici italiani la
partecipazione alla vita politica. Soltanto in età giolittiana tale divieto
sarebbe stato eliminato progressivamente, fino al completo rientro dei cattolici
"come elettori e come eletti" nella vita politica italiana: solo nel 1919, con
la fondazione del Partito Popolare Italiano di don Luigi Sturzo, i cattolici
furono presenti nel mondo politico italiano ufficialmente. Il contenzioso tra
Stato italiano e Santa Sede trovò una soluzione nel 1929, durante il governo
Mussolini, con i Patti Lateranensi, mediante i quali si giunse ad una effettiva
composizione bilaterale della vicenda.
Reazioni dei cattolici liberali. Tra i cattolici che salutarono
favorevolmente o entusiasticamente la Liberazione di Roma del 20 settembre 1870
vi furono i "modernisti", tra cui Alessandro Manzoni e lord Acton, perché
vedevano nella fine del potere temporale del papato una maggiore libertà dei
cattolici. Secondo i dati forniti dal Generale Raffaele Cadorna nel suo libro,
l'intera campagna di occupazione del Lazio costò 49 morti e 141 feriti
all'esercito italiano; e 20 morti e 49 feriti all'esercito pontificio. Questo è
l'elenco dei soldati pontifici caduti in seguito alla Presa di Roma:
Zuavi:
Sergente Duchet Emile, francese, di anni 24, deceduto il 1º
ottobre.
Sergente Lasserre Gustave, francese, di anni 25, deceduto il 5
ottobre.
Soldato de l'Estourbeillon, di anni 28, deceduto il 23 settembre.
Soldato Iorand Jean-Baptiste, deceduto il 20 settembre.
Soldato Burel André, francese di Marsiglia, di anni 25, deceduto
il 27 settembre.
Soldato Soenens Henri, belga, di anni 34, deceduto il 2 ottobre.
Soldato Yorg Jan, olandese, di anni 18, deceduto il 27 settembre.
Soldato De Giry (non si hanno altri dati).
Altri tre soldati non identificati, deceduti il 20 settembre.
Carabinieri:
Soldato Natele Giovanni, svizzero, di anni 30, deceduto il 15
ottobre.
Soldato Wolf Georg, bavarese, di anni 27, deceduto il 28 ottobre.
Dragoni :
Tenente Piccadori Alessandro, di Rieti, di anni 23, deceduto il
20 ottobre.
Artiglieria :
Maresciallo Caporilli Enrico, deceduto il 20 ottobre.
Soldato Valenti Giuseppe, di Ferentino, di anni 22, deceduto il 3
ottobre.
Elenco alfabetico dei caduti italiani il 20 settembre 1870:
Agostinelli Pietro, Aloisio Valentino, Bertuccio Domenico, Bianchetti Martino,
Bonezzi Tommaso, Bosco Antonio, Bosi Cesare, Calcaterra Antonio, Campagnolo
Domenico, Canal Luigi, Cardillo Beniamino, Cascarella Emanuele, soldato Lorenzo
Cavallo[47], Corsi Carlo, De Francisci Francesco, Gambini Angelo, Gianniti
Luigi, Gioia Guglielmo, Iaccarino Luigi, Izzi Paolo, Leoni Andrea, Maddalena
Domenico, Marabini Pio, Martini Domenico, Matricciani Achille, Mattesini
Ferdinando, Mazzocchi Domenico, Morrara Serafino, Giacomo Pagliari (comandante
del 34º battaglione Bersaglieri), Palazzoni Michele, Paoletti Cesare, Perretto
Pietro, Prillo Giacomo, Rambaldi Domenico, Renzi Antonio, Ripa Alarico, Risato
Domenico, Romagnoli Giuseppe, Sangiorgi Paolo, Santurione Tommaso, Spagnolo
Giuseppe, Thérisod Luigi David, Tumino Giuseppe, Turina Carlo, Valenzani
Augusto, Xharra Luigi, Zanardi Pietro, Zoboli Gaetano.
La presa di Roma nel cinema.
Nel 1905 viene realizzato il film La presa di Roma di Filoteo
Alberini, uscito il 20 settembre per commemorare l'azione. Tra l'altro il film
fu il primo proiettato pubblicamente in Italia.
Nel 1971 Antonio Racioppi dirige, dietro la macchina da
presa, Mio padre monsignore un film che ha il sapore di una commedia, ma che
culmina con un atto di eroismo. Fra gli attori figurano: Giancarlo
Giannini, Lino Capolicchio, Marisa Merlini, Barbara Bach e Gastone Moschin.
Nel 1972 Alfredo Giannetti realizza Correva l'anno di grazia
1870, a cui partecipano attori del calibro di: Anna Magnani, Marcello
Mastroianni e Mario Carotenuto.
Nel 1980 Luigi Magni cura la regia di Arrivano i bersaglieri,
ritratto della Roma nei giorni subito seguenti la breccia di Porta Pia. Mentre
dilaga il trasformismo, un aristocratico ostile ai conquistatori ospita in casa
uno zuavo, senza sapere che quest'ultimo ha ucciso suo figlio bersagliere.
Nel 1986 viene riproposta la presa di Roma in un episodio del
film Superfantozzi, quando la famiglia di Fantozzi il giorno 20
settembre 1870 acquista una casa a Porta Pia, che viene distrutta poco dopo
dai bersaglieri.
Nel 2003 sempre Luigi Magni dirige il film tv La notte di
Pasquino con Nino Manfredi, ambientato a poche ore di distanza dalla Breccia di
Porta Pia.
Nel 2013 la miniserie L'ultimo papa re con Gigi Proietti nei
panni del cardinale Romeo Colombo da Priverno e con la regia di Luca Manfredi,
si conclude con la presa di Roma da parte dei bersaglieri.
Porta Pia 150 anni fa: Roma libera e italiana.
Simonetta Fiori il 19 settembre 2020 su La Repubblica. Il 20 settembre di 150
anni fa i bersaglieri di Cadorna entravano nella nuova capitale del regno. Tre
punti di vista su quel giorno. "Romani! La mattina del 20 settembre 1870 segna
una data delle più memorabili nella storia. Roma ancora una volta è tornata, e
per sempre, ad essere la grande Capitale d'una grande Nazione!". Così il
generale Raffaele Cadorna salutò la conquista della città eterna dopo aver
aperto una breccia a pochi metri da Porta Pia. Alle 10 del mattino di
centocinquant'anni fa i primi bersaglieri e fanti del neonato Stato italiano
fecero il loro ingres...
Lo scempio urbanistico nato dalla Breccia poco Pia...20
settembre 1870. Con la Presa “militare” 150 anni fa, Roma viene annessa al Regno
d’Italia, diventandone la Capitale. Ma non è pronta. Vittorio Emiliani il 20
settembre 2020 su Il Fatto Quotidiano. Ma si combatterà o non si combatterà per
Roma Capitale? Da entrambe le parti ci sono velleità: Vittorio Emanuele II è già
parecchio superstizioso di suo e non vuole correre altri rischi entrando a Roma
e soprattutto varcando il grande portone del Quirinale. Sopra ogni cosa, ha una
paura fottuta della scomunica papale. Per questo […]
Porta Pia: i fatti, gli uomini, le armi.
Edoardo Frittoli il 20/9/2020 su Panorama. Il sogno di Roma
Capitale del Regno d'Italia preconizzata da Cavour si realizzò quasi un decennio
dopo la sua morte. Alla battaglia per la risoluzione manu militari della
"questione romana" si giunse dopo il fallimento delle vie diplomatiche con Pio
IX (che dopo la parentesi della Repubblica Romana si era chiuso in Vaticano
abolendo tutte le riforme precedentemente concesse). La vera svolta giunse con
la disfatta francese contro la Prussia e la caduta di Napoleone III, garante
della sicurezza e dell'integrità dello Stato Pontificio e della sua protezione
armata. Il ritiro graduale delle guarnigioni francesi dai territori governati
dall'ultimo Papa-Re aveva permesso l'avvicinamento delle divisioni Italiane del
"Corpo di Osservazione dell'Italia Centrale" alla Città Eterna dopo alcuni
scontri in territorio laziale con i soldati pontifici. L'ultimo tentativo di
risolvere la questione per vie diplomatiche ebbe luogo la sera prima della presa
di Roma quando il conte prussiano Henri Von Arnim, ambasciatore presso la Santa
Sede, comunicò il rifiuto delle trattative da parte del Papa, le cui decisioni
erano ormai pilotate dai comandanti dell'Esercito pontificio decisi a resistere
entro le mura. Quando scese la sera del 19 settembre 1870 non solo la zona di
Porta Pia, ma tutta la città di Roma era circondata dalle divisioni italiane
giunte nei pressi delle porte dislocate lungo le mura aureliane. Il comandante
generale Raffaele Cadorna si preparava all'assalto inizialmente pensato per il
giorno stesso ma successivamente posticipato al 20 settembre per permettere lo
svolgimento delle ultime mosse diplomatiche. Lungo via Tiburtina si era già
acquartierata la XIII Divisione del generale Emilio Ferrero con la Brigata Cuneo
sulla destra e la Brigata Abruzzi sulla sinistra in vista di un attacco ancora
da stabilire, se contro Porta San Lorenzo o Porta Maggiore, mentre la XI
Divisione del generale Enrico Cosenz si trovava nei pressi di Ponte Salario sul
fiume Aniene pronta a dare l'assedio alla porta omonima, la Salaria. A poca
distanza la XII Divisione, guidata dal generale Gustavo Mazé de la
Roche attendeva a Ponte Nomentano, con gli avamposti composti dagli uomini
del 41° Fanteria e 12° Bersaglieri rivolti verso la Porta Pia. Completavano il
quadro delle forze italiane incaricate dell'assalto di Roma la IX
Divisione comandata da Cadorna pronta ad attaccare la Porta San
Giovanni. Contemporaneamente presso la porta di San Pancrazio al Gianicolo si
videro arrivare le forze della II Divisione, comandata dall'eroe e veterano
dell'Unità d'Italia generale Nino Bixio. L'assalto, previsto alle prime luci
dell'alba del 20 settembre, prevedeva una serie di attacchi sincronici di
artiglieria alle diverse porte di accesso delle mura aureliane. Porta Pia,
diventata il simbolo della vittoria, non fu la prima a ricevere i colpi dei
cannoni. Erano le quando le bocche di fuoco della XIII Divisione iniziavano
l'attacco diversivo per attrarre parte dei pontifici alla Porta Maggiore,
supportate dall'azione di fanti del 59° in funzione di esca già dalla notte
precedente. La fanteria pontificia tentò anche una sortita nel buio, venendo
respinta. Durante lo scontro a fuoco caddero i primi due morti italiani della
battaglia per Roma, ore prima dell'azione epica della breccia. L'assalto a porta
Maggiore durò pochissimo, con pochi colpi sparati dalle batterie di Ferrero
giunte a soli 270 metri dalle mura. La bandiera bianca dei soldati del Papa si
alzò quando la luce del sole illuminava da poco la porta. Il primo baluardo
della Città Eterna era caduto. La Divisione del comandante in capo Raffaele
Cadorna, la Nona, muoveva verso porta San Giovanni già alle 4 del mattino,
con 14 pezzi di artiglieria al seguito, comandati dal generale Guglielmo De
Sauget da Vibo Valentia che si appostava alla cascina Matteis. Come convenuto,
alle del mattino dodici cannoni aprivano il fuoco soverchiando gli unici due
pezzi pontifici a difesa della porta, che in poco tempo si schiantava in fiamme
generando anche in questa zona la resa dei soldati di Pio IX. Fu in questo
frangente che il capo di Stato Maggiore delle forze pontificie, il
tedesco Hermann Kanzler, si risolse per la resa prima ancora che l'assalto
principale alle porte Salaria e Pia fosse compiuto. Mentre il comandante
dell'esercito di Pio IX organizzava la deposizione delle armi, gli Italiani
continuavano a far fuoco lungo le mura. Poco prima delle la Undicesima e
Dodicesima divisione erano in posizione per dare inizio all'attacco principale
verso le due porte Pia e Salaria, distanti tra loro poche centinaia di metri e
collegate dalle mura aureliane. Il Generale Giuseppe Angelino, secondo gli
ordini del superiore generale Mazé della XII Divisione, aveva diviso i suoi
uomini a destra e a sinistra della via Nomentana perché sferrassero l'attacco
sia attraverso la Porta Pia che per la breccia che le artiglierie avrebbero
dovuto aprire nella cinta muraria a ridosso del varco. Con lui erano
i Bersaglieri del 35° Reggimento in attesa a villa Torlonia, e i fanti della
Brigata "Bologna" con il 39° Fanteria a villa Massimo e il 40° a villa
Sant'Agnese. Completava lo schieramento la Brigata "Modena" del
generale Carchidio di Malavolta (41° e 42° Fanteria) con i Bersaglieri del 12°
Reggimento e le artiglierie. Acquartierati a cascina Bonesi approntavano i 12
cannoni a cui si aggiungevano altre due bocche a villa Dies lungo la Nomentana,
queste ultime puntate verso le artiglierie pontificie sistemate sulle mura. In
posizione più arretrata le riserve di artiglieria a Villa Albani (comandate
da Luigi Pelloux, futuro Primo Ministro del Regno) dove si era stabilito il
comando italiano di Raffaele Cadorna a soli 500 metri dalle mura. Pronti ad
intervenire erano anche altri sei Battaglioni Bersaglieri e ulteriori due
cannoni a villa Macciolini. Sono proprio le batterie di riserva ad aprire il
fuoco contro la Porta Pia alledel mattino, comandate da un ufficiale di
religione ebraica, il capitano Giacomo Segre del 9° Reggimento Artiglieria. Le
azioni di cannoneggiamento furono tutt'altro che agevoli per gli uomini di
Cadorna, che osservava la scena da un rilievo nel parco della villa Albani. I
pontifici avevano infatti concentrato il grosso delle difese a Porta Pia inclusi
numerosi tiratori scelti che presero a martellare i pezzi italiani disturbando
il tiro e colpendo persino alcune stanze della villa dove era il comando supremo
italiano. Per questo motivo il cannoneggiamento della porta risultò più lungo
che in altri punti delle mura, a causa dei colpi di precisione dei cecchini
pontifici sistemati sul tetto di villa Patrizi, avamposto stabilito appena fuori
le mura. Il primo assalto del 35° Bersaglieri sarà proprio contro i fucilieri
nemici, dopo aver aperto un varco con l'ausilio degli Zappatori del Genio. Dalla
porta Salaria i cecchini del Papa tenevano sotto scacco le forze di villa
Albani, tanto che il generale Cosenz decise di posizionare il fuoco di risposta
con i tiratori scelti del 49° Fanteria e 34° Bersaglieri. Tre ore e mezza dopo
il primo colpo di cannone, finalmente le mura crollavano a poche decine di metri
dalla porta. La breccia era visibile dai comandi italiani, ma le difese
pontificie non davano segni di resa. Porta Pia era infatti barricata
dall'interno, mentre la Salaria era stata addirittura murata e alcuni pezzi
dell'artiglieria papale avevano preso a sparare sugli Italiani dal colle
del Pincio. Fu necessario allora che il generale Mazé spostasse le artiglierie a
villa Torlonia dalla Nomentana, per proseguire il bombardamento della porta che
alle risultava danneggiata da una breccia di 30 metri di ampiezza. Fu allora che
Cadorna ordinò a Cosenz di preparare l'assalto finale avvicinando i suoi uomini
alla porta. Il 39°Fanteria comandato da Carchidio avrebbe dovuto assaltare la
porta coperto dal fuoco dei Bersaglieri del 35° Reggimento, mentre al 12°
Bersaglieri e al 41° Fanteria sarebbe toccato il passaggio attraverso la
breccia. Nella corsa all'assalto dalla Nomentana e dalla Porta salaria il primo
ad arrivare alle mura pontificie fu il 34° Bersaglieri giunto in riserva, e fu
anche il primo ad avere il primo caduto, il Maggiore Pagliari. All'ingresso dei
soldati del Regio Esercito si alzavano le prime bandiere bianche e i
trombettieri rispondevano con il "cessez le feu", che tuttavia non fu udito da
tutti nel caos dell'assalto. In particolare continuarono a sparare le truppe
scelte del Papa, gli Zuavi pontifici del generale Athanase de Charette,
asserragliati a poca distanza dalla porta conquistata dagli Italiani nella
villa Bonaparte, oggi sede dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede. Gli
ultimi scontri a fuoco si ebbero attorno alle 10 del mattino, mentre alla
medesima ora lontano dalla breccia presso la Porta San Pancrazio, la II
Divisione di Nino Bixio conquistava l'obiettivo non senza difficoltà e un certo
spargimento di sangue tra i suoi (7 morti e 23 feriti) a causa della strenua
resistenza dei pontifici e il tiro preciso delle artiglierie che sparavano senza
sosta dalla Leonina. Il giorno stesso il Luogotenente
Colonnello Primerano controfirmava l'atto di resa consegnato dal Capo di Stato
Maggiore pontificio, Maggiore Rivalta. Roma era italiana, ad eccezione della
parte a Sud dei bastioni di Santo Spirito comprendente il Monte Vaticano e
Castel sant'Angelo: l'ultimo lembo del potere temporale dei pontefici dal quale
si ritiravano lentamente i soldati del Papa ai quali erano comunque concessi gli
onori di guerra. Le forze in campo il 20 settembre 1870 furono caratterizzate da
una marcata disparità: mentre le forze guidate dal generale Raffaele Cadorna
contavano circa 65.000 uomini, le difese delle armate pontificie superavano di
poco le 13.000 unità. Dal punto di vista dell'armamento individuale invece, i
soldati di Pio IX si trovavano in vantaggio. Nel 1868 il comandante generale
Hermann Kanzler aveva infatti optato per l'adozione di un nuovo fucile
brevettato lo stesso anno, il Remington Rolling Block. Si trattava di un'arma a
retrocarica a colpo singolo calibro 12,7 mm. Prodotto dalla newyorchese
E.Remington and Sons era stato sviluppato a partire dai modelli impiegati
durante la Guerra Civile americana come quelli in dotazione agli uomini del
generale Custer a Little Big Horn. Caratteristica peculiare del modello in
dotazione ai Francesi (e quindi ai Pontifici) era l'otturatore in grado di
ruotare su un perno, meccanismo che riduceva ai minimi termini il pericolo di
inceppamento e garantendo l'efficacia di tiro per la capacità del fucile di 13
colpi al minuto. I proiettili erano metallici e la gittata massima di 900 metri
aveva un tiro utile di 300. I Remington ex pontifici, bottino di guerra, furono
per un periodo dati in dotazione ad alcuni reparti di Bersaglieri. Gli Italiani
potevano invece contare su un fucile che vide il proprio impiego in azioni
belliche unicamente in occasione della Presa di Roma. Si trattava del Carcano
modello 1867, uno dei primi fucili a retrocarica adottati dall'Esercito italiano
dopo la sconfitta per mano dai Francesi a Mentana, che erano equipaggiati
proprio con fucili a retrocarica "Chassepot". Salvatore Carcano, il padre di
molti fucili italiani, lo aveva progettato tenendo conto delle ristrettezze
economiche con le quali l'Italia post-unitaria dovette fare i conti. Nonostante
questo, il Carcano 1867 fu tutto sommato un fucile riuscito se suoi considera
che il budget per il suo sviluppo fu ridotto a circa un quinto di quanto
richiesto dal progettista (famosa fu la frase di Carcano in risposta ad un
funzionario: " Con rispetto parlando, Eccellenza…ma con dieci lire di spesa
massima a disposizione, speravate che sparasse anche dritto?"). Anche se in
realtà si trattava di una trasformazione del vecchio modello 1860 a retrocarica,
il Carcano 1867 era alimentato da proiettili di carta (sempre a causa dei
suddetti problemi finanziari del Regno) ed era dotato di un otturatore detto "a
catenaccio" a colpo singolo. Il percussore era ad ago e il calibro di 17,5 mm
per un tiro utile di circa 200 metri e una gittata di circa 800 metri. Il
problema principale del fucile era l'affidabilità essendo una riconversione di
una retrocarica, con problemi di resistenza alle intemperie e facilità
di inceppamento. Per questo motivo durante lo stesso 1870 sarà sostituito dal
più performante Vetterli-Vitali, che sarà utilizzato durante le prime avventure
coloniali dell'Italia post-risorgimentale. Una curiosità sulle armi impiegate a
Porta Pia riguarda la ipotetica presenza tra le mura della Città Eterna di una
delle prime mitragliatrici della storia. Diverse fonti parlano della presenza di
una Claxton .690, una mitragliatrice americana a sei canne meccanica ad
razionamento manuale, che sarebbe stata capace di 80 colpi al minuto per una
gittata superiore ai due chilometri. La leggenda vuole che Papa Pio IX ne avesse
impedito l'utilizzo direttamente al comandante degli Zuavi pontifici di Charette
per evitare un bagno di sangue che avrebbe finito per nuocere all'immagine del
Pontefice e per meglio dimostrare al mondo intero quanto quella di Porta Pia
fosse stato un atto di guerra nei confronti di uno Stato libero.
De Amicis, inviato di guerra a Porta Pia: il racconto di
quell'epica mattinata di 150 anni fa. Andrea Cionci su
Libero Quotidiano il 20 settembre 2020.
Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e scrittore, si
occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera lirica, ideatore del
metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di risonanza
internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha
appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del
sano e del vero – per quanto scomodi - vive una relazione complicata con
l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore.
Tra i primi giornalisti “embedded” (aggregati all'esercito) della
contemporaneità vi fu lo scrittore ligure Edmondo de Amicis (1846– 1908), autore
del notissimo, pedagogico libro “Cuore”. Intrapresa molto giovane la carriera
militare, dopo aver partecipato alla campagna del 1866, De Amicis lasciò il
mestiere delle armi per seguire le attività di giornalista, saggista e
narratore. Nel 1870, appena 23enne, si trovava però di nuovo sul campo di
battaglia al seguito del Regio Esercito come cronista militare. Vale la pena
riportare la sua cronaca della Presa di Porta Pia, poi inserita nel romanzo “Le
tre Capitali” sia per il valore di testimonianza oculare, sia per la prosa
“moderna e perfettamente italiana” dell’autore. Il testo è stato riportato quasi
integralmente nel fascicolo storico allegato al numero di settembre della
Rivista Militare, periodico dell'Esercito dal 1856. «Ieri mattina alle quattro
fummo svegliati a Monterotondo, io e i miei compagni, dal lontano rimbombo del
cannone. Partimmo subito. Appena fummo in vista della città, a cinque o sei
miglia, argomentammo dai nuvoli del fumo che le operazioni militari erano state
dirette su vari punti. Così era infatti. Il IV Corpo d’Esercito operava contro
la parte di cinta compresa tra porta San Lorenzo e porta Salara, la Divisione
Angioletti contro porta San Giovanni, la Divisione Bixio contro porta San
Pancrazio. Il Generale Mazè de la Roche, con la 12ª Divisione del 4° Corpo,
doveva impadronirsi di Porta Pia. Via via che ci avviciniamo (a piedi s’intende)
vediamo tutte le terrazze delle ville affollate di gente che guarda verso le
mura. Presso la villa Casalini incontriamo i sei battaglioni bersaglieri della
riserva che stanno aspettando l’ordine di avanzarci contro Porta Pia. Nessun
corpo di fanteria aveva ancora assalito. L’artiglieria stava ancora bersagliando
le porte e le mura per aprire le brecce. Non ricordo bene che ora fosse quando
ci fu annunziato che una larga breccia era stata aperta vicino a Porta Pia, e
che i cannoni dei pontifici appostati là erano stati smontati. Si parlava di
qualcuno dei nostri artiglieri ferito. Ne interrogammo parecchi che tornavano
dai siti avanzati, e tutti ci dissero che i pontifici davano saggio d’una
maravigliosa imperizia nel tiro, che i varchi già erano aperti, che l’assalto
della fanteria era imminente. Salimmo sulla terrazza d’una villa e vedemmo
distintamente le mura sfracellate e la Porta Pia malconcia. Tutti i poderi
vicini alle mura brulicavano di soldati; si vedevano in mezzo agli alberi lunghe
colonne di artiglieria; lampeggiavano fucili tra il verde dei giardini;
scintillavano lance al di sopra dei muri; ufficiali di Stato maggiore e
staffette correvano di carriera in tutte le direzioni. È impossibile ch’io vi
dia notizie particolari di quello che fecero le altre divisioni. Vi dirò della
Divisione Mazè de la Roche, che è quella ch’io seguii. La strada che conduce a
Porta Pia è fiancheggiata ai due lati dai muri di cinta dei poderi. Ci avanzammo
verso la porta. La strada è dritta e la porta si vedeva benissimo a una grande
lontananza; si vedevano le materasse legate al muro dai pontifici, e già per
metà arse dai nostri fuochi; si vedevano le colonne della porta, le statue, i
sacchi di terra ammonticchiati sulla barricata costrutta dinanzi; tutto si
vedeva nettamente. Il fuoco dei cannoni pontifici, da quella parte, era già
cessato: ma i soldati si preparavano a difendersi dalle mura. A poche centinaia
di metri dalla barricata due grossi pezzi della nostra artiglieria tiravano
contro la porta e il muro. Il contegno di quegli artiglieri era ammirabile. Non
si può dire con che tranquilla disinvoltura facessero le loro manovre, a così
breve distanza dal nemico. Gli ufficiali erano tutti presenti. Il Generale Mazè,
col suo Stato maggiore, stava dietro i due cannoni. Ad ogni colpo si vedeva un
pezzo del muro o della porta staccarsi e rovinare. Alcune granate lanciate,
parve, da un’altra porta, passarono non molto al disopra dello Stato Maggiore.
Gli zuavi tiravano fittissimo dalle mura del Castro Pretorio, e uno dei nostri
reggimenti ne pativa molto danno. Quando la Porta Pia fu affatto libera, e la
breccia vicina aperta sino a terra, due colonne di fanteria furono lanciate
all’assalto. Non vi posso dar particolari. Vidi passare il 40° a passo di
carica; vidi tutti i soldati, presso alla porta, gettarsi a terra in ginocchio,
per aspettare il momento d’entrare. Udii un fuoco di moschetteria assai vivo;
poi un lungo grido «Savoia!» poi uno strepito confuso; poi una voce lontana che
gridò: – Sono entrati! – Arrivarono allora a passi concitati i sei battaglioni
dei bersaglieri della riserva; sopraggiunsero altre batterie di artiglieria;
s’avanzarono altri reggimenti: vennero oltre, in mezzo alle colonne, le lettighe
pei feriti. Corsi con gli altri verso la Porta. I soldati erano tutti accalcati
intorno alla barricata; non si sentiva più rumore di colpi; le colonne a mano a
mano entravano. Da una parte della strada si prestavano i primi soccorsi a due
ufficiali di fanteria feriti: uno dei quali, seduto in terra, pallidissimo, si
premeva una mano sul fianco: gli altri erano stati portati via. Ci fu detto che
era morto valorosamente sulla breccia il Maggiore dei bersaglieri Pagliari,
comandante del 35°. Vedemmo parecchi ufficiali dei bersaglieri con le mani
fasciate. Sapemmo che il Generale Angolino s’era slanciato innanzi dei primi con
la sciabola nel pugno come un soldato. Da tutte le parti accorrevano emigrati
gridando. Tutti si arrestavano un istante, a guardare il sangue sparso qua e là
per la strada: sospiravano, e ripigliavan la corsa. La Porta Pia era tutta
sfracellata; la sola immagine enorme della Madonna, che le sorge dietro, era
rimasta intatta; le statue a destra e a sinistra non avevano più testa; il suolo
intorno era sparso di mucchi di terra, di materasse fumanti, di berretti di
zuavi, d’armi, di travi, di sassi. Per la breccia vicina entravano rapidamente i
nostri reggimenti. In quel momento uscì da Porta Pia tutto il Corpo diplomatico
in grande uniforme, e mosse verso il quartier generale. Entrammo in città. Le
prime strade erano già piene di soldati. È impossibile esprimere la commozione
che provammo in quel momento; vedevamo tutto in confuso, come dietro una nebbia.
Alcune case arse la mattina fumavano, parecchi zuavi prigionieri passavano in
mezzo alle file dei nostri, il popolo romano ci correva incontro». Dopo
l’irruzione dei Bersaglieri in Roma, De Amicis passa a descrivere l’entusiasmo
della popolazione, in netto contrasto con lo scoramento dei volontari pontifici.
«In mezzo alla piazza vi sono circa trecento zuavi disarmati, seduti sugli
zaini, col capo basso, abbattuti e tristi. Intorno stanno schierati tre
battaglioni di bersaglieri. Il Colonnello Pinelli e molti ufficiali guardano giù
dalla loggia del palazzo che chiude il lato destro della piazza. Popolani,
signori, signore, donne del popolo, vecchi, bambini, tutti fregiati di coccarde
tricolori, si stringono intorno ai soldati, li pigliano per le mani, li
abbracciano, li festeggiano. […] Passano carrozze piene di cittadini che agitano
in alto il cappello; i soldati, rispondono alzando il cheppì; le braccia si
tendono dall’una parte e dall’altra, e le mani si stringono. Passano signore
vestite dei tre colori della bandiera nazionale. Tutti gli ufficiali che passano
in carrozza, a piedi, a gruppi, scompagnati, sono salutati con alte grida. Si
festeggiano i medici, i soldati del treno, gli ufficiali dell’intendenza.
Passano i generali e tutte le teste si scoprono. – Viva gli ufficiali italiani!
– è il grido che risuona da un capo all’altro del Corso. In piazza San Carlo un
maresciallo dei carabinieri a cavallo, scambiato per un generale, è ricevuto da
una dimostrazione clamorosa, che gli cagiona un grande stupore. Da tutte le
strade laterali al Corso continuamente affluisce popolo. Non v’è gruppo di
cittadini che non abbia con sè un soldato, e ciascun gruppo osserva il suo da
capo a piedi, gli toglie di mano le armi, gli parla tenendogli le mani sulle
spalle, stringendogli le braccia, guardandolo negli occhi cogli occhi
scintillanti di gioia. – Viva i nostri liberatori! – si grida. Davanti al caffè
di Roma alcuni giovinetti gettano le braccia al collo di due robusti artiglieri
e li coprono di baci disperati. A quella vista tutti gli altri intorno fanno lo
stesso; cercano correndo altri soldati, li abbracciano, li soffocano a furia di
baci. – Viva il nostro esercito nazionale! – gridano cento e cento voci insieme.
– Viva i soldati italiani! – Viva la libertà! – E i soldati rispondono: – Viva
Roma! – Viva la capitale d’Italia! – In molti, specialmente nei giovani,
l’entusiasmo sembra delirio; non hanno più voce per gridare, si agitano, pestano
i piedi, accennano le bandiere e fanno atto di benedire, di ringraziare, di
stringersi qualche cosa sul cuore. Non vidi mai, ve lo giuro, uno spettacolo
simile; è impossibile immaginare nulla di più solenne e di più meraviglioso».
Porta Pia, la vera storia: così fu presa Roma.
A 150 anni dalla breccia di Porta Pia, ripercorriamo quei
momenti. Così venne la città dei Papi divenne la capitale del regno d'Italia.
Matteo Carnieletto, Domenica 20/09/2020 su Il Giornale. È l'alba del 20
settembre 1870 e il sole si affaccia timidamente su Roma. Le truppe del Regio
esercito italiano si sono mosse nella notte per avvicinarsi alle mura della
città eterna, ultima roccaforte di papa Pio IX. Tutti sono pronti alla guerra.
All'interno delle mura, il generale Hermann Kanzler arringa i suoi 16mila
uomini: dovranno essere pronti a immolarsi per difendere "il dolce Cristo in
terra", quello che, anche se nessuno ancora lo sa, sarà l'ultimo papa re. Al di
fuori delle mura, invece, i soldati italiani sono pronti a combattere affinché
la città eterna diventi la capitale d'Italia. Non più Torino, non più Firenze.
La capitale del neonato Regno deve essere la città dei cesari e dei papi. "O
Roma o morte", aveva detto Giuseppe Garibaldi a Marsala il 19 luglio del 1862.
Così fu. Già a partire dall'inizio dell'estate, la città è in subbuglio. La
guerra franco-prussiana ha infatti rinvigorito le spinte di coloro che, anche
all'interno dello Stato pontificio, vogliono far di Roma la capitale d'Italia.
Si legge nei documenti: "Molti privati spontaneamente portavano personalmente, o
partecipavano per iscritto informazioni, come accade quando una causa è
popolare; ma era difficile discernere le vere dalle false. Molte erano
fantastiche e frutto di una riscaldata immaginazione, con quale disturbo per un
Quartier Generale già di molto preoccupato, è superfluo l'accennare. E quale
danno poi se si fanno le operazioni su falsi o alterati dati! E ciononostante, a
tempi più tranquilli, alcuni di siffatti inventori di notizie reclamarono
compensi...Essenzialmente le informazioni positive ed utili, provenivano da
ufficiali dell'esercito segretamente spediti. Fra le informazioni attendibili vi
fu quella che allo scoppiare della guerra franco-germanica ebbero piuttosto
luogo parecchie liti fra tedeschi e francesi dell'esercito pontificio". Spie,
vere o presunte, ovunque. E la certezza che un attacco sarebbe prima o poi
arrivato. Il 20 di settembre, gli scontri iniziano poco dopo le cinque di
mattina. Sono gli zuavi a sparare per primi, vedendo un gran numero di soldati
schierati. Uno dei primi a cadere, se non il primo, è il caporale Piazzoli, che
viene colpito mentre cerca di caricare il pezzo di artiglieria che avrebbe
dovuto sparare il primo colpo. L'attacco viene così ritardato, ma solo di pochi
minuti. Secondo una leggenda, è dunque il capitano Giacomo Segre, israelita, a
sparare per primo. Come mai proprio lui? In quanto ebreo non sarebbe incorso
nella scomunica papale. La realtà è però diversa, come ci spiega il generale di
Brigata Fulvio Poli: "L'aneddoto che fu incaricato lui di aprire il fuoco contro
le mura di Roma per evitare la scomunica papale non trova conferme nei
documenti. Segre era un eccellente artigliere di un esercito pluriconfessionale.
In verità, alle 5 e 15, le artiglierie della 9^ Divisione e della 13^ aprirono
il fuoco secondo quanto aveva ordinato il generale Cadorna; pochi minuti dopo,
iniziarono pure quelle dell'11^ e 12^. Alle 5 e 20, aprirono il fuoco le
batterie della riserva". I documenti sono chiari e smontano la vulgata che è
arrivata fino ai giorni nostri: "Al centro le batterie da posizione della
riserva e le altre due dell'11^ incominciarono a battere in breccia il tratto di
cinta già stabilito e più di tutte contribuì alla rovina della muraglia la 5^
batteria del capitano Segre per la breve distanza che la separava dal
bersaglio". Ci vogliono tre ore prima che cada il muro che difendeva il
pontefice. Vengono sparati 888 e, alle 8.30, viene finalmente aperta la breccia
di Porta Pia. Si alza un intenso fumo. Odore di calce e di polvere da sparo.
L'artiglieria non si ferma e continua a sparare fino alle 9.45, quando una
bandiera tricolore appare sulla torretta di Villa Patrizi. È il segnale: Roma è
presa. Il muro crolla completamente, ad eccezione di una raffigurazione di
Maria, come scriverà Edmondo De Amicis, all'epoca giovane ufficiale testimone di
quegli eventi: "La porta Pia era tutta sfracellata; la sola immagine della
Madonna, che le sorge dietro, era rimasta intatta; le statue a destra e a
sinistra non avevano più testa; il solo intorno era sparso di mucchi di terra;
di materassi fumanti, di berretti di Zuavi, d'armi, di travi, di sassi. Per la
breccia vicina entravano rapidamente i nostri reggimenti". I soldati pontifici,
infatti, non resistono più di tanto. È Pio IX stesso a ordinare, in una lettera
la cui data è stata cambiata più volte, che non venga versato sangue
inutilmente. La missiva, datata inizialmente 14 o 19 settembre, venne poi
modificata più volte, cambiando la frase "ai primi colpi di cannone" con
o"appena aperta una breccia" e "a qualunque spargimento di sangue" con "a un
grande spargimento di sangue". A distanza di 150 anni, non sappiamo ancora
perché il Santo Padre volle assumersi la responsabilità dei caduti. Ma così fu.
Come del resto si fece anche da parte italiana: la battaglia "doveva essere
morbida, non doveva dare occasioni alla comunità cattolica - più di quante non
ne offra di per sé un attacco armato al capo supremo della Chiesa - di montare
uno scandalo internazionale" (Antonio di Pierro, L'ultimo giorno del Papa Re. 20
settembre 1870: la breccia di Porta Pia). I morti del resto furono solo 48 per
il regio esercito e 19 tra quello pontificio: "L'andamento delle operazioni
evidenzia, da un lato, come la resistenza pontificia, per quanto inizialmente
accanita, fu poco più che simbolica e, dall’altro, dimostra la volontà italiana
di non portare danno alla città e alla sua popolazione", ci spiega il generale
Poli. Si chiudeva così un'era, quella dei papa re, e se ne apriva un'altra:
l'unità d'Italia era stata raggiunta. E guadagnata con il sangue.
20 settembre 1870, attacco a Roma: le operazioni militari nel
dettaglio. Andrea Cionci su Libero Quotidiano il 19 settembre 2020.
Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e scrittore, si
occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera lirica, ideatore del
metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di risonanza
internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha
appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del
sano e del vero – per quanto scomodi - vive una relazione complicata con
l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore.
«La nostra stella, o signori, ve lo dichiaro apertamente, è di
fare che la Città Eterna, sulla quale 25 secoli hanno accumulato ogni genere di
gloria, diventi la splendida Capitale del Regno Italico». Così Cavour
identificava il destino d’Italia con questa dichiarazione in Parlamento dell’11
ottobre 1860. Ci vollero dieci anni per realizzare una delle tappe più
significative per l’Unificazione Nazionale, iniziata con l’epopea garibaldina e
definitivamente compiuta con l’annessione della Venezia Giulia e del Trentino
dopo la Grande Guerra. Il momento propizio scaturì dalla sconfitta della Francia
a Sedan, nel 1870, contro la Prussia. La guarnigione francese a Roma a
protezione del papa veniva ritirata e così sparivano all’improvviso, tutti gli
ostacoli che si erano opposti alla soluzione della cosiddetta «Questione Romana»
(che si concluderà definitivamente solo nel 1929, con i Patti Lateranensi). Era
stato fatto un ultimo, estremo tentativo per un pacifico accordo con il Papa, ma
l’intransigenza della Corte Pontificia fece rimanere inascoltato anche l’appello
con il quale Vittorio Emanuele II si era rivolto a Pio IX. Il Regio Esercito
italiano – spiega la Rivista Militare nel fascicolo storico del numero di
settembre - già tre giorni dopo la sconfitta di Napoleone III a Sedan, il 5
settembre 1870, si trovava già nei pressi di Spoleto con tre divisioni puntate
su Roma: l’11ª comandata dal Generale Enrico Cosenz, accampata a Rieti, la 12ª,
guidata dal Generale Gustavo Mazè de La Roche a Terni e infine la 13ª agli
ordini del Generale Emilio Ferrero, a Orvieto. A capo dell’operazione, il
prudente ed energico generale Raffaele Cadorna. Per parare eventuali imprevisti
e scoraggiare ogni volontà di resistere da parte delle truppe papaline, furono
aggiunte, nell’imminenza dell’attacco, altre due divisioni: la 9ª agli ordini
del Generale Diego Angioletti in afflusso dal sud Italia e la 2ª agli ordini del
Generale Bixio, che avrebbe minacciato Roma provenendo da Civitavecchia. Come
spiega il Generale Antonio Lotito, nel pomeriggio del giorno 11, il primo ad
entrare nel territorio dello Stato Pontificio fu proprio Nino Bixio, il quale
avanzò verso Bagnoregio. Gli ordini di Kanzler, comandante dell’Esercito
Pontificio, erano di “resistere all’attacco delle camicie rosse, ma in caso
d’invasione da parte dell’Esercito Italiano, l’ordine era di ripiegare verso
Roma”. Così fecero gli Zuavi di stanza nelle località via via occupate. Il 12
settembre, mentre tutte le divisioni italiane varcavano il confine dello Stato
pontificio, Kanzler dichiarava lo stato d’assedio nella città. Il primo scontro
avviene per la conquista di Civita Castellana, con 3 feriti fra i papalini e 7
fra gli italiani; Civitavecchia capitola il 16 settembre senza opporre
resistenza alla divisione di Bixio. In località Sant’Onofrio, a pochi km dal
centro di Roma, durante lo scontro a fuoco con gli zuavi papalini in ritirata,
gli italiani hanno il primo caduto: il sergente Tommaso Bonezzi, dei Lancieri di
Novara. Il 17, le truppe italiane varcano il Tevere ed ogni divisione occupa le
posizioni previste dal piano d’attacco. Come riporta il Colonnello Attilio
Vigevano nel suo volume “La fine dell’Esercito Pontificio”, complessivamente, il
Regio Esercito schiera: 60 battaglioni di fanteria di linea, 17 battaglioni
bersaglieri, 20 squadroni di cavalleria, 19 batterie di artiglieria, 9 compagnie
zappatori del genio, con 7.300 cavalli e 114 cannoni. Spiega il Generale Lotito:
«In prossimità delle mura della Città Eterna vennero schierate le artiglierie in
organico alle divisioni, più quelle della riserva. Le artiglierie divisionali
avrebbero dovuto effettuare dei tiri di disturbo, per favorire l’assalto delle
truppe. Quelle della riserva, destinate all’effettuazione del cosiddetto “tiro
di breccia”, avrebbero dovuto aprire un varco nella cinta muraria». Intorno alle
5,10 del 20 settembre, con cinque minuti di anticipo, l’artiglieria italiana
apre il fuoco contro le Mura aureliane mentre nei dintorni assistono alle
operazioni una moltitudine di civili, tra cui giornalisti, pittori, patrioti
romani già esiliati, oltre a un eterogeneo insieme di ambulanti, curiosi e
persino saltimbanchi e giocolieri. Come ricorda Assobersaglieri: «Alle 9.05 i
vertici pontifici si riuniscono a palazzo Wedekind, (di fronte a Montecitorio,
noto ai romani come sede storica del quotidiano “Il Tempo”) per decidere fino a
quando protrarre la resistenza. Intorno alle 9.45, il fuoco delle batterie della
riserva italiane apre una breccia fra Porta Pia e Porta Salaria, così il
Generale Cadorna dà l’ordine di inizio movimento alle truppe verso le mura: una
pattuglia di bersaglieri va in avanscoperta fin sotto la breccia e riferisce che
ormai lo sventramento effettuato è percorribile da truppe appiedate». Vengono
quindi predisposti per l’assalto finale il 34° battaglione bersaglieri e 3
battaglioni del 19° reggimento di fanteria da Villa Albani, il 12° battaglione
bersaglieri e il 2° battaglione del 41° fanteria da Villa Falzacappa, quindi il
35° battaglione bersaglieri con il 39° e il 40° reggimento fanteria da Villa
Patrizi. Sono le 10,05 e tutto sembra finito, ma fuori dalla breccia ci sono due
divisioni di soldati italiani che si ammassano e spingono per entrare nella
città. A poche decine di metri, altri pontifici che trovandosi a Villa Bonaparte
non hanno ancora ricevuto l’ordine di resa, aprono un fitto fuoco di fucileria
sulla massa di militari italiani ancora fuori Porta Pia e uccidono 4
bersaglieri, fra cui il Maggiore Giacomo Pagliari, ferendo altri 9 soldati di
varie specialità. C’è un momento di smarrimento, di stasi, ma alle 10.10 i
bersaglieri del 12° battaglione avanzano al passo di carica, baionetta inastata
e, incitati dalle note che il trombettiere suona per dare ancora più vigore
all’assalto, superano la breccia regalandoci quella icona risorgimentale che
rimarrà impressa nell’immaginario collettivo e nei testi di Storia. Il primo
bersagliere a superare la breccia è il Sottotenente Federico Cocito, del 12°
battaglione. Passati i primi fanti piumati, un boato di esultanza si leva dalle
divisioni che premono dietro di essi per entrare nella Città Eterna, quella che
ora sarà la capitale della nuova Italia. Conclude il Generale Lotito: «Mentre la
resistenza cessava a Porta Pia, la bandiera bianca fu issata lungo tutta la
linea delle mura. I Generali Ferrero e Angioletti la rispettarono, invece Bixio
continuò il bombardamento per circa mezz’ora». Mazè e Cosenz proseguirono nel
loro assalto, le truppe italiane oltrepassarono la breccia sparando, facendo
prigionieri e irrompendo dentro la cinta muraria; vi furono ancora scontri qua e
là che si spensero in poche ore con la resa chiesta dal Generale Kanzler. Venne
stabilito che le milizie pontificie sarebbero uscite dalla città con gli onori
di guerra e che la Città Leonina sarebbe rimasta al Pontefice. Per ordine di
Cadorna, così come convenuto con il Governo, non furono occupate la Città
Leonina, Castel Sant’Angelo, i colli Vaticano e il Gianicolo. Si realizzava, in
tale modo, una delle missioni affidate alla Forza Armata all’atto della sua
istituzione il 4 maggio 1861: fare l’Italia.
Raffaele Cadorna senior: il generale prudente ed energico che
aprì la breccia di Porta Pia. Fu padre del
Generalissimo Luigi e nonno di Raffaele jr. comandante nella guerra di
liberazione. Andrea Cionci su Libero Quotidiano il 16 settembre 2020.
Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e scrittore, si
occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera lirica, ideatore del
metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di risonanza
internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha
appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del
sano e del vero – per quanto scomodi - vive una relazione complicata con
l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore.
Cadorna: il nome di una famiglia legata ad almeno un secolo di
storia italiana di cui si ricorda soprattutto uno degli esponenti, quello del
Generalissimo Luigi che fu Comandante supremo durante la Grande Guerra.
Purtroppo, una grossolana demonizzazione ideologica sedimentata nei decenni ha
trasferito un’immagine stereotipata di questo grande stratega ammirato sia dai
suoi nemici che dagli omologhi stranieri ed ancor oggi studiato nelle accademie
militari americane.
Grazie anche alle recenti riedizioni critiche dei libri da lui
scritti in autodifesa, presentate alla Sala Zuccari del Senato, la sua figura
sta conoscendo, tuttavia, una fase di radicale rivalutazione storica. Tuttavia,
a ridosso dell’imminente 150° della Presa di Porta Pia vogliamo tratteggiare la
figura di suo padre, il Generale Raffaele Cadorna senior (Milano, 9 febbraio
1815 – Roma, 6 febbraio 1897) che fu anche il nonno del generale Raffaele jr.
comandante del Corpo Volontari della Libertà durante la Guerra di Liberazione.
Fu Raffaele “il vecchio” a guidare, infatti, il IV Corpo d’Esercito alla presa
di Roma. La Rivista Militare (periodico dell’Esercito) di settembre ha raccolto
- nel fascicolo storico allegato per l’anniversario - le testimonianze dei
pronipoti del generale, il conte Luigi e il colonnello Carlo, che hanno
condiviso documenti inediti ed episodi tramandati in famiglia. Il Generale
Raffaele era quello che si potrebbe definire un “tecnico prudente ed energico”:
prima al servizio del Regno di Sardegna e poi del Regno d’Italia, era cadetto di
un’antica famiglia nobile piemontese, di Pallanza, che però ancora non vantava
il titolo comitale conferito poi dal Re proprio per la conquista di Roma.
Un giovane indisciplinato. Da ragazzo, Raffaele era di
temperamento piuttosto esuberante, tanto che fu espulso per indisciplina due
volte dall’Accademia Militare di Torino. Grazie anche all’intercessione del
padre, stimato ufficiale, vi fu riammesso ed entrò in servizio presso il 1°
reggimento della Brigata Savoia. Dopo una lunga gavetta, la sua carriera
decollerà: egli, infatti, nasceva come ingegnere militare e i suoi progetti per
fortezze e fortificazioni cominciarono ad essere presi sempre in maggior
considerazione dallo Stato Maggiore. La sua competenza tecnica nelle
fortificazioni - che sarà provvidenzialmente ereditata dal figlio Luigi per
munire la Linea del Piave - ebbe risvolti non solo nell’ingegneria militare, ma
anche in quella civile. Non per nulla, il Generale progettò il cimitero comunale
di Pallanza e restaurò l’antico castello di Brolio di proprietà dell’amico
barone Bettino Ricasoli.
Un gustoso aneddoto. Nel ’48, raggiunto il grado di Maggiore,
partecipava alla Prima Guerra d’Indipendenza e il 12 marzo dell’anno dopo, su
incarico di Carlo Alberto, fu inviato dal Feldmaresciallo Radetzky per
“denunciare” l’Armistizio di Salasco, ovvero per riprendere la guerra del
Piemonte con l’Austria. Racconta il Colonnello Carlo Cadorna che il suo
bisnonno, per tentare di carpire qualche elemento utile dalle reazioni del
Feldmaresciallo asburgico, finse di dimenticare il berretto nella sala
dell’incontro. Ebbe modo, così, tornandovi, di sorprendere in riunione i
generali avversari. Per quanto non fosse stato in grado di cogliere indizi di
particolare rilevanza, l’episodio è significativo della determinazione e
dell’acume dell’ufficiale.
La “Ridotta Cadorna” che salvò l’Europa. L’esperienza che maturò
in Algeria a fianco dei francesi gli sarà preziosa durante la guerra di Crimea,
quando partì al seguito del corpo di spedizione sardo comandato dal Generale
Alfonso La Marmora. In quel contesto, racconta il Colonnello Carlo, Raffaele
Cadorna notò che la testa di ponte francese predisposta a difendere il ponte di
Traktir sulla destra del fiume Cernaia, era mal dislocata sul terreno. Da
esperto geniere, di propria iniziativa fece scavare dai suoi uomini una trincea
a zig–zag, a protezione dei francesi, per consentire l’incrocio dei fuochi. La
“Ridotta Cadorna”, così chiamata, venne presidiata da tre compagnie del 16°
reggimento di fanteria e da altrettante di bersaglieri. L’attacco russo avvenne
su due colonne, una si infranse sulle trincee dei piemontesi che resistettero
per un’ora ripiegando poi sul poggio. Questa posizione fu tenuta durante tutta
la battaglia, ed ebbe un ruolo importante per il suo esito vittorioso. I
giornali inglesi titolarono: “Il piccolo Piemonte ha salvato l’Europa”, ma, a
quanto pare, il Generale La Marmora fece presto sparire questi giornali per non
essere messo in ombra dal suo sottoposto.
Un cattolico alla conquista di Roma. A metà agosto del 1870,
mentre volgevano al peggio le fortune di Napoleone III in guerra contro la
Prussia e i suoi alleati, Raffaele Cadorna - che aveva più volte dimostrato di
saper combinare la capacità militare con l’accortezza politica - ebbe il comando
del Corpo di Spedizione ordinato dal governo Lanza–Sella per l’espugnazione di
Roma e la debellatio dello Stato Pontificio tracciandone il piano il 1°
settembre. Eppure, come ricorda lo storico del Risorgimento Aldo A. Mola:
«Cattolico praticante, ma senza ostentazione – secondo la tradizione
dell’aristocrazia subalpina – non era né anticlericale, né massone, a differenza
del generale garibaldino Nino Bixio, prudenzialmente posto al comando della
“retroguardia” dell’impresa proprio per non allarmare la Santa Sede».
La fine del potere secolare ecclesiastico. «Nella Storia –
continua il Colonnello Carlo Cadorna – la strategia vincente è sempre stata
quella che ha saputo combinare la realizzazione di rapporti di forza favorevoli,
di preminente competenza militare, con la prudente ed accorta azione politica,
sola responsabile nel decidere il come ed il quando. Il Papa Leone I, fermando
Attila con la sua ieratica figura, aveva consentito alla Chiesa Cattolica di
sostituirsi all’Impero Romano nella difesa della civiltà mediterranea: da allora
essa si avvalse, in modo preponderante, della facoltà di mettere le case
regnanti al suo servizio mediante la concessione del diritto divino ad
esercitare il potere. Tuttavia, la Rivoluzione francese e Napoleone Bonaparte
rovesciarono questo rapporto mettendo, piuttosto, il Papa al proprio servizio ed
introducendo i principi laici. Proprio sulla perdita di consistenza e
giustificazione storica del potere temporale dei papi si basò quindi la politica
di Cavour, volta ad orientare l’opinione politica europea verso la separazione
del potere temporale da quello spirituale. Venuto a mancare Cavour nel 1861, la
sua politica fu ben interpretata da Giovanni Lanza che, con prudenza ed
accortezza, attese che si creassero le condizioni non solo storiche, ma anche
politiche e militari, perché il Papa dovesse prenderne atto”.
La strategia impiegata. La caduta di Napoleone III, sconfitto a
Sedan, (2 settembre 1870) offrì l’occasione per l’applicazione del disegno. Il
Generale Raffaele Cadorna dovette quindi conciliare la superiorità militare –
che gli consentiva di entrare in Roma e convincere il Papa a desistere – con la
moderazione politica. Questa esigeva che il risultato fosse ottenuto velocemente
(vi era stato un precedente negativo con la Repubblica Romana nel 1849) e con
pochissime perdite nell’Esercito Pontificio. Non restava quindi che l’arma della
sorpresa: impedire, cioè, ai papalini di comprendere fino all’ultimo dove si
sarebbe compiuto lo sforzo principale. Furono perciò disposte tutt’attorno alle
Mura Aureliane le cinque divisioni disponibili, lasciando all’artiglieria della
12ª il compito di aprire la breccia di Porta Pia che, stando ai telegrammi
inviati da Cadorna al Governo, sarà attuato in quattro ore, nella mattina del 20
settembre 1870.
Sega da amputazioni e acido fenico: la medicina di guerra
nella presa di Porta Pia. Andrea Cionci su Libero
Quotidiano il 18 settembre 2020.
Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e scrittore, si
occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera lirica, ideatore del
metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di risonanza
internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha
appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del
sano e del vero – per quanto scomodi - vive una relazione complicata con
l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore.
«Ore 10. Forzata la Porta Pia e la breccia laterale aperta in 4
ore. Le colonne entrano con slancio, malgrado una vigorosa resistenza». Il
telegramma del Generale Raffaele Cadorna del 20 settembre 1870 ben descrive la
brevissima campagna di guerra contro l’esercito pontificio il quale attuò solo
una “difesa di bandiera” per espresso ordine del papa Pio IX. La resistenza dei
papalini avrebbe dovuto essere infatti simbolica quel tanto da significare al
mondo come Roma fosse stata conquistata con un atto di guerra. Un bagno di
sangue non avrebbe giovato all’immagine del Regno d’Italia né del Papa che,
opponendo una resistenza così accanita, per quanto legittima, avrebbe permesso
un massacro nella culla della Cristianità. Eppure, per quanto i combattimenti
fossero stati brevi, durante lo scontro per la presa di Roma ci si fece male
comunque: per il Regio Esercito, caddero in combattimento 48 uomini (3 Ufficiali
e 45 di Truppa), i feriti complessivamente furono 143. L’Esercito pontificio
lamentò 19 morti e 68 feriti. Va ricordato che, nelle guerre fra ‘800 e ‘900,
solo una piccola percentuale dei soldati veniva uccisa direttamente dalle
granate e dai colpi di arma da fuoco o di arma bianca. La stragrande maggioranza
dei decessi avveniva soprattutto per le infezioni: tetano, setticemia, cancrena
falcidiavano i feriti in un’epoca in cui la penicillina era ancora di là da
venire. Secondo uno studio del Colonnello Cesare Tapinetto, gli italiani si
erano attrezzati costruendo 3 ospedali temporanei a Terni, Rieti ed Orvieto e
nel frattempo ci si appoggiò agli ospedali civili di Rieti, Amelia, Narni,
Terni, Spoleto, Foligno, Città di Castello, Orvieto e Radicofani, per una
capacità totale di 1.700 posti letto ad uso militare. Tuttavia, nonostante le
fatiche e la malaria, gli ammalati furono pochi. Entrati in Roma, gli italiani
stipularono delle convenzioni con gli ospedali romani: questi erano tenuti con
molta cura anche perché i volontari che formavano i reparti di élite, come gli
Zuavi, ad esempio, provenivano spesso dalla nobiltà o, comunque, da classi
agiate. La Rivista Militare, (periodico dell’Esercito dal cui fascicolo storico
di settembre, in questi giorni, stiamo traendo notizie in quantità) ha
recuperato un volume del 1871: “Resoconto del servizio di ambulanza
nell’ospedale pontificio” del dottor Alessandro Ceccarelli, direttore delle
ambulanze e chirurgo–capo pontificio, che offre un panorama sulla medicina di
guerra dell’epoca. Le innovazioni tecnologiche delle armi producevano maggiori e
più gravi ferite rispetto al passato. Il fatto che i proietti d’artiglieria
fossero divenuti in gran parte esplodenti produceva molte lesioni da scheggia e
pericolosissimi erano i proiettili di rimbalzo: «Sebbene il combattimento non
avvenisse a campo aperto, pure, si verificò un maggior numero di ferite
dell’estremità inferiori in confronto alle superiori». Le pallottole di tipo
Minié, di forma ogivale con alette, creavano ferite più gravi: «Ai nuovi
proiettili nulla resiste – scriveva Ceccarelli - le fratture e le ferite
penetranti sono fatte frequentissime, e quali fratture, e quali lesioni di
visceri!». Le lesioni venivano lavate con acqua fenicata, ovvero addizionata ad
acido fenico. Nel 1867, vi era stata infatti una svolta nella storia sanitaria
con la messa a punto del metodo antisettico da parte del medico inglese Joseph
Lister il quale aveva intuito, sull’onda delle scoperte di Pasteur, l’importanza
di disinfettare le ferite e gli strumenti chirurgici. A tale scopo, aveva
elaborato una soluzione di acido fenico che, tuttavia, risultava abbastanza
irritante e tossica per il corpo umano. Un fondamentale sostituto di tale
disinfettante diverrà, nel 1907, la tintura di iodio, scoperta dal medico
italiano Antonio Grossich e che salvò qualche milione di nostri compatrioti in
armi, almeno fino all’introduzione della penicillina. Le ferite venivano poi
occluse con stoppa cardata – una sorta di ovatta – anch’essa disinfettata con
acido fenico. Le contusioni e gli ematomi venivano trattati con ghiaccio
raccolto in sacchetti di carta “pergamenata”. Le febbri da infezione erano
curate col solfato di chinina, a volte si praticavano iniezioni di ammoniaca per
stimolare il cuore, ma pare che questo rimedio fosse di breve durata. Per
facilitare il riposo dei pazienti venivano somministrati degli oppiacei, come si
era già sperimentato durante la Guerra Civile americana e quelli infetti
venivano tenuti separati dagli altri degenti. Le amputazioni erano prassi
ordinaria. Riportiamo la nota relativa a un paziente italiano: “Serra Leopoldo –
Anni 41 – Bologna – Capitano del 12° Bersaglieri – Ferita per arma da fuoco
trasfossa dal 3° superiore al 3° inferiore della faccia esterna della gamba
sinistra, muscolare – Ingresso 24 Settembre Emolienti – Irrigazioni fenicate –
Compressione ed occlusione – Guarigione 12 Ottobre”. Altri pazienti non furono
così fortunati come questo Capitano. Con questo articolo avremo forse evocato
immagini sgradevoli: l’odore pungente di brutali disinfettanti, il fetore di
ferite cancrenose, le grida degli amputati o i lamenti degli agonizzanti. Ce ne
rendiamo conto. E’ però importante citare anche dettagli che “possono turbare le
persone sensibili” per ricordare, ogni tanto, per quale motivo il nostro
Tricolore comprenda il colore rosso.
IL SECOLO BREVE DELL’ITALIA - 1866-1945, ANNI DI SANGUE -
"Il senso dei leader per la guerra. La sconfitta è colpa dei
soldati". di Lorenzo Giarelli su Il Fatto Quotidiano, 15 giugno 2020. - Esiste
un secolo breve del mondo – reso celebre dallo storico britannico Eric Hobsbawm
– e c’è poi un secolo breve tutto italiano, che condensa in ottant’anni la parte
finale del processo unitario, la tragedia fascista, la lacerazione del settembre
1943 e la successiva, nuova, unità, questa volta in nome della Repubblica e
della Costituzione. Eventi il cui filo conduttore si bagna del sangue delle
guerre combattute, appunto, tra il 1866 e il 1945. A raccontarlo nel suo ultimo
libro è Nicola Ferri, già magistrato e membro del Csm, “storico dilettante”
(ipse dixit) del XX secolo e firma del Fatto quotidiano, che in La nostra
memoria perduta – Le 16 guerre d’Italia da Crispi a Mussolini cerca di trovare
coerenza tra battaglie ora coloniali ora parte dei conflitti mondiali, ma con in
comune quasi sempre “l’illusione di facili vittorie” e la caratteristica di
“essere marcate dalla irrazionalità, dall’avventurismo, dal miope opportunismo,
dall’impreparazione, dall’improvvisazione, dal turpe cinismo per la sorte dei
soldati mandati allo sbaraglio e dalla fretta di sederci al tavolo della pace”.
Si potrebbe dire che in queste righe c’è il senso del libro e della nostra
storia compresa tra gli ultimi 40 anni dell’Ottocento e i primi 40 del
Novecento. E se il secolo breve di Hobsbawm si chiudeva “con il rumore di
un’esplosione e un piagnisteo”, si può dire che l’esperienza italiana sia colma
degli uni e degli altri. Ferri sceglie di raccontare le 16 guerre concentrandosi
“sulle storie”: di generali, di soldati, di uomini di Stato crudeli o soltanto
troppo piccoli di fronte al momento. Un modo per rendere l’argomento alla
portata anche dei meno esperti o di chi ha terminato gli anni scolastici da un
pezzo, senza per questo fare a meno dell’accuratezza. Gli aneddoti e le voci dei
protagonisti raccolte nei telegrammi, nei diari o nelle cronache dell’epoca
aiutano a chiarire di volta in volta il contesto e pure a smontare alcune delle
false ricostruzione storiche divenute – chissà perché e chissà come – verità
acclarate nell’immaginario collettivo. Ne è esempio la prima delle 16 guerre,
quella che la “compiacente storiografia dell’epoca” battezzò, senza più essere
smentita, come la “Terza Guerra di Indipendenza”. Slogan fortunato ma che
semplifica i fatti, edulcorandoli all’uso dell’Unità d’Italia: in realtà fu “un
patto d’alleanza con il cancelliere Otto von Bismarck”, che mirava a “affrancare
la Prussia dalla pesante supremazia dell’Impero Asburgico nella Confederazione
degli Stati tedeschi”. L’accordo, stipulato nel 1866 con “il patrocinio di
Napoleone III”, prevedeva che l’Italia tenesse occupato parte dell’esercito
austriaco sul fronte Lombardo-Veneto, in modo da agevolare le azioni prussiane
altrove. Così andò, tanto che nonostante le nostre sconfitte (“Uomini di ferro
su navi di legno hanno sconfitto uomini di legno su navi di ferro”, commentò
l’ammiraglio Whilelm von Teghetoff dopo la battaglia di Lissa) ottenemmo quel
che volevamo al tavolo di pace, dove ci potemmo presentare da vincitori in
quanto alleati della Prussia che intanto aveva sgominato l’esercito austriaco.
Fatta l’Italia, come noto, si cercò di fare gli italiani senza accontentarsi di
chi viveva tra i confini. Alla fine del XIX secolo fummo sedotti dall’illusione
delle guerre coloniali, che ci avrebbe accompagnato per decenni, fino al goffo
machismo africano del Ventennio fascista. Il primo tentativo, nel 1887, fu in
Etiopia ed evidenziò i tratti peggiori del nostro colonialismo: “Imprevidenza,
iattanza, disprezzo degli avversari, eroismo di chi non ha scampo e alla fine
preferisce la morte al tribunale militare” (riportando le parole di Angelo Del
Boca). Al disastro di Dogali, la nostra peggior sconfitta di quella spedizione,
sarebbe seguito quello di Adua nel 1896, che portò alle dimissioni di Francesco
Crispi e alla fine della seconda guerra in Etiopia. Da lì la Libia d’inizio
secolo, nuovo avamposto delle velleità di conquista risvegliate da un improvviso
nazionalismo gonfiato a furor di giornali e intellettuali (“La grande proletaria
s’è mossa”, scriveva Giovanni Pascoli), che portò sì ad una costosissima
vittoria, ma dopo “una guerra inutile, sanguinosa e priva di ogni vantaggio
politico, sociale, economico, strategico”. Il contrario di quel che
s’aspettavano gli italiani, quando nel 1911 Giuseppe Bevione, giornalista vicino
a Giovanni Giolitti, sulla Stampa spacciava la conquista della Libia come
“soluzione al problema dell’emigrazione e della questione meridionale perché la
Tripolitania e la Cirenaica potevano ospitare milioni di italiani”. In Africa
saremmo tornati anche con Benito Mussolini, in una delle 3 guerre iniziate prima
dell’ingresso nel Secondo conflitto mondiale (Etiopia, Spagna e Albania), nota,
più che per la vittoria, per la scelta dell’arsenale: “Autorizzo all’impiego –
scriveva il Duce a Pietro Badoglio – anche su vasta scala di qualunque gas”. Per
stroncare la resistenza abissina, l’Italia si affidò ai gas asfissianti in
spregio alla convenzione di Ginevra del 1925. Erano anni in cui i Generali
italiani utilizzavano metodi spietati persino contro i nostri stessi soldati, a
cui imputavano sconfitte causate da errori nelle alte sfere. Ne è emblema la
Prima guerra mondiale, teatro della nostra disfatta più celebre, a Caporetto:
“Cadorna, nel tentativo di nascondere le sue responsabilità (e quelle dei
Generali Capello e Badoglio), cercò di addossare tutte le colpe della disfatta
ai suoi soldati che pure in larghissima parte si erano battuti con grande
coraggio e spirito guerriero”. Lo stesso Mussolini, una ventina d’anni più
tardi, quando ormai era chiaro che la Seconda guerra mondiale sarebbe stata la
fine delle sue fortune, avrebbe preferito prendersela col suo popolo. Il 17
aprile 1943, in un clima che già preludeva l’armistizio dell’8 settembre,
parlando ai dirigenti del Partito fascista il Duce sbottava contro gli italiani
“cretini, imboscati, deficienti (che) siccome non hanno mai fatto la guerra,
trovano un alibi alla loro coscienza dicendo che questa guerra non si doveva
fare”. Svanito il sogno della vittoria al fianco dei tedeschi, l’armistizio
avrebbe visto un re in fuga e un Badoglio “terrorizzato” che “non si era
preoccupato affatto di assicurare la difesa di Roma, vergognosamente abbandonata
a se stessa, con l’esercito sbandato e i pochi reparti ancora in assetto
operativo lasciati senza ordini”. Conclusione coerente del nostro secolo breve,
il cui approdo alla democrazia sarebbe stato poi possibile soltanto al caro
prezzo del sangue della Resistenza.
Il Colonnello Cadorna sfida il Professore Barbero sul nonno
Generalissimo. Andrea Cionci su Libero Quotidiano
il 17 dicembre 2020.
Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e scrittore, si
occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera lirica, ideatore del
metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di risonanza
internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha
appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del
sano e del vero – per quanto scomodi - vive una relazione complicata con
l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore.
Tra questi, la leggenda nera del Comandante Supremo Luigi Cadorna
“incompetente, insensibile macellaio che mandava a morire i nostri soldati
seguendo tattiche ottocentesche”. Negli ultimi anni, questa visione
oleografica, figlia di romanzi e film totalmente ideologizzati, è in fase di
radicale revisione grazie a un’analisi attenta dei dati e dei documenti. Due
anni fa si è ricordato il conflitto ’15-’18 appena come celebrazione della “fine
della Grande Guerra”, come se questa fosse terminata “causa pioggia” e non per
il sacrificio dei nostri 600.000 soldati, o per la sapiente fortificazione della
linea del Piave predisposta con grande anticipo dal Generale Cadorna, o per la
decisiva vittoria di Vittorio Veneto del Gen. Diaz (4 novembre 1918) che
costrinse la Germania alla resa pochi giorni dopo (11 novembre 1918). (Gli
accordi armistiziali prevedevano infatti che gli italiani potessero passare in
armi attraverso l’Austria per invadere la Baviera). Nel 2021 ricorrerà
il centenario del Milite Ignoto e quindi, quale migliore occasione per riaprire
un serio dibattito storico, su base TECNICA e non ideologica? Offre
l’occasione Carlo Cadorna, Colonnello di Cavalleria in congedo, nipote del
Generalissimo, che per tutta la vita ha studiato a fondo, con la consapevolezza
tecnico-militare propria di un “addetto ai lavori”, la storia di suo nonno. Non
a caso, l’anno scorso ha presentato, insieme ad altri autorevoli relatori,
presso la Biblioteca del Senato, la sua revisione delle memorie del Generale
Cadorna, corredate di nuovi documenti. Oggi, attraverso la lettera aperta che
pubblichiamo, il Colonnello Cadorna lancia una “cordiale sfida” al notissimo
storico torinese Alessandro Barbero per un pubblico dibattito:
"Gentile Prof. Barbero, sono un Suo ammiratore per la grande
capacità comunicativa con la quale trasmette ai Suoi ascoltatori la Sua enorme
passione per la Storia ed anche per l'indubbia capacità storica con la quale ha
saputo affrontare, nel Parlamento Italiano, il centenario della Grande Guerra.
In quella circostanza storica, Lei ha saputo individuare in una frase di
Prezzolini, celebre per la sua acutezza storica, il vero nocciolo di quei fatti
lontani ma ancora tanto vicini per le conseguenze storiche ancora oggi presenti.
Mi dispiace sinceramente perciò sentire da Lei, in occasioni minori, le
espressioni di vecchi pregiudizi, contraddetti dalla documentazione storica,
vecchia e nuova, nonché da una conoscenza professionale degli argomenti
tecnico-militari che riguardano la guerra. Ne è un esempio particolarmente
diffuso quello delle critiche alle offensive di Cadorna che “avrebbero mandato i
soldati a morire contro i reticolati nemici”. La Relazione della Commissione
d’inchiesta (vol. II, pag. 189) ne fa giustizia rilevando che le morti sono
avvenute per “l’errata applicazione dei giusti criteri della circolare (attacco
frontale ed ammaestramento tattico) da parte di taluni comandanti”. Tale
affermazione trova riscontro in un episodio rilevante ma ignorato dalla
storiografia: il figlio di Cadorna, Ten. Raffaele (padre di Carlo n.d.r.) era
nel 1915 ufficiale di collegamento presso la IX divisione della III armata.
Rilevò nelle sue considerazioni per il Comando Supremo che le prescrizioni della
circolare tattica venivano ignorate: ne derivò una vera e propria rivolta della
gerarchia militare che indusse il Duca d’Aosta a rivolgersi direttamente a
Cadorna che fu costretto a riprendere il figlio davanti alla gerarchia.
L’episodio è stato documentato da una fotografia e dimostra come la tattica
(impiego delle forze) esulasse dai poteri/responsabilità di Cadorna. Le segnalo
infatti che l'argomento è stato completamente rivisto, avvalendosi di una
documentazione storica primaria che è stata in parte ignorata ed in parte
nascosta oltre che da un esame tecnico dei principali documenti che sono stati
artatamente manipolati da una parte rilevante della storiografia. Il risultato è
stato pubblicato sul libro "Caporetto? Risponde Luigi Cadorna", Bastogi Libri,
2020: su di esso La invito ad un pubblico dibattito lasciandoLe volentieri,
oltre ai vantaggi della comunicazione e dell'età, anche quello del luogo. Suo
aff.mo Col. Carlo Cadorna".
La Seconda Guerra Mondiale: i ricordi e gli orrori dei
bombardamenti e dei morti. Paolo Guzzanti su Il
Riformista l'8 Luglio 2020. Qui comincia un’avventura: il racconto della nostra
storia dalla fine della guerra a oggi, un anno alla settimana partendo dal 1945,
l’ultimo anno di guerra guerreggiata e anche della fine della guerra. Ma, ancor
più, delle apocalittiche stragi della guerra, e naturalmente della liberazione e
dei partigiani e delle ultime sacche tedesche e della pace fragile, incerta,
senza che fosse chiaro il nostro destino e la nostra fine. Tutto era nell’aria e
tutti sapevano anche senza che si dicesse più del necessario. I racconti del
sangue e della pena erano talmente eccessivi, che annoiavano. E poi la
riscoperta libertà a mano armata, delle vendette che come fai a impedirle e
anche quelle che invece erano altre stragi e bugie e verità e ombre e luci e
silenzi e altre bugie e cose che assolutamente non si potevano dire né pensare.
Le uniformi alleate erano amichevoli e festose. Non ricordo i tedeschi. Soltanto
i loro passi di notte, ma non le loro facce. Non sono uno storico di professione
ma sono un torbido amante della storia. Uso uno dei grandi doni dei nostri
tempi, che è l’accesso ai documenti filmati che non si erano mai visti prima:
centinaia di ore e di immagini che permettono a tutti di farsi le proprie idee
ma più ancora di provare le proprie emozioni. Purtroppo, il novanta e oltre per
cento di quel che si trova su Internet e specialmente su You Tube, è in lingua
inglese. Sono riuscito nella mia vita a dotarmi di questo settimo senso che
consiste nel poter godere ciò che è prodotto in quella lingua, e consiglio a
tutti, specialmente a chi abbia finora soltanto letto e studiato sui libri, di
correre a guardare i documentari fatti di immagini e documenti, a letto o sul
divano, sotto un albero o mentre piove e guardare il nostro passato con gli
occhi delle macchine fotografiche e video. Io da tempo non sono più giovane, ma
quest’anno lo sono in maniera speciale perché sto per compiere ottanta anni.
Nel 1945 avevo dunque cinque anni e non sapevo che milioni di miei coetanei se
ne andavano in fumo nei camini di Auschwitz. Non lo sapeva nessuno. Ma
appartengo alla generazione dei bambini perduti. Ricordo i bambini polacchi,
sfollati a Grottaferrata, alle porte di Roma. Non ho idea del perché i polacchi
fossero sfollati alle porte di Roma, ma tutti i popoli erano nel caos e si
perdevano nudi e affamati. Li invidiavo perché avevano i capelli biondi e le
sopracciglia nere. Io ero rosso e non erano un portafortuna, i capelli rossi.
Giocavamo con i carri armati sfondati anneriti dalla puzza della morte. Avevo
visto l’anno precedente i carri armati Sherman parcheggiati nel giardino di
piazza Cairoli e un soldato nero con le Lucky Strike nella retina dell’elmetto
si era sporto dal suo carro e mi aveva offerto un cake nel cellophane che mia
madre gettò via perché fascisti e tedeschi abbandonando Roma avevano detto che i
bambini sarebbero stati avvelenati o fatti esplodere con matite al tritolo. Le
immagini dei partigiani a Milano, i camion, le donne che marciano con
impermeabile e mitra, come le immagini dei campi di sterminio e della bomba
atomica sarebbero arrivate più tardi… Noi eravamo già stati liberati, ma ricordo
che quando andavamo in campagna in Sabina io e mia cugina venivamo ancora
nascosti nelle bigonce del somaro e coperti di foglie di fico. Poi si sentiva un
ronzio ed era Pippo. Pippo era qualsiasi ricognitore o caccia, amico o nemico,
inglese o tedesco o americano, che veniva a rompere il cazzo a chi viveva nella
paura tra i campi e le formiche usando le sue mitragliatrici come la gomma per
cancellare i contadini, i bambini e i cani ridotti a strie di sangue e scarpe
spaiate. Passava Pippo e ci buttavano per terra nel fosso e sentivi i sassi che
scoppiavano e poi qualcuno magari ci restava secco e si diceva che c’era
scappato il morto che non era mai un morto preciso, ma un morto come tutti gli
altri, con un telo e senza scarpe. A febbraio c’era stata la Conferenza di
Yalta con i quattro grandi. E si dice che Churchill si scambiò con Stalin una
bustina di fiammiferi con scribacchiato il consenso a prendersi (Stalin) i Paesi
dell’Europa dell’Est che lo stesso Churchill due anni dopo, a Fulton negli Stati
Uniti, avrebbe chiamato oltre-cortina, oltre the iron courtain che taglierà in
due l’Europa. A me bambino già risultava nelle emozioni familiari, la guerra
fredda. Mio zio giovane comunista girava in bici spargendo volantini, mio padre
più conservatore discuteva ad alta voce e poi gli americani che ballavano il
boogie-boogie per strada e giravano le camionette perché mancavano gli autobus e
si saliva con una scaletta di legno. Mi facevano studiare a casa con un anno di
anticipo, indottrinato da una vecchissima vanitosa maestra amica di mia nonna,
tutta incipriata che non sorrideva mai per non far crescere le rughe. Portava un
enorme cappello pieno di veli e riporti e odorava di cipria ed era stupida e
cattiva. Dirò in questa storia qualcosa su di me, l’unica persona che conosce
bene, giusto come utensile. Era un’epoca di fango e stupore, tutti uguali e
tutti con le gambe graffiate e la faccia piena di schiaffi. Mentre noi eravamo
liberati, a Milano c’erano ancora i tedeschi e i fascisti ma intanto la
produzione bellica della Germania nazista malgrado i bombardamenti a tappeto era
al suo massimo. La Germania non smetteva di raddoppiare la produzione
industriale anche grazie a milioni di schiavi, ma non aveva più uomini da
mandare al fronte. Aveva soltanto macchine, la Germania. Inglesi e americani
decisero di colpire il morale dei tedeschi prendendo una cittadina d’arte priva
di valore militare (salvo qualche fabbrica di munizioni leggere) e di
annientarla con tutti i suoi abitanti. Quella città era Dresda e ci furono tre
passaggi aerei, uno inglese, uno americano e poi un altro misto che
scoperchiarono al primo passaggio i tetti delle case, poi le accesero di fuochi
inestinguibili e infine portarono la città alla temperatura di tremila gradi per
cui in trentacinquemila morirono liquefacendosi in una melma verdastra. Il capo
dell’aviazione militare inglese fu accusato di genocidio e il ministro della
propaganda di Hitler disse che gli alleati erano dei mostri. Gli americani
bombardarono Tokio che era una città di carta e legno e fecero molti più morti
che con le bombe atomiche. Intanto, a milioni erano morti nelle fosse, nei
forni, nella fame e nel cannibalismo, assassinati in gruppi, orde, camion,
plotoni, sul ciglio del baratro e della calce. La notizia delle bombe atomiche
era allora incomprensibile ma associata all’idea di fine del mondo. Sotto le
nostre finestre in via Monte della Farina, di notte sparavano perché c’erano
quelli del Gobbo del Quarticciolo che si scontravano con la polizia, o così mi
dicevano. Gli americani per noi si chiamavano tutti Johnson, romanizzato
Giònzon. Sul motivo di “parapaponzi-ponzi-po’” si cantava la strofetta: “Cosa
fanno gli alleati? Sempre sbronzi-sbronzi, so’ ”. C’erano pochi sciuscià,
shoe-shine, che lucidavano le scarpe ma ne vidi molti di più l’anno successivo a
Napoli dove De Sica fece il film sugli scugnizzi, che eravamo tutti noi piccoli
sopravvissuti. Si fucilava molto. A Forte Bravetta ogni giorno un plotone della
polizia penitenziaria fucilava qualcuno legato sulla sedia, sulla schiena e
colpo di grazia alla nuca. Si fucilavano i fascisti. Divisi su tutto, ma in
posizione di tregua transitoria i democristiani e i social-comunisti (si diceva
così perché Pietro Nenni era alleato del Pci di Togliatti ed ebbe anche il
premio Stalin che poi riconsegnò). A casa mia si comprava il Messaggero e vedevo
in prima pagina questi fucilati e facevano una morbosa impressione. Hitler era
diventato un mostriciattolo rattrappito nel suo cappotto e distribuiva buffetti
ai ragazzini della Hitler Jugend che morivano contro i russi che stavano già
entrando a Berlino. Diceva a tutti che stava per uccidersi e raccomandava di
consegnarsi agli angloamericani ed evitare i russi. Poi si sparò, sparò a sua
moglie e si fece dar fuoco accuratamente in una buca del terreno scavata
apposta. Mussolini intanto passava le sue ultime giornate e diceva che avrebbe
preferito l’arrivo dei russi agli americani perché gli italiani meritavano una
buona lezione. Quando i comunisti lo presero prigioniero e poi lo fucilarono
senza far chiasso mandando un gruppetto dei loro ad ammazzare sia lui
che Claretta Petacci, si dice che Pietro Nenni, che era stato in gioventù un
compagno di cella di Mussolini e che provava per lui sentimenti misti, si
infuriò per il colpo di mano e poi dettò il titolo d’apertura dell’Avanti! il
giornale dei socialisti di cui nel 1914 lo stesso Mussolini era stato direttore
prima di essere espulso. Il titolo era: “Giustizia è fatta!”. A giugno dettero
l’incarico di formare un governo a Ferruccio Parri, capo partigiano di Giustizia
e Libertà che resse una coalizione piena di speranze ma con pochi mezzi che durò
meno di sei mesi. Molti anni dopo lo andai a trovare e viveva con la moglie nel
casermone sulla via Cristoforo Colombo per deputati e senatori, una specie di
sarcofago. Non ricordo come si chiamava la moglie, una signora deliziosa che mi
volle a tutti i costi far provare la macchina da cucire a pedali con cui aveva
fatto l’orlo ai fazzoletti tricolori per i partigiani di GL mentre lui,
Ferruccio, se ne stava seduto sul divano un po’ triste e poco incline ai
ricordi. Un galantuomo di compromesso. La vera guerra sarebbe scoppiata di lì a
poco fra filoamericani di De Gasperi e filorussi di Togliatti. Sui muri si
vedevano manifesti di Stalin dipinto come un orco o come un santo e comparivano
scritte entusiaste e sgrammaticate, come “Ataveni” che stava per: “Ha da
venire”, sottinteso, Baffone”. Nessuno lo chiamava Stalin. Solo Baffone. E quei
baffi erano un segno grafico di una potenza di cui non ricordo l’uguale, tanto
che quando Baffone morì otto anni dopo, ricordo perfettamente dove ero, perché
Baffone era il segno del tempo e di un mondo terribile e irripetibile, ma che
allora era vivo benché fosse morto.
Una non aggressione è il contrario di un'aggressione?
Storia del patto Ribbentrop Molotov, l’alleanza tra Hitler e Stalin. Paolo
Guzzanti su Il Riformista il 20 Settembre 2020. Due anni fa, avendo trovato un
filmato che ancora non conoscevo, scrissi un lungo articolo sull’alleanza
fra Hitler e Stalin, nota come Trattato di non
aggressione Ribbentrop-Molotov, in cui descrivevo quel che chiunque può vedere
nei filmati: i generali e i soldati, sia dell’esercito nazista che di quello
sovietico partecipano a una comune parata militare a Brest Litovsk (oggi Brest
in Bielorussia). Lì l’Armata Rossa rende onore alla Wehrmacht nazista con
fanfare e festoni e con bandiere con stella falce e martello più svastica,
pranzo di gala con limousine nere e volti sparuti di bambini polacchi ebrei che
non sanno ancora quel li aspetta. Quel che aspettò me fu una caterva di insulti
su questo tono: «Come ti permetti lurido mascalzone di infangare l’onore
dell’Unione Sovietica che ha da sola sostenuto e respinto con più di venti
milioni di morti l’invasione nazifascista?». E poi, quanto al “patto di non
aggressione” Ribbentrop-Molotov mi veniva spiegato per l’ennesima volta che si
trattò di un capolavoro di astuzia di Stalin il quale, perfettamente consapevole
del fatto che prima o poi Hitler avrebbe aggredito l’Urss, stipulò quel “patto
di non aggressione” che gli fece guadagnare tempo prezioso durante il quale le
divisioni dell’Armata Rossa e le industrie belliche furono trasferite fin sugli
Urali, sicché poi quando venne il momento, l’Urss guidata da Stalin e un gruppo
di magnifici generali seppero resistere, e conquistare Berlino, costringendo
Hitler al suicidio e la sua cricca alla forca. Comunque, una non-aggressione è
pur sempre il contrario di una aggressione, o no? Ecco il punto. No. Tutto quel
che c’è da sapere su questa storia è pubblico ed accessibile a tutti. Ma
l’intera storia non è stata mai raccontata se non in modo sfuggente. La storia
del “patto” è tragicamente imbarazzante sia per come cominciò che per come finì.
Cominciò quando, nel luglio del 1939, Hitler pensò che fosse ora di riprendere
la conquista incompiuta in Europa, dove aveva già occupato tutte le zone
tedescofone, compresa la Cecoslovacchia, e l’aveva fatto con il permesso
di Francia e Inghilterra alla conferenza di Monaco del 1938, organizzata
da Benito Mussolini. Stalin a Monaco non fu invitato. E neanche i cecoslovacchi
furono invitati. Stalin se la legò al dito, considerando i paesi capitalisti e
imperialisti (ma non la Germania nazional-socialista) come traditori. Francia e
Inghilterra a Monaco avevano avvertito Hitler che la Cecoslovacchia era da
considerare l’ultimo acquisto tedesco e che se per caso Hitler avesse attaccare
la Polonia, Francia e Inghilterra sarebbero intervenute in sua difesa. Il primo
ministro inglese Neville Chamberlain tornò a Londra sventolando sorridente un
trattato firmato anche da Hitler che avrebbe dovuto garantire la pace per
vent’anni. Fu allora che Winston Churchill commentò: «Hanno svenduto l’onore per
la pace e otterranno il disonore e la guerra». La Polonia stessa pretese
a Monaco un pezzo di Cecoslovacchia. Tutti mostravano enormi appetiti dopo la
fine della Prima guerra mondiale, che aveva scoperchiato un’Europa di mille
lingue e costumi, senza confini, ma con molte ambizioni e dagli anni Venti in
poi era stata un teatro di colpi di mano, rivoluzioni mancate e formazioni di
milizie. Hitler l’aveva scritto con estrema chiarezza nel suo Mein Kampf: al
mondo sarebbero dovute restare soltanto due potenze di stirpe tedesca,
la Germania e la Gran Bretagna, che considerava un Paese consanguineo con cui
sperava di fare la pace. Che non venne mai. Quanto all’Est, era stato molto
chiaro: tutti gli slavi andavano trattati da sotto uomini, da sottomettere o
eliminare e comunque da cacciare dalle grandi pianure destinate a costituire lo
«spazio vitale» del grande e potente «popolo tedesco». Stalin si era fatto
tradurre personalmente il Mein Kampf e lo aveva letto sottolineandolo con una
matita azzurra. In quel libro erano anche nominati tutti i capi della
rivoluzione bolscevica, lui compreso, come assassini, banditi da strada e – nel
caso di Stalin – ex rapinatori di banche. Stalin non era un tipo emotivo. Non
era neanche un grande oratore. Diversamente da Hitler e Mussolini scriveva
accuratamente i suoi discorsi diligenti e ideologici, ma senza slancio
passionale e con un inguaribile accento georgiano. Tutti lo descrivono come
paranoico, ma probabilmente aveva ben presente la posta in gioco in una partita
di potere così lunga e complessa come la formazione dell’Urss e le guerre da
combattere. Prima una guerra proprio con la Polonia, persa malamente nel 1920 da
lui e da Trotsky. Poi la interminabile guerra civile con gli eserciti stranieri
e quelli dei generali “bianchi”. Infine una guerra sotto casa, al confine
fra Siberia e Manciuria, dove si erano installati da un decennio i giapponesi,
che provocavano continui scontri di frontiera. In questi si faceva le ossa uno
dei futuri eroi, il generale Zukhov, uno dei pochi che si salvò dalle purghe che
nel 1937 portarono al plotone d’esecuzione quasi tutti gli alti e medi
ufficiali, partendo dal divo generale Michail Nikolaevic
Tuchacesvkij, maresciallo dell’Unione sovietica a 44 anni e inventore dell’uso
moderno dei carri armati e dell’aviazione, di cui Stalin era gelosissimo fin dal
1930 quando lo chiamava “il piccolo Napoleone”. In quella mattanza di generali
e marescialli, i tedeschi avevano messo lo zampone con la diffusione di
documenti falsi preparati da Renhard Heydrich, il gelido comandante delle SS di
cui Hitler diceva: «Quell’uomo ha un cuore di ferro, ne sono orgoglioso ma mi fa
paura». Le carte tedesche furono fatte passare per le mani del presidente
cecoslovacco Benes e dalle sue a quelle di Stalin, il quale però non le prese in
grande considerazione, perché aveva già deciso di far fuori quell’astro nascente
che gli ricordava Napoleone. Non erano tempi confrontabili con i nostri, se non
per il culto della menzogna storica, il sacro Graal delle bugie per cui ognuno è
sacrificabile. I “trattati di non aggressione” erano di gran moda negli anni
Trenta perché potevano essere disdetti in qualsiasi momento, ma servivano
momentaneamente per fornire reciproche garanzie. Il punto era che il “patto di
non aggressione” offerto dai tedeschi ai sovietici era una scatola di
cioccolatini con doppio fondo. In superficie, uno strato di parole diplomatiche
che certificavano la stabilità delle relazioni fra i due Paesi. Ma nel
doppiofondo c’era un altro documento in cui si diceva che quando la Germania
avesse ritenuto di agire in Polonia, l’Urss doveva sentirsi libera di agire in
una serie di Paesi concordati. Questi Paesi erano la Finlandia, le tre
repubbliche Baltiche, parte della Romania e parte della Bielorussia. Come era
nato questo accordo? Da un discorso di Stalin a Mosca in cui aveva compiuto una
distinzione fra la Germania nazional-socialista e le potenze imperialiste
occidentali. Ci fu molto brusio nelle cancellerie perché von Ribbentrop,
ministro degli Esteri tedesco, insistette molto con Hitler affinché prendesse in
considerazione l’eventualità che Stalin potesse essere considerato almeno nel
medio periodo un alleato. Hitler non aveva alcuna personale simpatia per Stalin
e mandò il suo fotografo personale insieme alla delegazione che partiva
per Mosca, affinché fotografasse i lobi delle orecchie di Stalin per vedere se
l’attaccatura fosse di tipo semita o no. Non risultò semita e questa era già una
buona cosa. Stalin, viceversa – le testimonianze in proposito sono
abbondantissime – aveva un debole proprio per alcuni aspetti canaglieschi
di Hitler. Apprezzò moltissimo quando il Führer, un anno dopo essere stato
nominato cancelliere, decise di liberarsi di Ernst Roehm e delle sue milizie
ormai inutili e sgradite, facendo trucidare più di centocinquanta uomini o
costringendoli al suicidio. Roehm, come molti dei suoi uomini, erano omosessuali
e furono colpiti di notte nei loro letti insieme ai loro giovani amanti. Quando
Stalin conobbe i dettagli di questa storia scoppiò in una esclamazione di
entusiasmo: «Ma è un vero diavolo, questo Hitler! È bravissimo!».
Storia d’Italia, il 1946: dal fascismo ai coriandoli la
nascita della Repubblica. Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 22 Luglio 2020. Volete capire davvero cosa sta succedendo? Perché
siamo a questo punto e a che punto siamo? Volete sapere chi siete, o chi
potevate essere, o chi non sarete mai, e chi erano i vostri genitori? Non ci
riuscirete se non ripassate la storia. Se non studiate il passato, le radici. E
allora abbiamo chiesto a Paolo Guzzanti di raccontarci la storia della
Repubblica. Da quel gennaio del ‘46, quando la Repubblica nasceva e lui doveva
ancora compiere sei anni, fino ad oggi, che la Repubblica è diventata seconda o
terza o quarta, e lui è arrivato a ottanta. Lo farà con un articolo a settimana,
per settanta settimane, correndo sul filo della sua memoria, e degli studi che
ha fatto, e della sua attività di giornalista. Lo farà con la sua penna e le sue
idee. Buona lettura.
Il 1946 fu l’anno in cui nacque la Repubblica. Infatti, per
imitare l’inizio di Pinocchio, cominceremo col chiedere: “C’era una volta?”.
“Una repubblica! “ diranno i piccoli lettori. No, cari ragazzi, avete sbagliato:
c’era una volta un re. Ma molto piccolo. Lo chiamavano “Sciaboletta” e per lui
avevano dovuto abbassare di parecchi centimetri l’altezza minima alla visita di
leva. Era stato lui a chiamare al governo Benito Mussolini nel 1922 quando molti
gli consigliavano invece di farlo arrestare ed era stato sempre lui a farlo
arrestare una settimana dopo il primo bombardamento di Roma del 19 luglio 1943
organizzando un colpetto di Stato perfettamente costituzionale. Il fascismo è
stata l’unica dittatura della Storia abbattuta con un voto di sfiducia dopo
“ampio e approfondito dibattito” nel Gran Consiglio del Fascismo che era un
organo costituzionale.
Quando, all’alba del 25 luglio, il Duce tornò a Villa Torlonia la
moglie Rachele era sulla soglia in ansia e gli chiese: «Mo’ Ben, com’è andata?».
E lui: «Mi hanno messo in minoranza e hanno ridato i poteri al re». Rachele si
infuriò: «Ma avresti dovuto fare come Hitler, ti portavi un po’ delle tue
camicie nere e li facevi fuori tutti». Mussolini era ancora ottimista: «Oggi
vado dal re e sistemo tutto» rispose esausto. Invece era stato il re a sistemare
tutto: arrivato a Villa Savoia con le ghette e il cappello, Mussolini fu fatto
accomodare nel salottino, il suo autista e la scorta furono arrestati, il re gli
disse che l’aveva sostituito con il maresciallo Pietro Badoglio ma che non
doveva preoccuparsi per la sua incolumità. Poi lo accompagnò all’ambulanza che
lo aspettava piena di carabinieri che però non sapevano che Mussolini era agli
arresti.
Ne seguì una peregrinazione comica finché il capo del fascismo fu
sistemato in albergo isolato di Campo Imperatore dove fu tentato dall’idea del
suicidio con la piccola pistola che gli avevano lasciato e fu liberato da un
commando di nazisti forsennati guidati da Otto Skorzeny al comando di alcuni
alianti. Quel piccolo re aveva visto che per lui e casa Savoia tirava un’aria
pessima, ci sarebbe stato un referendum e preferì andare in esilio lasciando suo
figlio Umberto che fu re per un solo mese e detto “Il Re di Maggio”. Fu indetto
il referendum per il 2 giugno del 1946 e con il referendum gli italiani e per la
prima volta le italiane che non avevano mai votato ai tempi del Regno furono
chiamati ad eleggere il primo Parlamento come Assemblea Costituente e dire se
volevano restare un regno o diventare una Repubblica. Le forze maggiori –
socialisti (che erano più numerosi dei comunisti) i comunisti, larga parte dei
cattolici molti fascisti che votavano Uomo Qualunque o altre formazioni minori –
erano repubblicane. Ma quando cominciò lo spoglio delle schede al ministero
degli Interni si accorsero che i voti per il re superavano di gran lunga quelli
per la Repubblica e scoppiò il panico. Il ministro Romita decise di non dir
nulla finché lo spoglio non fosse finito e fu una faccenda lunghissima e
controversa. Il Sud aveva votato in massa per il re e il Nord in massa per la
Repubblica. Ci furono accuse di brogli e ancora oggi se ne parla anche perché
qualcuno ebbe la discutibile idea di bruciare le schede votate sicché non si
poté fare una riconta. Il presidente della Cassazione anziché annunciare la
vittoria della Repubblica disse che si sarebbero prima discussi i ricorsi e si
rischiò la guerra civile. Il nuovo re-luogotenente Umberto Secondo, ad urne
aperte, scoprì di essere ancora il re e fece sapere che se non si fosse risolta
la questione immediatamente avrebbe nominato un suo governo, mentre era
presidente del consiglio Alcide De Gasperi, il leader democristiano trentino che
per anni era stato un deputato dell’Imperial Regio Governo a Vienna. La minaccia
era seria: se il “Re di maggio” faceva un governo formalmente legittimo ci
sarebbero stati due governi e probabilmente la guerra civile. De Gasperi prese
una decisione molto audace: si proclamò Capo provvisorio dello Stato al posto
del Re luogotenente che preferì salire su un piccolo aereo e partire dopo aver
sventolato il suo cappello con aria mesta davanti a una folla di monarchici
piangenti. Casa Savoia aveva tentato di giocare a carta americana: Real Casa
chiese alla Casa Bianca di essere sostenuta contro il “pericolo sovietico”. Ma
avevano sbagliato i conti: alla Casa Bianca, dove Harry Truman era succeduto
a Franklin Delano Roosevelt, erano tutti repubblicani, odiavano tutti i re e
specialmente quelli italiani. Chi era molto seccato per l’esito del referendum
fu Winston Churchill che seguitava a sognare un mondo di imperi e di teste
coronate.
La massa degli elettori italiani aveva votato per i tre grandi
partiti: la Democrazia Cristiana di Alcide De Gasperi con più di otto milioni di
voti, il Partito socialista di unità proletaria di Pietro Nenni con quattro
milioni e 758 mila voti e il Partito comunista di Palmiro Togliatti (sotto il 20
per cento, superato dai socialisti quasi al 21) con poco meno di quattro milioni
e mezzo. I tre quarti degli italiani avevano votato i grandi partiti e fra
questi c’era una forte maggioranza di sinistra perché socialisti e comunisti
formavano ancora una unione “socialcomunista” e si parlava spesso di una
possibile fusione. I democristiani avevano la maggioranza nelle aree che oggi
sono della Lega, i comunisti nelle regioni “rosse” (che durante il fascismo
erano state nerissime) e i socialisti con uno spettro un po’ più largo. Che
Italia era? Posso dire quel che ricordo da bambino: una sovreccitazione
frenetica nelle strade, tutti correvano in bicicletta, urlavano, formavano
crocicchi, sembra la celebrazione del “Free Speach” dei parchi londinesi. Preti
assatanati contro i comunisti, rivoluzionari, casalinghe, operai, professori,
tutti trovavano una cassetta della verdura su cui salire e parlare al popolo. Ma
pochi sanno che durante il Regno d’Italia e fino alla fine della Grande
Guerra nel 1918, la democrazia italiana era riservata per censo a una parte
della borghesia: soltanto chi paga le tasse ha diritto di rappresentanza per
decidere come spenderle. Con la fine della Grande Guerra fu concesso
benignamente il voto a tutti gli uomini senza distinzione di censo.
E così il Parlamento si riempì di un caleidoscopio di partitini
che contribuirono allo spappolamento della vecchia democrazia paternalistica.
Nessuno usava il deodorante, non esisteva lo shampoo e i capelli erano lavati
con saponi e bicarbonato. Tutti bevevano quantità insensate di pessimo vino a
tavola, bambini compresi, e infuriava una dieta della pasta e dell’ingrassamento
dopo gli stenti della guerra. Si aspettava ancora il ritorno di molti
prigionieri di guerra che non sarebbero più tornati e mio padre vedeva in sogno
il suo compagno di banco inghiottito dalle nevi della Russia. Era un’Italia a
coriandoli: non votarono quelli dell’Alto Adige ancora sotto controllo alleato,
ma votarono le città di Tenda e Oneglia che diventarono francesi. Roma era piena
di soldati e la polizia vestiva con l’elmetto e viaggiava su jeep con la
cappotta e si chiamava “la celere”, antisommossa perché le sommosse erano sempre
nell’aria. Era ancora l’Italia del Cln (Comitato di liberazione nazionale di
tutti gli antifascisti) ma era già l’Italia spaccata dalla guerra fredda.
Tuttavia, si sapeva che l’Italia, come la Grecia, era stata assegnata
all’Occidente e Stalin non gradiva colpi di mano. Erano gli anni di “Napoli
milionaria” di Eduardo e della “Tammurriata Nera”, le molte nascite di bambini
colorati presi in custodia da suore terribili come quelle di Fellini.
Era fatta: la guerra era finita davvero, la democrazia era
cominciata davvero, i conti sarebbero stati regolati nel 1948 con le vere
elezioni e tutto andava avanti con molta “borsa nera” (il mercato parallelo e
l’arte di arrangiarsi, che era già nel Dna. Entusiasmi e disperazioni si
affacciavano in ogni famiglia e paese, il mondo si spaccava e gli ultimi nazisti
tedeschi avevano scelto l’Argentina come nuova patria provvisoria. Dall’America
Latina un napoletano scrive “Munastero ‘e Santa Chiara” che descriveva il crollo
morale ma tutti dicevano che bisogna guardare avanti, girare pagina, perché
ormai chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato. Il che non era vero.
Storia d’Italia, il 1947: l’anno in cui tutta Europa ci
odiava. Paolo Guzzanti su Il Riformista il 29 Luglio
2020. Fu l’anno che determinò il futuro. Nel 1947 tutti furono obbligati a
mettere le carte in tavola e dire da che parte stavano. La guerra fredda era
scoppiata e nessuno, ma proprio nessuno, sapeva che non sarebbe diventata calda.
Al contrario: ricordo che nel 1947 mia madre affettava e metteva sotto sale un
prosciutto di campagna da cui saltavano fuori dei vermi. non esisteva lo schifo.
Tutto era buono. scatolette, tonno, fagioli, si faceva il sapone in casa con una
puzza orrenda di pentoloni pieni di grasso animale. Un tappeto di patate sotto
il letto. Taniche di petrolio per i lumi bellissimi pieni di nappe, nastrini e
vetri colorati che mio padre aveva comperato perché la corrente saltava.
Cocomero e burro sotto un filo d’acqua nel lavello di marmo della cucina. Estati
torride senza un filo di vento. Freddo invernale con i geloni alle dita, lo
scaldino nel letto con la brace, io mi portavo sotto le coperte di contrabbando
il nostro gattone nero chiamato Fascista perché aveva una specie di M bianca sul
petto. L’aveva portato un ingegnere amico di mio padre che frequentava il papa
sostenendo che il micio era figlio della gatta di Pio XII, Pacelli, quello che
aveva dischiuso le ali sulle macerie del bombardamento del 19 luglio
al Tiburtino. Il fratello di mia madre era diventato comunista e girava in bici
e con mio padre discutevano per ore sulla porta di casa, il secchio
dell’immondizia foderato di carta di giornale. Le voci alla radio erano
gracchianti perché il tono ufficiale era molto mussoliniano, a destra come a
sinistra. Passato Capodanno, il giornale radio avvertì che il presidente del
Consiglio stava volando verso gli Stati Uniti ed era la prima volta che De
Gasperi usciva dall’Italia. L’espressione “Presidente del consiglio dei
ministri” era stata scelta e usata solo in Italia al posto di primo ministro o
capo del governo, per scongiurare l’arrivo dell’uomo forte. Il 1947 era l’anno
in cui sarebbe stata votata la nuova Costituzione e quello in cui l’Italia
avrebbe firmato il trattato di pace con le potenze vincitrici perdendo l’Istria
con tutti gli istriani, fuggiti o infoibati, di cui nessuno voleva più sentir
parlare. Trieste era tagliata in due, mezza americana e mezza comunista, Zona A,
Zona B, e la faccenda sarebbe andata avanti per un pezzo. E poi sarebbe stato
l’anno del Piano Marshall, dal nome del Segretario di Stato americano George
Marshall, annunciato con un discorso all’Università di Harvard. L’America
capovolgeva le tradizioni: i vincitori avrebbero rimesso in piedi i vinti a
proprie spese, per evitare quel che era accaduto fra le due guerre mondiali.
Ricordo, da ragazzino, un mondo di gente molto confusa, piena di ira e di
frustrazione e tutti avevano voglia di mettere le mani addosso a qualcun altro.
De Gasperi non era stato invitato dalla Casa Bianca ma dalla rivista Time.
L’Italia non era popolare: era un Paese vinto e detestato. I francesi ci
odiavano per averli “pugnalati come Maramaldo”. Gli inglesi ci odiavano per la
guerra e ci odiavano i greci, gli slavi, i tedeschi e i russi perché avevamo
mandato corpi di spedizione in casa loro. La guerra franco-prussiana del 1870
aveva lasciato i semi avvelenati della Prima Guerra Mondiale e la pace di
Versailles aveva fatto schiudere le uova di serpente della seconda. Ora ci
trovavamo all’inizio di una Terza Guerra: l’Occidente a guida americana e
capitalista contro l’Oriente a guida russa e comunista. Scompariva l’Impero
britannico, collassato per decisione americana. Roosevelt aveva avvertito gli
inglesi: vi aiutiamo, ma voi dovete smontare tutta la baracca imperiale. E il
disfacimento partì dall’India. Da un punto di vista esistenziale –
l’esistenzialismo fioriva a Parigi – eravamo senza identità e temevamo la morte
atomica, l’ultima novità prodotta a Hiroshima. Si seppe in quell’anno del diario
di Anna Frank: la dimensione della Shoà era ancora non chiara. L’America
accettava di riceverci, ma senza trombe e tappeti rossi. Quelli sarebbero venuti
dopo. La delegazione che arrivò a Washington comprendeva il direttore della
Banca d’Itala Domenico Menichella, Guido Carli direttore dell’Ufficio Cambi, il
ministro del Commercio con l’Estero Pietro Campilli, su un affaticato
quadrimotore Skymaster, tutti imbragati con i paracadute, salvo Menichella che
era afflitto da un’enorme pancia. Due giorni di volo. De Gasperi si era affidato
all’ambasciatore Alberto Tarchiani che conosceva bene l’America e che lo portò
dal nuovo presidente Truman e che era diventato il mastino della guerra fredda.
C’era stato il discorso di Winston Churchill all’università americana di Fulton
in cui per la prima volta era stata inaugurata l’espressione iron
courtain la “cortina di ferro” di ferro, che tagliava anche Trieste, città
contesa agli jugoslavi del maresciallo Tito. Gli americani dettero a De Gasperi
un assegno da cinquanta milioni di dollari come ringraziamento per l’aiuto
ricevuto dall’Italia durante la guerra. Ma una cosa doveva esser chiara: i
comunisti, dovevano andare fuori dal governo. Era scoppiato il caso greco. I
comunisti greci, contro il divieto di Stalin, avevano cominciato una rivoluzione
destinata ad essere repressa dagli inglesi senza che i sovietici muovessero un
dito. Durante la visita di De Gasperi, il segretario di Stato James Byrnes si
dimise perché non condivideva la nuova politica antisovietica. Lo
sostituiva George Marshall, esperto mediatore fra comunisti e nazionalisti
cinesi, l’uomo che avrebbe legato il suo nome al famoso “Piano”. L’Italia
ottenne un finanziamento ulteriore di 100 milioni di dollari dalla Export Import
Bank subito dopo il rientro di De Gasperi. Pietro Nenni, ministro degli Esteri e
capo dei socialisti che era andato ad accoglierlo all’aeroporto, annotò sul suo
diario che De Gasperi era «totalmente cambiato». Dietro il successo di quel
primo incontro aveva lavorato come tessitore Francis Spellman, di 47 anni, che
era stato creato cardinale l’anno prima da Pio XII. Francis Joseph
Spellman, nato nel 1889 in Massachusetts, aveva fatto la spola fra l’ambasciata
americana e lo studio del papa, per poi finire le sue serate nelle osterie di
Frascati con il suo autista Francesco Lamonaca, che era il mio prozio di Forio
d’Ischia. Questo mitico Zio Ciccio, leggendario narratore della Prima guerra
mondiale vista con occhi napoletani, era diventato l’autista dell’ambasciata
americana e del cardinale che lui chiamava Spellmànne e che gli raccontava nei
dettagli, dopo aver raggiunto il necessario livello etilico, delle istruzioni
ricevute dal papa per l’incontro alla Casa Bianca di De Gasperi. Il viaggio fu
un successo. Ma fu subito chiaro che l’Alcide, era deciso a sbattere fuori i
comunisti e i loro alleati. i comunisti devono uscire dai governi di coalizione
in Occidente. E così fu. Pochi giorni dopo, Nenni si dimise da ministro degli
Esteri e il suo partito si spaccava per la la scissione socialista di Palazzo
Barberini, quando Giuseppe Saragat (futuro presidente della Repubblica anche lui
come Spellman molto amante del vino) ruppe con il Psiup, fondando il Psli, poi
Psdi, partito socialdemocratico italiano, pronto a governare con una Dc
filoamericana e antisovietica. Fra gli scissionisti, a sorpresa, anche Anna
Kuliscioff, rivoluzionaria comunista ebrea ucraina che in Italia aveva diretto
il quotidiano socialista Avanti! con Benito Mussolini (di cui fu brevemente
l’amante) e che poi era scappata in Unione Sovietica entrando nel gruppo
dirigente leninista. Da cui poi era fuggita orripilata. E arrivò il Piano
Marshall. Poiché tutti convenivano che l’avvento di Hitler fosse stato provocato
dalle disumane condizioni in cui il popolo tedesco fu tenuto dai vincitori
della Grande Guerra, gli americani decisero non di chiedere riparazioni e danni,
ma al contrario di pagare di tasca loro il finanziamento economico della
rinascita dell’intera Europa, Est ed Ovest. Qualcosa di inimmaginabilmente
grande, perché comprendeva anche l’Unione Sovietica dei Paesi dell’Est, non
ancora sotto dittatura comunista, come la Cecoslovacchia. Ma Stalin non ne volle
sapere ed ordino a tutti gli Stati e partiti comunisti di opporsi al piano
Marshall, malgrado le proteste di alcuni governi. In Italia il Pci si allineò
con Mosca. Gli inglesi, seccati con gli americani che giocavano da padroni,
resero noto il loro ritiro dalla Grecia in piena guerra civile e Truman accolse
la notizia come un dato di fatti: nasceva la “dottrina Truman”, che delegava il
comando all’imperatore d’occidente in Pennsylvania Avenue. Stalin era furioso:
voleva che la Germania pagasse le riparazioni dovute, ma Molotov (“Martello”, il
ministro degli Esteri di Stalin, lo stesso che aveva firmato con i nazisti il
patto del 1939) fu sconfitto. Truman mise mano al portafoglio e sborsò 250
milioni per la Grecia e 150 per la Turchia, da proteggere da sovietici. In
Italia Togliatti, con un colpaccio a sorpresa, ruppe l’unità delle sinistre e
votò alla Costituente a favore dell’articolo 7 della Costituzione che avallava i
patti fra Mussolini e Vaticano, per far breccia nei cattolici. Il primo maggio,
la strage del bandito Salvatore Giuliano a Portella Della Ginestra. I
manifestanti accolti dal fuoco delle mitragliatrici che falciano la folla con
800 colpi: 11 morti e 71 feriti. Giuliano ha da poco ricevuto i gradi di
colonnello e la bandiera di combattimento dal congresso segreto dei separatisti
che dicono di voler portare la Sicilia nella Confederazione degli Stati Uniti.
Sarà una vicenda loschissima, che finirà con Giuliano ammazzato da suo
cognato Gaspare Pisciotta in un finto conflitto a fuoco e con Pisciotta
ammazzato con un caffè corretto, che produrrà il noto sketch “Venga a prendere
un caffè da noi”. In Italia una crisi di governo a freddo estromette i
comunisti, così come accade in Francia. A luglio il Comitato centrale del Pci
dichiara impossibile proseguire nella “democrazia progressiva” ma Togliatti
promette un atteggiamento moderato per non rompere l’unità nazionale
antifascista. Il 7 settembre in un comizio a Parma Palmiro Togliatti allude a
una forza armata del Pci di 30 mila uomini e il discorso viene interpretato come
una minaccia al governo e improvvisamente scoppia una sorta di crisi
insurrezionale alimentata dal maresciallo Tito e a settembre l’ambasciatore
italiano a Washington Tarchiani si fa ricevere dall’assistente del segretario di
Stato per avvertirlo della possibilità di una insurrezione sostenuta dall’Urss.
Comincia così la vera guerra fredda italiana. Ad ottobre nasce la Cia che è
succeduta all’Oss: giudica le forze armate italiane sufficienti per controllare
una insurrezione, ma non per far fronte a un intervento jugoslavo.
Monsignor Montini, il futuro Paolo VI e che sotto Pio XII fu un eccellente
spy-master confermò al rappresentante diplomatico americano del presidente
Truman l’appoggio morale della Santa Sede a un eventuale contro i comunisti. Il
27 novembre arriva al Viminale l’uomo duro dell’anticomunismo: Mario Scelba, in
sostituzione del prefetto di Milano Ettore Troilo ex partigiano accreditato a
sinistra. Gian Carlo Pajetta alla testa di un corteo partigiano occupò la
prefettura e altri edifici pubblici milanesi. Togliatti e De Gasperi
sdrammatizzarono la crisi e la disinnescarono. Era nato di fatto un primo
compromesso storico fra la Dcfiloamericane e il Pci filosovietico. Una guerra
fredda fatta di molte parole e larvate minacce sarebbe stata tollerata e
considerata accettabile, dai tempi. Ma nessuno voleva sfracelli.
Storia d’Italia, il 1948: la “guerra” tra Togliatti e De
Gasperi. Paolo Guzzanti su Il Riformista il 5 Agosto
2020. Quando si dice “successe un Quarantotto”, si pensa a quello del 1800.
Catastrofe rivoluzionaria, la Storia mise le macchine all’indietro tornando alle
parrucche incipriate. Un secolo dopo, nel nostro 1948, finiva per sempre la
finzione dell’unità antifascista. Fu l’anno delle elezioni vinte dai
democristiani e perse dai comunisti, l’anno dell’attentato a Togliatti che –
gravemente ferito – pensava soltanto a calmare gli spiriti e quando si risvegliò
dall’anestesia chiese: che cosa ha fatto Bartali? Bartali aveva ricevuto un
messaggio da Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, che lo supplicava di
vincere la tappa del Giro di Francia di quel giorno. Bartali era molto indietro
in classifica. Aveva 20 minuti di distacco dalla maglia gialla. Speranze di
rimonta zero. E invece quel giorno Gino, che era ormai vecchio, dette l’anima e
vinse la tappa di Briancon dando quasi un quarto d’ora di distacco al campione
francese Louison Bobet che pensava ormai di aver già vinto il Tour. Una impresa
impensabile. Il giorno seguente vinse di nuovo sul traguardo di Aix les
Bains, prese altri cinque minuti a Bobet e conquistò la testa della classifica.
Che tenne fino alla fine: il 24 luglio vinse il Tour e gli scontri di piazza, in
Italia, cessarono quasi per miracolo. La pace era salva. Gli italiani
dimenticarono le revolverate a Togliatti esplose dallo studente Pallante e tutto
finì bene. Un giornale satirico titolò: “Pallante ( cioè l’attentatore, ndr)
condannato a venti anni di tiro a segno”. I comunisti, cacciati dal governo su
richiesta americana e in base alle decisioni di Yalta, si lasciarono mettere da
parte protestando solo il minimo sindacale. La Grecia che aveva voluto fare la
rivoluzione era finita schiacciata dagli inglesi. Nel 1948 partirono la
Costituzione e la vera guerra fredda, sia in Italia che nel mondo ma
specialmente a Berlino. La città si trovava nella zona della Germania sotto il
controllo sovietico (la Germania Est, cioè la Rdt) ed era a sua volta suddivisa
in quattro zone: una ai russi, una ai francesi, una agli inglesi e una agli
americani. Stalin tentò di bloccare il settore occidentale frutto della fusione
delle aree americana, inglese e francese, scintillante di luci e vetrine aperte
che adesso, cinta d’assedio, rischiava di soffocare. Fu allora che gli americani
compirono una delle più vittoriose smargiassate celebrata con francobolli e
musei: il ponte aereo. Centinaia, migliaia, decine di migliaia di aerei
portavano o atterravano a Berlino Ovest per portare tutto quel che serviva
all’intera città: latte e medicinali, vestiti e macchinari senza rallentare mai,
senza far mancare un paio di scarpe. Stalin tentò di minacciare azioni aree
militari ma lo zio Tom lasciò vedere le sue Colt alla cintura e Stalin che non
era un giocatore d’azzardo, si ritirò. In Italia il Fronte Popolare di
comunisti e socialisti perse le elezioni. Il fronte aveva come simbolo la faccia
di Garibaldi, ma ne girava una versione di cui se capovolgevi Garibaldi vedevi
Stalin. Io avevo otto anni e ricordo tutto. Era una guerra di fumetti, di
cartelli, urla, carta, altoparlanti, gente che correva con pacchi di giornali e
vendeva testate oggi scomparse. Qualche rissa, qualche revolverata, poca roba.
Il Fronte perse. I democristiani stravinsero. Il cantore della sinistra Ivan
della Mea, quanlche anno dopo mormorava alla chitarra: “Vi ricordaste del
diciotto aprile, che avé votà democristiani senza pensare all’indomani, senza
pensare alla gioventù”. I miei cugini comunisti erano “Pionieri” del partito e
portavano il fazzoletto rosso al collo. Io quello dell’Asci cattolica, cioè i
“Boy Scout”.. Loro leggevano il Pioniere di Gianni Rodari che odiavo perché era
tutta una pippa simbolistica con Pomodorone grasso capitalista e c’era sempre un
furbettino comunista che lo metteva in culo a tutti. Noi feroci anticomunisti
leggevamo sul “Corrierino” capitan Cocoricò e il signor Bonaventura ricco ormai
da far paura. Tirava anche un brutto vento da guerra religiosa: il papa per non
sbagliarsi aveva scomunicato i comunisti e molti di loro, essendo cattolici,
andavano a piazza San Pietro a urlare che loro credevano in Dio, ma anche a
Baffone, un punto teologico molto controverso. A Piazza San Pantaleo, alla messa
dei ricchi con la pelliccia come i ricchi di Miracolo a Milano di Vittorio De
Sica, una ipertiroidea isterica e passionale vestita di rosso brandendo il
foglio del partito urlava, “L’Uità! L’Unità! Ahò, v’avesse da fa’ male un
pochetto de marchesismo-leninismo, sa? V’avesse da fa’ male”. Era come ai tempi
delle vere guerre di religione quando valeva il principio secondo cui “cuius
regio, eius et religio” e cioè: ti becchi la religione del tuo re, e zitto. Io
ero di reame stracattolico anticomunista e mia nonna e mia zia e mia madre,
tutte maestre, a luce di candela di sego fatta in casa, scrivevamo, con penne ad
inchiostro col pennino e la carta assorbente, i risultati che diceva la radio su
un quadernone ordinatissimo. Si sentiva che quelle elezioni erano per la vita e
per la morte. Se venivano i comunisti, dicevano, sarebbero arrivati i russi e ti
avrebbero impiccato papà e mamma, è questo che vuoi figliolo? No, padre, non lo
voglio. E allora recita cinque pater ave e gloria, figliolo. Sì, padre. Facevo
le elementari davanti al Pantheon, alla Palombella e con la stessa
maestra Agnese Marcucci che era stata anche l’insegnante di Albero Ronchey: una
rossa fiammeggiante con un seno prorompente, papista fascista nazista
colonialista carducciana anticomunista. In classe avevamo il compagno Bartoloni,
figlio di carbonaro comunista che ogni giorno si avvicinava alla cattedra e
diceva: “Ha detto così mi’ padre che appena vincemo lui te viè a piantà ‘a
bandiera rossa sulla cattedra e tu devi pià ‘a tessera der partito communista”.
Agnese ci prendeva giusto: “Ahm, sì? E allora dì a tu’ padre che si s’azzarda a
entrà co la bandiera rossa, lo faccio arestà da le guardie”. E continuavano per
ore. Ogni giorno il mio compagno di Banco Alberto Limentani (erano più della
metà ebrei di ghetto i miei compagni di scuola sfuggiti alla razzia del 16
ottobre del 1943) ogni mattina mi dava a bere di essere appena rientrato
da Israele dove col suo piccolo aereo combatteva la guerra d’indipendenza e
faceva volare il suo caccia con una matita incastrata fra mignolo e indice e
sparava e io sparavo con lui e morivo d’invidia perché lui diceva parole
straniere molto strane e forti. Infatti, le Nazioni Unite avevano autorizzato
due Stati, uno ebraico e uno palestinese, ma la Legione Araba aveva vietato lo
Stato ebraico e decise di distruggere la cittadella ebraica dove i combattenti
erano ragazzini dell’Haganà che venivano dal ghetto di Varsavia. Stalin a
quell’epoca sosteneva gli ebrei, ma secondo modalità molto particolari e
veramente staliniane: a gennaio aveva fatto eliminare l’attore yiddish Solomon
Mikkeli presidente del Comitato ebraico antifascista organizzato dal capo della
polizia segreta Berija. Era stato il sottile Suslov, il futuro ideologo a
convincere Stalin della slealtà del Comitato che aveva il progetto di dar vita
ad una Repubblica ebraica di Crimea. La guerra arabo- israeliana si svolse quasi
a mani nude e il segretario della Lega Araba, generale Azzam Pascià proclamò la
“Jihad”, o Guerra Santa “come ai tempi delle invasioni mongole o delle
crociate”. Il Muftì di Gerusalemme, Haj Amin Al Husseini, invocò lo sterminio:
“Fratelli musulmani, uccidete gli ebrei! Uccideteli dal primo all’ultimo”. A
maggio, gli eserciti della Giordania, Egitto, Siria, Iraq, Arabia Saudita,
Libano, Sudan attaccarono Israele. Combatteva anche un contingente palestinese.
Cominciò quella che gli israeliani chiameranno “Guerra d’indipendenza” ebraica.
Più di 500 mila palestinesi fuggirono dalla Palestina cercando rifugio negli
stati arabi vicini, nella speranza che la guerra contro gli “invasori” fosse
rapida e definitiva. Gli eserciti arabi furono però inaspettatamente battuti ad
uno ad uno dal nuovo esercito israeliano figlio di anni di clandestinità e di
alta capacità tecnica appresa durante la Seconda guerra mondiale e degli
ufficiali ebrei che avevano combattuto nell’esercito britannico e
nella resistenza europea. Resisteva parzialmente, senza subire una vera
disfatta, soltanto la Legione Araba dell’emiro Abdullah (o Abd-Allah), alleato
ed armato dagli inglesi, guidato da Glubb Pascià, alias generale John Bagot
Glubb, ufficiale di carriera inglese, pluridecorato della Prima guerra mondiale,
noto come Abu Henek (“mento storto”, a causa di una ferita di guerra). La
Legione occupò la Cisgiordania e una parte di Gerusalemme. Con questi nuovi
frammenti territoriali lo sceicco Abdullah cambierà poco dopo nome al suo paese
chiamandolo Giordania ed assumerà il titolo di re. Nel giugno del 1948 il leader
dei comunisti cecoslovacchi Slànsky e il segretario del Partito comunista
israeliano Shamuel Mikunis ottennero da Stalin l’autorizzazione a reclutare
ebrei per combattere in Israele, ma poi il dittatore cambiò idea e li fece far
fuori, compreso Slànsky. A dare il la sarà Ilja Ehrenburg con un articolo sulla
Pravda in cui sostenne che gli ebrei sfuggiti all’Olocausto che non avevano
scelto Israele erano ormai ansiosi di assimilarsi e aderire con zelo agli
emergenti partiti comunisti staliniani”. Scrisse Mastny: “ furono spesso gli
uomini preferiti da Stalin per lavori particolarmente sporchi, ma erano anche i
più vulnerabili alle purghe una volta esaurito il loro compito”. Il 18 giugno
del ’49 fu creato nella Cia, nata l’anno precedente e ancora piena di
intellettuali dell’Oss ed ex combattenti antifascisti del “Lincoln
Bataillon” della guerra di Spagna, l’Office of Special Projects “per pianificare
e condurre operazioni clandestine, in coordinamento con il Joint Chiefs of
Staff. Per motivi di sicurezza e di flessibilità operativa, e per ottenere il
massimo grado di efficienza, l’ufficio progetti speciali opererà
indipendentemente dagli altri componenti della CIA”. Le operazioni “Stay Behind”
sono accorpate con le esistenti organizzazioni occidentali per la guerra
psicologica e i gruppi di guerra clandestina inglesi e francesi. Usa Gb e
Francia sono le sole potenze che nella Nato hanno accesso al “North Atlantic
Military Committee Standing Group”, creato per coordinare “Stay Behind”. Questa
operazione verrà poi esposta pubblicamente da Giulio Andreotti nel 1990 con il
nome di codice italiano di “Gladio” e sarà al centro di un grande scandalo
spionistico e politico. Chi adesso pagava veramente era la
povera Cecoslovacchia, con un governo democratico legittimo, sottoposta alle
cure del colpo di Stato Comunista. Stalin non scherza, l’America non scherza. In
Italia c’è il grosso problema delle armi nascoste del Pci e la paventata
capacità di mobilitazione. Molti partigiani si comportano come gli americani
dopo la rivoluzione quando fu approvato il secondo emendamento: abbiamo diritto
di portare le armi per difendere la democrazia, nessuno ci può disarmare. Questo
fu il primo serio compromesso storico. La Dc in particolare accettava una
smilitarizzazione graduale del Pci che mandava in bestia americani e inglesi.
Esistevano convenzioni politiche e regole non dette. Togliatti garantiva che non
ci sarebbero state insurrezioni, il ministero degli Interni in cambio non faceva
troppi rastrellamenti. Dare tempo al tempo, era la massima. Ma intervennero
molto fatti nuovi. La Costituzione entrò in vigore, e questo fu un fatto
stabilizzante. Socialisti e comunisti si ritrovarono all’opposizione, e questo
fu destabilizzante anche se previsto e poi ci fu l’attentato a Togliatti,
segretario del PCI, ex numero due del Comintern a Mosca, ex responsabile
sovietico nella guerra di Spagna dove si era occupato di far fuori trotskisti e
anarchici, più che fascisti e franchisti e recuperare il tesoro spagnolo con cui
farsi pagare gli armamenti sovietici. Dalla Spagna Togliatti era stato
richiamato per firmare le condanne a morte del gruppo comunista dirigente
polacco liquidato per spianare la strada della spartizione
della Polonia tra nazional socialist tedeschi e comunisti russi. Davide Lajolo,
direttore dell’Unità, ricordò: “Quando gli chiesi perché firmò quelle condanne
ingiuste, rispose: se non l’avessi fatto, mi avrebbero ucciso e avrebbero
comunque eseguito le condanne. A che cosa sarebbe stata utile la mia morte?”.
Togliatti nel 1943, spinto a tornare da Mosca in Italia per ordine perentorio e
notturno di Dimitrov, il numero uno dell Comintern, su ordine di Stalin, gli
disse che occorreva in Italia un partito nuovo, largo, accomodante, aperto a
tutti, non settario e che smussasse tutti gli angoli che rallentavano l’ultimo
sforzo bellico contro Berlino: e fu il” partito nuovo” della volta di Salerno.
Ma nel 1948 era cambiato tutto davvero e per sempre. Ovest contro Est, due patti
militari opposti. La guerra perenne in Medio Oriente. La certezza che una
prossima guerra fosse questione di anni, forse mesi. E che saremmo probabilmente
stato inghiottiti nel sistema sovietico che non sembrava poi così allettante. Ma
Stalin era popolarissimo, era l’angelo vendicatore, era la mano della giustizia,
era un duro dalla parte dei poveri e dei derelitti. Non importava se fosse il
più grande serial killer della storia (cosa che si sarebbe saputo soltanto con
il XX Congresso del PCUS del 1956) e tutti erano gli uni contro gli altri
armati: famiglie, regioni, credenti e miscredenti, c’era voglia di delazione e
voglia di mangiare senza fondo. L’obesità dilagava. Non era praticata alcuna
forma di rispetto reciproco. La guerra mentale era quanto di meglio potesse
sostituire la guerra fisica. I prigionieri di guerra non si rivedevano. La gente
scherzava e rideva e aveva voglia di dimenticare, di essere sguaiata, di fare
sesso, di chiudere finalmente tutte le partite del dolore, ma quando queste
cicatrici copriranno le ferite, nessuno se ne ricorderà più perché quella
generazione stava già morendo e non lo sapeva.
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1948
1 gennaio. Entra in vigore la Costituzione Repubblicana.
30 gennaio. Un estremista uccide a revolverate Gandhi, l’uomo che
ha conquistato l’indipendenza dell’India dagli inglesi e il leader mondiale
della nonviolenza.
22 febbraio. Golpe in Cecoslovacchia. Il partito comunista assume
il potere.
18 aprile. Si vota in Italia. Lo scontro è tra la Democrazia
Cristiana di De Gasperi e il Fronte Popolare che unisce i comunisti di Togliatti
e i socialisti di Nenni. Vince la Dc ottenendo quasi il 49 per cento dei voti
(mai nessun partito, da solo, arriverà a questo successo record); il Fronte
Popolare si ferma al 31 per cento.
1 maggio. In Grecia vengono fucilati 213 partigiani comunisti.
11 maggio. Luigi Einaudi, liberale, ministro del Bilancio e
governatore della Banca d’Italia, viene eletto Presidente della Repubblica. Il
suo nome viene scelto da De Gasperi dopo che il candidato ufficiale del partito,
Carlo Sforza, era stato azzoppato dai franchi tiratori della sinistra Dc.
Einaudi riunisce la Dc, ottiene il voto di liberali e socialdemocratici e
sconfigge Vittorio Emanuele Orlando, sostenuto dalle sinistre.
14 maggio. Nasce lo stato di Israele.
5 giugno. Si apre il processo contro Rodolfo Graziani, capo delle
forze armate nella Repubblica di Salò. Viene condannato a 19 anni di prigione,
dei quali 17 condonati.
24 giugno. Le autorità filosovietiche della Germania Orientale
proclamano il blocco di Berlino.
14 luglio. Uno studente di 24 anni, Antonio Pallante, spara
cinque colpi di pistola a Togliatti ma non lo uccide. Disordini, incidenti,
proteste violente in tutt’Italia. Togliatti, prima di entrare in Camera
operatoria, raccomanda al suo partito di mantenere la calma.
30 settembre. Esce nelle edicole il fumetto Tex.
2 novembre. Rovesciando i sondaggi Henry Truman, democratico,
viene rieletto presidente degli Stati Uniti, sconfiggendo il repubblicano Thomas
Dewey.
10 dicembre. Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo.
Storia d’Italia, 1949: l’anno in cui diventammo il paese
cerniera della Guerra Fredda. Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 12 Agosto 2020. Ricordo me stesso nel 1949 spaventato all’uscita
di scuola perché non sapevo come digerire la notizia: la squadra del Torino,
tutta quanta, era morta. Precipitati in aereo sulla collina di Superga. Era una
notizia eccessiva come la guerra e non potevo separarmi dalle immagini delle
figurine di quei giocatori e dal fatto che fossero morti. Gli anni, quegli anni,
diventavano giorno dopo giorno più terribili. Poi, dopo, a decenni di distanza
tutti avrebbero usato queste parole insignificanti come ricostruzione,
pacificazione, democrazia, miracolo economico. Non c’era ancora nulla, nel 1949.
La società che ricordo era mentalmente settaria e violenta, tutti molto
aggressivi e ognuno con un suo conto da regolare, politico o umano.Tutte le
famiglie o quasi erano uscite distrutte dalla guerra e la spaccatura della
guerra fredda ci passava per le ossa. nelle famiglie, a tavola. Mia nonna si
vantava di aver sfilato di tasca a suo figlio una copia de l’Unità. ma
quell’anno, il 1949, fu un annus terribilissimus perché la guerra, quella
prossima, era nell’aria e sembrava cosa fatta. L’America aveva rotto con
la Russia e così la Francia e l’Inghilterra. Noi italiani non contavamo nulla,
ma quando i grandi dell’Occidente decisero di formare un’alleanza anti-sovietica
che si sarebbe chiamata “Alleanza Atlantica”, il governo De Gasperi chiese e
anzi supplicò di accettarci fra i soci fondatori. Scoppiò la rivoluzione. A
sinistra. I comunisti si indignarono: questa nuova roba atlantica altro non era
che l’ennesima crociata contro i comunisti che hanno salvato il mondo dai
nazisti: è un tradimento, una mascalzonata, un attentato contro la pace, la
democrazia eccetera. Le cose non stavano proprio così: tutta l’Europa dell’Est,
che Stalin aveva prima trattato con Hitler nelle clausole segrete del Patto di
Non Aggressione dell’agosto del 1939 e che poi si era fatto riconfermare
da Churchill e da Roosevelt, era stata sì assegnata come “zona d’influenza”
all’Unione Sovietica, ma a condizione che la democrazia rappresentativa e le
libertà fondamentali fossero state garantite. Invece nel 1948 un colpaccio di
Stato aveva instaurato la dittatura del partito a Praga e lo stesso era successo
in tutti gli Stati che da allora in poi furono chiamati “satelliti”. Inoltre, lo
scisma del maresciallo Tito aveva sottratto all’impero sovietico la grande
Jugoslavia che restava un Paese comunista, sì, ma “diverso”: molto legato agli
inglesi, aperto al turismo occidentale, ma più che altro con l’arma al piede, se
a Stalin fosse saltato in mente un colpo di mano: gli jugoslavi erano stati i
soli, sia pure con un potente aiuto inglese (un figlio di Churchill collaborava
strettamente con Tito) a vedersela con i tedeschi. Il fatto che Tito fosse ora
l’uomo nero per Mosca e per tutti i comunisti ortodossi permise a Palmiro
Togliatti di reclamare a gran voce il ritorno di Trieste all’Italia. Intanto,
l’Italia – Paese che non era per nulla ben visto in Occidente – fece nel 1949
una pessima e maleodorante figura: un’inchiesta americana sul modo in cui
venivano spesi dai Paesi beneficiari i soldi del piano Marshall, rivelò che
l’Italia li stava sperperando in regalie per gli amici, giochi di potere e
correnti, nulla di strutturale ma anzi di molto personale e vagamente mafioso.
Fu uno scandalo internazionale che mise in grandissimo imbarazzo il nostro
governo che balbettò, promise, face la faccia feroce e cercò di recuperare
ancora una volta l’onore perduto. Ma nel frattempo avevamo, come Paese,
guadagnato una posizione nuova e invidiabile che ci avrebbe reso moltissimo per
mezzo secolo sotto ogni punto di vista, in particolare perché ci avrebbe
permesso di giocare, secondo le circostanze con il piede in due staffe. Eravamo
diventati il Paese cerniera e questo ci avrebbe dato molti vantaggi. Il fatto di
avere il più grande partito comunista dell’Occidente, per di più un partito
influente a Mosca e composto da un gruppo dirigente disciplinato in cui non
prevalevano le teste calde che avrebbero voluto passare dalla Resistenza alla
rivoluzione, era un fattore d’interesse anche per gli alleati. Interesse e
pericolo allo stesso tempo. Il Papa, il principe romano Eugenio Pacelli, era un
anticomunista oltranzista. Fece un pubblico discorso in cui dichiarò che santa
Romana Chiesa Cattolica Apostolica Romana era perfettamente d’accordo
sull’Alleanza Atlantica che avrebbe tenuto a distanza i comunisti russi,
considerati come il maggior pericolo per il genere umano. Gran parte del Partito
socialista guidato da Pietro Nenni (allora molto stalinista che poi avrebbe
capovolto la sua posizione restituendo il Premio Stalin che aveva ricevuto) si
infuriò contro il Patto Atlantico e in molti gridarono in Parlamento che
un’alleanza contro l’Unione Sovietica era da considerare come uno schiaffo al
Paese che più di tutti aveva contribuito alla sconfitta del nazismo e ne
nacquero molti tafferugli in aula. L’anno precedente erano stati infatti
ritrovati a Berlino nella Wilhelmstrasse i documenti originari del cosiddetto
“Trattato di non aggressione” fra Terzo Reich nazista e Unione
Sovietica, contenenti le clausole segrete che prevedevano l’immediato intervento
russo nell’invasione della Polonia (come accadde il 17 settembre del 1939) e
l’attribuzione all’Urss dei tre Paesi baltici, Bessarabia, Romania e mano libera
in Finlandia. I sovietici negavano ad alta voce e soltanto Michail Gorbaciov nel
1989 confermò che le clausole erano autentiche e che dunque l’Urss aveva
tecnicamente iniziato la seconda guerra mondiale dalla parte tedesca. Nel 1949
nessuno era appassionato alla scoperta della verità, ma tutti avevano il
coltello fra i denti, per cui il clima politico e nelle strade e nelle famiglie
diventò violento, con tafferugli. In Parlamento l’ambiente era rovente, i
discorsi erano tutti retorici e minacciosi, ma i numeri erano numeri e alla fine
il Patto Atlantico passò e l’Italia entrò in quella che poi si chiamerà
la Nato (Trattato dell’organizzazione del Nord Atlantico, benché fossimo nel Sud
mediterraneo). L’Italia era diventata anche la terra delle spie perché Paese di
frontiera fra Est ed Ovest e perché eravamo anche nel pieno crocevia del Medio
Oriente. Abbiamo già raccontato quel che era accaduto nel 1948, quando
le Nazioni Unite dettero mandato per la nascita di due nuovi Stati, uno ebraico
e uno arabo palestinese, ma che quest’ultimo fu respinto con sdegno dalla Lega
Araba che cercò distruggere il focolaio ebraico con tutti gli eserciti
disponibili, restando alla fine battuta dal giovane Stato israeliano pieno di
giovani che si erano battuti in Europa contro i nazisti. Era appena terminato
l’esodo arabo dal nuovo Stato di Israele da cui erano fuggiti in 720 mila arabi
che vivevano nelle regioni bibliche della Giudea e Samaria.In Israele i nuovi
dirigenti Ben Gurion e Golda Meir tentarono di convincere gli arabi a restare
rendendosi conto che si stava aprendo una piaga che non si sarebbe più
riemarginata. Soltanto frange terroriste ebraiche spingevano verso la cacciata
degli arabi, seguendo una linea di condotta sanguinaria che si era già mostrata
con l’eccidio di Yeir Dassin. Gli arabi che accettarono di restare ottennero una
cittadinanza pari a quella dei cittadini ebrei, con alcune limitazioni, come il
non obbligo di prestare il servizio militare. Ma fino ad oggi gli arabi
musulmani anti-israeliani cittadini dello Stato di Israele sono gli unici arabi
musulmani con diritto di voto attivo e passivo, diritto di formare partiti,
pubblicare e leggere quel che vogliono. I palestinesi dell’esodo che avevano
lasciato i luoghi in cui nasceva Israele furono accolti con profonda ostilità
dagli Stati arabi e furono costretti a concentrarsi in campi profughi dove
diventarono di fatto il più potente strumento di pressione per ogni trattativa
con Israele, strumento per pressioni reciproche e per i combattimenti contro gli
israeliani. Intanto, centinaia di migliaia di ebrei che vivevano (anche da
duemila e cinquecento anni) nei Paesi arabi, si spostano in Israele. Si
registrano attacchi alle comunità ebraiche ad Aden, in Egitto, Libia,
Siria e Iraq, dove il “sionismo” diventò un reato punito con la pena capitale.
Il bilancio del primo rientro ebraico nei confini palestinesi fu di circa
seicentomila persone che sostituirono, più o meno, gli arabi fuggiti. Seguirono
degli armistizi di cui solo alcuni si trasformarono in trattati di pace, con
l’Egitto, il Libano e la Giordania che si annesse la Giudea e la Samaria con il
consenso dell’Inghilterra e del Pakistan, quest’ultimo un nuovo Paese di
religione musulmana emerso dall’indipendenza dell’India dall’impero britannico.
L’Italia si trovava a far parte di uno scacchiere che prevedeva uno stato di
guerra più o meno permanente tra Israele e gli Stati arabi, con un nuovo
elemento: il petrolio. L’Italia stava per liquidare una vecchia azienda di Stato
che risaliva all’epoca fascista per uso agricolo, l’Ente nazionale Idrocarburi,
l’Eni, quando furono trovati giacimenti di gas e petrolio in Italia e il nuovo
capo dell’ente, Enrico Mattei, si improvvisò manager di una azienda che avrebbe
combattuto da parti a pari con le “Sette sorelle” del petrolio mondiale e che
avrebbe avuto un ruolo nuovo ed essenziale nella politica estera italiana, tutta
volta allo sfruttamento delle risorse di gas e petrolio sullo scacchiere
mediorientale. L’Italia aveva appena scoperto di aver posseduto con la Libia,
ormai indipendente, il più grande lago di petrolio del mondo, ma si stava
rifacendo con una politica molto sfrontata, aggressiva, quasi del tutto
indipendente dallo stesso governo italiano. Nel mese di agosto arrivò la
sorpresa tanto temuta: gli Stati Uniti perdevano ufficialmente il primato di
unica potenzia atomica del mondo, perché l’Unione Sovietica faceva esplodere la
sua prima bomba. L’Occidente non ne fu poi così scioccato. Si sapeva da anni che
i sovietici seguivano gli americani a poca distanza e gli esperti statunitensi
affermarono che il contributo spionistico offerto dai coniugi Rosenberg e di
altri circa duecento agenti aveva accelerato il processo. Questa novità benché
attesa e temuta strappava agli Stati Uniti un potere implicito anche se mai
dichiarato: quello di poter inferire il primo colpo, senza dover attendere una
risposta di parti intensità. Gli americani avevano dalla loro un buon nucleo di
scienziati tedeschi portati negli Stati Uniti, capeggiati da Von Braun che era
stato l’inventore dei missili “V2” con cui la Germania aveva bombardato Londra e
che guiderà la ricerca spaziale americana fino alla conquista della Luna. Fra
russi e americani circolava la battuta “i nostri scienziati tedeschi sono
migliori dei vostri”. Intanto, un evento di portata mondiale e millenaria, se è
ancora lecito usare aggettivi tanto pomposi, si concluse quell’anno: la Cina,
questo enorme Paese eternamente malato, eternamente conquistato, frazionato,
povero, dominato da dinastie e da stranieri (anche l’Italia aveva a Shangai la
sua rappresentanza militare come ogni Paese occidentale coloniale) era stata
conquistata dall’esercito popolare di Mao Zedong che proclamò la Repubblica
Popolare Cinese. Il secondo Stato comunista del mondo diventato tale per una sua
evoluzione e rivoluzione interna, dopo l’Unione Sovietica. La vittoria di Mao fu
salutata come il più grande evento del dopoguerra da tutte le sinistre mondiali,
anche in considerazione del fatto che sia Mao che gli uomini del suo Stato
maggiore, fra cui Ciu Enlai (suo potente e coltissimo ministro degli esteri)
venivano da una covata intellettuale che si era sviluppata in Francia, alla
università della Sorbonne e persino negli Stati Uniti, dove un altro leader, il
futuro presidente del Vietnam Ho-Chi-Minh, aveva lavorato per anni come
cameriere studiando l’opera di Lincoln. La Cina era stata invasa dal Giappone
negli anni Trenta che aveva creato uno stato cinese fantoccio in Manciuria, ai
confini con la Siberia sovietica, dove proprio alla vigilia della seconda guerra
mondiale si registrarono feroci scontri tra giapponesi e sovietici. Si formarono
così due eserciti cinesi di resistenza contro il Giappone: quello di Mao e
quello nazionalista filoccidentale del maresciallo Chang-Kaishek che
combatterono insieme contro gli invasori nipponici e poi si scontrarono fra loro
e il vincitore fu il comunista Mao, al termine della sua “lunga marcia” durata
ben nove anni spesi arruolando contadini. Il maresciallo sconfitto si ritirò
nell’isola di Taiwan, che ancora veniva indicata con il nome coloniale di
Formosa. Lì Chang governò mantenendo in piedi un esercito con cui sognava di
tornare sul continente e riconquistare Pechino. Dopo la sua morte, Taiwan
diventò un protettorato americano, ma dal punto di vista del diritto
internazionale nessuno obiettò che l’isola apparteneva alla Cina che proprio
oggi la rivendica con grande energia, come ha fatto per l’ex colonia britannica
Hong Kong. Taiwan, insieme a Singapore, Hong Kong, la Cambogia e il Vietnam (per
non dire dell’Australia) costituisce la più lacerante ferita nel fianco del
regime di Pechino. Quando ero un giovane giornalista nel 1963 nella redazione de
l’Avanti! ci davamo appuntamento ogni mercoledì e venerdì davanti alle
telescriventi intorno alle 15 perché a quell’ora ogni settimana dell’anno, le
batterie costiere cinesi bombardavano i disabitati scogli di Quemoy e Matsu, i
più vicini a Taiwan, in segno di “grave avvertimento” del popolo e dell’esercito
della Repubblica cinese. Ricordo che a quell’epoca era d’uso festeggiare
l’evento brindando con pessimo spumante a temperatura ambiente.
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1949
25 gennaio – Ben Gurion è eletto primo ministro di Israele.
3 febbraio – Inizia il processo a Budapest al cardinale Jozsef
Mindszenty. Accusato di spionaggio. Ergastolo.
5 febbraio – Negli Stati Uniti viene pubblicatoil rapporto
Hoffman. L’Italia è accusata di aver sperperato i fondi dle piano Marshall. In
particolare è sotto accusa la decisione di Fanfani di dare alcuni miliardi
all’Ina Casa per costruire case popolari.
5 marzo – L’ex procuratore generale dell’Urss Andrej Vysinskij
diventa ministro degli esteri al posto del mitico Molotov. Anche Vysinskij è
mitico: è il Pm che ha fatto condnanare a morte decine di alti dirigenti del
partito, compreso Bucharin.
11-20 marzo – L’Italia aderisce al patto atlantico (NATO).
Contrarie le sinistre. Dissensi nella Dc. Votano contro due nomi eccellenti:
Luigi Gui e Giuseppe Dossetti.
4 Maggio – L’aereo sul quale viaggia la squadra di calcio del
Torino – quella di Valentino Mazzola – si schianta sulla collina di Superga.
Muoiono tutti: giocatori accompagnatori, giornalisti.
14 maggio – Riammessi al lavoro i dipendenti statali ex fascisti.
23 maggio – Nasce la Repubblica Federale tedesca.
14 giugno – A Cortemaggiore, in provincia di Piacenza, viene
scoperto un gigantesco giacimento petrolifero. All’Eni inizia l’era Mattei.
29 agosto – L’Urss annuncia di aver costruito la bomba atomica.
1 ottobre- Mao Tse Tung annuncia la nascita della Repubblica
popolare cinese.
16 ottobre – Finisce la guerra civile in Grecia. I comunisti sono
sconfitti.
6 dicembre – Nasce il quotidiano Paese Sera.
Storia d’Italia, 1950: quando le Madonne piangevano e si
cantava Bandiera rossa. Paolo Guzzanti su Il
Riformista il 20 Agosto 2020. Il 1950 lo ricordo per un fiasco. Un fiasco tutto
di vetro, senza la paglia esterna, perché era di vetro anche quella. Sul collo
del fiasco c’erano in rilievo quattro basiliche. Credo fosse l’anno mariano, o
il giubileo, qualcosa di molto importante. Avevo dieci anni. E fu quell’anno in
cui mia madre e sua madre, mia nonna Amelia dai capelli rossi come i miei (e di
mio padre), mi avvisarono con tono grave e ufficiale che non potevo più essere
considerato un bambino, ma un “fanciullo”. Propri così dissero: fanciullo.
Parola che nel frattempo è morta. Godi fanciullo, stagion lieta è codesta. O i
due fanciulli del Pascoli che se le davano di santa ragione nella pace d’oro
dell’ombroso parco con “parole grandi più di loro”. Era l’anno di tante cose, la
più terribile fu l’inizio della guerra di Corea che tutti percepirono come il
ritorno della Seconda guerra mondiale. Ma colgo l’occasione per dare un’idea di
che mondo fosse, perché ho imparato da anziano che se non ci capisce il
contesto, non si capisce niente. I bambini erano per la metà figli di contadini
con i pidocchi i capelli rasato, le orecchie a sventola e gli occhi bassi per
rispetto verso i signori. Tuttavia nel 1950 ci furono sommosse contadine
in Calabria per l’occupazione delle terre. Voi non avete idea delle sommosse
contadine e per l’occupazione delle terre. I signori calabresi, in genere
baroni, se la godevano a Napoli come intellettuali campando di rendita per gli
sterminati ettari di sterpaglie da cui il contado doveva tirar fuori pane e
companatico per sé e i baroni con villa sopra Posillipo. C’erano i contadini in
rivolta e la polizia che interveniva con le camionette. L’ultima volta
nel Lazio, ero presente qualche anno dopo, quando vidi uno squadrone di
carabinieri a cavallo caricare a sciabola piatta i contadini che avevano
occupato le terre incolte. Non ci scapparono morti, ma era un’altra Italia oggi
estinta. E l’Italia del 1950 era cattolicissima, ateissima, comunistissima,
tutto col superlativo. C’erano molti fascistissimi che si sentivano ancora in
divisa e a scuola i compagni di classe figli di un padre soldato o ufficiale
facevano il saluto al duce e poi si accapigliavano con quelli che cantavano
bandiera rossa. Baffone – Josep Stalin – era ancora il più grande santo di tutte
le icone e mezzo Paese contava sul suo avvento, una specie di santa invasione
come quella di Mehemet Alì che invase Costantinopoli e tagliò la testa a tutti i
cristiani che si erano rifugiati in Santa Sofia. Lo aspettavano a piazza San
Pietro dove i cosacchi avrebbero – sceondo la vulgata più accreditata – fatto
abbeverare i cavalli nelle fontane del colonnato del Bernini. Ancora non si
cantava Bella Ciao, ma solo Bandiera Rossa e L’inno dei lavoratori che diceva:
su fratelli, su compagni, accorrete in fitta schiera, sulla libera bandiera
splende il sol dell’avvenir. C’era una meravigliosa iconografia. La chiesa era
tutta in latino, incenso, e apparivano ovunque le Madonne e tutti si davano la
voce che c’era un a nuova Madonna alle quattro fontane e tutti andavano di notte
coi fari e la vedevano piangere ma poi non risultava sulle fotografie. Mi
capitavano degli arruolamenti per servire messa e seguire il baldacchino
del Santissimo a San Carlo ai Catinari, che è una chiesa con la più grande
collezione di teschi in marmo scolpiti ovunque e dovevi stare attento a dove
mettevi i piedi cantando oremus domine non sum dignus orate fratres ideo precor
beatam Mariam semper virginem e si andava così con un latino pasticcione e
popolaresco che tutti recitavano, anche gli atei e i comunisti perché le
iconografie erano vitali tutte, con enormi falci e martello, i rimasugli
fascisti, le croci e le madonne. A scuola ci sommergevano di versi di Giovani
Pascoli e Giosuè Carducci. Tutto a memoria. Mia madre, seriamente, per il mio
compleanno e pensando di riempire un vuoto nella mia cultura e nella sua
biblioteca, mi regalò in edizione di pelle e oro zecchino, le “Prose” di
Carducci di cui non fregava niente a nessuno, quando invece avevo supplicato di
avere un piccolo canotto gonfiabile per il mare. Non esistevano le pinne e
ancora neppure la maschera col boccaglio, di cui giravano i primi esemplari fra
le scorte dei soldati americani, gomma nera, vetro pesante, tubo di rame e tappo
di sughero chiodato. D’altra parte, nel loro conservatorismo i miei mi mandavano
in giro – unico e solo – con i pantaloni alla zuava (stretti alla caviglia)
perché non avevo ancora l’età adulta del pantalone lungo e nei boyscout chiesero
a lungo perché non fosse ripristinata la mantella blu dei tempi della Prima
guerra mondiale. La mia maestra delle elementari, che ho già citato e che era
una fascistona patriottica rossa anche lei e che fu la maestra anche di Alberto
Ronchey con cui poi ce la litigammo nelle memorie, un giorno venne in classe
tutta impettita, ci disse di aprire i quaderni, salì sulla cattedra e illuminata
dal sole della finestra che dava sul Panteon, annunciò come se avessimo vinto
una guerra: “Oggi le Nazioni Unite hanno affidato all’Italia un mandato speciale
per l’amministrazione dell’ex colonia della Somalia”. Prendemmo nota con la
penna di legno laccato e il pennino cambiabile che si ripuliva con lo straccetto
e si intingeva nel calamaio in un buco del pesantissimo banco di quercia
massiccia. L’anno prima i miei mi avevano portato a visitare Londra, viaggio in
treno, ed ero rimasto sbalordito dal fatto che gli inglesi, che avevano vinto la
guerra contro di noi, erano poverissimi dietro le trincee di sacchetti di
sabbia, le donne guidavano il tram e per colazione ti davano le aringhe che, con
mia sorpresa, trovai adorabili. Da noi si mangiava a quattro palmenti e ci era
andata di lusso. Il bandito Salvatore Giuliano, che aspirava sui lavoratori
a Portella della Ginestra con la mitragliatrice convinto di servire alti poteri
anticomunisti e di potersi far accettare dagli americani, viene fatto fuori
a Castelvetrano dal cognato Gaspare Pisciotta e la sua morte è sceneggiata in
modo da sembrare l’esito di un conflitto a fuoco con i carabinieri.
Cesare Pavese, poeta e scrittore comunista, l’uomo di un Piemonte immerso in
virtuoso silenzio protetto dal mare d’acqua, si uccide con i barbiturici e tutti
si chiedono quanto ci sia di politico e quanto di personal eo di ideologico.
Dall’America arrivava mensilmente la rivista Selezione dal Reader’s Digest, uno
dei più formidabili strumenti di propaganda editoriale che penetra nella società
italiana con storie che costruiscono nei lettori una disposizione nostalgica
verso l’American way of life, così come faranno i fumetti di Disney firmati da
Barker, senza contare il successo mondiale del cartone animato Cenerentola che
riprende la lunga interruzione dal primo cartone a colori “Biancaneve” del 1937
di cui notoriamente era pazzo Adolf Hitler. Dall’America arrivavano i primi
ritmi di un genere di musica evoluta dal boogie-boogie che poi sarà il Rock’n
Roll, ancora in uno stato primitivo, elaborato dalle truppe sui fronti di guerra
europei. La guerra di Corea, che non è ancora stata chiusa, fu un evento
tremendo. Pochi erano persino al corrente dell’esistenza della Corea, così come
più o meno tutti ignorarono l’esistenza della colonia francese del Vietnam che
era già in grande agitazione indipendentista. La Corea era stata tagliata in due
sul 38mo parallelo in attesa di elezioni generali ma il governo Nord, sotto
gestione comunista filocinese, ruppe l’accordo e invase il Sud. Gli Stati Uniti
promossero una coalizione dell’Onu guidata da loro con il leggendario generale
McArthur che fumava una pipa di canna di mais, il quale riconquistò il Nord ma
si trovò contro l’esercito popolare della neonata Cina comunista di Mao Zedong.
Fu una guerra atroce e trermenda che l’America non vinse e nella quale morirono
non meno di due milioni di soldati, prevalentemente cinesi. Il generale
americano chiese il permesso alla Casa Bianca di usare l’atomica e conquistare
Pechino., e fu licenziato in tronco. Nel frattempo, il generalissimo Chang
Kai-shek, battuto dai comunisti, si imbarcò con tutta la sua armata
per Taiwan che conservava il nome coloniale di Formosa, dove costituì una
repubblica cinese anticomunista che ancora esiste e che Pechino o rivendica in
queste ore come parte integrante della Cina. Lo fa sulla base degli accordi
presi con gli americani nel 1978 dopo la rappacificazione avviata dal
presidente Nixon con Mao, per mettere i bastoni fra le ruote dell’Unione
Sovietica. Avevano tutti una paura dannata della bomba atomica e le dispense si
riempivano di scatolette di carne e piselli. In compenso la gente si
appassionava ai grandi processi criminali con le paginate sui giornali
quotidiani. Il primo fu quello a Rina Fort, accusata di aver soppresso la moglie
e i tre figli del suo amante. Un processone in cui furono pronunciate le più
ottuse bestialità sulle donne e che comunque si concluse con un ergastolo per
l’assassina. La guerra fredda conobbe un nuovo giro di vite: gli Stati Uniti
inaugurarono ufficialmente la stagione che prende nome dal senatore Joseph
McCarthy della Virginia, secondo il quale l’intera amministrazione statale è
infiltrata dai comunisti, che agiscono come se fossero veri americani, ma che in
realtà sono la quintessenza del non-americanismo. Bisogna ricordare che in
America esiste l’aggettivo unamerican che non vuol dire antiamericano, ma
semplicemente non americano. Ciò che suona falso come americano. Escono film su
alieni che sembrano perfettamente umani (e americani) ma che hanno un microchip
dietro la nuca che li fa agire secondo gli ordini di un mondo che vuole
conquistare la Terra e che probabilmente ha la sua centrale a Mosca. Comiunciano
i processi contro la maggior parte della gente del cinema e della letteratura,
tutta più o meno di sinistra e che aveva vissuto la Seconda guerra mondiale
anche come una crociata contro il nazifascismo sentendosi legittimamente alleata
con l’Unione Sovietica. Tutti erano stato d’accordo nel deporre un pietoso velo
sulla prima alleanza fra Hitler e Stalin dal settembre del 1939 al giugno del
1941, ma il comune sentire era ancora fortemente incline a vedere nella Russia
sovietica un grande alleato, che stava trasformandosi in un nemico da arginare e
forse da combattere con le armi. Tutti i comics, i réportage giornalistici e una
parte del cinema si dedicarono alle malvagità che emergevano dai numerosi orrori
che accadevano oltre la “Cortina di ferro” fra i paesi “satelliti” e l’Unione
Sovietica. Questa nuova guerra raggiunse rapidamente punte di furore isterico,
simmetrico a quello della controparte filosovietica anche in campi
apparentemente neutrali come l’arte, la letteratura e l’urbanistica. Il nostro
era un Paese cattolico e madonnaro strutturato sulle sezioni territoriali della
Democrazia Cristiana, del partito socialista, di quello comunista, le stazioni
dei carabinieri e le parrocchie, come nei racconti di Don Camillo di Peppino
Guareschi. L’Italia di destra e di sinistra erano riunite in una comune
diffidenza verso gli americani perché era chiarissimo che costoro non portavano
soltanto pancake, popcorn, coccola, dentifrici, caramelle col buco e vitamine.
Gli americani portavano una irresistibile ventata di libertà sessuale, di
franchezza sessuale, sempre più esplicita e totalmente estranea alle tradizioni
di un Paese come l’Italia che in materia di sesso era ancora totalmente bigotto.
La resistenza all’innocente ed esplicito libertinaggio degli americani trovava
un fronte curiosamente unito fra estrema destra ed estrema sinistra in Italia,
dove Fanfani imponeva alle ballerine della Rai di indossare sulle gambe dei
monacali “body” grigi.
Togliatti e i suoi angeli custodi.
Maurizio Caprara su Il Corriere della Sera il 23 agosto 2020. Uno dei rimproveri
era rivolto a Giuseppe Di Vittorio, in quel momento segretario generale della
Cgil, la Confederazione generale italiana del lavoro, già perseguitato dal
regime fascista, incarcerato, confinato e più avanti eletto all’Assemblea
Costituente. Il rilievo mosso nei suoi confronti era: «Il compagno Di Vittorio
abbastanza spesso quando deve intraprendere un viaggio in treno preferirebbe
partire senza accompagnatore, accusandoci perfino di “dilapidare il danaro della
classe operaia” (sic) acquistando biglietti per il compagno che ha l’incarico di
seguirlo. Quando egli parte in macchina, specialmente alla volta di Cerignola,
se i posti sono occupati da familiari egli lascia a terra l’accompagnatore». Il
termine desueto che oggi può far sorridere — accompagnatore — era usato nel 1950
per indicare un militante del Partito comunista addetto alla scorta. Una guardia
del corpo, compagnia della quale avrebbero fatto volentieri a meno anche altri
dirigenti del Pci. Per esempio Gian Carlo Pajetta, che aveva vissuto in carcere
circa tredici anni perché antifascista, e Umberto Terracini, che ne aveva
scontati quasi dodici, inoltre sei di confino e poi aveva presieduto la
Costituente. «Il compagno Pajetta più volte di sera è uscito senza
accompagnatore (...). Spesso il compagno Terracini trova strano che il suo
accompagnatore lo segua a teatro e ci va da solo», veniva riepilogato con
disappunto. Morale ricavata dalle descrizioni: «Una seria vigilanza mai potrà
realizzarsi se i compagni dirigenti considerano i compagni della vigilanza come
“nemici”, o come dei poliziotti ai quali bisogna far perdere le tracce».
La relazione di Antonello Trombadori. Contrassegnata dalla
dicitura «Riservata», la relazione che contiene queste frasi è datata 25 agosto
1950. Riguarda l’incidente di auto che, tre giorni prima, aveva causato al
segretario Palmiro Togliatti un’incrinatura dell’osso frontale e la frattura di
una vertebra. Evento con echi internazionali, l’infortunio del 22 agosto di
settant’anni fa. Non un banale fatto di cronaca sulla statale tra Ivrea e
Pont-Saint-Martin, lungo la quale era finita fuori strada l’Aprilia che portava
verso le vacanze in Valle d’Aosta Togliatti, Nilde Iotti e la figlia adottiva
Marisa. Che un camion, all’improvviso, avesse deviato il percorso dell’auto era
una spiegazione insufficiente per Botteghe Oscure. Quali precauzioni non erano
state adottate? Quali errori intralciavano la protezione dei dirigenti? Ne era
derivata un’inchiesta, della quale il documento che abbiamo
rintracciato nell’archivio del Pci conservato dalla Fondazione Gramsci era
parte. A scrivere le otto cartelle fu Antonello Trombadori, responsabile della
Commissione di Vigilanza. Le indirizzò alla «Segreteria del Partito». Per
coglierne il senso va tenuto presente che due anni prima il Pci aveva due
milioni e 99 mila iscritti, era il più grande partito comunista dell’Occidente e
il 14 luglio 1948 il suo segretario era stato ferito a colpi di pistola da un
attentatore. Il Partito comunista sovietico si era definito «contristato del
fatto che gli amici del compagno Togliatti non siano riusciti a difenderlo dal
vile attacco». Nella ritrosia di alcuni verso l’essere scortati contava il
sospetto che certi accompagnatori raccogliessero informazioni sui dirigenti per
il vicesegretario del Pci Pietro Secchia e per Mosca invece di lavorare per
Trombadori. Analizzato subito da molti, dal ministro dell’Interno all’ambasciata
americana in Italia, l’incidente di auto riproponeva una questione simile. Era
per dimostrare impegno nel garantire l’incolumità del segretario che la
direzione del Pci, dopo l’attentato, aveva istituito la Commissione di
Vigilanza. E la sicurezza mancata all’Aprilia sarebbe stata tra gli argomenti
impiegati da Stalin, a fine 1950, per motivare la sua proposta di mandare
Togliatti a Praga per guidare il Cominform, la struttura erede
dell’Internazionale comunista. Un’offerta respinta dall’interessato. Già
partigiano nei «Gruppi di azione patriottica», tanto colto quanto incline a
romanesco sarcasmo, Trombadori nella relazione ricorse ai toni richiesti dalle
circostanze. Seri. Alla segreteria consigliò: «Quale che sia la versione
ufficiale che si preferisce dare alle cause del sinistro noi dobbiamo, in sede
di lavoro, guardare in faccia alla realtà e riconoscere che soltanto l’elevata
velocità (oltre i cento all’ora) e la sottovalutazione dell’ostacolo potevano
provocare quanto è accaduto». L’incidente veniva addebitato a «inammissibile
leggerezza dell’autista compagno Aldo Zaia». Con un’aggiunta indicativa di
quanto i segretari di partito del tempo fossero potenti eppure non indiscussi,
tuttavia, Trombadori metteva agli atti di aver chiesto in precedenza la
sostituzione di Zaia e che era stata rinviata tra l’altro «perché il compagno
Togliatti non riteneva pienamente giustificata la misura». Nessuno sapeva,
allora, che in ottobre il segretario sarebbe entrato in coma e sarebbe stato
salvato da un’operazione chirurgica al cervello. Tanti testi possono far
conoscere che cosa sono stati i partiti di massa della cosiddetta «Prima
Repubblica», interventi pubblici, resoconti di riunioni e così via. Ma uno
spaccato eloquente è in questa relazione. Nella quale si osservava: «Soltanto
apparentemente il compito di accompagnatore di Togliatti può essere simile a
quello di una sentinella, in realtà quello che conta molto è la capacità che
quest’uomo ha per far vivere insieme senza attriti i due autisti, i guardiani
della casa, ecc, e lo spirito di iniziativa (...)». In altre parole, occorrevano
capacità politiche. Anche per essere «accompagnatori».
Marta Cartabia: «De Gasperi, riparatore di brecce e
restauratore di case in rovina…». su Il Dubbio il 20
agosto 2020. Pubblichiamo una parte della Lectio degasperiana 2020 “Costituzione
e ricostruzione” che la presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia,
ha tenuto a Pieve Tesino lo scorso 18 agosto. Pubblichiamo una parte della
Lectio degasperiana 2020 “Costituzione e ricostruzione” che la presidente della
Corte Costituzionale, Marta Cartabia, ha tenuto a Pieve Tesino lo scorso 18
agosto. «Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per
abitarvi». Questo splendido passo di Isaia (Is 58,12), a me molto caro, ci
introduce al tema scelto con grande lungimiranza dagli organizzatori per la
Lectio degasperiana di quest’anno: «Ricostruzione e Costituzione». La parola
ricostruzione risuona da mesi nella riflessione pubblica ed è risuonata nel
corso di questa estate, specie nelle ultime settimane, in occasione della
cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova, ricostruito, appunto, dopo
la tragedia del crollo di due anni fa. In quella occasione, l’architetto Renzo
Piano, che ha donato il progetto del nuovo ponte, nel suo intervento di saluto,
ha espresso, con parole bellissime, pensieri profondi da cui desidero prendere
le mosse per la nostra riflessione odierna. Anzitutto, ha osservato, la
ricostruzione è sempre figlia di una tragedia, di una frattura che non si
cancella e non si dimentica; una ferita che non si rimargina – come ha
sottolineato il Presidente della Repubblica nella medesima occasione – e diventa
l’essenza stessa di quello che saremo. La ricostruzione incorpora, dunque, un
passato che non si può ripristinare così come era, ma richiede un rinnovamento.
Per ricostruire occorrono un’idea e un cantiere, prosegue l’illustre architetto
e senatore. Un’idea, per dare forma a ciò che non l’ha più. Un cantiere, per
realizzare quell’idea attraverso il lavoro, l’opera instancabile e tenace di una
comunità di persone. 2 Similmente, la ricostruzione dell’Italia dopo la
catastrofe alla fine della Seconda guerra mondiale, ha richiesto un ideale – che
ha la stessa radice etimologica di idea – e un lavoro nato dal coinvolgimento di
un popolo. In quella ricostruzione Alcide De Gasperi svolse un ruolo preminente,
come uomo di pensiero e di azione. Anche allora c’erano tragedie, fratture,
macerie e ferite non rimarginabili; anche allora fu necessaria un’idea per
ridare forma nuova alla convivenza civile di un popolo disorientato; anche
allora fu necessario un grande cantiere per ricostruire su solide fondamenta la
casa comune. Oggi, come allora, – superate le fasi più acute dell’emergenza
innescata dalla pandemia – siamo alle prese con una ricostruzione, avviata
quando si è incominciato a pensare al “dopo”. A un “dopo” che difficilmente
potrà assumere la forma di un semplice ritorno al “prima”, sia pure dopo una
parentesi lunga, dolorosa e straniante, ma pur sempre una parentesi. In questo
frangente, è più che mai fecondo riandare alle fonti della storia. (…).In questa
prospettiva, ricco di spunti di riflessione anche per il nostro oggi è il
percorso di un uomo, qual è Alcide De Gasperi, che ha fatto della ricostruzione
una delle sue principali preoccupazioni e, soprattutto, il metodo della sua
azione politica; un uomo che, non a caso, ha operato da protagonista sulla scena
pubblica proprio in quel decennio della storia d’Italia che viene usualmente
denominato «periodo della ricostruzione» dopo le guerre e il fascismo.
Significativo è che il documento più organico in cui si possono rintracciare le
linee di pensiero e di azione di Alcide De Gasperi rechi il titolo «Idee
ricostruttive della Democrazia Cristiana» del 1943. Egli contribuì alla
ricostruzione con pensiero e azione: idee e cantieri, per riprendere ancora la
felice immagine usata da Renzo Piano. Il contributo di De Gasperi alla
ricostruzione non può essere compreso disgiungendo questi due aspetti, che in
lui furono sempre uniti. Il primo è quello più propriamente di pensiero, che
egli ebbe modo di elaborare in particolare durante il periodo dell’“esilio” in
Vaticano e del lavoro condiviso con gli esponenti del Partito Popolare e con i
giovani che avevano preso a riunirsi dall’inizio del 1940 a casa di Sergio
Paronetto. Qui si era incominciato a ragionare seriamente di ricostruzione. Tra
le personalità che partecipavano a questi incontri, che sarebbero poi scaturiti
nella redazione del Codice di Camaldoli del 1943, vi erano oltre allo stesso De
Gasperi, anche Guido Gonella, Giuseppe Spataro, Mario Scelba, Pasquale Saraceno,
Mario Ferrari Aggradi e infine anche Giulio Andreotti. (…)La sua azione
ricostruttiva, dunque, si muoveva contestualmente su una pluralità di piani e
rispondeva a una «visione integrale» dei bisogni che urgevano. Tutt’altro che
secondaria per lui fu altresì la componente morale e culturale. Il suo imponente
“cantiere ricostruttivo” portò a risultati tangibili, da più parti qualificati
come prodigiosi nella storia d’Italia e d’Europa, perché egli non trascurò mai
il “fattore umano” nella sua integralità, convinto che «più che i programmi
contano gli uomini che sono chiamati ad attuarli». (…)Veniamo più da vicino al
tema della nostra riflessione che è «Ricostruzione e Costituzione»: ed è sul
terreno costituzionale, a me più familiare, che intendo rimanere saldamente
ancorata. È bene però sin da subito sottolineare che per comprendere il
contributo così ricco e articolato, come quello che offrì De Gasperi alla
ricostruzione costituzionale, occorre affrancarsi da una nozione meramente
testualistica di Costituzione per abbracciarne una più ampia e ricca, che
include la prima, ma non si esaurisce in essa. Le costituzioni nascono dalla
storia e vivono nella storia. Il momento della scrittura di una costituzione è
un momento epico nella vita di un popolo; eppure, solo con la scrittura, la
Costituzione non può garantire se stessa. Occorrono soggetti sociali, politici e
istituzionali che siano in grado di conferire alle scelte costituzionali solide
fondamenta e radici robuste, capaci di reggere all’urto delle intemperie. Per
questo rimane attuale l’intuizione fondamentale di Costantino Mortati che ci ha
consegnato una nozione complessa di costituzione, risultante tanto dal testo
scritto – la Costituzione formale – quanto dai rapporti tra le forze sociali e
politiche – la Costituzione materiale. Ed è proprio su questo piano che si può
apprezzare il lascito di De Gasperi. Infatti, chi si basasse solo sul processo
di scrittura della nuova carta costituzionale, cioè si affidasse solo lettura
dei lavori dell’Assemblea costituente, ne trarrebbe l’impressione di una assenza
o di una presenza assai parsimoniosa: fatto salvo un intervento importante al
momento dell’approvazione del futuro articolo 7 della Costituzione sui rapporti
con la Chiesa cattolica, si annoverano altri due brevi interventi, all’inizio e
alla fine dei lavori, e niente più. Se paragonato al contributo degli altri
cattolici eletti in Assemblea costituente – Dossetti, La Pira, Moro, solo per
citare alcuni nomi eminenti – l’apporto diretto di De Gasperi alla scrittura
della carta costituzionale appare assai contenuto. Eppure, non errano quegli
osservatori italiani e stranieri che attribuiscono un ruolo di spicco allo
statista trentino in tutta la fase costituente. In anni recenti, un
autorevolissimo osservatore esterno al dibattito politico italiano non esita a
definire De Gasperi come vero e proprio leader carismatico della svolta
costituzionale italiana dopo la fine della seconda guerra mondiale. Si tratta di
Bruce Ackerman, eminente costituzionalista dell’Università di Yale, che nella
sua più recente opera che indaga sulle origini e sulla legittimazione delle
Costituzioni contemporanee riserva un ampio spazio alla nascita della
Costituzione (…)La sua fu un’opera di “coibentazione” e consolidamento delle
istituzioni repubblicane e della nascente democrazia, attraverso un’azione di
politica interna ed estera che si svolse parallelamente ai lavori dell’Assemblea
costituente, per assicurarne la permanenza al di là del mutare dei governi. De
Gasperi aveva visto in prima persona cadere sotto i colpi del fascismo non solo
il costituzionalismo italiano, ma anche la Costituzione di Weimar del 1919,
avanzatissima nei suoi principi, ma fragilissima nella sua struttura, in cui non
si era riusciti a trasferire al nuovo sistema politico la lealtà degli apparati
del vecchio: un fallimento, quello di Weimar, che spianò la strada al
nazionalsocialismo e all’ascesa di Hitler in Germania. (…)«Il Governo ora, fatta
la Costituzione, ha l’obbligo di attuarla e di farla applicare: ne prendiamo
solenne impegno. Noi tutti però sappiamo, egregi colleghi, che le leggi non sono
applicabili se, accanto alla forza strumentale che è in mano al Governo, non vi
è la coscienza morale praticata nel costume». De Gasperi veniva da lontano e
guardava lontano: per questo vedeva nella stabilizzazione nazionale, europea e
internazionale il necessario complemento all’operazione costituente, che egli
perseguiva con la sua azione di governo, distinta ma parallela ai lavori della
Costituente. Collocato in questo contesto di più ampio respiro, il numero
limitato dei suoi interventi diretti ai lavori dell’Assemblea costituente è,
dunque, un indicatore scarsamente significativo per valutare la reale incidenza
che il pensiero e l’azione di De Gasperi spiegarono sulla configurazione del
nuovo ordine costituzionale. Al contrario, la fase costituente fu segnata
profondamente dalla sua azione. Tra l’altro, egli contribuì con un apporto
decisivo ad alcune fondamentali scelte di metodo che agevolarono la transizione,
permettendo che la Carta costituzionale fosse scritta in tempi relativamente
brevi e soprattutto in un clima pacifico e collaborativo fra tutte le forze
politiche antifasciste, anche nei momenti più critici e di maggior tensione. Si
possono evidenziare tre punti: anzitutto la scelta per la Costituente in luogo
del metodo insurrezionale; in secondo luogo la decisione a favore del referendum
istituzionale; infine, la delimitazione dei poteri dell’assemblea costituente,
escludendo dal suo campo di intervento l’azione di governo e la legislazione
ordinaria. Sul primo fronte, occorre osservare che sin dall’epoca delle
discussioni in sede di CNL si fece fautore dell’idea di una Assemblea
costituente in opposizione all’ipotesi insurrezionale avanzata dai socialisti.
Famose sono le dichiarazioni che egli pronunciò in sede di CNL: «Non temo la
parola rivoluzione, ma ne ho fastidio dopo venti anni che il fascismo,
richiamandosi ai diritti della rivoluzione, ha commesso tante soperchierie e
violato i diritti dei cittadini. Ad ogni modo la vera rivoluzione è la
Costituente». La vera rivoluzione è la Costituente. De Gasperi è lapidario. Le
sue parole lasciano intendere che sullo sfondo si svolgeva una discussione
condizionata dalla dicotomia restaurazione–rivoluzione, come se l’alternativa
che si poneva alla fine del fascismo fosse un aut-aut: o un ritorno al passato,
o un sovvertimento radicale, una palingenesi sociale da imporsi con il metodo
insurrezionale. De Gasperi non si fa intrappolare nell’alternativa tra nostalgie
e utopie. Dal punto di vista metodologico egli prediligeva la strada della
ricostruzione, una terza via alternativa tanto alla mera restaurazione quanto
alla radicalità della rivoluzione. E tale via passava attraverso una
Costituente, democraticamente eletta. Il suo obiettivo era di assicurare alla
nascente democrazia una prospettiva stabile e proiettata a lungo nel futuro, ben
oltre il momento epico della fase costituente, cosa che la rivoluzione non era
in grado di assicurare: «noi siamo preoccupati soprattutto di salvare nel futuro
lo Stato democratico noi desideriamo il metodo permanente della democrazia, che
è l’antirivoluzione». Altrettanto netta è la sua posizione quanto al metodo per
risolvere la questione istituzionale, nella scelta cruciale tra monarchia e
repubblica. Questa alternativa era fortemente lacerante sul piano politico,
lungo vari crinali che dividevano il paese. Per questo, la sua proposta fu
sempre chiara nel voler sottrarre questo compito gravoso all’Assemblea
costituente. Il nodo tra monarchia o repubblica doveva essere sciolto con un
voto diretto da parte del popolo. (…)Il favore di De Gasperi per il referendum
istituzionale era mossa anche dall’obiettivo di evitare che l’ombra della
discussione su un punto così controverso, si proiettasse sui lavori
dell’Assemblea costituente, avvelenandone il clima. (…). Egli non volle mai
caricare l’Assemblea costituente delle funzioni di legislazione ordinaria, che
vennero portate in capo all’esecutivo. Le uniche eccezioni erano costituite
dalla legislazione elettorale e quella di ratifica dei trattati internazionali 9
Ciò si rivelò provvidenziale giacché permise di mantenere il clima di
collaborazione fra tutte le forze politiche all’interno dell’Assemblea
costituente anche nel corso del ’47, quando il viaggio di De Gasperi negli Stati
Uniti portò a un progressivo inasprimento dei rapporti con i comunisti,
culminato, nel maggio del medesimo anno, con la loro esclusione dal governo.
Erano i mesi decisivi per la conclusione del Trattato di pace e, allo stesso
tempo, per il perfezionamento del testo costituzionale. Le tensioni di quel
momento sono impresse nella memoria di tutti per la forza delle parole con cui
prese l’abbrivio il suo famoso discorso a Parigi al Palazzo del Lussemburgo, di
fronte ai delegati delle potenze vincitrici: «Prendendo la parola in questo
consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro
di me. ho il dovere di parlare come italiano; ma sento la responsabilità e il
diritto di parlare anche come democratico antifascista ». A Parigi, come già a
Londra, si trovò in un ambiente di freddezza e di sospetto. Ma parlò con
nobiltà, come rappresentante dell’Italia, ma dell’Italia democratica; come uno
che per la libertà aveva patito. (…)Questi tre interventi – l’Assemblea
costituente, il referendum istituzionale e la distinzione dell’azione di governo
da quella propriamente costituzionale – permisero di «gettare un ponte
sull’abisso» e di giungere al più grande rivolgimento della storia politica
moderna d’Italia nella 10 concordia, mentre altrove furono guerra civile,
terrore e massacri, come egli stesso osservò nel suo discorso all’Assemblea
costituente il 25 giugno 1946. C’è da chiedersi da dove De Gasperi attingesse
una tale chiarezza di giudizio, una tale tenacia nell’azione e una tale
creatività nell’individuazione di soluzioni praticabili e condivisibili, in un
periodo così confuso e convulso, eppure così decisivo, della storia di Italia e
d’Europa. Lascio a chi meglio di me conosce la sua storia personale individuare
le sue risorse più profonde, che forse più adeguatamente possono rispondere a
questo interrogativo. (…) La sua linea politica è orientata alla continua
ricerca del centro, in modo da ricomporre le inevitabili polarità, guardando
anzitutto ai fatti: di qui l’idea di ricostruzione che, come si è detto, non è
restaurazione, ma neppure rivoluzione: «Il ricostruttore non s’indugerà in
discussioni ideologiche alla ricerca dello Stato ideale né, d’altro canto, si
lascerà turbare dai miti di una palingenesi rivoluzionaria», si legge nel
Testamento politico che prosegue, richiamando ironicamente una battuta del
politico belga Félix de Mérode: «Quando ordino un paio di scarpe il calzolaio
prende le misure sul piede mio e non su quello di Apollo». La ricostruzione che
egli propone è un metodo che parte dal dato di realtà, confida nella forza dei
fatti e segue le tracce presenti nella storia così com’è. Tra tante, spicca una
qualità della sua azione politica che, mi pare, derivi proprio dalla sua
caratteristica di uomo di confine, sempre chiamato a camminare su un crinale, a
muovere i suoi passi in ambienti impervi, insidiosi e severi: la qualità è
quella di un realismo lungimirante. Certo, si potrebbe obiettare, c’è un
realismo prigioniero della realtà stessa, che si risolve in un immobilismo, in
pura fatalistica conservazione. Ma non è questo il realismo che caratterizza
l’azione e, oserei dire, la vita di De Gasperi: la traccia che egli ha lasciato
nella storia d’Italia e d’Europa è quella di un rinnovamento che pesca
nell’esistente e ha un respiro di lungo periodo. La sua è una politica che pone
le basi di alcuni orientamenti di fondo, alcuni dei quali si realizzano subito e
altri matureranno nel tempo. Il suo è un realismo lungimirante, perché animato
da grandi ideali, «impregnato di idealità», come ebbe già a scrivere nel 1922 su
«Il Nuovo Trentino»; un realismo che lo accomuna ai fondatori dell’unificazione
europea espresso nella famosissima dichiarazione del 1950 di Robert Schuman,
anch’egli significativamente, uomo di confine. (…).In una lettera del 7 luglio
1928, scritta dal carcere mentre la sua famiglia si trovava in montagna per il
periodo estivo, De Gasperi scrive: «Anche io sto preparandomi per una scalata di
roccia sai dove sto esercitandomi? Nelle Malebolge dell’inferno dantesco, con
Virgilio che dirige la scalata, senza corda e senza piccozza (per il pericolo
del fulmine). Ma intanto (prosegue la lettera, introducendo una splendida
citazione dantesca): Così, levando me su ver la cima D’un ronchione, avvisava
un’altra scheggia, Dicendo: Sopra quella poi t’aggrappa; ma tenta pria s’è tal
ch’ella ti reggia. Non era via da vestito di cappa». 13 Il metodo di De Gasperi
è tutto qui. Il cammino sicuro del montanaro, dal passo fermo che arriva senza
dubbio alla vetta: «uno stile di concretezza, di rigore, di realismo, animato da
una grande tensione ideale: è De Gasperi», come ricordava Pietro Scoppola
qualche anno fa in questa medesima occasione, nella prima Lectio del 2004. Non è
l’assenza delle avversità a permettere la ricostruzione e la rinascita, ma il
saper discernere una strada percorribile che le attraversa e le supera, di un
superamento che innova, di un’innovazione che non rinnega il passato, che non si
arresta mai neppure di fronte a un ponte crollato, come nelle Malebolge
dantesche: levando me su in ver la cima. Una via percorribile, indicata da una
guida sicura; percorribile per quanto scomoda e impervia – non era via da
vestito di cappa – erta, esposta e disagevole, lungo la quale il ruolo di chi
conduce sta tutto nell’avvistare, passo dopo passo, un appiglio – avvisava
un’altra scheggia – per potersi aggrappare e procedere nell’ascesa. E come
l’alpinista sa bene, occorre sempre verificare che l’appiglio sia tal ch’ella ti
reggia, che sia in grado di sostenerti, pena la rovina. Questo splendido passo
della Commedia che egli regala alla moglie in uno dei momenti più bui della sua
esistenza racchiude tutta la sua personalità e il segreto del suo “carisma”: un
uomo con i piedi saldamente ancorati a terra e con lo sguardo rivolto in alto e
lontano.
Storia d’Italia, 1951: quando dalla radio uscì fuori il mondo.
Paolo Guzzanti su Il Riformista il 27 Agosto 2020.
Nella scuola Emanuele Gianturco, al lato del Pantheon, erano venuti quella
mattina gli ispettori speciali del ministero. Perché era un evento speciale di
cui non capivamo niente ma ci faceva ridere perché l’evento era la Ceca, sigla
che stava per Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e potete immaginare
degli scolari piegati sul foglio a scrivere pensieri dementi sulla Ceca. Ma ci
inflissero un preambolotto teorico con cui trasmetterci lo spirito
di Ventotene di cui non sapevamo nulla, ma capimmo che si trattava di grande
evento perché per la prima volta i Paesi europei invece di prendersi a cannonate
si mettevano insieme per produrre carbone e acciaio. «Questo – ci disse
l’austera signora del Ministero – è solo il primo passo di una cosa molto più
grande che un giorno si farà e si chiamerà Europa». Ma non si chiama già Europa?
chiese uno. «Sarà l’Europa unita, senza più guerre e un giorno si chiamerà gli
Stati Uniti d’Europa». Bella idea e scrivemmo colonne e colonne di fogli
protocollo riempiti di ridondanti ed enfatiche banalità. Però era successo
qualcosa. Poi, c’era sempre questa guerra di Corea che adesso sembrava sotto
casa. Era peggio della Prima guerra mondiale, dicevano, perché milioni di
soldati si sparavano nelle trincee scavate nella neve ed era tutto sangue, urla
dei feriti e morte. E cinesi, si diceva, che arrivavano a ondate. Non come
uomini singoli, ma come masse liquide prive di individui distinguibili. Tutti
uguali, i cinesi. E più le forze dell’Onu sparavano, più quelli tornavano. Era
una guerra di cui arrivavano notizie militari e minacce pesanti alla nostra vita
privata. La guerra che avevamo vissuto era finita solo da sei anni, e adesso
parlavano di una nuova generazione di bombe atomiche che potevano far sparire un
continente. Il tasso di rancore nella guerra fredda saliva in casa e nelle
strade. Avevo undici anni ma ricordo perfettamente quanto quella guerra fosse
globale. E poi la radio. La radio era tutto. Si aspettava quel segnale
dell’uccellino della radio che preparava – un fischietto meccanico come un
telegrafo che scandiva il tempo – all’ora esatta cui seguiva immediatamente la
voce di uno speaker che si annunciava dicendo: «Giornale Radio». Non era un
giornalista, uno di passaggio. Era come la voce della Bbc in Inghilterra. Era
una voce solo maschile, grave, profonda, dall’ortoepia – cioè la pronuncia –
corretta al punto tale che nessuna parlata regionale, neanche toscana, poteva
eguagliarla per perfezione. Il Giornale Radio era pieno di ministri e di
dichiarazioni, compilato sulle agenzie di stampa governative con pochissime
interviste a personalità ufficiali, campioni sportivi o attori. Il trionfo della
radio fu a novembre di quell’anno. Il 14 novembre il Po andò fuori dagli argini
e sommerse il Polesine. Nessuno aveva memoria di una sciagura talmente grande,
per di più vissuta in diretta, ventiquattro ore al giorno, comprensibile a
tutti: fu la prima catastrofe naturale globalizzata d’Italia. Era l’Italia in
cui la gente viveva attaccata alla terra come gli insetti e nella provincia di
Rovigo fu un disastro perché quasi duecentomila persone furono cacciate di casa
dalle acque e ci furono più di cento morti e parlavano tutti, il papa e i
ministri i leader politici e si facevano sottoscrizioni che venivano annunciate
alla radio vaglia per vaglia, lira per lira. Oggi siamo abituati alla
televisione e a quel che succede con i terremoti, altre sottoscrizioni e
racconti penosi. Ma la radio era una scatola di legno color noce o radica con un
vetro su cui si leggevano i nomi di tutti i paesi e le città del mondo fra cui
cercarti la stazione fra gli scrosci statici e sibili. Quando arrivò in casa una
radio monumentale potentissima in cui bastava premere un tasto per avere
la Rai o il grammofono incorporato, era qualcosa come Wi-Fi moltiplicato Netflix
e potevi girovagare fra lingue mai sentite. Inoltre, la radio forniva
sceneggiati fantastici pieni di cigolii sinistri, urla dal pozzo della
vertigine, tutto il mondo di Edgar Allan Poe in particolare e le voci di comici
surreali come il misterioso Alberto Sordi che ancora non aveva un volto. I gatti
erano più frequenti dei cani negli appartamenti infestati dai topi e il nostro
ne ha avuti almeno tre, tutti amatissimi. Questa faccenda della guerra alle
porte era molto angosciosa. Gli Stati Uniti stavano preparando una bomba più
potente di quella di Hiroshima che sarebbe stata all’idrogeno e anche i
sovietici erano al lavoro fervente con i loro ordigni. In Italia le carriere
degli iscritti al Pci e al Psi erano molto ostacolate, per non dire boicottate.
Cresceva lo spionaggio e questo era un fenomeno comune all’Est e all’Ovest. La
gente di destra o comunque anticomunista era sicura che da un momento all’altro
arrivassero i cosacchi di Stalin per abbeverarsi nelle fontane di piazza San
Pietro e permaneva nell’aria una vaga ipotesi insurrezionale. Togliatti e i
dirigenti del Partito comunista scoraggiavano le fantasie di presa del potere
con le famose armi nascoste e ben oliate (a intervalli regolari polizia o
carabinieri trovavano qualche deposito di mitra Sten e qualche bomba) e una
quantità di bambini saltava in aria sulle bombe inesplose della guerra. Era un
bollettino quotidiano terribile di mutilazioni e morti. C’era grande fermento
nell’agricoltura e in Parlamento era finalmente passata una riforma agraria
molto più moderata di quanto avesse voluto la Cgil, ma comunque era davvero
cominciata la fine del feudalesimo. Nel senso proprio: era stato deciso per
legge che i retaggi feudali andassero rimossi, il che significava che da una
parte cresceva una classe di ex servi della gleba che dicevano sissignore e
mandavano i guadagni al padrone, dall’altra era l’inizio della fine di questa
classe parassitaria e felice dei grandi proprietari agrari che delle loro terre
se ne erano sempre fregati con un’entrata comunque garantita senza far niente.
Sempre meno, ma erano comunque troppi. Stava cambiando proprio la composizione
della materia italiana: la metà che era ancora terrosa e largamente analfabeta
insieme alla borghesia più giovane che non vedeva ancora le prospettive che si
sarebbero aperte con la grande ricostruzione, aveva già cominciato ad emigrare
non solo negli Stati Uniti, ma nell’Argentina di Perón e dei suoi descamisados,
particolarmente amati anche dai nostalgici fascisti e dai fuggiaschi del Terzo
Reich tedesco. Anche il Brasile si riempiva di italiani, come l’Australia e- in
Europa – la Francia dei rital (come venivano spregiatamente chiamati gli
emigrati dal Paese che era stato loro nemico er poi occupante durante la guerra)
e poi in Belgio, nel buio delle miniere e delle stragi nelle gallerie. Non era
ancora l’Italia della Seicento e dell’Autostrada del Sole e tutte le aziende del
nord cercavano di convertirsi nel tessile e proprio nel Polesine e nel Veneto,
le donne e i bambini lavoravano giorno e notte intorno alla macchine da cucire
per confezionare calze che poi i loro uomini con la valigia di cartone andranno
a vendere in treno oltre le frontiere. Era arrivata la penna biro, o a sfera.
Quella classica che gira ancora oggi di plastica trasparente con dentro la
cannula con la sfera rotante. Fu una rivoluzione millenaria: non più inchiostro,
non più macchie e per qualche tempo la scuola resistette all’ “americanata”
della penna che poi si butta e c’era questa resistenza visibile verso il nuovo e
il moderno. Le donne seguivano la moda sulle riviste della moda che puntavano
tutte sulla moda elegante e sul bon ton, mentre dall’America arrivava una
ventata di femminismo pratico: la donna come è, come vorrebbe essere, seducente
e pratica. Il New Look veniva dalla Francia di Christian Dior e gli stilisti
italiani, benché in erba, erano già determinati a competere e si gettavano in
una mischia che avrebbe prodotto dall’anno successivo Palazzo Pitti. La moda era
un’arte totalmente rinnovata che già aveva la forza di fare da volano per un
mondo da inventare, o meglio di un mercato che già esisteva ma che non sapeva
bene che cosa desiderare. Dai miei appunti di ragazzino romano vedo i
pianerottoli delle case perbene carichi di materiali imprevisti: motori per
auto, gomme per autotreni, scatole di medicinali. Erano arrivati gli
antibiotici, già si moriva di meno con la penicillina che certamente a me aveva
salvato la pelle almeno due volte. Ma ricordo una borghesia appena uscita dalle
botte che cercava di fare affari, comprava e vendeva, modificava, viaggiava e –
con grandissimo scandalo di mia madre che pure era una giovane bella donna –
faceva sesso. La Chiesa era occhiutissima, le organizzazioni cattoliche erano
fortemente sessuofobiche e quando maschi e femmine imboccavano la via dello
sviluppo e dell’adolescenza, una rete di precauzioni era già pronta ad
accoglierli separandoli per genere e spingendoli nel migliore dei casi a fare
sport. Sport come antidoto del peccato. I giovani non facevano molto sesso.
C’erano i casini ma non credo che fossero usati da una grande popolazione.
C’erano amanti e mantenute (vari gradi della degradazione femminile) ma le
ragazze avevano una paura fottuta. Portavano imbragature di reggicalze, calze,
gancetti da spezzarti le unghie e poi erano terrorizzate da tutto: gravidanza,
deflorazione, genitori, persino i fratelli e la sessualità era una faccenda del
tutto sotterranea e leggendaria, se non catacombale. Il massimo che poteva
accadere – con le dovute precauzioni – era il bacio o pomiciare (a Roma) o
limonare ma si favoleggiava del petting (mani addosso per arpeggi improvvisati
(i maschi avevano delle femmine una conoscenza pari a zero, non giravano foto
anatomiche, la pubblicazione dei seni era vietata e si andava in galera,
bisognerà arrivare ad un’esplosione non meditata di Cesare Zavattini vent’anni
più tardi quando di colpo disse “cazzo” alla radio e l’evento fu festeggiato
come se fosse comparsa la madonna. Ma le parolacce erano per solo uso maschile e
le femmine concedevano poca promiscuità e sempre sul filo dell’infarto. Le donne
erano uscite dal tunnel della moglie fascista cittadina o massaia o mungitrice e
un anno prima del disastro del Polesine dalle risaie erano già uscite le gambe
di Silvana Mangano e grandi fantasie erotiche sulle mondine di Riso Amaro di De
Santis. Erano uscite fuori le gambe e la donna che lavora e che, essendo sola e
bella e immersa nella melma, sa trattare alla pari gli uomini esattamente come
nella letteratura afroamericana facevano le donne nelle piantagioni: “Sciùr
parùn dalle belle braghe bianche, dame le palanche che andemo a ca’” era una
canzone sia del lavoro che dell’indipendenza femminile e tutto ciò arrivava a
sferzate, non faceva parte del mondo di prima, non faceva parte del mondo delle
ginnaste, delle Giovani italiane e degli stereotipi, come invece succedeva – e i
giornali ne erano pieni – nel mondo sovietico, dove le lavoratrici e i
lavoratori somigliavano nel realismo socialista ai quadri italiani (e fascisti)
di Sironi, in cui il corpo dei maschi e delle femmine appariva interamente
dedicato alla costruzione della società ideale. Un’Italia che aveva voglia di
divertirsi. Repressa, tante cerimonie religiose che non potete neanche
immaginare, mesi mariani e novene, processioni e confessioni, per non dire del
puritanesimo del Partito comunista in diretta concorrenza con quello
democristiano. Lì, i socialisti cominciarono un po’ a fare razza a parte: aria
libertaria, anche un po’ sporcacciona, parlavano sfrontatamente di
contraccettivi, di aborto e amore libero anche per smarcarsi dai comunisti che
già allora si ispiravano più a santa Maria Goretti che a Sophia Loren che aveva
diciassette anni e si dava da fare con particine gloriose che di lì a poco
l’avrebbero portata al contratto con la Paramount.
Storia d’Italia, 1952: quando Scelba bloccò la ricostituzione
del partito fascista. Paolo Guzzanti de Il Riformista
il 2 Settembre 2020. Per me (ma sono fatti miei, e però fatti che ancora mi
segnano) il 1952 fu un anno terribile perché morì in casa la mia amata nonna
Amelia, rossa come me, vedova di un giornalista assassinato, una combattente di
ferro che amavo in modo incontenibile. Quando fu chiaro che stava morendo di
cancro ai polmoni, lei che non aveva mai fumato, io lavorai con martelli e seghe
per crearle un letto confortevole, con molti cuscini, posizioni, basi per
bicchieri, e un bicchiere da usare come campana da far tintinnare. Poi,
approssimandosi la sua morte non ebbi più la forza di guardarla e l’abbandonai.
In un ultimo sospiro mi disse “Da te non me lo sarei mai aspettato” e io fuggii
a Villa Borghese dove capitanavo una banda di ragazzini in guerra con altri
ragazzini e il giorno della sua morte, quando tutte le rondini di Roma si
levarono in un urlo nel momento finale, io rimasi stordito e non mi accorsi che
la banda di Nasone aveva preparato un’imboscata dietro le palme dell’Orologio ad
acqua, così persi la guerra e tornai a casa dove avevano spruzzato del
cloroformio per preservare il cadavere di Amelia finché non la impacchettarono e
portarono via. Tutto ciò è davvero personalissimo e non interessante, ma ognuno
ha le sue giornate e i suoi anniversari, accadde sessantotto anni fa. Amelia,
dopo la morte seguitò per qualche tempo a far tintinnare il suo bicchiere
costringendomi a correre al suo letto smontato e apprezzai i suoi segnali,
benché non creda a queste cose: in famiglia si decise tacitamente di non farne
mai menzione per nessun motivo. Era dunque il 1952 e due furono i fatti oltre i
fatti: una ragazzina adorabile diventò regina d’Inghilterra e la televisione
cominciò a trasmettere il Telegiornale col mappamondo e una sigla che faceva
parapappà-parapapà. Se non l’avete mai vista com’era, andate sui documentari per
rendervi conto com’era fatta la ragazzina Elisabetta, a cui volavano le vesti
come a Marylin, con la sorella Margaret, mentre fanno impazzire i marinai sulla
tolda della nave da guerra che nel 1946 aveva portato la famiglia reale al lungo
viaggio di ringraziamento in Africa. Questo ringraziamento dei reali era per
tutto l’impero che aveva combattuto con tutti i colori della pelle e dei
costumi, delle uniformi e i turbanti, i costumi e le insegne, nella Seconda
guerra mondiale. Oggi non ne abbiamo più memoria: guardiamo l’Inghilterra e
pensiamo alla Brexit, a Boris Johnson che si becca il Covid come Briatore e ai
ragazzi nei pub. Ma, sapete, c’era una volta un impero. Lo dico perché lo
ricordo: prendete un mappamondo e provare a immaginare che cosa fosse l’impero
britannico che Churchill pronunciava – come ogni buon conservatore – “thi
Empaaahh”. L’impero andava dal Canada ai Caraibi, dall’Egitto al Sud Africa,
all’India col Pakistan, dall’Australia alla Nuova Zelanda, quelle terre che oggi
fanno parte dei “Fine Eyes” i cinque occhi, che comprendono gli Stati Uniti, ma
non il Sudafrica. Re Giorgio, il vecchio Bernie che aveva sempre balbettato
(“The King’s Speech”, se ricordate il film) e che era stato costretto a fare il
re al posto del fratello amato dalle folle, che volle sposare la divorziata
americana Wally Simpson e che poi andò a fare la corte ad Hitler a Berlino,
tanto che Hitler contava di rimetterlo un giorno di nuovo sul trono. Elizabeth
era una ragazzina ciclista e volenterosa e si era innamorata di quello strafico
greco che è il principe Filippo (per accudire il quale ha deciso di non
esercitare quasi più i suoi uffici regali) sul quale gravava però l’ipoteca
del Duca di Mountbatten, il king maker che finì sbriciolato sulla sua barca da
una bomba islandese negli anni Settanta. Quando il re morì, Elisabetta viveva
felice a Malta con suo marito Filippo, di cui era pazza, e lui faceva la
carriera militare nella Royal Navy. La morte del padre era prematura e fece
saltare tutti i piani: Filippo dovette lasciare la carriera e trasformarsi in
una specie di cameriere consorte; lei smise di correre in bicicletta o guidare
da scavezzacollo la sua jeep a Malta e tornò a fare la regina di una Piccola
Bretagna che non era più l’impero più grande del mondo. Era successo
all’Inghilterra qualcosa di simile a quel che era accaduto con la Prima guerra
mondiale all’Austria, che da grande impero centrale fu ridotta a quella piccola
nazione che è ancora oggi. Il mondo cambiava radicalmente. Comandavano ormai
soltanto Stati Uniti e Urss: Churchill sapeva bene che quello era il prezzo
richiesto dagli americani per pagare la salvezza della Gran Bretagna assediata
da Hitler: noi vi salveremo, ma voi lascerete l’impero perché noi americani non
ammettiamo imperi. Si potrà dire naturalmente che gli americani hanno il loro
impero, ma mai tecnicamente: dalla guerra con la Spagna all’inizio del Novecento
avevano trattenuto come colonia le Filippine fino alla fine della Seconda guerra
mondiale, ma decisero che dovevano a quel popolo la libertà senza condizioni,
anche per ricompensare il contributo filippino alla guerra contro i giapponesi.
La Francia stava cominciando a perdere i suoi pezzi in Estremo Oriente, cioè nel
Sud Est asiatico, le antiche colone del Tonchino del Vietnam,
Cambogia e Laos con le loro città edificate imitando Parigi. I rivoluzionari
comunisti che avevano combattuto contro i giapponesi avevano studiato tutti
alla Sorbonne a Parigi, erano degli intellò cresciuti sotto la protezione del
partito comunista francese e la Francia stava per andare incontro alla disfatta
militare di Diem Bien-Phu. Il mondo stava cambiando molto radicalmente: non più
imperi, re e regine (salvo Elizabeth), molta guerriglia nelle colonie dei Paesi
europei che ne avevano ancora, come il Congo belga e le colonie britanniche,
stava cominciando quella separazione del mondo fra americani, russi e
terzomondisti. E da noi? La televisione. Ne avrete letto tanto e visto e molti
di voi c’erano. Ma ricordate che cos’era un televisore? Un marziano tondeggiante
in mezzo al salotto con tutte righine dentro che si distorcevano e potevate
passare ore a regolare quelle righine lungo tutta la scala dei grigi. Poi, il
telegiornale. C’era il martedì pomeriggio un telefilm western per i ragazzi.
Qualche cartone animato, non voglio fare la storia della televisione, ma
ricordare un’emozione. Io mi emoziono facilmente: dopo l’arrivo del colore non
riuscii per anni a separarmi dallo stupore per il fatto che le immagini fossero
a colori. E ricordo benissimo proprio l’incoronazione di Elisabetta seconda in
diretta, in Mondovisione, una visione tutta distorta, da far schifo, ma era una
diretta. Intanto il vecchio Winnie, Winston Churchill, era tornato ad essere
primo ministro e annunciò con tono distratto che il suo Paese stava preparando
la bomba all’idrogeno. Non se ne poteva fare a meno: russi e americani si erano
già portato avanti, i francesi seguivano. Noi italiani non eravamo nessuno.
Ancora ci odiavano per il fascismo e anche per aver cambiato fronte quando i
tedeschi erano ormai sconfitti. Proprio nel 1952 l’Unione Sovietica mise il veto
al nostro ingresso all’Onu, così come fece con il Giappone. Non ci volevano. Ma
fummo arruolati nella comunità della difesa europea, cioè l’embrione poi
abortito di un esercito europeo che non si è mai fatto e che avrebbe dovuto
essere sottoposto al comando anglo-francese. Accadevano fatti dall’esito ignoto:
un oscuro generale cubano, Fulgencio Batista, fece un colpo di Stato all’Avana
per conto dei grandi casinò americani e prese il potere. I fratelli Castro e
altri futuri ribelli studiavano dai gesuiti, In Italia Mario Scelba, il ministro
degli interni di ferro, l’anticomunista intransigente (che io conobbi e
intervistai sul letto di morte molti anni dopo) decise di varare una legge che
mettesse al bando i fascisti vietando la ricostituzione del partito fascista
sotto qualsiasi forma. I fascisti dichiarati a quell’epoca erano milioni, per
non dire dei monarchici che conquistavano il municipio di Napoli con il
sindaco Achille Lauro, di cui si dice che regalasse una scarpa prima e una dopo
il voto ai suoi elettori. Ma ricordo perfettamente questa Napoli del 1952
imbandierata con le croci Savoia, il nodo Savoia e tutti quei principi, duchi, e
popolani monarchici. E poi, appunto, i fascisti che si organizzavano,
celebravano, marciavano e menavano. Gli studenti fascisti passavano a vie di
fatto – cioè menavano a pugni e con bastoni – nelle scuole e nelle università.
La polizia picchiava e manganellava. Gli inglesi, persino, che amministravano
una parte di Trieste, caricavano selvaggiamente i triestini che quell’anno
manifestavano per il ritorno all’Italia sulle note di “Trieste mia” e “Vola
colomba”, canzoni patriottiche da Sanremo, di un nazionalismo timido. Fu persino
necessario bloccare il fondatore del Partito Popolare, don Luigi Sturzo, perché
voleva formare alleanze con i neofascisti: Alcide De Gasperi e Giulio
Andreotti (suo numero due) si opposero e l’Italia cominciò a prendere una forma
più definita: l’anticomunismo non impediva un radicale antifascismo, anche se
cresceva la violenza sia verbale che fisica nella vita quotidiana. Agli
americani però importava soltanto l’atteggiamento di chiusura e ostilità nei
confronti dei comunisti e il Sifar, il nostro servizio segreto al centro di una
serie di scandali futuri, seguiva le direttive americane per un maccartismo
sempre più energico contro tutti i comunisti e anche i socialisti loro alleati.
Lo stesso accadeva in Francia dove il Pcf, riemerso dalle ceneri della vergogna
per aver appoggiato con trepidante entusiasmo l’alleanza militare
fra Urss e Germania dal settembre 1939 al giugno del 1941, era diventato una
forza politica potente e totalmente allineata sulle posizioni sovietiche, molto
di più di quanto non lo fosse il partito comunista italiano di Palmiro
Togliatti, che trovava sempre un modo sottile per evitare giudizi negativi
su Stalin. La Francia, inoltre, era ogni giorno di più un obiettivo sensibile
per le sue colonie, non soltanto in estremo oriente, ma specialmente in Nord
Africa e in Algeria, dove si profilava uno scontro titanico prima della
inevitabile rinuncia all’impero coloniale (benché ancora oggi la Francia sia un
Paese europeo con colonie). Una visita del generale
americano Ridgway a Parigi provocò moti di piazza repressi nel sangue, con
scioperi generali e scontri. Era la guerra fredda nella sua versione quasi calda
che provocava fiammate nel momento e nei luoghi più diversi. La Repubblica
Democratica tedesca, cioè la Germania Orientale comunista, si fece il suo
esercito integrato con quello sovietico, diventando la forza armata più temibile
del nascente Patto di Varsavia, ancora non ufficiale, ma che sarà l’alleanza
anti-Nato dell’Europa sotto controllo sovietico. Il mondo si spacca sempre di
più, si contrappone, la caccia è aperta nei paesi delle ex colonie e ovunque si
combattono guerra non dichiarate, insurrezioni popolari non tutte spontanee e
gli eserciti occidentali costruiscono reparti antiguerriglia da usare in Africa,
Asia e America Latina. Ma il colpo più potente lo sferra Mosca, sostenendo il
colpo di Stato in Egitto di quattro ufficiali, fra cui l’astro
nascente Nasser, che nazionalizzerà il canale di Suez e l’ingegnere
egiziano Yasser Arafat, che fonda il nucleo dirigente del futuro fronte della
liberazione della Palestina. Israele nel frattempo crea il più sofisticato e
moderno servizio segreto del mondo, con regole e compiti che non condivide con
altri. Il Mossad inizia la sua vita operativa dando la caccia nel mondo a tutti
i gerarchi nazisti che l’hanno fatta franca. Gli Stati Uniti, dopo Harry
Truman, eleggono il vecchio e saggio generale Dwight Eisenhower come presidente
degli Stati Uniti, cioè colui che ha guidato gli eserciti alleati alla vittoria
contro i nazisti. Una volta alla Casa Bianca, Eisenhower diventa un presidente
bipartisan, non ossessionato dall’anticomunismo maccartista, ma piuttosto dai
rischi di un eccessivo potere dell’apparato industriale-militare nato dalla
concorrenza tecnologica con l’Urss nella guerra fredda. Il mondo sa di essere in
bilico fra due blocchi, anzi tre. Nulla è certo, ma tutto è molto scuro e
soverchiante. L’esistenzialismo come atteggiamento filosofico si sparge
dalla Francia all’Europa e all’Italia, fino a sfiorare New York. Le canzoni
esprimono venature angosciose e l’amore è ancora contaminato dall’idea di
morte. Charles Aznavour canta “L’amour et la guerre” e i teatri si affollano per
le commedie del nonsenso. Anche l’umorismo appare enigmatico o simbolico, come
quello del rarefatto Renato Rascel.
25 gennaio – L’Unione sovietica, insieme ad altri quattordici
paesi, pose il veto all’ingresso dell’Italia fra i paesi membri dell’Onu. Il
nostro Paese entrò poi il 14 dicembre del 1955.
6 febbraio – A soli venticinque anni Elisabetta II diventa regina
del Regno Unito e succede al padre re Giorgio VI. La sovrana è da allora alla
guida della Gran Bretagna, al quarto posto nella classifica dei regni più lunghi
della storia.
10 marzo – L’Esercito Nazionale di Cuba, guidato dal generale
Fulgencio Batista, mise in atto un vero e proprio colpo di stato, stabilendo una
dittatura militare nel paese.
24 aprile – Alcide de Gasperi e Giulio Andreotti impedirono a don
Luigi Luigi Sturzo, in occasione delle elezioni amministrative, di formare liste
civiche con il Movimento Sociale Italiano e monarchici in funzione
anticomunista.
27 maggio – Italia, Francia, Germania Ovest, Paesi Bassi, Belgio
e Lussemburgo aderiscono al trattato Ced (Comunità Europea di Difesa)
condividendo un unico esercito, la Forza Atlantica.
16 giugno – Il generale statunitense Matter Bunker Ridgway è in
visita a Parigi e nella capitale francese: si verificano scontri molto violenti
fra manifestanti e forze dell’ordine.
23 luglio – Entra in vigore il trattato istitutivo della Comunità
Europea del Carbone e dell’Acciaio, la Ceca.
A cura di Chiara Viti
Storia d’Italia, 1953: lo Stivale spaccato da guerre di
religione. Paolo Guzzanti su Il Riformista il 10
Settembre 2020. Avevo dodici anni e, mentre camminavo verso il Senato, gli
strilloni dei giornali (esistevamo gli strilloni che vendevano le copie sul
braccio) gridarono: «È morto Stalin! È morto Baffone! I comunisti di tutto il
mondo in lutto!». Era vero: era proprio morto Stalin. Non che lo conoscessi
molto, ma da anni si parlava sempre soltanto di lui, che ci guardava dai
manifesti. Ora descritto come belva, ora il buon vecchio Uncle Joe, come lo
chiamavano gli americani, ma anche l’uomo nelle cui fauci milioni di persone
erano sparite. Era ancora un’Italia da guerre di religione e la religione era un
tema politico perché il Papa Pio XII era un anticomunista militante e proprio in
quell’anno dagli Usa mandarono a Roma come ambasciatrice Clara Boothe Luce, una
anticomunista ossessiva, sicura che i russi avessero avvelenato gli affreschi
della sua camera da letto per ucciderla. Clara pretendeva di impartire al Papa
lezioni di anticomunismo ed Eugenio Pacelli un giorno esplose: «Signora, le
disse: la prego di credere: sono cattolico anch’io». Per fortuna, in quel 1953
si chiuse la sanguinosissima guerra di Corea con armistizio al 38mo parallelo,
ancor oggi il confine che Trump ha varcato per stringere la mano al grasso
ragazzo che «sparava razzi». Gli americani avevano avuto un altro bagno di
sangue, più simile a quello della Prima guerra mondiale delle trincee che a
quello della seconda. La Cina aveva perso quasi due milioni di soldati
in Corea, mentre intanto il generalissimo Chiang Kai-shek (che con Mao aveva
combattuto contro i giapponesi prima della resa dei conti) si era ritirato
nell’isola di Taiwan con tutta la sua armata sconfitta. Chiang ricevette dagli
americani armi sufficienti per una lunga resistenza e quella resistenza dura
fino ad oggi, mentre si addensano su quell’isola e quei mari nuovi venti di
guerra nel Mare del Sud della Cina e nello stretto di Formosa dove si sono
radunate la flotta americana, quella australiana, l’indiana, la giapponese e
perfino la Vietnamita, perché il Vietnam di oggi – scherzi della Storia – è
alleato militarmente degli americani contro i cinesi. Il mondo del 1953 lasciò
uova di serpente che ancora devono schiudersi. Intanto a Taiwan hanno varato una
democrazia pacifista ecologica che attragga gli ecologisti in un fronte
anticinese, mentre la Cina cerca di arrestare l’emorragia delle aziende
come Samsung e Apple che fuggono dal suo territorio, provocando disoccupazione.
Sempre nel 1953 a Bruxelles i sette nani della finanza e dell’industria cercano
di trasformare la Comunità del carbone e dell’acciaio in un embrione di Europa.
L’idea era caldeggiata dagli americani per un solo motivo: bisognava impedire
che per la terza volta dopo il 1870, il 1914 e il 1939 il mondo finisse
nell’apocalisse per la faida infinita tra Francia e Germania. Certo,
il Manifesto di Ventotene con Altiero Spinelli e i padri fondatori, contava. Ma
alla base della concreta idea d’Europa c’era il desiderio di riconoscere alla
Germania la supremazia industriale purché rinunciasse ad avere un peso militare:
le veniva assegnato solo il minimo sindacale per stare nella Nato, ma la sua
fortuna sarebbe consistita nel rinunciare ai carri armati per produrre Mercedes
e Audi, lasciando agli Usa il compito e la spesa della sicurezza, posizione che
oggi Trump ricusa, tirandosi indietro dagli impegni del secolo scorso. Ci fu un
grandioso e appassionante delitto nel 1953: il primo dei grandi delitti italiani
e che passò alla storia come “caso Montesi”. Ne parlai con Gabriel Garcia
Marquez, dopo aver scoperto che il grande scrittore era stato all’epoca inviato
a Roma da Bogotà e aveva scritto tutto sul caso Montesi. Il caso consisteva nel
ritrovamento del cadavere di una povera ragazza, Wilma Montesi, nuda e morta
sulla riva del mare a Torvaianica. Di che cosa era morta? Non si sa. Dunque,
tutte le ipotesi erano buone. Perché non cocaina? Feste fra ricchi potenti che
divorano ragazze innocenti? Boss democristiani? E perché no. Non emerse nulla,
ma il ministro Piccioni ebbe la carriera stroncata benché innocente. L’opinione
pubblica chiedeva che si trovassero i colpevoli fra gli alti papaveri della Dc:
era uscita la canzone Papaveri e papere cantata da Nilla Pizzi e per “alti
papaveri” si intendeva gli intoccabili, viziosi politici nei cui festini si
sacrificavano le sventurate ragazze del popolo. Tutto molto enfatico, con il
quotidiano modernissimo Paese Sera (comunista) e Momento Sera (centrista) che
uscivano con più edizioni al giorno, i reporter tutti usciti da un romanzo
di Chandler, tutti a imitare gli americani, specialmente i comunisti. L’aria da
guerra fredda soffiava sempre più greve. Intanto, sempre a proposito di guerra
fredda, Charlot, ovvero il popolare comico inglese Charlie Chaplin si vide
incriminato dagli americani come sospetto comunista e non tornò più in America
fino al 1971 quando ricevette l’Oscar alla carriera. Intanto, sempre in
quell’anno, coniugi Julius ed Ethel Rosenberg furono portati nella stanza della
morte di Sing Sing di New York (oggi è un museo), legati alla sedia elettrica e
– come dicono gli americani – “fritti”. Sembra non ci siano dubbi sul fatto i
due – più probabilmente Julius – passarono i segreti atomici ai russi, Ma a
mandarli sulla sedia c’era di sicuro il desiderio di vendicarsi contro i commies
che avevano superato gli americani nella qualità delle bombe, essendo arrivati a
quella al plutonio. L’esecuzione fu atroce, penosa, con le luci gialle che
s’abbassavano quando la leva che dirottava l’energia era abbassata e i corpi
tremavano davanti ai giornalisti seduti sulle sedie a distanza di sicurezza.
Furono fatti friggere a lungo col fumo che usciva dalla calotta avvitata sul
loro cranio, finché non morirono. D’altra parte, ancora si fucilavano reduci
nazisti, anche con qualche irreparabile errore giudiziario. Le elezioni non
fecero scattare la legge truffa, ma furono comunque vinte dal centro e dunque
proseguirono i governi democristiani di coalizione, con socialisti di Nenni e
comunisti di Togliatti all’opposizione. L’Italia cominciava a riprendersi
industrialmente e i consumi crescevano. La moda italiana cominciava a imporsi su
quella francese e le auto italiane godevano di buon prestigio. Anche
l’alfabetizzazione procedeva, gli analfabeti diminuivano e la televisione era
diventata il nuovo dizionario, teatro, maestro di scuola, amico, padre
spirituale, scatola dei sogni. Nei paesi capitava che attori come Alberto Lupo,
che recitavano il ruolo del cattivo, fossero inseguiti coi forconi. I lettori di
telegiornali erano spesso applauditi o insultati per le notizie che davano. Il
calcio e il ciclismo dominavano le fantasie dei ragazzi, specialmente maschi e
costituivano la valvola di sfogo contro le frustrazioni collettive. Gli sport di
massa funzionavano come antidepressivi e come eccitanti. E pochi fecero caso a
una notizia che avrebbe cambiato la prospettiva della vita: la scoperta del Dna,
l’acido desossiribonucleico sul quale sono scritte in lingua proteica tutte le
nostre caratteristiche personali e di specie. La Chiesa non era molto contenta
degli eccessivi progressi della scienza. Ma tutti furono felici quando a Roma si
inaugurò lo Stadio Olimpico ospitando il match Italia-Ungheria. E nell’Est? Che
fanno quelli dell’Est sovietico, adesso che Baffone è morto? Se ne sapeva poco.
Si disse che gli ebrei avevano tirato un sospiro di sollievo perché Stalin stava
per lanciare una purga contro i medici “cosmopoliti”, cioè ebrei, per fare un
repulisti antisemita in tutto il partito. Qualcuno disse che gli avevano fatto
la pelle. Quanto meno, nessuno aveva soccorso Stalin crollato a terra. Dopo un
periodo di incertezza, in cui sembrava che avesse vinto l’obeso Malenkov, alla
fine emerse il nuovo vero leader Nikita Kruscev, contadino e soldato che aveva
lavorato a fianco di Stalin e di cui denuncerà le criminali malefatte al XX
congresso del 1956. Per ora Nikita è un novizio che conta meno di Palmiro
Togliatti e del leader cinese Mao Zedong. Quando gli operai di Berlino
Est scioperano per orario di lavoro e salario, il partito dei lavoratori da
Mosca gli manda i carri armati. È la prima strage, cui seguiranno quelle
di Budapest e di Praga. Il cubano Fidel Castro, appena laureato, raduna in
montagna un gruppo di rivoluzionari e decide di assaltare la caserma Moncada. Li
prendono tutti e li mettono sottochiave, ma “l’assalto alla Moncada” diventerà
l’inizio della rivoluzione. Gli americani si preoccupano: ma questo Fidel
Castro, non sarà comunista per caso? Gli americani prendono la guerra fredda
molto sul serio: e alla General Electric licenziano i sospetti comunisti. Ma
dall’America arrivano anche nuovi oggetti e stili di vita, dalla caramella col
buco ai cosmetici a basso costo e i dentifrici per un alito da drago alla menta,
e svanisce il sentore delle ascelle e dei piedi in un Paese che era abituato a
un bagno in bagnarola settimanale e qualche pediluvio nel bagnapiedi di zinco.
Non si usava molto la carta igienica, sostituita da quella di giornale con cui
si foderava anche il secchio dell’immondizia che gli immondezzai prelevavano
dietro la porta di casa con dei grandi sacchi di juta. I preti erano vestiti
come don Camillo e non trovavi un gay neanche col lanternino. I padri e le madri
mollavano schiaffoni senza risparmio e i figli se li prendevano zitti, con le
orecchie rosse e la testa bassa.
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1953
5 marzo. Muore Stalin.
31 marzo. Approvata dal Parlamento italiano la nuova legge
elettorale, che le opposizioni chiamano la “legge truffa”. Assegna il 65% dei
seggi alla coalizione di liste che raggiungeranno il 50 per cento dei voti.
11 aprile. Una ragazza di 24 anni, Wilma Montesi, viene trovata
morta nella spiaggia di Torvaianica. L’inchiesta diventa un giallo politico.
Finisce sotto accusa un gruppo di ragazzi della Roma bene che avevano tenuto un
festino in una villa lì vicino. Uno di questi ragazzi è Piero Piccioni, figlio
di Attilio, probabile successore di De Gasperi alla guida della Dc. La carriera
politica di Attilio è travolta. E anche la vita del giovane Piero, che risulterà
poi del tutto innocente.
17 aprile. Il grande attore e regista Charlie Chaplin annuncia
che non tornerà più negli Stati Uniti dove è stato messo sotto accusa dai
maccartisti che sostengono che sia comunista.
17 maggio. A Roma viene inaugurato lo stadio Olimpico con la
partita di calcio tra Italia e Ungheria (l’Ungheria, in quegli anni, è
considerata la più forte nazionale del mondo).
29 maggio. Un alpinista neozelandese e uno del Nepal conquistano
l’Everest, cioè la vetta più alta del mondo.
2 giugno. Elisabetta è incoronata regina d’Inghilterra.
7-8 giugno. Si svolgono le elezioni politiche in Italia, la legge
elettorale non scatta perché nessuna coalizione raggiunge il 50 per cento dei
voti. La coalizione centrista (Dc, Psdi, Pri e Pli) candidata a ottenere la
maggioranza assoluta, si ferma al 49,85 per cento.
19 giugno. A New York vengono uccisi con la sedia elettrica i
fisici Julius ed Ethel Rosenberg, marito e moglie, con due figli piccoli,
accusati di avere passato segreti militari ai sovietici per costruire la bomba
atomica. In tutto il mondo clamorose proteste antiamericane.
26 luglio. Fidel Castro dà l’assalto alla caserma Moncada.
Militarmente è un fallimento ma di fatto inizia la rivoluzione cubana.
28 luglio. De Gasperi si presenta alla Camera per avere la
fiducia sostenuto solo dal suo partito e dai monarchici. Non ottiene la fiducia.
Finisce la carriera di De Gasperi che morirà l’anno dopo, Anche la famosa legge
truffa viene cancellata dal Parlamento. Il nuovo presidente del consiglio è
Giuseppe Pella.
7 settembre. Il comitato centrale del Pcus elegge Nikita Krusciov
segretario generale del partito. Krusciov è il commissario politico che guidò la
resistenza di Stalingrado. È lui il successore di Stalin.
Storia d’Italia, 1954: dalla nascita della Tv al caso Montesi
che stroncò la carriera di Piccioni. Paolo Guzzanti su
Il Riformista il 18 Settembre 2020. Gli americani avevano già portato il
dentifricio Colgate, la caramella col buco Life Saver, il tostapane e il burro
di arachidi ma nel 1954 ci scaricarono il Rapporto Kinsey: tutto sul sesso.
Nell’Italia d’allora il sesso era interdetto – come argomento – alla maniera di
un paese islamico, o anche cattolico e perfino comunista. Un po’ tutta l’Europa
era così. Gli inglesi dicevano che di due cose non si deve parlare
esplicitamente: dei servizi segreti e di quel che succede in camera da letto,
perché tutti sappiamo di che si tratta e non è proprio il caso di parlarne.
invece il Rapporto Kinsey frutto di anni di studio, interviste, filmati, tutto
pubblicato sul settimanale italiano Oggi. Uno shock, uno scandalo, una avidità
repressa e anche un grande senso di liberazione. Dunque, a quanto pare, tutti in
tutto il mondo, uomini donne e gay, copulano, si accoppiano, ma diciamolo pure,
scopano. O se preferite si accoppiano, mettetela come vi pare. Si parlava anche
di masturbazione con dettagli da far svenire le madamine per bene, e – senza un
velo di riguardo, nemmeno allusivo – di rapporti anali. La Chiesa la prese
malissimo ma la gente non parlava d’altro. Non per questo si può dire che il
1954 fosse un anno felice. Tutti nodi seguitavano a venire al pettine: il caso
Montesi si ingigantiva benché non uscisse fuori nulla e il ministro Attilio
Piccioni dovette dimettersi per il coinvolgimento di suo figlio nelle serate
con Wilma Montesi, la giovane morta trovata sulla spiaggia. La storia
di Trieste finalmente arrivava a una fine anche diplomatica col passaggio
definitivo all’Italia. La Germania smetteva di essere la nazione punita ai
margini della comunità – come era accaduto dopo la fine della Prima guerra
mondiale, con vessazioni che spianarono la strada ad Hitler– e già esistevano in
natura, colpivano paesi e investivano dighe quelle che oggi con orgoglio
neolinguistico chiamiamo “bombe d’acqua”. Il 13 gennaio in Austria una bomba
d’acqua spianò il villaggio di Blons e uccise duecento abitanti. Nessuno le
chiamava così perché i feroci acquazzoni con frane morti e dispersi erano
all’ordine del giorno. Era finita l’epopea di Alcide de Gasperi, aveva
tentato Amintore Fanfani e fallì, sicché ci provò il ministro di polizia Mario
Scelba, l’uomo della “celere” col manganello, ma anche quello che aveva messo al
bando ogni possibile riedizione del partito fascista. L’Unione Sovietica
perfezionava la sua penetrazione in Egitto appoggiando il nuovo rais Gamal
el-Nasser il quale pretenderà da Mosca la gigantesca diga di Assuan, un nuovo
esercito fiammante in grado di distruggere Israele e un esercito di istruttori
capaci di far funzionare il Paese. Marilyn Monroe non era ancora considerata la
bimba del sesso che diventerà fra poco, ma intanto sposa Joe Di Maggio, un
super-palestrato italo-americano eroe nazionale di Baseball. Prossimo
talamo, Arthur Miller, intellettuale e commediografo. Si chiude anche, con
l’eliminazione di Gaspare Pisciotta (il cognato killer per conto dei
carabinieri) la faccenda del bandito Giuliano, chiudendo molte bocche che non
potranno mai più raccontare la pazzesca avventura dell’esercito separatista, su
cui avevano contato in molti prima di liberarsene per sempre. La Dc palermitana
resta turbata e spaccata e molti anni più tardi il “resident” del KGB a Roma
venne nella Commissione d’inchiesta che presiedevo per raccontarci una serie di
spregiudicate operazioni fra americani e russi, condotte in Sicilia e su cui è
difficile fare la tara.
I guai grossi cominciano però in Vietnam, una delle colonie
francesi nel sud-est asiatico che durante la guerra patriottica contro gli
invasori giapponesi si era battuta con valore e che dopo la guerra non aveva
alcuna voglia di tornare sotto Parigi. I francesi non si resero minimamente
conto di quel che li aspettava e pensarono di avere di fronte dei
guerriglieri “Viet-minh” (che gli americani si chiamarono Vietcong”) e invece si
scontrarono con uno dei più poderosi eserciti in uniforme del mondo, armato sia
dall’Unione Sovietica che dalla Cina comunista e ben diviso in divisioni,
reggimenti e compagnie con un’artiglieria di prim’ordine e per di più affiancato
da un esercito partigiano di sostegno in larga parte femminile che aveva portato
a spalla su per le montagne, ben smontate, tutte le armi necessarie per la
battaglia finale che si combatté sull’altopiano di Dien Bien Phu. La stampa
francese criticò in modo sprezzante lo Stato maggiore per l’invio di un vero
esercito in Indocina, con quella che sembrava una smisurata potenza di fuoco che
aveva spedito in Vietnam per combattere quattro straccioni di guerriglieri
nascosti nella giungla. Capirono troppo tardi di trovarsi nel mezzo di una
battaglia campale più simile a quella combattuta fra americani e tedeschi nelle
Ardenne che a una scaramuccia coloniale. L’esercito francese vide emergere
dall’altissima vegetazione grandi pezzi di artiglieria pesante di fabbricazione
russa e cinese. Per l’opinione pubblica francese e poi europea e infine mondiale
fu un grande shock. A primi del 1900 una potenza asiatica, il Giappone, aveva
vinto e umiliato una potenza europea come la Russia zarista. In Corea gli
americani erano stati costretti ad arretrare fino al 38mo parallelo da cui erano
partiti, e adesso stava accadendo di nuovo: il più forte esercito continentale
europeo era tenuto in scacco in mezzo alla giungla da un esercito modernissimo
portato sotto le gallerie ed emerso dal nulla. di cui non avevano idea. La
battaglia fu lunga e sanguinosa, ma alla fine i francesi dovettero arrendersi e
umiliarsi, chiedere e firmare la propria resa. La cosa più interessante, nel
corso di questa guerra, fu il ruolo americano: gli americani che avevano
sostenuto lo smantellamento dell’impero britannico e l’indipendenza dell’India e
dell’Egitto, adesso parteggiavano più o meno apertamente per i vietnamiti e i
cambogiani che smontavano l’impero francese. Occorreranno quasi dieci anni prima
che gli americani decidano, cotto Kennedy, di sostituirsi ai francesi e perdere,
dopo altri dieci anni, un’altra guerra sanguinosissima che terminerà con la fuga
degli americani da Saigon aggrappati agli elicotteri che decollavano dalla
terrazza dell’ambasciata. Ma nel 1954 gli eroi della guerra antifrancese, Ho Chi
Minh, Giap e i cinesi Mao e Chu En Lai erano per lo più grandi ammiratori
dell’America che aveva vinto la Seconda guerra mondiale, che aveva sostenuto la
Cina. Inoltre, il personale politico delle forze anticolonialiste parlava
francese e inglese avendo studiato a Parigi ed essendosi formato sul modello del
partito comunista francese. Nello sport il ’54 fu l’anno dell’epico scontro
calcistico per la finale dei Mondiali fra Germania
Occidentale e Ungheria giocata a Berna il 4 luglio. La Germania vinse 3-2 ma
l’eroe celebrato da tutti gli spettatori fu il capitano ungherese Puskas (che
fuori dal campo era arrivato al grado militare di colonnello), che segnò tutti i
gol della sua squadra, più l’ultimo annullato. E accadde in quel giorno, quasi
dieci anni dopo la fine della guerra, qualcosa che dal 1939 non si era più
vista: una bandiera tedesca, della Germania occidentale chiamata RFT, salì sul
pennone di uno stadio di calcio, accompagnata dalle note dell’inno tedesco. Ciò
fece molto piacere ai tedeschi, anche se non entusiasmò il resto del mondo. Ma
in Germania già cresceva una nuova generazione che chiedeva rispetto: noi non
siamo i nostri padri, siamo innocenti e non vogliamo portare sulle spalle il
peso del passato altrui. Del resto, gli ungheresi di Puskas erano allora i maghi
del football per eleganza, intelligenza e capacità di sorprendere. Tutti i
ragazzini europei giocavano a calcetto nelle strade minacciandosi il
mitico “tiro ungherese”. Puskas dopo Berna tornò in patria come un eroe
nazionale, ma quando due anni dopo si trovò in Spagna mentre i carri sovietici
entravano a Budapest per schiacciare la rivoluzione antirussa, se ne resterà
prudentemente in Spagna per diventare una delle stelle del Real Madrid. Il mondo
si stava consolidando, Nikita Krusciov era ancora un oggetto sconosciuto, con
quella sua faccia da buon contadino, di cui molti conoscevano il passato di
ottimo ufficiale e di uomo fedele a Stalin anche negli anni del terrore. L’idea
che l’Europa possa costituire da sola un proprio esercito unito e indipendente
da quello americano e russo, fallisce bocciata dal Parlamento francese che non
aveva alcuna intenzione di sciogliere la Francia nel resto dell’Europa. La
Francia, come l’Inghilterra vuole la sua propria bomba atomica e la sua
indipendenza di manovra, essendo ancora una delle potenze coloniali e per di più
subito dopo aver perso una grande colonia in una umiliante sconfitta coloniale,
cosa che stava causando un ritorno del nazionalismo e dell’isolazionismo
francese, che aveva serpeggiato anche durante l’umiliante occupazione e
collaborazione con i tedeschi. Intanto Achille Compagnoni e Lino
Lacedelli scalano il K2 con Walter Bonatti guidati da Ardito Desio e tutto il
mondo ne parla e sugli schermi del pidocchietto (cinematografi da quattro soldi,
generalmente dei preti) tutti vanno a vedere il cinegiornale dell’impresa.
Certo, anche la tv ne parla, ma per vedere la tv bisogna ancora stare tutti
accatastati in cucina intorno all’enorme tubo catodico, o nei bar dove te lo
appendevano sotto il soffitto. Così, quando l’immagine scarrucolava, qualcuno
doveva salire sui tavoli e perché non esisteva il telecomando. A fine estate,
dopo aver risolto la questione di Trieste tornata all’Italia, dopo aver
riammesso la Germania nel salotto buono con la partita contro l’Ungheria e la
sua ammissione nella Nato, quando insomma tutti sognavano un autunno mite e
glorioso, ecco che arriva la bomba d’acqua. Di quelle catastrofiche fece franare
la Costiera Amalfitana da Cava dei Tirreni a Vietri, Maiori, Minori fino
a Salerno, causando più di trecento morti e seimila senzatetto. L’Italia del
fango e dello smottamento si conferma la vera frontiera italiana. Il Paese non
si regge e si inginocchia sotto i mutamenti climatici, ma anche sotto i
temporali. Ma va peggio alla Francia, che non ha ancora digerito la sconfitta
indocinese e si trova di nuovo in guerra con la più amata e francesizzata delle
sue colonie: l’Algeria, guidata dal Front de Libération National, che alla fine
la Francia perderà per referendum e che causerà la più grande trasmigrazione di
residenti africani, arabi e coloni, i cosiddetti “Pieds Noirs” sul suolo
francese. Ma sarà una lunga e terribile guerra che contorcerà tutta la politica
europea e mondiale. È cominciata una nuova era: quella delle guerre non
dichiarate, ma guerre di fatto. Le insurrezioni anticoloniali guidano questa
nuova tendenza che farà delle guerre e degli eserciti repressivi la nuova
costante del futuro mezzo secolo, man mano che tutti i territori coloniali
raggiungeranno, almeno nominalmente, l’indipendenza passando per lo più da un
regime colonialista a uno dittatoriale.
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1954
3 gennaio – Nasce la Tv in Italia.
14 gennaio – Marilyn Monroe sposa il campione di baseball Joe Di
Maggio.
9 febbraio – Gaspare Pisciotta, il luogotenente del bandito
Giuliano, viene ucciso con un caffè avvelenato nel carcere dell’Ucciardone.
Si porta nella tomba il segreto sui mandanti della strage di
Portella della Ginestra.
23 febbraio – Nasce il primo vaccino contro la poliomielite.
13 marzo – L’esercito vietnamita guidato dal generale Giap
sconfigge i francesi nella battaglia di Dien Bien Phu. I francesi son costretti
a lasciare il Vietnam.
18 aprile – In Egitto prende il potere Nasser.
4 maggio – Golpe in Uruguay. Prende il potere Alfredo Stroessner
che lo manterrà per più di 35 anni.
17 maggio – La corte suprema americana dichiara illegale la
segregazione razziale.
4 luglio – Finale dei campionati mondiali di calcio. La grande
Ungheria di Puskas viene sconfitta dalla Germania federale. Strascico infinito
di polemiche: i tedeschi erano drogati? L’arbitraggio fu pilotato?
31 luglio – Lino Lacedelli, alpinista ampezzano, conquista il K2,
cioè la vetta più difficile dell’Himalaya.
18 settembre – Il caso Montesi porta alle dimissioni del ministro
degli esteri Attilio Piccioni, perché suo figlio è sospettato di essere stato
coinvolto nella morte della giovane trovata senza vita sulla battigia di
Torvaianica. Il figlio di Piccioni in realtà non c’entra niente ma gli equilibri
nella Dc cambiano per sempre.
Il guzzantino. Storia d’Italia, 1955: in Tv arriva Mike
Bongiorno e la Fiat lancia la 600. Paolo Guzzanti su
Il Riformista il 29 Settembre 2020. Quando sono nato, l’Italia entrava in guerra
con vergogna: attaccando la Francia già arresa ai tedeschi e i francesi ci
chiamarono Maramaldi. Inoltre, i francesi all’inizio sulle alpi liguri ci fecero
neri e rievocare i primi anni di questa storia e della mia vita è stato poco
coinvolgente. Ma con il 1955 la faccenda cambia. Come tutti i quindicenni ero
sempre innamorato. Non si andava a vere feste, non parliamo di dormire a casa di
amici e quanto alle femmine il loro atteggiamento d’ordinanza era lo stupore.
Noi non avevamo coraggio e loro avevano una paura dannata di tutto: della
verginità, della gravidanza, malattie, reazioni paterne, matrimoni forzati, non
c’era la pillola e non tutte usavano l’assorbente restando sotto il controllo
ciclico matriarcale. Ma c’erano i Platters. C’era Pat Bone. C’era il
primo Modugno. Noi balli sulla mattonella, si concentravano le digressioni negli
angoli strategici di casa. Il giradischi e il Juke-box, la magica scatola
luminosa dove i dischi scendevano e le ragazze si stringevano al collo e fra un
bacio e una lacrima saliva una disperazione. Era arrivata la Seicento e dunque
il sesso in macchina era finalmente possibile, se solo riuscivi a non far
partecipare la leva del cambio. Nel 1955 esplose la libertà: arrivò il Rock’n
Roll e l’indumento che non sarebbe mai più tramontato: il blue-jeans nella sua
versione scorticante, colore unico e tessuto unico, risvolti alti fini, cuciture
rosse enormi. Il Rock’n Roll esplose nei cinema quando la gente abbandonava le
scomode poltroncine di legno e si metteva a ballare nei corridoi. La chiesa di
sua santità Eugenio Pacelli era preoccupatissima: l’americanismo ormai entrava
da tutte le fessure della vita tradizionale e della fina modestia italiana, i
manifesti mostravano baci prossimi all’orgasmo e ballavamo per strada e con le
donne potevi persino accennare al problema sessuale senza beccarti un ceffone e
nasceva dopo la Vespa anche la Lambretta e si scriveva con la Olivetti che era
il sogno di ogni studente, a rate, mille lire al mese. Gli inglesi si lamentano:
noi abbiamo inventato lo scooter e gli italiani se ne sono appropriati. Gli
italiani si appropriavano di tutto, inventavano tutto, erano dei draghi, non
lamentosi come oggi. Nasceva l’auto Bianchi con la Bianchina, la nostra risposta
alla Deux Cheveaux Citroen, meno adatta all’amore, ti saluto la posizione del
missionario. Ma con la Seicento parte l’intera famiglia sui primi tratti
dell’Autostrada del Sole, vanno a ruba i tavoli da picnic e si sfornano lasagne
domenicali. In compenso, chiude la produzione della Cinquecento giardinetta,
minuscola imitazione del caravan americano, in cui entravano anche sei persone,
purché due nel bagagliaio. Il primo Rock’n Roll era un’estensione
del boogie-woogie, e provocò una reazione conservatrice di tutte le Nille
Pizzi e i Cinico Angelini, con la riscossa terrificante di “Son tutte belle le
mamme del mondo quando il lor bimbo stringono al cuor” e poi milioni di
canzoncine innocue, ma rimate, dall’arietta innocente, orecchiabili e cretine
fra strazi gioiosi come Piripicchio e Pitricicchio e l’infernale barca che tornò
sola come la cavallina storna, perché tre fratelli avevano dato la loro vita per
salvare una bella bionda. La poetica italiana per italiani è da asilo infantile,
da asilo senile, da allegro convento, e intanto si inaugura a cavolo un
frammento della metropolitana di Roma. In politica, si manda al Quirinale il
bell’uomo Giovanni Gronchi, democristiano di sinistra con i voti dei
neofascisti, ciò che avrà conseguenze nel 1960. Viene emesso un francobollo
sbagliato, il famoso “Gronchi Rosa” che pochi fortunati si contenderanno. Si
avverte nell’aria l’impressione che l’Italia “vada a sinistra” perché Gronchi è
di sinistra insieme al fido Fernando Tambroni, uno che provocherà un disastro
nel luglio del 1960. Il festival di Sanremo si trasmette, ma in differita: dopo
il varietà “Un due e tre” di Vianello e Tognazzi che perderanno presto il posto
per aver fatto della satira. È il momento del trionfo di Claudio Villa che
stravince con Buongiorno tristezza sia pure cantando in playback per una
laringite. Villa è l’antimoderno per eccellenza, il Francisco Franco della
canzone italiana che ha sempre puntato sulle melodie che piacciono a napoletani
e romani. I francesi sono irrequieti: hanno perso il Vietnam, stanno affrontando
la ribellione dell’Algeria. La classe media scende in piazza con le casseruole
dietro a Pierre Poujade. Tira un’aria indecifrabile di casseruole sbattute, il
vecchio mondo imperiale tira le cuoia e Francia e Gran Bretagna sono
preoccupatissime per l’egiziano Gamal Nasser che parla di nazionalizzare il
canale di Suez. Nasser vuole anche strozzare Israele impedendo alla Stato
ebraico l’accesso al petrolio. Da tutto l’Est sovietico arrivano storie di
sofferenza, specialmente dall’Ungheria. Se la nuova Repubblica Federale
Tedesca è ammessa nella Nato e autorizzata ad avere un suo esercito sotto il
comando militare integrato, l’Est sovietico risponde formando la sua “Nato
dell’Est” che si chiamerà “Patto di Varsavia” e vi partecipano con l’Urss, la
Germania Est, la Polonia, la Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria,
Romania e Albania. La Repubblica Democratica Tedesca veste i propri soldati con
uniformi della tradizione tedesca e non all’americana come quelli occidentali.
Persino la lingua tedesca è accuratamente preservata, nell’Est comunista, dalle
influenze occidentali. Ogni anno il Patto di Varsavia programmerà un’unica
esercitazione che prevede un attacco improvviso delle forze imperialiste, alle
quali le forze del patto socialista, dopo aver respinto l’assalto si spingeranno
in un travolgente contrattacco fino a chiudere tutti i porti atlantici impedendo
così uno sbarco americano. In Argentina finisce la parabola di Peron, deposto da
un colpo di Stato mentre in Italia fa passi avanti la Ceca col mercato comune.
Gli Inglesi non sono attratti dall’Unione europea che considerano una vicenda
interna tra francesi e tedeschi. Ma sono invece preoccupati con i francesi per
il progressivo crollo dei due imperi: quello britannico e quello francese che
stava franando nelle rivolte arabe dell’Africa del Nord. Winston Churchill che
era tornato brevemente al governo, si dimette definitivamente. L’India è
indipendente per colpa dei “cugini” americani che non tollerano alcun impero. A
Londra Ruth Ellis di ventinove anni, è impiccata per aver ucciso il suo amante.
È l’ultima impiccagione del Regno Unito. La sua storia sarà raccontata in
Ballando con uno sconosciuto: un film terribile su una ragazza abusata e
perseguitata da un uomo e che, quando lei finalmente si ribella e lo uccide,
viene giustiziata. Un’altra epoca finisce: il boia di Londra con la sua scienza
di pesi con cui spezzare la terza vertebra e causare una morte
istantanea. Antonio Segni sardo democristiano conservatore diventa primo
ministro e sarà il futuro presidente della Repubblica. Nasce il Terzo
Mondo. Organizzato dal principio: né con l’America né con l’Unione
Sovietica. Nasce un nuovo gruppo di Stati, guidato dall’indonesiano Sukarno, che
non voleva schierarsi né con gli Usa né con l’Urss. Ma esplodono in tutto il
mondo, Africa e Asia in particolare, guerre di decolonizzazione contro i vecchi
padroni europei. Gli americani non soccorrono gli europei. Io a quindici anni mi
trovavo con mio padre in Austria e vidi partire sia i sovietici che gli
americani da Vienna che era stata occupata come Berlino. La partenza delle
truppe russe fu guardata dalle finestre in modo torvo e una breve cerimonia per
inaugurare la statua al milite ignoto sovietico andò deserta. Furono le mie
prime fotografie. L’Est e l’Ovest non sembravano affatto attirati dalla
convivenza pacifica ma solo dalla necessità di evitare una guerra per sbaglio.
Quanto al resto, si odiano. La guerra non esplose, salvo che in Asia, ma
in Europa la vivevamo con una forma d’angoscia particolare che spingeva
all’edonismo e al tanto peggio, tanto meglio. Cominciarono i primi “Summit”: gli
incontri fra i grandi della terra per assicurarsi che nessuno avrebbe tirato per
primo il grilletto. Ce ne fu uno con il presidente russo Nikolai
Bulganin (nessuno lo ricorda: aveva il pizzetto e un’aria saggia), il presidente
americano Eisenhower, il francese Faure e Anthony Eden per il Regno unito. Si
incontrano a Ginevra e rilasciano comunicati cauti. L’unico significato era: non
siamo ancora sull’orlo della guerra. Poi si vedrà. Ma la frattura politica fra
chi sta con i comunisti e chi è contro i comunisti si faceva nevrotica. Poiché
in Italia si parlava di un governo con i socialisti ancora alleati dei
comunisti, insorse il cardinal Ruffini di Palermo per battere il pugno sul
tavolo: l’alleanza non s’ha da fare. Ma in compenso la televisione italiana
manda in onda Mike Bongiorno col suo “Lascia o raddoppia” e gli italiani
impazziscono, le ragazze si innamorano di Mike e del suo accento, i bar sono
zeppi di spettatori perché solo pochi hanno un televisore a casa. I radicali si
separano dal Partito radicale e formano la prima pattuglia di matti libertari. E
infine, siamo ammessi alle Nazioni Unite dove non ci voleva nessuno. La Cia, su
proposta del Dipartimento di Stato, comincia delle trattative con la sinistra
italiana. Prima con i socialisti e poi con i comunisti: separatevi da Mosca e vi
manderemo al governo. Io che ero socialista di sinistra, ricordo i primi
dibattiti indignati “per l’odiosa interferenza dell’imperialismo americano”.
Però, se ne parlava. I socialisti avevano ormai sviluppato una forte corrente
autonomista che non ne voleva sapere del matrimonio con i comunisti.
Nella Democrazia cristiana si sviluppava parallelamente una sinistra sindacale
pronta a fare il governo con chiunque venisse dalla sinistra. Era cominciata una
lunga marcia, lunga e contorta. Furoreggiava “La donna ricca non la voglio no
perché ogni riccio nasconde ‘nu caporiccio” ed era morto l’idolo James
Dean fracassandosi contro un albero ubriaco fradicio. Il Partito comunista, per
ordine di Togliatti, metteva all’indice la pittura astratta sponsorizzata
dalla Cia che cercava di imporre Pollock e Rothko. Guttuso, che si era dato
all’astrattismo, fu preso severamente per le orecchie: “Picasseggia, quando non
devesi picasseggiare” aveva commentato sarcastico Nello Ajello. Il vero Picasso
picasseggiava poco e tornava realista puntando specialmente sul suo nuovo brand:
la colomba ì, simbolo della pace dei popoli amanti della pace (quelli comunisti)
contro i popoli amanti della guerra che minacciano l’umanità. La guerra
ideologica corre nelle gallerie e nelle pagine della cultura. Togliatti firma un
feroce editoriale contro l’arte astratta su Rinascita intitolato “Scarabocchi”.
Chi vuol capire, capisce.
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1955
19 gennaio – Il presidente americano Dwight D. Eisenhower tiene
la prima conferenza stampa trasmessa in tv.
9 febbraio – Dopo 13 anni di lavori viene inaugurata a Roma la
prima linea della metropolitana (la tratta Termini-Laurentina che oggi è la
metro B).
9 marzo – Al salone dell’auto di Ginevra viene presentata la Fiat
600. Nei successivi 14 anni di produzione verranno vendute 5 milioni di auto di
questo modello.
5 aprile – Winston Churchill, dopo anni di sofferenze fisiche e
difficoltà politiche nella fase post-bellica, decide di dimettersi. Gli
succederà Anthony Eden.
29 aprile – Giovanni Gronchi, esponente della Dc, diventa il
terzo Presidente della Repubblica della storia d’Italia. Viene eletto al quarto
scrutinio con i voti delle maggiori forze politiche del tempo, compreso il Pci e
l’Msi.
15 maggio – Viene firmato a Vienna il Trattato di Stato austriaco
che ristabilisce la sovranità e la libertà della nuova Austria democratica.
16 settembre – In Argentina un colpo di Stato militare
destituisce il presidente Juan Domingo Peròn.
30 settembre – L’attore James Dean muore a soli ventiquattro anni
in un incidente stradale a bordo della sua Porsche Spyder.
19 novembre – In Italia va in onda la prima puntata dell’iconico
quiz televisivo Lascia o raddoppia?, condotto da Mike Bongiorno.
11 dicembre – In un convegno a Roma, al cinema Cola di Rienzo,
dopo la scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito
Radicale.
14 dicembre – Sulla base di una mozione canadese l’Italia entra
ufficialmente a far parte della Nato.
Il
guzzantino. Storia d’Italia, 1956: dalle Olimpiadi di Cortina alla tragedia
Marcinelle passando per il naufragio dell’Andrea Doria.
Paolo
Guzzanti Il Riformista l'8 Ottobre 2020. Quando ho iniziato a scrivere questa
serie di articoli dedicati agli anni della nostra storia repubblicana, sapevo
che mi aspettava un momentaccio: raccontare il 1956 e renderlo per quanto
possibile palpabile, comprensibile a chi non c’era e a chi fosse nato anche
mezzo secolo dopo. Per me il 1956 è ieri. Tutto il film è da allora nella mia
mente. Mia e dei miei coetanei o di quelli che avevano venti, trent’anni o poco
più e che non ci sono più perché così va il tempo e va la storia. Tutti gli anni
sono memorabili ma il 1956, ad undici anni dalla fine della guerra, fu quello
più feroce. Non soltanto per quel che accadde in Ungheria e nel Medio
Oriente, ma per il fatto che per la prima volta lo vedemmo – in bianco e nero
sfarfallante – sullo schermo di quel nuovo coso che era il televisore,
finalmente installato in tutte le case italiane: un aggeggio tondeggiante,
pesante, su cui si accendeva per ore un disegno grafico chiamato Monoscopio. Su
questo passavamo ore per regolare uno schermo con oltre seicento righine grigie.
Fu lì, su quello schermo, che vedemmo accadere per la prima volta i fatti più
gravi, oltre a Mike Bongiorno che trasmetteva Lascia o Raddoppia?. L’altro
aggeggio entrato ormai in ogni casa era il frigorifero: non più burro tenuto in
fresco nel lavandino, ma tonnellate di ghiaccio e ghiaccioli. E tramontava il
gusto per l’arrendamento borghese detto “Rinascimento” (buffet e contro-buffet
da una tonnellata con specchi e zampe di leone dappertutto) per cedere ad un
nuovo stile razionale “svedese”, lineare e senza fronzoli. Il Paese cresceva
molto, l’industria andava a tutta birra, le famiglie mettevano al mondo figli, i
nonni restavano in casa come vice genitori e lì morivano. La disciplina era
ancora di ferro e volavano schiaffoni e punizioni. I vigili urbani,
le “guardie” (cioè i poliziotti e i carabinieri) non erano amichevoli e andavano
a spiare le coppie che amoreggiavano in luoghi di fortuna. Era vietato parlare
di sesso salvo che nelle surreali barzellette degli adolescenti brufolosi
impacchettati nei blue jeans ancora rigidi come lamiere. Ma le donne si
vestivano sempre meglio, così come le figlie adolescenti, chi aveva pochi soldi
aveva in genere una zia armata di macchina da cucire per confezionare tailleur
sui modelli pubblicati dai settimanali femminili. Il genio italiano emergeva, in
modo sparpagliato ma anche disciplinato perché le scuole, specialmente
pubbliche, erano severissime, con insegnanti dai vestiti un po’ logori, ma
temutissimi. Il Paese leggeva i giornali della sera e guardava le notizie al
cinema, dove ogni film era preceduto dalla Settimana Incom che era un
telegiornale pieno di ministri che tagliavano nastri. Ma quell’anno fu il teatro
di avvenimento importanti, sanguinosi, alcuni chiusero un’epoca, anche se non
tutti se ne accorgevano. Fu l’anno del rapporto segreto al Ventesimo
congresso del Partito comunista sovietico in cui il successore di Stalin, Nikita
Krusciov, rivelò un po’ più della metà dei delitti compiuti da Stalin, ma
benevolmente classificati come «errori» da imputare non al sistema comunista, ma
ad un imprevisto eccesso di narcisismo assassino, chiamato «culto della
personalità». Di conseguenza, molti seguaci di quel culto nei vari paesi
soggetti all’Unione Sovietica furono eliminati. Per afferrare l’enormità di quel
che veniva rivelato – ma tutto si sapeva molto bene – bisognerebbe rendersi
conto della natura quasi divina del “compagno Stalin”, che sopravviveva dopo la
sua morte avvenuta due anni prima in circostanze tuttora non chiare. Il rapporto
era segreto, ma fu fatto trapelare per brani alla stampa occidentale che lo
diffuse e pian piano lo ricostruì. Era come se il Papa avesse annunciato che Dio
non esiste. I comunisti occidentali e in particolare Palmiro Togliatti, la
presero malissimo anche perché molti di loro avevano partecipato ai fasti dello
stalinismo. E poi le stragi di Budapest, pudicamente chiamate «i fatti di
Ungheria». Quei morti in quasi diretta televisiva per la prima volta nel mondo:
la rivolta di operai, studenti e intellettuali anche comunisti, contro i carri
armati sovietici. Cittadini in bianco e nero. Sparavano e morivano davanti
all’occhio televisivo del mondo. Chi non morì subito – circa cinquantamila
uomini – fu poi fatto eliminare da Janos Kadar, che aveva partecipato alla
rivolta e poi era passato ai russi che lo mantennero sul trono fino alla morte.
E la neve. Le inarrestabili nevicate del 1956 da gennaio alla metà aprile con le
città del centro e del Sud paralizzate, con una ondata di una micidiale
influenza che ne ammazzava più del Covid. Gli alberi di Roma che crollavano.
Infine, l’ultimo guizzo, il colpo di coda coloniale dei francesi e degli inglesi
che reagiscono come ai tempi delle cannoniere alla nazionalizzazione del Canale
di Suez proclamata da Nasser, il nuovo raìs egiziano e leader del mondo arabo.
Ma non è più stagione di cannoniere e accade un fatto nuovissimo e – per i tempi
– scioccante: americani e russi sembrano pronti a bombardare Londra e Parigi se
non schiodano da Suez. Da dove partire? Certamente da tutti quegli operai e
studenti ungheresi che indossavano un trench alla Humphrey Bogart: una cicca
nell’angolo della bocca e un mitra in mano. Impassibili, un caricatore dopo
l’altro. Le ragazze che riempiono i contenitori di pallottole. Avevo sedici anni
e ricordo i profughi ungheresi miei coetanei arrivati a Roma prima di Natale e
che accompagnavamo alle bancarelle di piazza Navona. Loro ci mostravano le mani
bruciate dall’uso della mitragliatrice. Ragazzi, anzi ragazzini. E i miei amati
parenti comunisti che friggevano nel dolore e nella spossatezza di non poter
parlare ma piangevano più che altro per le sorti della squadra di calcio
ungherese, un mito e una leggenda. Ricordo una manifestazione a Roma da piazza
del Popolo a piazza Venezia furiosa e apocalittica piena sia di gente
democratica che di molti fascisti: tutto l’anticomunismo della recente guerra
tornava proponendo corpi di spedizione, arruolamenti, cose di pura propaganda. E
poi Suez. Che cosa era successo a Suez? Il canale costruito dagli europei e di
proprietà anglo-francese fu sequestrato, anzi nazionalizzato, da quel colonnello
arabo che parlava alle folle senza gridare e dicendo cose mai udite prima: «In
questo momento, mentre pronuncio queste parole, le nostre forze armate stanno
prendendo possesso del Canale di Suez. Coloro che lavorano al Canale stiano
calmi, nessuno li toccherà ma da questo momento il canale è solo egiziano».
Delirio. Anthony Eden, primo ministro britannico, bello ed elegante, so british,
non credeva ai suoi occhi ed orecchie. Ma come si permette questo beduino, o
quel che è? Telefonate con Parigi: bisogna agire, siamo noi le potenze coloniali
europee e siamo noi ad avere costruito il canale. Tel Aviv vede che gli arabi
vogliono la morte di Israele prendendoli per fame e avverte: noi ci stiamo.
Colpo di mano. Sbarchi, paracadutisti, navi: le potenze coloniali europee vanno
a dare una lezione ai ribelli. Ma qualcosa di imprevisto ed imprevedibile
accade: gli Stati Uniti con il loro presidente-soldato Eisenhower, insieme
alla Russia sovietica di Nikita Krusciov sbarrarono a mano armata il passo ad
inglesi e francesi: Foster Dulles, il segretario di Stato americano, il creatore
della Cia guidata da suo fratello Allan, prese il microfono all’Onu e disse: «E’
per me un momento terribile dovermi opporre agli alleati storici e fratelli
inglesi e francesi per dir loro no. Dovete ritirarvi immediatamente. L’epoca
degli imperi è finita, l’America non permetterà a nessuno di agire come
nell’Ottocento. Lasciate Suez o sarà la guerra». Da Mosca Krusciov disse: «O ve
ne andate o io mando i miei bombardieri con le bombe atomiche
sopra Londra e Parigi». Per molto tempo tutti fecero finta che non accadesse
nulla, ma dovettero sloggiare. Ma l’Unione Sovietica aveva già occupato
l’Ungheria con i carri armati: Imre Nagy, il mite capo dei ribelli, con i suoi
baffetti arricciati, occhialini e il gilet, fu giustiziato alla maniera
di Cesare Battisti: gli fecero salire tre gradini e lo misero di schiena contro
una tavola. Un boia gli stringeva il cappio al collo per poi strangolarlo con la
forza delle sue mani, facendo a lungo scalciare Nagy al quale erano caduti gli
occhialini di mano. Ma la cosa più grave fu che quell’invasione dell’Ungheria e
quella repressione che portò a oltre centomila morti in combattimento e quasi
altrettanti in vario modo giustiziati o fatti sparire, avvenne per pressione e
decisione di Palmiro Togliatti e del gruppo dirigente del Pci e del leader
comunista cinese Mao Zedong. Giorgio Napolitano ha raccontato in modo
particolarmente addolorato e onesto la tragedia di quella decisione. Allora
tutto il partito fu compatto nell’applaudire l’intervento sovietico, salvo una
dozzina di intellettuali fra cui Lucio Colletti, Paolo Spriano, Antonio
Giolitti che era figlio di Giovanni e che Togliatti esibiva come nome di
prestigio e pochi altri. Piero Melograni ha raccontato che ai tempi della
rivoluzione ungherese – che il Pci declassò col titolo “Fatti di Budapest” –
nella sede del Pci non esisteva un televisore perché il partito era contrario
alla diffusione delle immagini che contrastavano il potere dei documenti
politici. La realtà fu che tutti, per la prima volta nella storia, vedemmo
giorno dopo giorno quel che accadeva a Budapest dove i carri sovietici
abbattevano caseggiati per colpire un ribelle, e la città era ridotta un carnaio
infernale. I socialisti italiani del Psi si spaccarono fra “carristi” (quelli
che approvavano l’intervento dei carri armati) e autonomisti che non volevano
più condividere l’alleanza con un partito comunista. Ma non successe nulla di
grave e di definitivo. Le ferite, specialmente quella della memoria, si
rimarginarono rapidamente. Io ricordo me stesso, sedicenne, molto agitato e
disperato per quello che avevo visto. E per la prima volta nella mia vita del
giornalista che ancora non ero, fui preso dalla febbre di sapere, essere
informato, capire tutto: perché era successo, che cosa era accaduto prima, che
fine avevano fatto tutti quegli esseri umani, quei ragazzi, quei vecchi, quelle
donne che attraversavano la strada fra i colpi di cannone e di cui non si
parlava più? Quella gente che fino a ieri avevo visto viva e piena di un calmo
coraggio mentre sparava nello stesso modo e con la stessa epica partigiana con
cui i resistenti parigini sparavano ai nazisti. La guerra era finita soltanto
undici anni prima ed era già stata dimenticata e superata dalle nuove angosce,
ma l’Italia era già uno splendido Paese nuovo e moderno, elegante e pieno di
charme, con l’industria che produceva automobili ed elettrodomestici come quelli
americani e con la moda e gli stilisti che stavano già rendendoci diversi,
brillanti, con quel talento in più, quell’anomalia geniale che è l’unico e
solo patrimonio italiano, oltre la storia e la geografia.
LA CRONOLOGIA
DEGLI EVENTI DEL 1956
26 gennaio – A
Cortina iniziano le Olimpiadi invernali. Zeno Colò vince la discesa libera.
3 febbraio
– Grande gelo in tutta Europa. Roma per 15 giorni è sommersa dalla neve.
25 febbraio
– Krusciov parla al congresso del Pcus e rivela i crimini di Stalin. Il suo
rapporto dovrebbe restare segreto ma viene pubblicato dal New York Times.
20 marzo – La
Francia concede l’indipendenza alla Tunisia.
19 aprile
– L’attrice Grace Kelly abbandona il cinema e sposa Ranieri, principe di Monaco.
21 aprile
– Nasce il Giorno, giornale dell’Eni di Enrico Mattei che già pensa al
centrosinistra.
19 maggio
– Iniziano i lavori per la costruzione dell’autostrada del Sole. Ci vorranno
otto anni per inaugurarla.
29 giugno –
Marilyn Monroe sposa lo scrittore Arthur Miller.
25 luglio –
Affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, speronato da una nave
norvegese. Ci sono decine di morti, ma oltre 700 superstiti grazie alle
operazioni di salvataggio coordinate dal comandante Piero Calamai e ad una
eccezionale manovra di una nave francese accorsa in soccorso. Calamai non vuole
scendere dalla Andrea Doria, ma i suoi ufficiali lo costringono.
26 luglio – Il
Presidente egiziano Nasser nazionalizza il canale di Suez. Francia e Gran
Bretagna furiose. Tensione internazionale alle stelle.
8 agosto – A
Marcinelle, in Belgio, crolla una miniera. Muoiono, sepolti 262 minatori dei
quali 136 italiani. È la più grave tragedia sul lavoro del secolo.
23 ottobre
– Inizia la rivolta d’Ungheria contro l’Unione sovietica.
28 ottobre –
Centouno intellettuali comunisti italiani firmano un documento contro l’Urss. La
direzione del Pci li condanna severeamente.
Tra le firme
quelle di Lucio Colletti, Asor Rosa, Carlo Muscetta, Fabrizio Onofri, Paolo
Spriano.
29 ottobre –
Inizia la guerra arabo-israeliana.
4 novembre –
L’Armata rossa entra a Budapest.
6 novembre –
Dwight Eisenhower, repubblicano, ex capo dell’esercito americano durante la
guerra, viene eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti.
Sconfigge il democratico Stevenson.
27 dicembre –
In Italia le donne vengono ammesse nelle giurie popolari.
Storia d’Italia, 1956: quando a Marcinelle morirono centinaia
di "fottuti italiani". Paolo Guzzanti su Il Riformista
il 13 Ottobre 2020. Il terribile 1956, oltre ai “fatti d’Ungheria”, oltre
all’elenco parziale ma ufficiale (però a due anni dalla morte) dei delitti
di Stalin, e alla guerra del canale di Suez (di cui ricorderò un retroscena
cinematografico legato al sogno americano), fu anche l’anno di due terribili
disastri. Entrambi angosciosi e collettivi, dal momento che la televisione ormai
era entrata nella nostra vita, funzionava, e tutti potevamo vedere quel che
accadeva nel mondo. La prima tremenda tragedia fu a Marcinelle in Belgio,
dove 136 minatori italiani immigrati morirono gasati dai fumi in una galleria in
cui una scintilla elettrica incendiò un serbatoio di combustibile. Non morirono
solo loro: i morti in tutto furono 262, ma più della metà erano nostri
concittadini del Sud che vivevano nelle periferie delle località minerarie
come Bois du Cazier. Erano tremende immagini in bianco e nero: cadaveri – non si
vedevano ancora i cadaveri in televisione – e pianto di vedove, pianto di figli
impietriti. Era l’Italia che emigrava, che raggranellava franchi, marchi e
dollari. Era la stessa Italia che dal Sud andava nella Milano su cui Visconti
avrebbe girato Rocco e i suoi fratelli. Fu allora che ci rendemmo conto, tutti,
che il miracolo economico che cominciava a dividere nettamente i ricchi dai
poveri, non era lo stesso per tutti. E che mezza Italia aveva la valigia di
cartone pronta con lo spago, pronta a prendere treni eterni in cui spargere
l’odore delle arance e del cacio, della salsiccia e della pasta al sugo. Era la
stessa Italia che ora si trovava in ginocchio impietrita a Marcinelle in mezzo
alle bare. L’Italia immigrava e lo faceva in modo umile e modesto. In Francia e
in Belgio gli immigrati italiani li chiamavano “les ritails” ed era un termine
offensivo. Come in America i “Dagos” (chissà perché). Parole intraducibili.
Semplicemente volevano dire “fottuti italiani”. La seconda disgrazia fu l’Andrea
Doria. In realtà l’affondamento dell’Andrea Doria avvenne un mese prima di
Marcinelle, ma nella catena dei ricordi Marcinelle viene per prima. Era una nave
bellissima, la più bella nave italiana dopo il Rex di Fellini. Era la nave dei
sogni modesti delle lettrici di rotocalchi. Fu speronata e morirono in
cinquantuno. Una strage in mezzo al mare per ragioni incomprensibili. Fu
speronata dal mercantile svedese Stockholm della Swedish American Line, al largo
degli Stati Uniti. Il disastro del Titanic del 1912 aveva imposto nuovi standard
di sicurezza sui transatlantici e sembra che questi standard abbiano impedito
una strage più grave, visto che erano a bordo mille e duecento quarantuno
passeggeri e centinaia di uomini dell’equipaggio. Si piegò su un fianco,
l’Andrea Doria, e restò così a galla, fotografata dagli aerei e dalle altre navi
che vennero al soccorso, prima di affondare. Era estate piena, io ero a Ostia
con i miei perché a quei tempi Ostia era un meraviglioso quartiere romano sul
mare, liberty e gentile e la sera si prendeva il gelato in centro e oppure i
krapfen che arrivavano dalla cucina con un siluro d’acciaio su una fune. Gli
strilloni gridarono: “Paese sera! Edizione straordinaria! È affondata l’Andrea
Doria con centinaia di morti”. I morti non erano centinaia ma la notizia era
adatta all’estate dei capannelli e dei caffè. Tutti accesero i televisori e i
bar erano allora molto forniti di questi grossi oggetti luminosi. Era bello
restare ammutoliti davanti alle immagini e scuotere la testa. Il naufragio in sé
era un fatto mondano, più che nautico. La guerra aveva lasciato una scia di
memorie, racconti e storie tutte più o meno terrificanti e in fondo la triste
fine di quella bella nave diventò un argomento di passione nazionalista e di
grande sdegno per gli svedesi che ci avevano affondato la più bella barca di
casa. E arriviamo alla guerra di Suez, che fu un grand’evento di cui però allora
pochi, anzi nessuno, capì le conseguenze. Immagino che non molti lettori abbiano
ben presente, per motivi d’età, chi fosse Gamal Abd el-Nasser: fu il campione
del mondo arabo che si ribella agli europei. In realtà si era trattato di una
colonizzazione breve, visto che il mondo arabo aveva fatto parte dell’impero
Ottomano che fu smantellato nel 1918, insieme all’impero tedesco in Africa e a
quello austro-ungarico. L’Egitto era da tempo un protettorato di sua maestà
britannica, il cui governo aveva installato un playboy – re Faruk- sul trono
del Cairo. Faruk fu mandato a giocare le sue ultime carte
al Casinò di Montecarlo da una rivolta di giovani ufficiali cresciuti nel culto
del sistema britannico e con una buona preparazione militare. Fu un colpo di
Stato poco cruento e fra i giovani ufficiali prevalse Nasser, che era atletico,
anzi bello, intelligente, ottimo oratore e discretamente colto. Soltanto
recentemente sono stati resi accessibili documenti riservati del Dipartimento di
Stato, da cui si è appreso che il giovane Nasser odiava, sì, gli usurpatori
inglesi che insieme ai francesi facevano soldi a palate, facendo pagare il
transito sul canale di Suez su cui passavano le petroliere che portavano energia
in Gran Bretagna, Francia e nell’intera Europa. Ma amava l’America. Questa è la
scoperta. Nasser aveva il suo personale American Dream e questo sogno americano
era legato ad un film di Frank Capra: It’s a wonderful life del 1946, in cui un
giovane James Stewart interpreta il cittadino George Balley, il bravo ragazzo
costretto a difendere sé stesso e la sua famiglia dalle grinfie di un malvagio
riccone e che Iddio strappa al suicidio mandandogli un angelo custode senza ali
perché in punizione. Nasser era convinto che in quel film abitasse l’intero
inconscio dei suoi desideri: la vittoria del bene sul male, la fede in Dio e il
misterioso fascino dell’America che alla fine soccorre sempre i deboli e
costringe i malvagi ad arretrare. Gli americani, sia durante che dopo la guerra,
segretamente detestavano gli inglesi, amorevolmente ricambiati. Gli americani
avevano costretto la Gran Bretagna a mollare l’India ed erano decisi a sbatterli
fuori anche dall’Egitto. Quando l’ambasciata americana rese nota la passione del
nuovo “raìs” per il sogno americano del film di Capra, fu immediatamente inviata
una copia speciale del film a Nasser, sottotitolata in arabo, benché Nasser
parlasse un discreto inglese. Non si sa se gli americani abbiano attivamente
spinto Nasser a impossessarsi del Canale di Suez con un colpo di mano e dopo
aver costretto la guarnigione inglese ad andarsene. Nasser pronunciò un discorso
alla radio e in questo discorso introdusse una parola chiave che era il segnale
per i suoi: quando la pronunciò alcuni commandos egiziani penetrarono negli
uffici della compagnia del canale e ne presero possesso. Quel che accadde dopo
lo abbiamo ricordato nell’articolo precedente. Parigi e Londra decisero di
intervenire militarmente, ma avevano bisogno di un pretesto e si rivolsero a Tel
Aviv proponendo un accordo: voi israeliani occupate il Sinai e certamente
l’esercito egiziano vi attaccherà. A quel punto noi – francesi e inglesi –
annunciamo al mondo di aver mandato un corpo di peace keeper, ovvero alcune
migliaia di uomini, come forza di interposizione. E lo fecero, sbarcando un vero
esercito. Nasser fece per radio un discorso di chiamata alle armi copiato dal
celebre discorso di Churchill “We shall fight on the hills… we’ll never
surrender” e disse che gli egiziani avrebbero combattuto sui campi e sulle
spiagge e mai si sarebbero arresi. Il popolo egiziano sembrò impazzito, in un
delirio di patriottismo nazionalista. Fu a quel punto che Nikita Krusciov, il
successore di Stalin noto per andare per le spicce, annunciò che avrebbe
bombardato con le sue atomiche Londra e Parigi se i loro soldati non si fossero
ritirati immediatamente. Anthony Eden, il premier britannico che era stato il
ministro degli Esteri di Winston Churchill, cercò di giocare la carta americana
rivolgendosi al presidente Eisenhower per chiedergli aiuto. Il vecchio soldato
rispose con parole di gelo, più che di fuoco: “Non siamo mai stati informati di
questa operazione che disapproviamo totalmente”. Eisenhower criticò Krusciov per
aver minacciato di usare le atomiche e malgrado la guerra fredda, malgrado la
situazione drammatica in Ungheria, le due superpotenze si trovavano d’accordo
nel costringere i colonialisti europei ad andarsene. Nasser vinse, ma perse il
senso delle proporzioni. In preda all’enfasi bellica cominciò prima a dire e poi
a credere di aver vinto sul campo di battaglia l’Inghilterra, la Francia e anche
Israele che odiava per la sconfitta subita nel 1948. E questa fu la sua rovina.
Nasser voleva armi per combattere Israele e gli sembrò naturale chiederle
a Washington, a causa del suo sogno americano ispirato da Frank Capra. Ma
Washington rispose a brutto muso di non avere alcuna intenzione di dare armi
all’Egitto e a quel punto Nasser, un anticomunista islamico molto radicale,
compì il gesto impensabile: chiese a Mosca un esercito e finanziamenti per la
diga di Assuan. Ottenne entrambi provocando una crisi di nervi a Washington. Il
regolamento dei conti avvenne dodici anni dopo quando Nasser, sicuro di aver
messo in piedi la crociata contro Israele con una gigantesca coalizione araba,
fu di nuovo battuto sul campo nella guerra dei 6 giorni dall’esercito israeliano
e dal generale Moshe Dayan, quello con un occhio bendato, che travolse gli
egiziani; e dovettero fermarlo prima che arrivasse al Cairo. Dodici anni dopo.
La stella di Nasser smise di brillare e il suo grande sogno americano si
dissolse sulle sabbie del Sinai.
Dopo l'anno nero 1956 era impossibile illudersi sul comunismo.
Il centenario della nascita del Pci si avvicina. La
nostalgia sembra già farsi strada. Purtroppo. Giuseppe Bedeschi, Venerdì
18/12/2020 su Il Giornale. Si avvicina il centenario della fondazione del Pci,
il 21 gennaio 1920, escono libri e articoli sui giornali. Vorrei portare anch'io
una piccola testimonianza personale a proposito della storia comunista, una
testimonianza relativa a un anno fatidico, il 1956: che fu l'anno del rapporto
segreto di Krusciov al XX congresso del Partito comunista dell'Unione Sovietica,
e l'anno della rivoluzione popolare ungherese. Stalin era morto solo tre anni
prima. I partiti comunisti di tutto il mondo l'avevano osannato in modo
delirante. Ma il 25 febbraio 1956 accadde una cosa stupefacente e sconvolgente.
In un lungo discorso a porte chiuse (riservato cioè ai soli congressisti, senza
la presenza delle delegazioni dei partiti fratelli e senza i giornalisti),
Krusciov fece letteralmente a pezzi la figura di Stalin: il quale aveva
governato l'Urss in maniera dispotica e terroristica, e aveva commesso
innumerevoli delitti contro esponenti del partito e dell'esercito. Krusciov
raccontò cose atroci e rivelò che l'uso delle bastonature e della tortura era
diventato prassi corrente contro i supposti dissidenti. I dati forniti da
Krusciov erano terrificanti: per esempio, dei 139 membri del Comitato centrale
del partito al XVII congresso, il 70% era stato arrestato e fucilato. La stessa
sorte toccò alla maggioranza dei delegati a tale congresso: su 1966 delegati,
1108 vennero arrestati e poi fucilati. Purghe altrettanto feroci furono
scatenate contro l'esercito, con centinaia di vittime, sicché l'Armata Rossa si
trovò in uno stato confusionale di fronte all'aggressione hitleriana. Prima di
ripartire da Mosca, Togliatti ricevette dai capi del Cremlino una copia del
rapporto segreto. La situazione nella quale il leader comunista veniva a
trovarsi era assai sgradevole e imbarazzante. Il Pci, infatti, aveva tributato a
Stalin un culto sconfinato. I comunisti italiani lo avevano sempre considerato
il capo più amato, lo avevano esaltato in forme ditirambiche e morbose: Stalin
era l'uomo che aveva realizzato il socialismo nell'Unione Sovietica, che aveva
costruito dighe e deviato il corso dei fiumi, che aveva abolito lo sfruttamento
dell'uomo sull'uomo, che aveva battuto gli eserciti hitleriani col suo genio
politico e militare. Quando Stalin morì, i comunisti italiani lo piansero come
si piange un padre. Il giorno in cui fu annunziata la sua fine, l'Unità uscì
listata a lutto. «L'anima è oppressa dall'angoscia dichiarò Togliatti alla
Camera dei deputati per la scomparsa dell'uomo più che tutti gli altri venerato
e amato, per la perdita del maestro, del compagno, dell'amico». In tutta Italia
i comunisti organizzarono centinaia di manifestazioni, con enorme partecipazione
di popolo, per commemorare il genio che si collocava accanto a Marx e a Lenin.
Togliatti rientrò in Italia da Mosca il 6 marzo, e non fece cenno alle denunce
kruscioviane contro Stalin. Una settimana dopo, egli tenne una lunga relazione
al Comitato centrale del Pci, in cui affrontò anche la questione Stalin. Dopo
aver tracciato un quadro grandioso della società sovietica e dei suoi
straordinari progressi economici, sociali e civili, egli parlò delle critiche
che Krusciov aveva rivolto alla figura di Stalin. Togliatti disse: «Il compagno
Stalin ha avuto una grande parte, una parte positiva, nella lotta che ebbe luogo
subito dopo la morte di Lenin, per difendere il patrimonio leninista contro i
trotzkisti, i destri, i nazionalisti borghesi, per riuscire a prendere la strada
giusta di costruzione di una società socialista. Se questa lotta non fosse stata
condotta e non fosse stata vinta, l'Unione Sovietica non avrebbe riportato i
successi che ha riportato, e oggi forse nell'Unione Sovietica non esisterebbero
una economia e una società socialiste. Nel corso di questa lotta Stalin si
acquistò prestigio e autorità. Il suo errore successivo fu di mettersi, a poco a
poco, al di sopra degli organi dirigenti del partito, sostituendo a una
direzione collegiale una direzione personale. Si venne così creando quel culto
della persona che è contrario allo spirito del partito e che non poteva non
arrecare danni». Nessun accenno, da parte di Togliatti, al rapporto segreto di
Krusciov, che però venne pubblicato dal New York Times il 4 giugno, e poi fu
riprodotto dai grandi quotidiani italiani. Naturalmente, enorme fu il disagio
che si diffuse fra i comunisti. Le rivelazioni di Krusciov erano ben più
drammatiche dei toni edulcorati di Togliatti. Si imponeva subito una domanda: il
testo del rapporto segreto pubblicato in occidente era vero o no, era autentico
o no? L'Unità parlava del «cosiddetto rapporto segreto». Il mistero fu presto
sfatato. In un giorno di settembre del 1956, nella mia città (Ravenna) e in
molte altre città italiane, fu convocata dalla Federazione del Pci una riunione
(che si tenne in un'ampia sala di una sezione comunista), riservata ai dirigenti
di Ravenna e provincia: il Comitato federale, il direttivo della gioventù
comunista (di cui io facevo parte: avevo 17 anni), i sindaci e gli assessori
comunisti, ecc. Questa riunione (alla quale parteciparono alcune decine di
persone) fu presieduta da un autorevole esponente della Direzione del Pci, il
senatore Arturo Colombi. Il quale fece una lunga introduzione, e a un certo
punto disse: «e ora, compagni, veniamo al rapporto segreto di Krusciov
pubblicato dai giornali: è vero o non è vero, è autentico o no? Certo, compagni,
che è vero, certo che è autentico». Dalla sala si levò un accorato e struggente
«ohhh! ohhh!», che durò per parecchi secondi. Colombi reagì con rabbia:
«compagni, non dovete dire ohhh, non dovete scandalizzarvi, perché il nostro
partito ha un suo costume rigoroso: se non ha sconfessato il rapporto segreto,
ciò significa che esso è autentico!». I partecipanti a quella riunione uscirono
sconvolti, e molti di essi erano ormai convinti di una verità elementare ma
tremenda: che il mito dell'Urss e il mito della società comunista erano morti
per sempre.
Storia
d’Italia, 1957: dall’Euratom all’omicidio di Albert Anastasia.
Paolo
Guzzanti su Il Riformista il 22 Ottobre 2020. Fu a Roma che avvenne il
fattaccio. O se preferite il fatto meraviglioso. A me, anche allora che uscivo
dall’adolescenza selvaggia, sembrava un fatto enormemente burocratico: i grandi
della Terra, con le loro rispettabili Signore, segretari, parrucchieri, team ed
équipe, si calarono su Roma con ogni aereo, treno di lusso e limousine e il 25
marzo del 1957 fondarono l’Europa. Attenzione: non gli “Stati Uniti
d’Europa” come allora tutti speravamo, ma un’altra cosa, più pratica, di tono
minore, senza tanti mescolamenti perché moglie e buoi meglio se dei paesi tuoi.
Sempre Europa era, ma così doganale da sembrare dozzinale, tutta d’acciaio e
carbone da non sapere dove parcheggiarla, con il suo possente reparto economico
che trascinava un treno di casseforti su rotelle, e poi l’energia atomica. Ma ci
crederete? C’era, con l’Europa, l’Euratom, cioè la forza atomica energetica
europea. Non sto a rifare tutta la storia (per adesso) dei referendum che
cancellarono la possibilità dell’energia nucleare dal suolo italiano, ma ogni
volta che accendo la luce non dimentico che l’energia nella mia lampadina viene
dalle centrali nucleari francesi e che alla Francia io come tutti pago la
carissima bolletta e quanto ai rischi che possa accadere una sciagura alle
centrali francesi, condividiamo anche quel privilegio: di beccarci sia la
bolletta alta che il possibile rischio. Come è potuto accadere? Un sussurro, ma
non dire nulla intorno a voi, political correctness: le centrali nucleari sono
brutte e cattive, tutti gli altri ce l’hanno e noi no perché siamo furbi. Allora
l’Europa che vedevamo nascere nel 1957 non emozionava, non aveva ancora una
moneta (la più quotata era lo “Scudo”) né bandiere, non aveva un’anima ma
dovevamo tutti battere insieme le manine perché si stava realizzando davvero un
grande miracolo: Germania, Francia, Benelux, Italia e Austria erano state
finalmente denudate, legate e messe nello stesso sacco. Almeno in apparenza. In
realtà, Francia e Germania si assumevano la leadership dell’Europa e gli altri
sudditi avrebbero fatto finta di essere pari. Già si vedeva e sapeva. Ragion per
cui quando si parlava d’Inghilterra, tutti scuotevano la testa: ma figurati, gli
inglesi in Europa. Specialmente le prime due, per scongiurare la prossima
guerra. Era una scemenza. La Storia non si ripete mai specialmente sotto forma
di farsa e a garantire la pace non sarebbe stata l’Unione Europea ma l’arsenale
atomico di Usa e Urss, più i sub-arsenali di Francia, Gran Bretagna e Israele,
India e poi Cina. Farsi la guerra alla vecchia maniera? Improbabile: se tu mi
ammazzi, io prima di morire spingo il bottone rosso e da un sottomarino sotto
il Polo Nord e faccio partire un missile che ti farà sparire dal pianeta Terra.
Vale la pena soffermarsi un attimo su questo punto ingiustamente trascurato: da
che mondo è mondo, gli uomini si sono solo fatti guerre in tutte le generazioni
e luoghi. Ci fu una breve pax Romana, ma durò poco. Ciò che durò fu l’intervallo
fra la guerra franco prussiana del 1870 alla quale dobbiamo la cattura della
Roma papale da parte dell’Italia sabauda, e i colpi di pistola di Sarajevo che
innescarono la vera unica guerra mondiale, il cui seguito dal 1939 non fu che la
prosecuzione con conseguenze che esposero la malvagità umana oltre i limiti
conosciuti. C’era stata dunque la Belle époque, con il can-can, i pittori, le
automobili, qualche guerricciola coloniale con periferici bagni di sangue solo
indigeno, ma i caffè di Londra, Parigi, Berlino, Vienna, Roma,
Zurigo e Madrid avevano seguitato a servire sontuosi caffè. A Mosca meno,
perché Lenin ci insegnò che le rivoluzioni non sono dei pranzi di gala e poi
tutto finì nel sangue, nel disonore, nelle uova già dischiuse di guerra fredda,
ma pronta a diventare calda. Il gruppo di Altiero Spinelli e dei suoi
patriottici sodali a Ventotene aveva lanciato il manifesto ideale degli Stati
Uniti d’Europa e tutti avevano sognato questo giorno magnifico in cui francesi,
inglesi, tedeschi, italiani, spagnoli, danesi e norvegesi senza trascurare
olandesi e austriaci, si sarebbero abbracciati nelle varie lingue dando vita a
una federazione come quella americana che unisce cinquanta Stati sovrani. Nulla
di tutto questo. I sacri Trattati di Roma, da allora invocati ed evocati come le
leggi che Abramo ricevette da Dio in persona, erano montagne di carte, allegati,
traduzioni in dodici lingue e insomma l’idea di base era ancora quella di una
zona di libero scambio senza dogane che permettesse ad un gruppo di Paesi ricchi
di compensarsi a vicenda per le perdite di denaro alle frontiere e una certa
velocità nel trovare soluzioni condivise. Non molto più di questo Sottinteso:
così, almeno, Francia e Germania la pianteranno di farsi la guerra. Infatti,
Francia e Germania si dichiararono impero carolingio redivivo, la Germania che
ne aveva combinate troppe fu caricata di tutti i sensi di colpa di tutti gli
altri e invitata a non farsi più un esercito, cosa che Konrad Adenauer prese
bene: noi tedeschi dobbiamo smetterla di usare le armi per conquistare ciò che
possiamo ottenere attraverso la nostra economia a rullo compressore. Era nato
dunque un mercato comune senza dazi e molte sagge istituzioni che accantonavano
dentro per coloro che si fossero trovati in stato di necessità. Cambiare
bandiera? Ma quando mai. Di qui a un anno la Francia, spappolata dalle termiti
della quarta repubblica, sarebbe crollata in ginocchio per andare in
pellegrinaggio a Colombay Les Deux Eglises per supplicare le general Charles de
Gaulle, eroe della Resistenza non solo ai tedeschi ma anche agli americani,
francesi e anglofoni in generale, di prendere le redini de la République. Ma nel
1957 quella crisi non era ancora matura e la Francia stava al gioco. L’Italia
era una potenza energetica, nucleare e petroliera, le sue aziende andavano come
treni, la Fiat si era impossessata della fabbrica francese Seat che costruiva su
licenza le nostre Seicento e Cinquecento. Gli americani erano un po’ contenti ma
anche un po’ rosi dall’invidia perché l’America ha tutti i motivi per temere
l’Europa e già allora a Washington Adlai Stevenson disse che alla fine la terza
guerra mondiale l’aveva vinta la Germania che avrebbe avuto lo stesso bottino
che cercava Hitler, ma senza sparare un colpo. In Italia intanto si era
stabilito, senza tanto fracasso ma soltanto con qualche acceso discorso, che il
nostro Paese avrebbe fatto tesoro del più importante partito comunista
occidentale in eccellenti rapporti con l’Unione Sovietica, per un trattamento
commerciale di riguardo con il gigante russo, le cui commissioni sarebbero state
automaticamente riconosciute al Pci. In cambio, il Pci prometteva di lasciar
dormire sepolte e ben oliate le armi conquistate durante la Resistenza,
scoraggiando qualsiasi eventuale colpo di mano di frange
estremiste. Togliatti in questo senso aveva già dato prova di saggezza quando,
malamente ferito in un attentato, aveva fatto di tutto per placare gli animi e
spegnere le tentazioni insurrezionali. Il Pci non poteva formalmente approvare
l’Unione Europea perché a Mosca quel rilancio della Germania economica non
piaceva, seguendo l’eterno filo paranoico secondo cui qualsiasi rafforzamento
europeo si sarebbe tradotto in aggressione contro l’Urss. L’Unione Sovietica,
così come aveva risposto alla Nato occidentale creando il Patto di Varsavia, con
un criterio simile avrebbe rafforzato il già esistente Comecon per confederare
le risorse dei paesi satelliti con quelle della casa madre. I comunisti italiani
non condividevano granché, circolavano molte tesi eretiche di valutazione
positiva, ma per il momento dovevano esprimere sdegno e disprezzo per il
trattato di Roma. Il mio adorato professore di filosofia, comunistissimo e anche
ragionevolissimo, ci spiegò che questa comunità europea altro non era che la
riedizione dello Zollverein fra Paesi di lingua tedesca per una unione doganale
poi fallita. Nessuno avrebbe potuto immaginare una cosa come la Brexit, o
l’Euro, o “andare a battere i pugni a Bruxelles”. Allora si firmarono ben due
Trattati e i soci fondatori erano soltanto Francia Germania Belgio
Germania (Ovest) e Italia. Questo per la parte politica: economicamente veniva
al mondo anche il gemello dell’Unione e cioè la Cee, comunità economica europea.
I nostri Padri della patria firmatari erano Antonio Segni capo del governo con
il suo ministro degli esteri il liberale Gaetano de Martino. Per il Belgio c’era
il volitivo e ben pasciuto Paul-Henri Spaak, padre della ben più amata Catherine
Spaak. Konrad Adenauer, il cancelliere tedesco era l’uomo più ossuto e magro e
alto del mondo e i suoi zigomi con la sua fronte infossavano gli occhi che
sembravano avere uno sguardo inclemente. Belle ragazze che sembravano disegnate
da Disney indossarono gonne lunghe multicolori con le bandiere degli Stati e
quello fu l’unico aperto riconoscimento alle donne in uno scenario di tavolate
chilometriche con decine di camerieri, salviette, calici, brindisi, affreschi,
discorsi formali e informali, deposizioni di corone all’altare della Patria e
insomma un’orgia di formalità senza molto senso dell’umorismo, che però avevano
una forma e una ragione. Significavano non solo che la guerra era finita ormai
da più di un decennio, ma che l’Europa distrutta dai combattimenti e ricostruita
col piano Marshall era di nuovo competitiva, in prima linea, con questa novità
assoluta dei francesi e dei tedeschi che si tenevano per mano dopo essersene
date per settantacinque anni, salvo la pausa della Belle époque. Ma nel 1957 un
altro grande attore internazionale prese nuove forme e ne parleremo nel prossimo
articolo: la mafia. Non Cosa Nostra, ma la grande organizzazione transatlantica
che aveva dettato e seguitava a dettare condizioni in America e in Italia. Erano
i tempi in cui don Vito Genovese, “il Padrino” diventa il capo della mafia
americana. Joe Valachi, racconterà più tardi che le famiglie che contavano nel
1957 erano quelle di don Vito Genovese, Gaetano Lucchese, Giuseppe Magliocco,
Joseph Bonanno (alias Joe Bonanno, o Joe Bananas o Joe Bonanni) padrino di Joe
Valachi di Castellammare del Golfo e dei Gambino al cui capo, Albert
Anastasia fu tagliata la gola sulla poltrona del barbiere come risultato della
sentenza decretata dalle famiglie riunite nel summit di Palermo all’Hotel et des
Palmes. Grande storia.
LA CRONOLOGIA
DEGLI EVENTI DEL 1957.
17 gennaio
– Cuba: i barbudos castristi attaccano una guarnigione di polizia nella Sierra
Maestra. È la prima vittoria militare della guerriglia che poi sconfiggerà
Batista.
6 febbraio –
Italia: al congresso del Partito Socialista Italiano, il segretario Pietro Nenni
annuncia l’avvicinamento al Psdi di Giuseppe Saragat e la fine della
collaborazione con il Pci di Palmiro Togliatti.
6 marzo – il
Ghana è il primo stato dell’Africa occidentale ad ottenere l’indipendenza.
25 marzo – Sei
paesi europei firmano il Trattato di Roma, istitutivo delle Comunità economica
europea (Cee) e Comunità europea dell’energia atomica (Euratom): Italia,
Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.
Giugno – Urss:
fallisce il tentativo di destituire il segretario del Pcus Nikita Kruscev.
Egitto: l’Unione Sovietica invia sommergibili nel Canale di Suez.
4 luglio
– Italia: esordisce sul mercato automobilistico la Fiat 500.
25 luglio
– Tunisia: abolizione della monarchia e proclamazione della Repubblica. Habib
Bourguiba diventa il primo Presidente della Repubblica.
12 settembre
– Enrico Mattei conclude con lo scià Mohammad Reza Pahlavi un accordo per lo
sfruttamento dei giacimenti petroliferi iraniani.
24 settembre
– Little Rock, Arkansas: una folla di cittadini respinge nove bambini neri da
una scuola pubblica. Il presidente Eisenhower invia mille paracadutisti sul
posto per far rispettare la legge.
24 settembre
– Algeria: truppe francesi catturano Saadi Yacef, uno dei leader del Front de
Libération Nationale.
25 ottobre
– New York: Albert Anastasia, gangster italoamericano, viene assassinato mentre
è seduto sulla poltrona del barbiere. La decisione è stata presa a Palermo in
una storica riunione mafiosa all’hotel et des palmes.
3 novembre
– Unione Sovietica: lancio nello spazio dello Sputnik 2, con a bordo la cagnetta
Laika, che muore 7 ore dopo il lancio.
19 dicembre
– La Nato decide di installare basi missilistiche in Europa.
Storia d’Italia, 1958: dall’affermazione della Dc alla morte di
Papa Pacelli.
Paolo Guzzanti su Il Riformista l'11 Novembre 2020. Non vorrei che pensaste che
il 1958 fosse un anno da buttar via. Ci furono tsunami mai visti con onde alte
mezzo chilometro, stragi, catastrofi naturali e innaturali, ma più che altro
l’Italia ebbe il suo nuovo e vero inno: Volare. Senza offesa, io detesto
il festival di Sanremo e spero mi perdonerete. Detesto il festival, il suo
mondo, il 99 per cento della sua musica e del suo parolaio imbecille, soffro per
chi ne gode e per chi lo aspetta con trepidazione come il miracolo ligure di san
Gennaro, ma con più sorprese. Ciò dipende soltanto dalla mia natura malvagia che
ho tentato inutilmente di riparare. Ma Nel blu dipinto del blu fu uno shock
benefico benché arrivasse da San Remo del 1958 perché dopo tante barche che
tornavano sole, mamme di cui (pure) ce n’è una sola benché in gioventù fosse
rimasta avvinta come l’edera fra personaggi psichiatrici sull’orlo del suicidio
– “per me è finita” gridava Claudio Villa davanti a un innocente binario- ecco
che ti arriva questo Domenico Modugno con un testo e una voce e una postura fra
il futurista e il quadro di Chagall. Niente famiglia, niente storia, niente
realtà, soltanto un sogno monocromatico blu. Non suona il violino su un tetto
come un ebreo notturno che guarda una mucca galleggiante, ma una creatura
quantistica e puerile che infila le mani in una poltiglia azzurrastra e se la
sparge sulla faccia ciò che gli permette di decollare in verticale e volare nel
cielo infinito, oh-oh. Eravamo tutti per strada a cantarla: il fratello di mia
madre, un serissimo intellettuale comunista fu trovato di notte a cantare nel
blu dipinto di blu sui marciapiedi deserti e subito radiato (non espulso) dal
Partito. In America chiesero il significato di quelle parole e poi
sussurrarono: “oooh! is he flying in the sky in a deep blu immersion?”. E
diventammo ciascuno di noi italiani Mister Volare. Modugno era l’uomo dio di
un’Italia più inaspettata che nuova, riscattata perché surreale e lo rimase per
anni anche perché responsabile di altri capolavori come Vecchio Frac. A me in
quell’anno capitò la ventura di compiere inutilmente 18 anni in un mondo che non
prevedeva, la passione, l’amore, meno che mai le coppie. Ce ne stavamo torvi e
pieni di ormoni, acne e trasalimenti a ogni zaffata primaverile e ci saremmo
innamorati di uno scoiattolo o di una rondine. Invece mi rimandarono in latino e
greco sicché la mia austera famiglia mi mandò “a dozzena”, ovvero a pensione, a
casa del più grande latinista del tempo, il professore Attilio
Fantinati di Ferrara, che preparava le versioni di latino e greco per gli esami
di maturità. Si mangiava una zuppa detta “la minestra imminestrata” e poi mi
trascinava lungo il Po per ripetere ad alta voce e imparavo a tradurre dal
latino in greco antico e viceversa con i discorsi sulla prima decade di Tito
Livio del Machiavelli, dove imperversavano parole come “perciossiacosaché” che
registravo su un robusto quaderno nero con il filo in rosso con grafia da frate
amanuense, Come conseguenza, credo, diventai comunista sovietico leninista
intransigente nemico della civiltà occidentale, dogmatico, tassativo,
antiamericano, ateo furioso (l’ateismo era una rigorosa religione) e dunque
quando il presidente americano Dwight Eisenhower fece sbarcare in Libano, boots
on the ground, alcuni reggimenti di marines, restai scioccato dalla potenza
delle foto che pubblicò allora l’Espresso in cui si vedevano questi soldati
statunitensi calmi e potenti, affardellati e lievemente tristi, su un terra
straniera di cui non sapevano nulla e che poi avrei frequentato moltissimo come
giornalista, poco manca che ci lasciassi la pelle. Queste mie convulsioni ideali
e ideologiche dettero vita a un infuocato carteggio fra me e mio padre a Roma
con cui duellavo apertamente e che duellava a sua volta con logica e rabbia,
cosa che mi fu molto utile. Fine dei ricordi troppo personali. Quanto all’anno,
l’Europa si consolidava ma in realtà si spaccava perché la Francia, dilaniata
dalle guerre coloniali e dai numerosi generali e colonnelli pronti al colpo di
Stato, era lì-lì per consegnarsi al padre della patria Charles De Gaulle, di cui
ieri abbiamo ricordato i cinquant’anni dalla morte. Imperversava la guerra
coloniale in Algeria, il Fronte di liberazione nazionale colpiva militarmente e
i francesi facevano saltare le case con la gente dentro, ciò che Gillo
Pontecorvo raccontò nel suo magnifico film La battaglia d’Algeri. Il sesso era
ancora proibito ed era di pessimo gusto parlarne o alluderne, seguendo lo stesso
destino dei servizi segreti secondo le buone norme dell’aristocrazia britannica,
ma Vladimir Nabokov pubblicò lo spudorato capolavoro erotico Lolita, storia di
una dodicenne e di un quarantenne scritto da uno che era scappato a gambe levate
dalla Russia sovietica: bestseller, oggi quella storia arderebbe sul rogo nel
fuoco perenne perché racconta l’eros e l’istinto, la finzione delle barriere
d’età, tanto che se ne impossessò Stanley Kubrick. Mentre nel cosmo esplodeva il
primo satellite umano e sovietico Sputnik, nascevano il microchip e il pacemaker
e la senatrice socialista Merlin riuscì a far approvare la legge che chiudeva le
case chiuse – che sembra un controsenso e lo è – ma chiudeva l’azienda di Stato
magnaccia, restava lo Stato spacciatore di alcolici e tabacchi cancerogeni, ma
le signorine a settimana furono spedite a cercarsi alloggio altrove. Tralascio
la retorica della letteratura dei bordelli perché non fa parte della mia
generazione e l’ho trovata sempre un po’ attaccaticcia e retorica. Restarono in
voga espressioni come “fare melina”, “ragazzi in camera”, “marchette” e altre di
un mondo che era già morto. Bella rapina moderna di stile americano a Milano in
via Osoppo con oltre cento milioni di bottino, e promozione dell’Italia al rango
di grande paese evoluto anche dal punto di vista criminale. In Sicilia la mafia
seguitava a mettere in bocca al morto un sasso o un pesce o, in casi
particolari, i suoi propri genitali usati in maniera sconsiderata. Ah, e la pala
di ficu d’Igna. Al Sud eravamo ancora arretrati col delitto d’onore, ma anche al
Nord, specie da quando partivano i treni delle valigie di cartone che portavano
gli ex contadini calabresi, siciliani, pugliesi e campani nelle case di
ringhiera di Milano e Torino, trattati come negri in Alabama e famosi per usare
le vasche da bagno come pollaio o orto per la cicoria. Ma esce anche il grande
capolavoro di Tomasi di Lampedusa – di una famiglia che quando comprava camicie
si trasferiva a Londra – il Gattopardo la cui morale ben nota è che tutto deve
cambiare affinché possa restare come prima, segue film magnifico di Luchino
Visconti con Alain Delon, Burt Lancaster e Claudia Cardinale, uno dei pochissimi
film sul nostro Risorgimento. Del resto, Visconti si era già esibito in Senso,
dove una perversa aristocratica italiana manda alla fucilazione il suo infedele
amante austriaco. A metà giugno sui gradini di legno della forca salgono sul
patibolo i due eroi comunisti della rivoluzione antisovietica ungherese Imre
Nagy e Pal Malèter. Ma non li impiccano alla maniera londinese con botola e
morte istantanea, sono strozzati in piedi legati a una tavola da un boia che
stringe loro il collo, con un attrezzo che somiglia più alla garrota spagnola
usata da Francisco Franco che alla forca nostrana. Fra tante canzoncine,
canzonacce e magnifiche canzoni emerge una diciottenne sconosciuta e pressoché
angelica, ma terrestre: Mina. Successo immediato e quasi magico su cui nessuno
ha nulla da ridire, neppure io che sono una bestia. Ma c’è di più: Borís
Pasternàk, l’autore sovietico dissidente del Dottor Zivago riceve dal comitato
della Corona svedese il premio Nobel per la letteratura ed è costretto dalle sue
adorabili autorità moscovite a rinunciare. I comunisti occidentali borbottano,
disquisiscono, la prendono alla larga, ma leggono tutti il romanzo comprato e
pubblicato da un loro editore, Giangiacomo Feltrinelli, che salterà poi in aria
a Segrate mentre cercava di sistemare una bomba. E muore Papa Pacelli, Pio
XII, l’anticomunista magro, alto e conservatore che aveva combattuto il
comunismo come un crociato, ma anche quello che aveva dispiegato le sue bianche
ali sulle macerie di Roma dopo il bombardamento del 19 luglio del 1943, quello
che causò le dimissioni e l’arresto di Mussolini. Anche la Chiesa volta pagina.
E così Santa Romana chiesa elegge un uomo che sembra semplice e anzi
semplicione: il patriarca di Venezia Angelo Roncalli che riesuma un antico nome
papale: Giovanni. Ed è Giovanni XXIII. Era stato un grande diplomatico
sotto papa Pacelli, un uomo erudito e scaltro, ma estremamente onesto. Viene
accreditato di una presunta “apertura a sinistra” che manda in bestia i
cattolici conservatori italiani. Ma tira proprio aria di apertura a sinistra,
senza i comunisti – ancora – ma a sinistra. I socialisti di Pietro
Nenni cominciano a prepararsi e a compilare liste sia di occupazione che di
proscrizione in quella che il leader socialista chiama la “sala dei bottoni”.
Siamo agli albori di una nuova era laica, in cui gli anticomunisti socialisti
come Riccardo Lombardi sono però dei radicali di sinistra in fatto di economia e
comincia a circolare una parola proibita: nazionalizzazione di banche, enti,
elettricità specialmente e si apre un fronte di guerra interno sempre più
violento. L’anno volge al termine e se tornate sulle tracce del Padrino, il
film, ricorderete che approssimandosi la fine dell’anno, il generale
Fulgencio Batista sente che i colpi di mitra di Fidel Castro e dei suoi barbudos
si fanno troppo vicini e chiede agli amici americani di trasferirlo in Florida.
Fidel è giovane, Ernesto “Che” Guevara è giovane e bello, a Cuba si comincia ad
andare al “paradòn” cioè al muro perché i guerriglieri fucilano volentieri ma
rassicurano gli americani: non siamo e non saremo mai comunisti, non
preoccupatevi. Ma il generale e presidente Eisenhower si preoccupava e lasciò
mano libera a chi gli consigliava, in caso di vittoria di Castro, di organizzare
uno sbarco di esuli per riconquistare Cuba, ma questa è un’altra storia e
bisognerà attendere qualche anno prima di scoprire che Castro aveva un
informatore nella Cia, sicché quando lo sbarco avvenne si risolse in un
disastro.
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1958
1° gennaio – Entra in vigore il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità
Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM),
firmato da: Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.
31 gennaio – Gli USA lanciano nello spazio il loro primo satellite artificiale,
Explorer 1.
6
febbraio – All’aeroporto di Monaco di Baviera un aereo di linea, a bordo del
quale viaggia la squadra di calcio del Manchester United, si schianta. Di
rientro dal match contro la Stella Rossa, muoiono così 23 persone, fra cui otto
giocatori e otto giornalisti. Di quella formazione si salverà, tra gli altri, un
ventenne Bobby Charlton, diventato in seguito una leggenda del calcio mondiale:
vincerà Pallone d’oro, Mondiali e Coppa dei Campioni, la prima nella storia dei
Red Devils.
20 febbraio – Viene approvata la legge Merlin che dichiara illegittime le case
di tolleranza.
25 maggio – Alle elezioni politiche si afferma la Democrazia Cristiana.
29 giugno – Ai mondiali di calcio in Svezia, la nazionale di calcio del Brasile
vince il titolo per la prima volta.
9
luglio – In Alaska un terremoto di 7.9 gradi sulla scala Richter genera una
frana in mare, la quale conseguentemente provoca una colossale onda di 525 metri
che travolge l’intera Lituya Bay.
14 luglio – Colpo di Stato militare in Iraq: alla guida del paese viene nominato
il generale Abdul Karim Kassem.
29 luglio – Il presidente Dwight D. Eisenhower costituisce la NASA.
28 settembre. In Francia viene approvata con un referendum la nuova
Costituzione. Nel paese è istituita la Repubblica presidenziale.
9
ottobre – A Castel Gandolfo, provincia di Roma, muore Papa Pio XII.
23 ottobre – Lo scrittore sovietico Borís Pasternàk vince il premio Nobel per la
letteratura. Sarà costretto dalle autorità politiche del suo paese a
rinunciarvi.
28 ottobre – Viene eletto a sorpresa come neo pontefice il cardinale Angelo
Giuseppe Roncalli, già Patriarca di Venezia, il quale assume il nome di Giovanni
XXIII.
7
dicembre – Viene inaugurato il primo tratto dell’Autostrada del Sole, da Milano
a Parma.
Il
guzzantino. Storia d’Italia, 1959: quando non si parlava della mafia che
cresceva.
Paolo Guzzanti su Il Riformista il 19 Novembre 2020. L’anno che venne dopo, il
1960, sarebbe stato un Annus terribilis ma anche fulminante, tra i “fatti di
luglio” e “La dolce vita” di Fellini (biglietto a mille lire, mai visto prima).
Il 1959 fu uno di quegli anni che somigliano alla prima fase di una partita di
scacchi: quando si dispongono i pezzi da usare per piani segreti. La terza
guerra mondiale, che non c’è mai stata, fu in quel biennio sempre più incombente
e imminente. Il nuovo dittatore sovietico, il contadinesco ma abilissimo, e in
guerra anche eroico, Nikita Kruscev, fece organizzare una visita ufficiale
in Albania, all’epoca ancora un dominio sovietico, per pronunciare un
violentissimo discorso proprio contro di noi: “Se l’Italia si azzarderà ad
autorizzare l’installazione di missili americani, sappia che siamo pronti a
farla sparire dalla faccia della terra”. Un po’ di chiasso, ma neanche tanto.
Era normale. Le minacce militari nonché gli schieramenti di missili erano
all’ordine del giorno. In America era ancora presidente l’ex comandante supremo
degli eserciti alleati in Europa e Africa, Dwight Eisenhower, un presidente
eccellente e calmo, tuttavia bersaglio di tutti gli imitatori e attori satirici
per la scheletrica ovvietà dei suoi discorsi. A gennaio Fidel Castro con i suoi
barbudos (soltanto i guerriglieri che avevano combattuto alla macchia nella
Sierra erano autorizzati a non radersi come prova degli anni passati lì) si
insediò formalmente al governo di Cuba, riconosciuto da tutti i grandi Paesi fra
cui gli Usa che avevano per quell’isola un amore particolare e piuttosto
invadente, poiché era stata anche fino ai primi del Novecento l’ultima colonia
spagnola in America. Per quest’ultima motivazione, Cuba era particolarmente
curata, specialmente riguardo sanità e istruzione (che diventarono poi due
cavalli di battaglia del castrismo) così tutti si chiedevano da che parte
stesse. Il vicepresidente di Eisenhower era Richard Nixon, brillantissimo
avvocato che poi diventerà presidente e finì dimissionario nel 1972 per
lo scandalo Watergate (microspie nel quartier generale del Partito democratico)
reso noto da due giornalisti considerati mitici – Carl Bernstein e Bob Woodrow –
che ricevevano misteriosi pizzini da uno sconosciuto e diabolico personaggio che
nelle intercettazioni era chiamato “gola profonda”. Da allora, ogni volta che si
parla di un ispiratore segreto, in inglese oggi si usa il
termine “whisteblower”, ossia uno che spiffera ma come agente sotto copertura.
La storia è popolata dalle gole profonde e dai whisteblower che agiscono come
oscure divinità olimpiche, determinando il destino delle nazioni attraverso
intermediari ambiziosi che fanno carriera grazie alle soffiate, capaci di
determinare la linea politica e giudiziaria dei loro giornali, appesi alla
speranza dello scoop, come in Italia molti anni dopo imparammo da inchieste
extraterrestri come Mani Pulite, la vicenda Lockheed e molti dritti e rovesci
sulla mafia. Nel 1959, ad esempio, il primo dei grandi pentiti (che poi,
trent’anni dopo, fu gestito personalmente da Giovanni Falcone), e cioè Tommaso
Buscetta, fu arrestato a Palermo per faccende di piccola criminalità:
contrabbando di sigarette, associazione per delinquere e altre piccole
immondizie. Aveva 30 anni. Arrestato, ma subito liberato grazie al suo santo in
paradiso che era un deputato democristiano. A suo tempo vedremo come questo
personaggio diventò un protagonista di quel mondo occulto, costretto alla fuga e
riacciuffato in Brasile per essere messo sottochiave da Falcone – siamo ancora
lontani da quei tempi, che però maturavano come nelle complesse aperture di una
buona partita di scacchi. Le vicende cubane e quelle della mafia siciliana erano
procedute per anni in un intreccio che vedeva gli investimenti
nella Cuba di Fulgencio Batista e della sua rete di casinò, nel giardino di casa
degli americani che la consideravano un Paese accessorio, se non conquistato, a
causa della guerra di liberazione dalla Spagna che portò nell’orbita americana
anche tutti gli altri territori coloniali spagnoli, fra cui le Filippine che
diventarono e sono tuttora un pezzo importantissimo della politica in estremo
oriente. Dunque, Fidel Castro era ancora un fanciullone che aveva giocato con le
armi e le romantiche notti di agguati e sparatorie sotto le mura della Caserma
Moncada, e ancora nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato il pezzo più
importante della politica sovietica e poi la causa della crisi dei missili per
cui il mondo tremò per alcuni giorni, ma soltanto alcuni anni dopo. Allora Fidel
era un personaggio elementare e carismatico, non un genio, ma popolarissimo.
Eisenhower chiese al suo vice Nixon di capire da che parte stava e Nixon
invitò Fidel Castro a Washington per discutere la richiesta cubana di fondi con
cui finanziare la ripresa economica dell’isola dove i rivoluzionari avevano
distrutto il tessuto di case da gioco, bordelli, poker e scommesse in cui
sguazzavano anche le grandi famiglie siciliane. Qualche mese prima, Albert
Anastasia, il mammasantissima degli italoamericani, aveva avuto la gola tagliata
a New York sulla sedia del suo barbiere, in seguito agli accordi presi dalle
grandi famiglie nella riunione del 26 ottobre del 1957 nei saloni splendidi e
decadenti dell’Hotel Le Palme di Palermo. Lì, dove si fermava anche Frank
Sinatra, un divo stellare i cui rapporti con Cosa nostra erano noti quanto
quelli con la sua eterna fidanzata e poi ex moglie Mia Farrow che poi
sposò Woody Allen, con tutto il frastuono che ne seguì per le accuse da caccia
alle streghe scatenate contro il geniale regista, colpevole di essersi
innamorato e poi di aver sposato una delle figlie adottive della ex moglie.
Quest’ultima nel frattempo gli aveva donato, come unico suo figlio naturale, un
pupo oggi famoso giornalista e femminista che è il ritratto sputato di Frank
Sinatra, detto anche “The Voice”, la più calda e passionale voce d’America. Ma,
ricordiamolo ancora una volta, tutti questi brandelli di storia che nel 1959
vediamo dispiegarsi sulla scacchiera del mondo, daranno luogo a grandiosi e
tragici finali di partita di cui allora ancora nessuno sapeva niente. E
così, Richard Nixon accolse Fidel Castro a Washington e passò un paio di giorni
con lui per capire che tipo fosse questo guerrigliero che giurava di non essere
comunista ma lo sembrava. Poi ne riferì a Eisenhower: “È un tipo che trascina le
folle. Ha idee un po’ rozze ma sembra un ragazzo in buona fede. Vorrebbe il
nostro aiuto finanziario, ma non intende concedere risarcimenti per le imprese
americane che ha nazionalizzato. Dice che è nostro interesse aiutarlo,
altrimenti sarà costretto a rivolgersi altrove”. Dove l’avevamo già sentito
questo ragionamento? Ma sì, Gamal Nasser il nuovo bellissimo rais dell’Egitto,
il quale pensava che gli inglesi o gli americani avrebbero dovuto finanziare i
suoi sogni un po’ faraonici come la diga di Assuan e che poi quando si vide
sbattere la porta in faccia si rivolse a Mosca. Il gioco, visto oggi a ritroso,
era abbastanza semplice, ma allora pochi capivano in che modo girasse il mondo.
L’occidente americano era anticomunista e anche in Europa tiravano venti
bipolari, nel senso che tutti i gruppi ex fascisti o neofascisti pensavano che
fosse giunta la loro ora per tornare al comando. Al Comune di Roma si facevano
le prove per giunte anticomuniste col sostegno missino. Ciò spingeva comunisti e
socialisti a una radicalizzazione che poi, l’anno successivo, con il governo del
democristiano Tambroni (formalmente di sinistra ma che si alleò con i
neofascisti del Msi per avere la maggioranza) diventò un’insurrezione popolare
con decine di morti e feriti. Quasi una rivoluzione, che Palmiro
Togliatti riuscì a contenere e frenare ma che sconvolse il Paese creando
premesse per altre inaspettate conseguenze. La situazione internazionale e
specialmente cubana portò a riassetti drammatici nella mafia siciliana: il capo
dei capi, l’idolatrato e indiscusso signore di tutte le cosche, il medico ma
anche assassino nonché capo dei corleonesi Michele Navarra, fu fatto fuori sulla
strada statale 118 in località San Isidoro. Si disse subito che a premere il
grilletto era stato l’astro nascente del momento, e cioè Luciano Leggio detto –
non si sa perché – Liggio. Si sparò per un paio di mesi col bilancio finale di
nove morti ammazzati e uno strascico giudiziario eterno che vide alla fine tutti
assolti, e stiamo parlando di nomi non ancora famosissimi, ma del calibro
dei Provenzano, Liggio, Riina e Bagarella. Di mafia a quei tempi si parlava poco
e di malavoglia anche nei tribunali. Il nome di Cosa Nostra diventerà un valore
aggiunto portato da Buscetta, che diede a Falcone tutte le password necessarie
per leggere il grande libro nero. Nei tribunali e nelle sentenze si parlava con
distacco di criminalità organizzata. Ma la grande rete siciliana – quella della
calabrese ‘ndrangheta era ancora un fritto misto di piccole ‘ndrine locali,
tributarie della mafia siciliana e allora di poco conto – aveva santi in tutti i
paradisi: servizi segreti italiani e stranieri, politica locale e nazionale,
gerarchie ecclesiastiche, corpi di polizia e giornalismo. In quel coacervo
ancora indistinto ed esplosivo come il Big Bang spiccava un personaggio di
assoluto rilievo: Michele Sindona, che un quarto di secolo più tardi dopo finirà
– come Gaspare Pisciotta, il cognato assassino di Salvatore Giuliano –
avvelenato in carcere con una tazzina di caffè corretto. Sindona era un uomo
spregiudicato e dinamico, si sentiva con le spalle coperte ed era capace di
combattere mediaticamente. Viveva a Milano dove i siciliani di New York avevano
una delle loro basi migliori in quegli anni, e nella capitale lombarda entrò nel
giro d’affari della mafia americana attraverso Joe Adonis (al secolo, Giuseppe
Antonio Doto, nato a Montemerano, presso Napoli, nel 1902 e che fino al 1972
ebbe lo stesso potere nazionale e internazionale di Lucky Luciano, di cui fu
allievo fedelissimo). Luciano durante la guerra aveva lavorato per la marina
militare americana, costituendo un fronte del porto di New York contro le spie
tedesche che trasmettevano ai sottomarini U-Boat della marina hitleriana le
rotte dei convogli destinati alla Gran Bretagna perché fossero silurati e
affondati. Il lavoro di questi mafiosi di New York a caccia di nazisti però fu
poco più che una messinscena, utile soltanto per regolamenti di conti nella
criminalità di Manhattan. Ma finché la guerra non finì, Lucky – che vuol
dire “fortunato” – Luciano ebbe un trattamento carcerario principesco, con
puttane, cuochi e camerieri, quadri d’autore e liquori, ma sempre chiuso dentro
le turrite mura di Sing-Sing, oggi museo nazionale e curiosità storica. Quando
la guerra si concluse, sperò di avere se non una medaglia al valore almeno un
perdono per meriti patriottici. Ma non tirava più aria per tipi come lui e gli
americani lo espulsero come indesiderato perché era arrivato clandestinamente da
bambino senza mai procurarsi uno straccio di certificato che lo rendesse un
cittadino americano. Così, fu scaricato all’alba da un bastimento nel porto
di Napoli con bauli di vestiario, alla continua ricerca di giornalisti e
cineasti con cui sperava di raccontare la propria storia e leggenda. Erano
personaggi grandiosi, odiosi e terribili, questi mafiosi di New York, come don
Vito Genovese, Carlo Gambino o il bandito finanziere Louis “Lepke” Buchalter che
sapeva riciclare i proventi del crimine in fiorenti attività lecite. Adonis fu,
come Luciano, uno dei gangster rispediti in Italia dagli Stati Uniti perché,
come Luciano, ignoto all’anagrafe. Ma in Italia diventò presto famoso per la sua
catena di ristoranti “Joe’s Italian Kitchen” dove riceveva americani di un certo
livello cui faceva recapitare dai suoi camerieri armati buste piene di dollari.
Questo, anche, era il giro in cui si ritrovò Michele Sindona, il quale entrò fin
troppo nello spirito di questa società che sarebbe riduttivo definire
semplicemente mafiosa. Fu attraverso i mille canali di affari, ricatti,
guadagni, minacce e regolamenti di conti che Tommaso Buscetta trovò la sua
strada per levarsi di dosso i fastidi di due accuse di omicidio, mettendosi agli
ordini di un altro straordinario e quasi leggendario personaggio di questo mondo
infernale: quel Salvatore Greco detto “Chicchiteddu” o anche “Ciaschiteddu”,
ovvero l’uccellino, lo scricciolo, che con quella sua aria da passerotto
comandava le truppe e le retrovie di Ciaculli e che bisognava sempre citarlo con
i soprannomi per non confonderlo con altri e omonimi galantuomini, a loro volta
distinguibili per soprannomi come “l’Ingegnere”, “il Lungo”, “il Senatore” o il
fratello Michele Greco detto “u’ Papa”. Tutti personaggi con cui entrò in
familiarità Buscetta arrivando fino a Lucky Luciano. Al governo nazionale si
succedevano i democristiani di valore come Segni, Fanfani e Moro che però fra
loro erano in ostile antagonismo, ognuno alla ricerca della formula magica per
governare contro i comunisti, senza inimicarseli troppo e con l’aiuto dei
fascisti, senza amicarseli troppo. Un gioco pericolosissimo che nel breve giro
di un anno portò a tragiche conseguenze cui ancora prolungano i loro effetti.
LA CRONOLOGIA
DEGLI EVENTI DEL 1959
1° gennaio
– Il dittatore Fulgencio Batista abbandona l’Avana e fugge da Cuba. Fidel Castro
entra nella capitale del Paese in testa alle sue truppe.
8 gennaio – Al
Palazzo dell’Eliseo in Francia, René Coty, ultimo presidente della Quarta
Repubblica, passa le consegne a Charles de Gaulle, primo presidente della nuova
Costituzione.
26 gennaio
– Nel nostro Paese cade il secondo governo Fanfani. Il politico abbandonerà
anche la carica di segretario della Democrazia Cristiana.
3 febbraio –
In un incidente aereo perdono la vita i giovani musicisti Richie Valens, Buddy
Holly e J.P. “The Big Bopper” Richardson. È ricordato come il giorno in cui
muore la musica.
15 febbraio
– Il nuovo Governo italiano è presieduto da Antonio Segni.
9 marzo
– Viene venduta la prima Barbie, bambola destinata ad avere un enorme successo
commerciale.
14 marzo
– Aldo Moro è il nuovo segretario politico della Democrazia Cristiana.
17 marzo
– Dopo violenti scontri con gli occupanti cinesi, il XIV Dalai Lama fugge dal
Tibet alla volta dell’India.
8 maggio
– Viene festeggiata ufficialmente per la prima volta in Italia la festa della
mamma.
17 maggio
– Fidel Castro annuncia alla radio l’approvazione della legge per la riforma
agraria. I terreni dei possedimenti americani sono espropriati.
31 luglio – In
Spagna viene fondata l’ETA, un’organizzazione armata terroristica
basco-nazionalista d’ispirazione marxista-leninista, il cui scopo è
l’indipendenza del popolo basco.
24 settembre
– Inizia su Raiuno lo Zecchino d’Oro.
25 settembre
– Si incontrano a Camp David il presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower e
il segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, Nikita
Khruscev, dando avvio a una prima fase di distensione delle relazioni
internazionali.
7 ottobre – La
sonda russa “Luna 3” fotografa per la prima volta la faccia nascosta del nostro
satellite.
21 ottobre
– Viene inaugurato a New York il Guggenheim Museum, realizzato dall’architetto
Frank Lloyd Wright.
29 ottobre
– Esce in Francia sul periodico Pilote la prima storia a fumetti di Asterix.
1° dicembre
– Firma del Trattato antartico.
2 dicembre
– Nel Fréjus crolla la diga di Malpasset e l’inondazione che ne segue provoca
421 vittime. È il più grande disastro nella storia francese.
Il
guzzantino. Storia d’Italia, 1960: l’anno delle Olimpiadi di Roma che
trasformarono la città in un cantiere.
Paolo Guzzanti su Il Riformista il 26 Novembre 2020. Fu un anno di sangue e
gioia, il 1960 con quell’aria così tonda, nitida, da anno-design. Eppure fu un
anno anche terribile, oltre che pieno di vittorie e stupore, perché senza quasi
preavviso scoppiò una mezza guerra civile antifascista con molti morti e feriti,
anche l’avvenimento più grandioso, indimenticabile e pacifico fu quello
delle Olimpiadi di Roma con Giovanni Berruti (un ragazzino, un anno più grande
di me) che prese l’oro sui duecento metri e il grande Cassius Clay (che poi
scelse il nome islamico Mohamed Alì) che conquistò il titolo di campione del
mondo nei pesi massimi. Da allora la boxe è stata messa al bando in Europa e
pochi possono ricordare le emozioni televisive in bianco e nero del
combattimento di un uomo contro un uomo. Le Olimpiadi furono un evento
fantastico, urbanistico, televisivo, di costruzioni gigantesche, quartieri
interi che sorgevano per gli atleti – il Villaggio Olimpico – poi destinati a
edilizia popolare. Ma fino all’inizio ufficiale dei giochi la città sembrava
devastata da un terremoto di fango e invasioni aliene di macchinari scintillanti
e giganteschi che ci davano la sensazione di essere primi al mondo nel
trasformare una città antichissima in una Olimpiade per lo sport. Nacque così
la “la Via Olimpica”, oggi tangenziale, che fece scoprire ai romani quanto si
potesse correre su quella piccola autostrada che precorreva i raccordi anulari,
con l’uso di due gallerie che erano state scavate per caso, un’iniziativa del
ministro socialdemocratico Romita, per dar lavoro ai disoccupati messi senza
avere idea di come avrebbero potuto essere utilizzate. E furono utilizzate. Ma
mentre gli studenti soffrivano agli esami finali della maturità, giornali e
telegiornali esplosero con titoli da guerra civile per i drammatici e
inattesi “fatti di luglio” con scontri violentissimi fra operai, studenti e
polizia che si conclusero col bilancio di una ventina di morti fra Reggio
Emilia, Palermo, Genova e altre città italiane. Si trattò di una vera
insurrezione, motivata da una mobilitazione antifascista per impedire che i
neofascisti del Movimento sociale italiano di Giorgio Almirante rientrassero nel
gioco politico del governo e celebrassero il loro congresso nella città
di Genova, medaglia d’oro della Resistenza. Tutto scoppiò a giugno quando i
portuali di Genova – i “camalli”- che usavano un grosso uncino di ferro come
strumento di lavoro per scaricare le balle dalle navi, ma anche un’arma
leggendaria durante i combattimenti per strada, si radunarono e decisero di
impedire ai neofascisti del Msi di fare il loro congresso e scorrazzare a loro
piacimento per la città. La guerra era davvero finita? Assolutamente no, secondo
una parte del Partito comunista che, ad anni dalla fine della guerra seguiva
ancora la linea dell’antifascismo militante, militare e pronto alle armi. Niente
fascisti, niente allarme antifascista. Ma le cose andarono subito lontano;
l’organizzazione dei portuali e del partito a Genova se ne infischia dei divieti
della prefettura e raduna gli iscritti e gli ex partigiani che vengono caricati
dalla polizia, come previsto. Il partito, o almeno larga parte di esso, ha
deciso di rispondere ai divieti di legge con una mobilitazione che nessuno
avrebbe potuto pensare di sciogliere e così fu. La Genova rossa dei camalli, dei
lavoratori puri e duri nell’unica città italiana in cui la Resistenza – guidata
dal democristiano Paolo Emilio Taviani – ottenne la resa armata delle forze
tedesche prima che gli americani arrivassero, dette alla capitale ligure un
potere mai eguagliato da altre città. E la Genova rossa vince, La Cgil convoca i
suoi iscritti, la Cisl lascia libertà di aderire, la Uil socialdemocratica è
contro lo sciopero ma tutti sentono che la massa scesa in piazza non potrà esser
respinta con la forza e così gli scontri si prolungano fino al 2 luglio quando
il prefetto, cioè il ministero degli Interni, si arrende: il congresso
del Msi che avrebbe dovuto celebrare il ritorno di un partito neofascista al
centro, viene vietato. Ottenuta la vittoria il gruppo dirigente comunista
della Cgil incassa la vittoria e da ordine di sospendere lo sciopero, cosa che
fece autonomamente senza neanche dirlo ai socialisti. Pietro Nenni che era stato
anche uno dei grandi leader della Resistenza commentò: «Com’era facile
prevedere, la vittoria antifascista di Genova viene usata dai comunisti in
termini di frontismo, di ginnastica rivoluzionaria, di vittoria della piazza,
tutto il bagaglio estremista che pagammo caro nel 1919». Poi disse ai suoi di
avere provato la stessa sensazione di quando piombò la notizia-bomba che il
Partito comunista aveva dato ordine di fucilare Mussolini, senza consultarsi con
gli alleati. Anche quella volta Nenni aveva masticato amaro, si era infuriato e
poi però aveva subito dettato il titolo d’apertura del giornale
socialista Avanti!: “Giustizia è fatta”. L’antefatto l’abbiamo accennato negli
articoli precedenti: sedeva al Quirinale il presidente democristiano Giovanni
Gronchi della sinistra Dc – un uomo che veniva dai popolari e che aveva
combattuto la prima fase del fascismo e nel Quirinale era diventato famoso per
la sua vita galante oltre che per un francobollo con la sua immagine stampata in
un lezioso color rosa che fu prontamente ritirato dalla zecca dello Stato ma che
diventò un carissimo pezzo per collezionisti: il famoso “Gronchi Rosa”. Gronchi
aveva dato subito la sensazione di voler sdoganare i missini per poterli usare
nel gioco parlamentare, tirandoli fuori dal cosiddetto “arco costituzionale” che
li chiudeva in una sorta di ghetto da cui poi li tirò fuori Cossiga, il quale
volle imporre come presidente del Consiglio incaricato e contro il parere del
suo partito, un suo uomo, Fernando Tambroni che era anch’esso di sinistra –
ricordo mio padre, un ingegnere conservatore, fuori dai gangheri per questa
imposizione “di sinistra” del capo dello Stato – ma la Dc non voleva concedere
al capo dello Stato un diritto che non gli competeva: quello di scegliere
autonomamente il primo ministro, per lo più tra la cerchia dei suoi fidi,
ignorando il partito democristiano con tutte le sue complicatissime regole e
bilanciamenti interni. A Giorgio Almirante non parve vero di poter tornare in
prima linea giocando d’azzardo offrendo a Tambroni la copertura parlamentare per
sostenere il governo se i democristiani avessero abbandonato Tambroni. L’effetto
fu esplosivo: i neofascisti erano davvero rientrati nel gioco politico da
protagonisti e per suggellare la promozione chiesero e ottennero l’impensabile:
celebrare il loro congresso a Genova, la città più antifascista d’Italia.
Almirante abilmente giocò sia la questione di principio – siamo tutti legittimi
rappresentanti – che avrebbe dovuto consentire lo sdoganamento del Msi la cui
sigla sintetizzava il nome di Mussolini e che aveva per simbolo il feretro del
duce da cui usciva una macabra fiamma ardente. A Botteghe oscure Togliatti era
preoccupatissimo perché la frazione di sinistra guidata da Secchia ed altri
erano favorevoli a qualsiasi forma di pressione popolare che rimettesse in
discussione la posizione internazionale dell’Italia. Togliatti sapeva che questo
doveva essere assolutamente evitato e che non avrebbe avuto neppure in caso di
successo l’appoggio armato sovietico, così com’era successo nel 1947 quando una
parte del partito comunista greco aveva deciso di insorgere per la conquista del
potere ad Atene (assegnata all’Occidente) e Stalin non mosse un dito finché gli
inglesi, occupanti in Grecia, non sterminarono gli insorti ridotti. Togliatti
era stato spedito in fretta e furia da Stalin che lo fece svegliare dal numero
uno del Comintern, Dimitrov, il quale trasmise ad “Ercoli” (nome di battaglia
di Togliatti) l’ordine di tornare in Italia e far uscire il partito comunista
dalla condizione di minuscolo partito militarizzato intransigente, per farne un
partito aperto a tutte le alleanze, fino ai liberali, ai monarchici, certamente
ai cattolici, purché uniti nel fronte antifascista. Fu quella che
poi Togliatti elaborò nella famosa “Svolta di Salerno” con un ampio respiro, ma
che comunque significava che i comunisti italiani avrebbero mantenuto la loro
posizione in Occidente senza cedere alle forti pulsioni rivoluzionarie. Quelli
che poi vennero furono i “fatti di luglio”. E quest’uso della parola
apparentemente neutrale “fatti” veniva usata quando si dovevano denominare
eventi controversi ma violenti con scontri, morti, occupazioni militari come era
avvenuto ini Ungheria e accadrà in Cecoslovacchia. A Roma io mi trovai con altri
studenti a Porta San Paolo dove fummo caricati a sciabola piatta dalla
cavalleria dei carabinieri guidati dai capitani D’Inzeo, campioni olimpionici di
equitazione e posso giurare che una carica di cavalleria è qualcosa di terribile
e perduto, potente e inarrestabile perché i cavalli non hanno freni e neanche
gli uomini che li cavalcano e ricordo benissimo questi ufficiali che sembravano
usciti dal Regno di Umberto primo, con il busto proteso in avanti e la lama
scintillante, che lanciavano fra loro parole inaudibili, brevi, militari e
l’’apertura a ventaglio dei destrieri puntava nella nostra direzione. Noi
fuggivamo come conigli davanti ai cani da caccia mentre quello squadrone di
cavalleria cresceva di andatura per arrivare a noi come una forza invincibile
per massa e velocità, preparata a travolgere, calpestare e se occorre ad
uccidere. Niente a che fare con le camionette della Celere che per quanto
brutali temevano i marciapiedi. Fu brutta e fantastica, fu terribile e
incredibile. Indimenticabile, quei due fratelli e quell’odore dei cavalli, che
avevamo perduto nella memoria. L’otto novembre di quel 1960 gli americani
elessero John Fitzgerald Kennedy, giovane e amato miliardario democratico
cattolico (il primo presidente cattolico, il secondo credo sia Biden, se non ha
cambiato per strada) dopo il primo celeberrimo duello televisivo con Richard
Nixon, l’ex vice di Eisenhower che si batté bene, ma vinse il bello e nuovo
Kennedy, anche se suo padre era un noto trafficante di alcool che aveva usato il
suo ruolo di ambasciatore a Londra per questo commercio illegale con gli Stati
Uniti e dove peraltro, essendo irlandese, tifò in un primo tempo per i tedeschi.
Si disse anche, con parecchie prove, che l’elezione di John avvenne perchè suo
fratello Robert, procuratore, accettò di dare tregua al capo del sindacato
mafioso Tom Giancana, che offrì i voti operai in cambio del favore. Ma allora
nessuno conosceva questi ed altri dettagli. Il giovane Presidente sembrava
perfetto e sarebbe entrato nella White House nel gennaio del 1961 per essere poi
assassinato nel 1963 con un delitto di cui non si venne mai a capo. Era uscito
anche un filmino divertentissimo con Peter Sellers che si chiamava Il ruggito
del topo, e fu durante quel film al cinema Ritz che baciai la mia fidanzata,
cosa che non era ancora così scontata. I fatti di luglio preoccuparono
moltissimo gli alleati che videro l’Italia come un Paese in balia dei comunisti
che prima avevano scatenato la protesta e poi l’avevano disciplinatamente
riassorbita. Quanto era potente il Pci e quanto fragile il governo democratico?
Questa domanda cominciò a diventare nella Nato una questione di tremenda
importanza che avrà molte conseguenze nel 1964. quando il mese di luglio rivelò
altri fatti e altri pretesi o veri complotti. “La Dolce Vita” diventò subito
un’espressione internazionale coma “paparazzi” usata da Fellini. Anita
Ekberg (“Anitona” da allora per tutti i romani che la desideravano come una
Venere e l’adoravano come una Madonna) faceva il bagno nella Fontana di
Trevi, Marcello Mastroianni arrostiva nell’eros le adolescenti del tempo,
accadeva anche che qualche intellettuale si suicidasse e che la vita apparisse
di colpo tanto dolce quanto insensata, elegante e inutile, banale e lussuosa.
Tutto il mondo guardava all’Italia come un Paese eternamente artistico,
vagamente corrotto, terribilmente sexy. Malgrado tutto.
LA CRONOLOGIA
DEGLI EVENTI DEL 1960
1° gennaio
– Il Camerun proclama l’indipendenza. In Africa, nei mesi successivi sarà la
volta anche di Senegal, Congo, Somalia (dall’Italia), Burkina Faso, Costa
d’Avorio, Repubblica del Congo, Gabon, Nigeria e Mauritania.
3 febbraio
– Esce nelle sale cinematografiche La dolce vita, uno dei capolavori di Fellini
e tra i più celebri film della storia del cinema a livello mondiale. La Chiesa
cattolica e la destra chiedono invano l’intervento della censura.
18 febbraio
– A Squaw Valley in California iniziano gli VIII Giochi olimpici invernali.
29 febbraio
– Un terremoto in Marocco uccide un terzo della popolazione di Agadir.
23 marzo
– Antonio Segni si dimette da Presidente del Consiglio italiano.
8 aprile – Il
nuovo Governo guidato da Fernando Tambroni ottiene la fiducia alla Camera dei
deputati grazie ai voti della Dc, del MSI e di quattro ex deputati monarchici.
16 maggio – Il
fisico statunitense Theodore Maiman inventa il primo laser.
22 maggio
– Con magnitudo 9.5, si abbatte in Cile il terremoto più forte mai registrato.
Il maremoto generato dalla scossa tellurica, oltre a distruggere tutti i
villaggi lungo 800 km di costa, percorre 17.000 km e arriva fino in Giappone,
dall’altra parte dell’Oceano Pacifico.
23 maggio – Il
Governo israeliano annuncia l’avvenuta cattura in Argentina del criminale
nazista Adolf Eichmann.
7 luglio – A
Reggio Emilia durante gli scontri tra forze dell’ordine e lavoratori perdono la
vita cinque operai. L’evento sarà noto come la Strage di Reggio Emilia.
10 luglio
– L’Unione Sovietica si aggiudica la prima edizione del Campionato europeo di
calcio, battendo in finale la Jugoslavia.
21 luglio
– Nello Sri Lanka, Sirimavo Bandaranaike è eletta Primo ministro. È la prima
donna al mondo a ricoprire tale carica.
20 agosto.
Viene inaugurato a Fiumicino il nuovo aeroporto “Leonardo da Vinci”.
25 agosto – A
Roma si aprono le XVII Olimpiadi. L’Italia grazie a 13 ori giungerà terza nel
medagliere, alle spalle di Unione Sovietica e USA.
8 novembre
– John Fitzgerald Kennedy vince le elezioni sconfiggendo il candidato
repubblicano Richard Nixon e diventando così il 35° Presidente degli Stati
Uniti.
13 novembre
– Sammy Davis Jr. sposa May Britt. Il matrimonio tra l’artista di colore e
l’attrice svedese desta scalpore, perché le unioni interrazziali sono all’epoca
vietate in 31 dei 50 Stati degli USA.
25 novembre
– Tre delle quattro sorelle Mirabal, attiviste politiche dominicane, vengono
assassinate per ordine del dittatore Rafael Leónidas Trujillo. In loro memoria,
questa data verrà ricordata come la Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne.
Nicola Graziani per agi.it il 22 settembre 2020. No, non veniva
dalla Germania post nazista portando la sua conoscenza in fatto di missili e
razzi: si nascondeva semmai tra i sogni bacati di qualche complottardo
nostalgico, magari entusiasta di Trujillo, Colui che avrebbe fatto saltare il
Mondo con i suoi abitanti. L’infernale archipendio chiamato Macchina di Fine di
Mondo non sarebbe scattato per via di un tre stelle convinto che i comunisti gli
avvelenassero l’acqua minerale. Sarebbe bastato molto meno: un oscuro paio di
stellette o poco più, forse nascosto in qualche caserma periferica o in qualche
ufficio al ministero della Difesa in Via XX Settembre. Quando John Fitzgerald
Kennedy lo lesse in un rapporto segreto, alla vigilia della tremenda figuraccia
della Baia dei Porci, dovette prendere una sofferta decisione. Fu così che
grazie al Dottor Stranamore nascosto in Italia cambiò tutto, nella Guerra
Fredda: la dottrina nucleare, i rapporti tra Usa ed Urss, persino gli equilibri
interni della Nato. Straordinaria potenza di un uomo mai esistito oppure, se
esistito, somigliante molto meno al Generale McArthur che non, piuttosto, al
Colonnello Buttiglione, lo stralunato ufficiale dell'Esercito italiano creato da
Mario Marenco come caricatura del mondo militare. E' quanto emerge da nuovi
documenti dei National Archives statunitensi. Della Baia dei Porci si è detto,
ma da sola la circostanza non rende il quadro generale. In quel momento infatti
Kennedy si trova chiuso tra le pressioni dei repubblicani del Congresso, che lo
accusano di essere “soft on communism”, ed un Nikita Krusciov che lo considera e
lo tratta da ragazzino viziato. La Nato è in crisi: il Generale De Gaulle non
solo medita l’abbandono della struttura militare dell’Alleanza, che arriverà
anni dopo, ma si è messo a finanziare gli autonomisti francofoni del Quebec.
L’America Latina ribolle tra voglie castriste e caudilli sanguinari. In Europa
l’entusiasmo per il nuovo inquilino della Casa Bianca è forte, ma vai a sapere
se durerà e se, soprattutto, sarà possibile reggere alle spallate dei
bolscevichi: quando Khrusciov parla di coesistenza pacifica non si sa mai se
intenda coesistere per sempre da buoni vicini oppure lasciare che l’Urss
ricarichi le pile per tornare all’attacco. Infine l’Italia: chiede di poter
mettere bocca sull’impiego dei missili nucleari americani presenti sul suo
territorio. Ce ne sono, di missili dispiegati in tutta Europa, ben 4.000. La
maggior parte in Germania Ovest, certo, ma l’altro paese geograficamente adatto
a fare da rampa di lancio in caso di attacco nucleare è la Penisola, e la cosa è
stata opportunamente valutata nel destinare vettori e testate. L’Italia: si
apra a questo punto una parentesi. Premessa essenziale per comprendere questa
storia, che ci giunge oggi grazie al lavoro del National Security Archive della
George Washington University, accademia tra le migliori della Capitale
americana: siamo nel febbraio del 1961. Nel 1961 l’Italia incubava un
cambiamento politico gravido di conseguenze: finiva il centrismo, era in
gestazione il centrosinistra. Con un passaggio traumatico: il Governo Tambroni,
frutto di una mai più ripetuta intesa della Dc con un Msi all’epoca
dichiaratamente neofascista. Scontri di piazza, morti e feriti. Tambroni messo
da parte, al suo posto Amintore Fanfani. La cosa, si vedrà, ha la sua importanza
nel lungo periodo. Nell’immediato basti dire che a pretendere il diritto di
parola sull’uso dei missili dislocati tra Aviano e Sigonella è proprio lui. Del
resto si tratta di un discepolo di Giorgio La Pira, sindaco (che sant’uomo, ma
che tormento) di Firenze che si diverte in quegli anni ad andare a Mosca a
interloquire con Krusciov – in compagnia dell’altro suo allievo Vittorio
Citterich – infischiandosene di quel che si dice di lui sul Potomac. In sintesi:
JfK, mentre medita sui complicati equilibri internazionali, osserva John John
che gli salta sulle ginocchia in mezzo allo Studio Ovale, ma non sa esattamente
che pesci prendere. Da ultimo arriva un avvertimento, a firma di una
sottocommissione del Congresso (quella unificata per gli Affari Europei):
esistono “questioni imbarazzanti riguardanti l’attenuarsi degli standard di
custodia e controllo da parte americana delle armi nucleari, soprattutto in
quelle destinate ai bombardieri”. Proprio come nel film di Kubrik, che però
uscirà solo nel 1964. Ma il romanzo da cui è tratto, “Red Alert” di Peter
George, è in piena circolazione dal 1958, e chissà chi ha suggerito la trama
all’Autore. Comunque sia, c’è poco da scherzare, tanto più che il rapporto
segreto sottolinea che “i missili nucleari Jupiter sono dislocati in paesi
politicamente instabili”. Ora, i Jupiter sono finiti, per l’esattezza, in due
capisaldi del fianco sud della Nato. Il primo à la Turchia, il secondo l’Italia.
La Turchia, in quel periodo, tira avanti tra un golpe militare e l’altro. Si
dirà: In Turchia è così, ma in Italia no. Giusto, ma anche sbagliato: perché
questi sono gli anni in cui è in gestazione non solo il centrosinistra, ma anche
la reazione a quella che viene considerata da qualcuno un incredibile cedimento
alle sinistre, interne ed internazionali. Anni in cui il tintinnar di sciabole
si ode sui marciapiedi di Roma, di generali con il monocolo e reduci della X
Mas. Cresce così la preoccupazione americana: i ricordi della Seconda Guerra
Mondiale sono ben vivi. In particolare lo sono alla luce di un terzo passaggio
del rapporto, quello in cui si cita esplicitamente l’eventualità di uno
“psicolabile” che ne approfitti per “usare le armi in modo non autorizzato”.
Più esplicitamente: “si impossessi di un’arma nucleare e la spari”. Un Generale
Ripper, insomma, ma anche quello che Tognazzi sarà anni dopo in un film di
Monicelli: “Vogliamo i colonnelli”. L’onorevole Tritorni, eletto nella
circoscrizione di Querceta-Castiglioncello-Vada, è qualcuno che fa veramente
paura agli uomini più potenti della Terra. Dategli in mano non una bomba per
far saltare la Madonnina del Duomo di Milano, ma La Bomba, e vedrete che botto.
Difficile che Kennedy conoscesse l’onorevole Tritoni, ma ugualmente convocò lo
Stato Maggiore Unificato. Pone domande, il Presidente, ma non ottiene risposte
esaurienti. Di lì a poco il disastro della spedizione contro Castro aprirà un
solco tra politici e militari che non si richiuderà nemmeno ai tempi del
Vietnam. Inizia così un intricato scambio di telegrammi, note, avvertimenti tra
e all’interno delle cancellerie di mezzo mondo, in cui gli Usa un po’ si
impongono, un po’ subiscono, alla fine devono trovare la quadra. Però la
soluzione non arriva, si fa aspettare, si allontana e si avvicina come una Fata
Morgana ed intanto a Vienna Kennedy viene pubblicamente umiliato da Krusciov, in
Sudamerica l’Alleanza per il Progresso langue ed in Europa quel revanscista di
De Gaulle si rifiuta di parlare persino inglese in pubblico: Il Continente siamo
Noi. E Fanfani? Fanfani tiene duro: o decidiamo anche noi sull’impiego delle
armi, o nisba. Il monello è abituato a tenere a bada le correnti democristiane,
figuriamoci se gli fa impressione la Casa Bianca. Da ultimo la spunta, quel
tremendo. Nel marzo del 1961 il consigliere della Casa William R. Tyler chiede
ufficialmente al segretario di Stato Dean Rusk (il che, conoscendo la scarsa
autonomia decisionale di Rusk, equivaleva al Presidente che lo imponeva senza
mezzi termini) di scrivere a Robert McNamara, il ben più riottoso segretario
alla Difesa. Quest’ultimo, un repubblicano di peso alla Corte di Re Artù, doveva
essere informato che il permesso preventivo nell’uso delle armi nucleari “non
può essere rifiutato ad un paese che ne ospita sul proprio territorio e che ne
faccia richiesta, attribuendo alla questione un’importanza di carattere
politico”. Del resto, perché rifiutare all’Italia ciò che in fondo già si
garantisce a Francia e Regno Unito? Una equiparazione che sa tanto di fine della
Seconda Guerra Mondiale: Roma non è più il ragazzo da picchiare, ma un alleato
da rafforzare. Tanto più che sarebbe “cosa ben poco felice se si volesse
persistere in posizioni negative nei riguardi delle richieste italiane, cosa che
potrebbe minare alla base la reciproca fiducia che si è installata nel campo
della collaborazione atomica e resiste fino a questo momento”. Frase sibillina
che trova la sua spiegazione in una circostanza: i Jupiter erano stati accettati
dall’Italia senza che si ricorresse ad un lacerante ed incerto dibattito
parlamentare a Montecitorio. In parole povere: Kennedy rinunciò chiedersi se si
trattasse di una cessione di sovranità da parte americana, Fanfani a chiedersi
se si trattasse di una cessione di sovranità da parte italiana. Entrambi avevano
un solo nemico: il Colonnello Buttiglione. Tempo pochi mesi, infatti, e cambiò
tutto. Dopo qualche mese Kennedy disse alla Nato che sarebbe stata abbandonata
la Dottrina della Distruzione Reciproca Assicurata (Mad), quella che fino ad
allora sanciva il principio che ogni pur minimo attacco nucleare sovietico
avrebbe avuto come risposta l’impiego di tutte le armi nucleari della Alleanza.
Dopo qualche mese – un po’ di più – sarebbe stato trovato il primo accordo
Usa-Urss per la limitazione degli esperimenti nucleari nello spazio. Dopo
qualche mese, soprattutto, piombò a Bologna per un convegno organizzato da Il
Mulino il principale dei consiglieri del Presidente americano, Arthur
Schlesinger Jr. Il convegno era di storia contemporanea, e la storia
contemporanea fu fatta: da Washington arrivava il via libera definitivo al
centrosinistra, che sarebbe stato gestito nella sua primissima fase – indovinate
da chi? – da Amintore Fanfani. Il quale non mancò di farsi sentire, il tremendo
monello, anche pochi mesi dopo, quando il mondo era di nuovo nelle grinfie del
Dottor Stranamore. Krusciov, ancora convinto che Kennedy fosse un ragazzino
viziato, gli aveva piazzato una salva di missili nucleari alle porte di casa,
vale a dire a Cuba. La vicenda dei Missili di Ottobre, e la sua conclusione
tutta a favore degli Usa e del loro giovane presidente, sarebbe stata raccontata
da Bob Kennedy in un avvincente libretto, Thirteen Days. Avvincente ma non
completo, perché se è vero che Krusciov tornò a casa con le pive nel sacco (lo
avrebbero fatto secco al Cremlino più tardi, per questo) e che JfK ne uscì come
un eroe nazionale e internazionale, il buon Bob dimenticò di annotare che in
mezzo a tanta gagliardia svolse il suo compito anche un accordo – non scritto,
ma sono quelli che durano di più – tra le superpotenze, e prevedeva la rimozione
di un quantitativo di Jupiter da alcuni anni puntati contro l’Urss. Inutile dire
che si trattava dei missili che si trovavano in Italia. Inutile dire che a
metterci una parolina piccola piccola, ma alla fine ascoltata, era stato sempre
lui, Amintore Fanfani. Diavolo d’un uomo: alla fine della storia si ritrovava ad
avere in saccoccia il diritto di dire no all’uso delle armi nucleari, senza
avere la seccatura di tenersene in casa nemmeno una. Ma è davvero la fine della
storia? No, e per due motivi. Il primo è che Kennedy, sempre dopo qualche mese,
arrivò in Italia in visita di stato e fu una marcia trionfale. Bagni di folla,
applausi scroscianti: in Europa amavano l’America e De Gaulle si sarebbe
rassegnato a non mandare più soldi in Quebec. Lo portarono letteralmente in
trionfo in mezzo alla gente su via dei Fori Imperiali, e qui qualche buontempone
ebbe l’idea di sfilare dalla fondina la pistola di una gente dei servizi di
sicurezza americani. Chissà, magari si sognava di utilizzarla in qualche golpe
prossimo venturo. Il secondo motivo è che gli anni passarono, ma i missili
restarono. Sul finire degli anni Settanta il governo della Germania Ovest
denunciò che l’Urss aveva piazzato di nascosto una selva di SS-20 a testata
multipla contro le principali capitali europee. Si proponevano, al Cremlino, di
raggiungere anche una serie di obiettivi in America. Occorreva una risposta a
suon di Cruise e Pershing-2 da dispiegare in tutta l’Europa Occidentale, Italia
compresa. Non si potè evitare, questa volta, il dibattito parlamentare:
l’opinione pubblica era troppo divisa. Non si potè evitare, al paritempo, il
cambiamento di governo. E chi venne indicato a coprire la carica di Presidente
del Consiglio? Ancora lui, Amintore Fanfani. Il monello sapeva fare le
monellerie, ma sapeva farle sul serio. Andò alle Camere e, sulla base delle sue
ottime conoscenze di latino, usò il periodo ipotetico della realtà e della
concretezza: “Si vis pacem, para bellum”. Lo avrebbe detto di sicuro anche
JfK.Lo avrebbe detto, chissà, anche Giorgio La Pira.
Quando don Sturzo sognava il "popolarismo" che l'Italia ha
rinnegato. Lo storico Flavio Felice ci fa riscoprire
il pensiero pluralista e anti nazionalista del sacerdote. Carlo Lottieri,
Mercoledì 23/09/2020 su Il Giornale. Nonostante sia stato uno dei protagonisti
della storia intellettuale e civile del Novecento italiano, Luigi Sturzo è stato
presto museificato perfino da quanti si richiamavano a lui. Nei decenni del
potere democristiano, infatti, il sacerdote siciliano è stato ridotto a un
piccolo santino da usare in occasione di convegni e commemorazioni, ma senza che
le sue idee venissero attualizzate. Anche il fatto che, una volta nominato
senatore a vita, egli abbia scelto di aderire al gruppo misto e non a quello
della Democrazia cristiana, è stato spesso taciuto: dato che avrebbe evidenziato
la sua distanza dal sistema politico impostosi all'indomani della Seconda guerra
mondiale. In maniera meritoria torna ad accendere i riflettori su Sturzo un
denso studio di Flavio Felice (I limiti del popolo. Democrazia e autorità
politica nel pensiero di Luigi Sturzo, edito da Rubbettino e in vendita a 25
euro), che tra i molti pregi ha quello di evidenziare come l'insegnamento
sturziano abbia sempre posto al centro l'autonomia della società rispetto al
potere. Mostrando una chiara attenzione a dibattiti contemporanei, il volume
insiste a più riprese sul fatto che in Sturzo la nozione di popolo sia sempre
declinata, per così dire, al plurale. Contrario a ogni visione collettivista e
nemico di ogni esaltazione religiosa dello Stato, il sacerdote siciliano
considerava le istituzioni quali semplici strumenti, non già nelle mani di
un'astratta e indefinibile comunità, ma invece di concrete persone variamente
raccordate tra loro. Non a caso, uno degli elementi precipui della prospettiva
del popolarismo sturziano è il municipalismo: all'ideologia astratta della
nazione, insomma, egli oppone la concretezza di persone che si conoscono, che
sono chiamate a farsi carico di problemi condivisi, che si confrontano
direttamente e devono farlo in maniera responsabile. Per questo motivo tornare a
Sturzo significa immunizzarsi da Jean-Jacques Rousseau, dato che il prete di
Caltagirone guardò assai correttamente alla teoria della sovranità popolare
assoluta «come a una derivazione della teoria delle monarchie di diritto divino»
(per usare le sue stesse parole). Una volta fattosi divinità, lo Stato non
poteva che divenire totalitario. Quando esamina la nozione di popolo che è al
cuore del popolarismo sturziano, allora, Felice ricorre spesso al termine
«plurarchia», a evidenziare che il popolo non è un'unità che possa legittimare
il potere sovrano (come per socialisti e nazionalisti), ma invece esso s'esprime
«perfino in forma rivoluzionaria come l'antitesi alle classi dirigenti, che
detengono il potere e che fanno coincidere la loro stessa esistenza con quella
dello Stato». Alla luce di tutto ciò, il fascismo non è più una parentesi entro
una storia luminosa. Al contrario, l'autoritarismo mussoliniano è una cosa sola
con l'esaltazione della nazione di matrice ottocentesca, con la difesa del
potere statale quale unica condizione per la convivenza, con il mito giacobino
di una comunità originaria, incontaminata, perfetta. A giudizio di Sturzo è
necessario proteggere il confronto aperto tra quanti discutono, contrattano e
negoziano, perché nell'imperfezione dei rapporti umani si manifesta quella
libertà su cui si reggono gli ordinamenti davvero rispettosi dei singoli e delle
comunità. In maniera non sorprendente, per Sturzo le grandi questioni alla fine
sono metafisiche. Quando s'oppone alla statolatria egli intende evidenziare lo
Stato è solo un mezzo, e mai un fine, e che per questo motivo esso non deve mai
neppure possedere, regolare o controllare tutti i mezzi (perché in quel caso
disporrebbe di tutti i fini, per ricordare qui una celebre formula di Friedrich
von Hayek). Nelle conclusioni al libro Felice ricorda, molto opportunamente,
come Sturzo sia stato vittima di una damnatio memoriae: come sia stato
marginalizzato dalle culture che hanno dominato la scena intellettuale della
nostra età repubblicana. Non a caso, quando egli torna in Italia dopo l'esilio
inglese e americano i suoi interventi sull'attualità (non di rado assai
polemici) non sono pubblicati sulle grandi testate dell'informazione italiana,
ma sul piccolo Giornale d'Italia. Cosa c'era di veramente inaccettabile, nelle
idee di Sturzo, per le classi dirigenti del Dopoguerra? Vi era la sua
predilezione per l'economia di mercato, contro il clientelismo e la corruzione
delle partecipazioni pubbliche (e contro l'assistenzialismo che egli imputò, ad
esempio, a un La Pira). Vi era pure il rigetto di ogni celebrazione del potere
(«l'origine di tutti i diritti e il fine di ogni attività politica», a giudizio
di tanti) e la ripresa di quella visione cristiana secondo la quale «la legge
era superiore al potere e le sue norme obbligavano sia i sovrani sia i popoli».
L'idea di una pari dignità ontologica tra quanti sono governanti e quanti sono
governati era insomma cruciale nel popolarismo sturziano. Probabilmente, per
uscire dal disastro attuale bisognerà partire proprio da lì.
No cari politici, la memoria non è un mercato delle pulci.
Marco Follini il 27 agosto 2020 su L'Espresso. Parlamentari e leader di oggi
glorificano a caso quelli del passato, spesso mischiando in un unico elogio
figure tra loro contrapposte. Un modo miserabile per cercare di colmare il loro
vuoto. All’indomani della Rivoluzione, come è noto, i nobili francesi si
rifugiarono a Coblenza a rimuginare sul loro destino e a sognare un improbabile
ritorno in patria. Di loro si disse che non avevano imparato niente e non
avevano dimenticato niente. Per chi ai giorni nostri non coltiva né la nostalgia
di Luigi XVI né l’illusione di Robespierre i conti con l’apprendimento e quelli
con il ricordo sono ovviamente un po’ diversi. Un po’, ma non troppo. Infatti
anche noi tendiamo a imparare poco e forse anche a dimenticare poco - a dispetto
delle nostre stesse parole d’ordine. Ci raccontiamo che tutto è inedito, è vero.
Mai accaduto prima d’ora. Ma poi invece rovistiamo quasi ogni giorno negli
armadi dei nostri progenitori per cercare ispirazione e conforto. La nostra
memoria collettiva continua imperterrita a spulciare negli annali della
Repubblica che fu, alla ricerca di nobili precedenti a cui aggrapparsi, di
virtuosi esempi a cui ispirarsi e di mitiche figure onuste di gloria da cui
trarre qualche spunto per noi stessi. L’affettuoso saccheggio del passato in
cerca di esempi, citazioni, aneddoti, consolazioni sembra essere una delle
attività preferite dei leader in campo e dei loro ghostwriter. Si compra nel
passato il credito di cui il presente non dispone. Da un certo punto di vista,
ce ne potremmo quasi rallegrare. Se infatti gli alfieri della Terza Repubblica
si rivolgono a Togliatti o a De Gasperi o a Nenni, se il Recovery Plan non è
altro che la rivisitazione del piano Marshall, se perfino i populisti
preferiscono evocare don Sturzo piuttosto che Guglielmo Giannini, forse vuol
dire che le migliori radici politiche del paese sono ancora ben piantate per
terra e magari, chissà, possono regalarci qualche frutto. Appena qualche anno fa
il passato repubblicano era terra bruciata, e l’unica prospettiva sembrava
quella di cavalcare verso territori sconosciuti. Ora invece viene quasi da
consolarsi al pensiero che si stia cercando in tutti i modi di onorare il debito
che abbiamo con i padri (nonni, a questo punto) della nostra storia. Sarà pure
un altro omaggio reso dal vizio alla virtù, ma si può dire che quella virtù è
meritevole e quel vizio non è poi così grave. Ora però si dovrebbe cercare di
elaborarlo, quel passato. E non lasciarlo lì, vanamente rimpianto e inutilmente
ricordato, al modo in cui usavano i nobili rintanati a Coblenza. E qui, invece,
il nostro asino finisce per cascare. Il fatto è che tutto questo richiamarsi
alla mitologia degli esordi repubblicani ha in sé qualcosa di equivoco. Noi
stiamo infatti ingarbugliando i fili del passato e facendo una discreta
confusione tra le molte memorie che lo attraversano. Il caso del comune di
Terracina, dove si voleva intestare una strada ad Almirante e Berlinguer,
accomunati dalla toponomastica di oggi per quanto erano divisi e contrapposti
dalla politica di ieri e ieri l’altro, è solo il caso più eclatante. Ma non è
l’unico. È già capitato che qualcuno dei nostri attuali statisti in erba abbia
dichiarato di ispirarsi al meglio di De Gasperi, di Berlinguer e di Almirante
(ancora), tutti insieme appassionatamente, quasi indifferenti l’uno all’altro. E
che altri abbiano farcito i loro discorsi di citazioni di questo e di quello,
incuranti di evocare di volta in volta i nomi di persone che ai loro tempi se le
erano date di santa ragione.
In attesa che arrivi anche il momento di Prodi e Berlusconi,
magari finendo con l’accomunare perfino loro, si può segnalare che un po’ tutti
i leader della nostra vicenda storica hanno avuto il loro attimo di gloria ad
opera di successori che non avrebbero mai immaginato - né, forse, prediletto più
di tanto. Una gloria che ora sembra radunarli sotto lo stesso tetto ma che
invece non dovrebbe prescindere dalle abissali differenze che correvano tra
molti di loro. La bislacca idea che si debba per forza avere una memoria
condivisa, uniformando i nostri giudizi laddove i nostri ricordi continuano ad
essere difformi, ingenera così una doppia stortura. Una rivolta verso il passato
che non sappiamo più elaborare. L’altra rivolta verso il presente che non
sappiamo più riconoscere. In una parola noi stiamo coltivando una memoria
disordinata e confusa, troppo strumentale e celebrativa. Quasi una sorta di
riedizione dell’album delle figurine Panini, dove però non figurano più le
squadre e si sbiadiscono i colori delle maglie che accendevano le passioni delle
opposte tifoserie. Così, si mettono insieme alla rinfusa fascisti e comunisti,
laici e cattolici, notabili di tutti i colori buoni per tutti gli usi. Si
celebra un lungo periodo della storia patria come fosse un tutt’uno ma poi se ne
occultano pudicamente le differenze, i conflitti, le asprezze. Finiamo così
per raccontarci una storia edulcorata, di cui si perde quel senso drammatico e
quel gusto controverso che i nostri padri conoscevano fin troppo bene e a cui
erano perfino, a modo loro, affezionati. L’esito di tutto questo è che si
appannano, insieme, la nitidezza dei ricordi e il valore delle differenze. Si
vorrebbe chiamare a raccolta le grandi figure nel nome di un improbabile
“embrassons nous”. Dimenticando che il nostro passato si è fatto largo invece a
furia di dispute e contrasti. E che non si può raccontarlo oggi come fosse un
prato fiorito, in cui ognuno può cogliere il fiore che più gli aggrada, e magari
fare un mazzolino in cui radunare con disinvoltura gente che ha speso la vita a
combattersi. Il fatto è che i grandi di una volta erano grandi anche per le
bufere che attraversavano e per tutti i venti che soffiavano contro di loro. I
più convinti delle proprie buone ragioni menavano quasi vanto delle maldicenze
degli avversari, vissute all’epoca come un involontario tributo al valore. Molto
probabilmente nessuno di loro aspirava alla glorificazione futura. Contavano
semmai di trarre la gloria dal loro presente. Che era l’unità di misura delle
riuscite e delle cadute, anche per quelli che guardavano più lontano. La gran
parte di loro, insomma, non ambiva tanto a farsi celebrare nei manuali di
storia. Né, credo, a venire onorati dalle citazioni di lontani successori che
non conoscevano (e che magari non avrebbero apprezzato più che tanto). La loro
ambizione era piuttosto quella di cambiare e migliorare la vita dei
contemporanei. Sospinti dal consenso della loro parte. E magari anche lusingati
dal fastidio che potevano arrecare alla parte avversa. L’ecumenismo dei ricordi
vorrebbe essere il segno di uno spirito inclusivo e di una costruttiva e
pacifica volontà di dialogo. Tutte cose che ci mancano. Così, cerchiamo nel
passato quello che non troviamo nel presente. A conferma del fatto che ogni
stagione ha le memorie che si merita, oppure quelle che si illude di meritarsi.
E che a noi purtroppo tocca più l’illusione che il merito. Dunque, se si vuole
dedicare attenzione a quelle storie occorre innanzitutto contestualizzarle.
Collocarle nel solco di quegli anni e riconoscere lealmente che il nostro
presente - bello o brutto che sia - non ha molto a che vedere con i nostri
antenati di maggior pregio. Quegli antenati hanno diritto alla loro storia, che
non necessariamente coincide con la nostra. La memoria è sempre uno scaffale
bene ordinato di una libreria magari un po’ impolverata. Non è il mercatino
delle pulci dove si accumulano alla rinfusa i resti di molti arredi di case e
palazzi che la gran parte degli acquirenti che passeggiano lì intorno non ha mai
abitato.
Lavoro, parrocchie, partiti mille tramonti
e l’oro di Bezos. Silvano
Moffa il 31 gennaio 2020 su Il Dubbio. “Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di
Amazon” il lungo viaggio in Italia dello storico Miguel Gotor.L’inutile vertice
sul Britannia di banchieri e manager per invertire l’avvitarsi del debito
pubblico. E ora il trionfo della distribuzione sulla produzione. La disfatta di
Adua, nel corso della guerra di Abissinia, non fu soltanto una umiliante
sconfitta militare ( 6000 soldati italiani uccisi dall’esercito di Menelik).
Essa segnò la fine della politica imperialista di Francesco Crispi in Africa e
la caduta del suo governo, in carica dal 1893. Parte da questa data, 1° marzo
1896, ” L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di
Amazon”, volume denso e originale, ultima fatica dello storico Miguel Gotor,
docente di Storia moderna all’Università di Torino ed ex senatore dal 2013 al
2018. Una storia dell’Italia osservata e indagata nei suoi aspetti politici,
sociali, culturali, di costume. Con l’occhio distaccato del ricercatore che
assembla date, avvenimenti, circostanze e coincidenze con la febbrile ottica,
quasi un’ossessione per lo studioso, di offrire quanto più materiale possibile
al lettore. Ma anche con la passione di chi si nutre di una visione, di un
proprio punto di vista, di convincimenti che vengono portati evitando, nei
limiti del possibile, di restare prigioniero di un taglio ideologico che
mortificherebbe oltremodo la natura della ricerca. Antico e mai superato dilemma
per lo storico quello di conciliare le proprie idee con la narrazione oggettiva
degli accadimenti. Vale per chi scrive di storia come per il romanziere, per il
giornalista, per chiunque si affanni a trovare una motivazione plausibile agli
avvenimenti che si affastellano. Miguel Gotor ripercorre il Novecento italiano
fino ai giorni nostri con uno stile sobrio e accattivante al tempo stesso, senza
fronzoli. Guarda la storia attraverso il susseguirsi dei fatti, e la analizza
nei suoi risvolti sociali e culturali. Anzi, se cerca una chiave di lettura dei
cambiamenti che segnano le epoche indagate e dei personaggi politici che ne sono
protagonisti, la trova scrutando nelle parole e nei sentimenti che agitano
canzoni, film, refrain popolari. La cultura popolare, ad ogni tornante della
storia, fotografa la condizione in cui versa l’Italia in quel dato momento. La
stratificazione storica si intreccia con i mutamenti antropologici e di costume
in una società che evolve verso la modernizzazione, portandosi dietro
contraddizioni e umori, passioni e rancori, riforme incompiute e pastoie
burocratiche, limiti politici insieme a sussulti reattivi, in un quadro solo a
tratti edificante. Così, lo storico passa in rassegna il regicidio di Umberto I
e la svolta liberale, l’epoca giolittiana e la nascita del nazionalismo con il
pullulare di riviste come “Il marzocco”, “Il regno”, “Leonardo”, “Hermes”, “La
voce”, “Lacerba”. Riviste nate intorno a carismatiche figure di intellettuali
del calibro di Enrico Corradini, Gabriele D’Annunzio, Giovanni Papini e Giuseppe
Prezzolini. Giovani ambiziosi, accomunanti dal gusto per la polemica graffiante
e dalla comune voglia di opporsi al decadimento del tempo, una sorta di
“avanguardia” intellettuale e nazionale “contro il conformismo imperante della
società liberale e le palingenesi rivoluzionarie promesse dai socialisti”.
Ancora: la Grande Guerra, il Fascismo, Le Centomila gavette di ghiaccio, epopea
di dolore e di morte dei nostri alpini della “Julia” sul fronte russo,
raccontata dall’ufficiale medico Giulio Bedeschi, il colpo di Stato del 25
luglio e il tradimento dell’” inglese” Grandi, piazzale Loreto, il “gran sole”
di Hiroshima. E poi, il lungo dopoguerra, De Gasperi, Togliatti e la svolta di
Salerno. E a seguire: la Repubblica dei partiti, il centrismo, prima, il
centrosinistra, poi. Il miracolo economico e la Fiat di Valletta, il film Rocco
e i suoi fratelli di Luchino Visconti che “metteva in scena la realtà
dell’emigrazione meridionale al Nord, sullo sfondo delle tensioni e dei
contrasti di un Paese in profondo cambiamento” e La dolce vita di Federico
Fellini, “uno straordinario affresco onirico di una Roma cinica e gaudente, in
cui le luci della ribalta e gli scatti dei paparazzi non riuscivano a nascondere
l’incombente sfacelo della città”. Eloquenti le pagine del libro dedicate alla
“scossa” del Sessantotto e alla svolta sovversiva del 1974. Qui Miguel Gotor
ripropone, ampliandone il contenuto e l’analisi, i suoi studi sul terrorismo e
la vicenda di Aldo Moro, cui ha dedicato anni di ricerca e testi fondamentali.
La ricostruzione del filo rosso che lega i primi movimenti giovanili di
contestazione studentesca che assunsero carattere internazionale, dagli Stati
Uniti al Messico, all’Europa, soprattutto in Francia, Germania e Italia, fino
alla strategia della tensione degli anni settanta e al terrorismo delle Brigate
Rosse, offre al lettore pagine intense e una narrazione degli avvenimenti che
lascia ancor oggi molte zone d’ombra e spiegazioni né scontate né esaurienti.
Come pure la lotta alla Mafia e l’intreccio, mai del tutto chiarito, tra mafia e
politica, con i feroci attentati ai giudici Falcone e Borsellino, la gestione
dei pentiti, il processo ad Andreotti, l’ascesa e la caduta di Craxi, Mani
Pulite, la fine della Guerra fredda tra i due blocchi che avevano fino allora
governato il mondo. “In questi anni di transito tra la fine della decade degli
Ottanta e l’inizio dei Novanta, incentrati intorno all’imprevedibile 1989 –
sottolinea Gotor – terminò anche un decennio in cui, tra lacerazioni e
contrasti, era avanzata una difficile modernizzazione della società e dei
costumi nazionali, in controtendenza rispetto alla progressiva sclerosi della
vita politica dei partiti. In quello spazio immaginario tra la crisi dei partiti
come agenzie di formazione di uno spirito pubblico e i cambiamenti della
società, in cui stavano perdendo la loro presa luoghi di intermediazione e di
aggregazione come le parrocchie, i sindacati e le associazioni, sostituiti dai
primi grandi centri commerciali, era avanzato un nuovo spirito secolarizzato e
sfuggente, che aveva una cifra libertaria di tipo individualista, ma anche un
tratto psicologico di solitudine e di smarrimento”. Nell’incedere della nuova
epoca e del clima che ne connotava i ritmi, il 2 giugno 1992, si faceva spazio,
al largo delle coste di Civitavecchia, il panfilo della regina Elisabetta II.
Portava con sé un equipaggio speciale. A bordo della nave Britannia salirono,
ospiti di una associazione finanziaria inglese esperta in investimenti, fusioni
e acquisizioni, i vertici delle principali banche italiane, i manager pubblici e
privati dell’Eni, dell’Iri, dell’Ina, dell’Efim, dell’Agip, della Snam, il
direttore generale di Confindustria Innocenzo Cipolletta, il direttore generale
del Tesoro Mario Draghi, una selezionata rosa del mondo politico, economico e
accademico. Mentre a terra si festeggiava la festa della Repubblica, al largo
dell’Argentario gli ospiti britannici prospettavano agli invitati la necessità
di diminuire il peso dell’industria pubblica, l’utilità di realizzare un piano
di privatizzazioni e liberalizzazioni così da recuperare risorse per ridurre il
debito pubblico italiano e per adeguare l’economia del Paese ai nuovi assetti
dei mercati internazionali definiti dopo la fine del mondo bipolare. “Il
ridimensionamento dell’intervento pubblico in economia – annota lo storico –
passava inevitabilmente attraverso l’affossamento del sistema dei partiti”. Un
vincolo esterno tornava a condizionare l’Italia nei suoi rapporti con il
processo di costruzione europea. Di lì a poco, le conseguenze si sarebbero
mostrate in tutta la loro portata. Tramontata la Repubblica dei partiti ( 1945-
94) sotto i colpi secchi della storia, stava sorgendo la “Repubblica
dell’antipolitica” che avrebbe accompagnato la vicenda italiana per i
venticinque anni successivi e oltre, “giungendo a illuminare, con i suoi
chiaroscuri, la tremula e incerta ombra del tempo presente, quello della
cronaca”. Nell’epilogo del lungo viaggio attraverso il Novecento italiano,
Miguel Gotor, getta lo sguardo sulla straordinaria impresa di Jeff Bezos, l’uomo
più ricco del mondo, l’ideatore della piattaforma di commercio online Amazon. La
profezia di Bezos, ammette lo storico, si è avverata su scala globale spostando
il cuore del lavoro come valore dalla produzione alla distribuzione, con lo
scopo di realizzare ingenti profitti facendo pagare poco al maggior numero di
persone possibile. Sorge spontanea la domanda: esiste un nesso tra
l’affermazione di questi processi sul piano economico, che interrogano
l’identità e il valore del lavoro, e gli affanni che ovunque stanno vivendo la
democrazia rappresentativa e i cosiddetti corpi intermedi? La risposta è
affermativa. Anche perché alla fine della catena di questa storia di commercio e
di fatica si trova il magazziniere di Amazon, il cittadino, l’elettore, il padre
di famiglia. Soggetti condizionati. Sottomessi. Ripiegati in un imbuto politico,
economico, sociale, civile. E’ lecito sperare per l’Italia, la Bella
Addormentata nello stagno di oggi, in un prossimo inaspettato risveglio? Sì,
forse.
·
E gli "storici"?
Tacciono…
Il Massone Garibaldi a disposizione della Chiesa di Roma.
L’unità d’Italia (o quasi): Nord
acchiappa-tutto, Sud e Sicilia colonie. Un libro per capire come andarono le
cose. I Nuovi Vespri il 26
ottobre 2020. Il libro lo ha scritto Michele Eugenio Di Carlo. Il titolo è: “Sud
da Borbone a Brigante”. proviamo a illustrare perché è importante leggero
seguendo la presentazione di Pino Aprile e citando qualche esempio, perché la
storia negata non è una caratteristica della sola Italia, perché ovunque i
vincitori hanno scritto e imposto la storia a proprio uso e consumo. Con il
titolo di “Sud da Borbone a Brigante” va il nuovo volume di Michele Eugenio Di
Carlo. E’ un libro sulla fine del regno delle Due Sicilie con la prefazione
dello scrittore e giornalista, Pino Aprile. Poiché siamo legati alla verità,
diciamo subito che noi non abbiamo ancora letto il libro. E allora come si
presenta un libro che non è stato letto? Non si presenta: e infatti quello che
state leggendo non è un nostro articolo di presentazione del libro, che faremo
quando lo avremo letto. Noi oggi ci limiteremo a riportare alcuni passaggi della
presentazione scritta da Pino Aprile (e non è poco) e a presentare e a
commentare l’argomento: e cioè quello che non è stato scritto sulla conquista
del Regno delle Due Sicilie dagli storici che hanno nascosto tante verità.
Intanto cominciamo col dire che i lettori de I Nuovi Vespri – con riferimento
soprattutto a coloro i quali leggono la sezione "Storia e controstoria" –
conoscono Michele Eugenio Di Carlo, perché ogni tanto pubblichiamo i suoi
articoli che trattano sempre di storia. L’argomento trattato in questo libro è
comunque noto ai nostri lettori, perché anche noi, con i nostri mezzi, da quando
siamo in rete, abbiamo cercato di raccontare la storia del Sud Italia e della
Sicilia prima della ‘presunta’ unificazione italiana. Sul Sud in generale
riordiamo i brani del volume Fegato scritto da Domenico Iannantuoni, del quale
abbiamo pubblicato ampi brani. poi ci sono gli articoli di Ignazio Coppola che,
se è vero che scrive solo quando è ‘confessato’ di fresco’, sono comunque
articoli di grande spessore e sempre molto documentati. per non parlare del
volume “e nel mese di Maggio del 1860 la Sicilia diventò colonia!” di Giuseppe
‘Pippo’ Scianò. Libro che racconta l’impresa dei Mille con dovizia di
particolari, facendo emergere non soltanto le cose rimaste nascoste, ma anche
testimonianze importanti che la storia ufficiale ha nascosto. Il tutto – e
questo è il grande merito di Scianò – con una puntuale bibliografia che taglia
le gambe a chi cerca di sminuire la portata delle tesi del libro, dove
Garibaldi, i garibaldini, i mafiosi e i massoni (allora insieme come accadrà
spesso negli anni successivi…) ne escono veramente male! Ci hanno colpito, nella
presentazione di Pino Aprile, tre domande poste dall’autore di Terroni a
proposito del nuovo libro di Michele Eugenio Di Carlo: “Perché un lavoro serio
come questo non lo abbiamo da tempo immemorabile a cura di titolari di cattedra
di storia? Perché il raffronto con quel che scrivevano autori ‘dalla parte dei
vinti’ è stato (salvo poche, tardive e lodevoli eccezioni) scartato a priori?
Perché la versione degli sconfitti, da Giacinto de’ Sivo (“Storia delle Due
Sicilie”), a Raffaele De Cesare (“La fine di un Regno”) è stata irrisa, ritenuta
inattendibile per definizione, perché portatrice del presunto risentimento dei
vinti che potrebbe deformare i fatti?”. La storia, si dice, la scrivono i
vincitori. E chi prova a opporsi a questa immutabile legge della prepotenza ne
paga le conseguenze. Come dimenticare le polemiche al vetriolo che hanno
accompagnato Giampaolo Pansa quando diede alle stampe Il sangue dei vinti?
Giampaolo Pansa, scomparso nel Gennaio di quest’anno, era un giornalista
progressista: tutto di lui si poteva dire, ma non che non fosse un uomo libero.
Era un uomo libero e anche progressista. Ma appena ha messo in discussione certi
miti della Resistenza – peraltro raccontando fatti molto documentati – è stato
travolto dalle critiche. Una critica, in particolare, è rimasta impressa nella
nostra mente: la critica di chi non contestava la veridicità dei fatti – che
erano incontestabili, perché il libro-inchiesta di Pansa era ineccepibile – ma
si limitava a porre la seguente domanda: a che serve parlare oggi di questi
argomenti? E’ la stessa critica che mosse a noi una persona intelligente quando
abbiamo pubblicato la serie di articoli su Garibaldi di Ignazio Coppola, dove il
cosiddetto eroe dei due mondi ne esce a pezzi: “A che serve scrivere oggi queste
cose? Sono vere, va bene, ma oggi servono soltanto a minare l’unità del nostro
Paese”. Il tema è sempre lo stesso: se la menzogna è stata ben raccontata, se
gli storici l’hanno avallata per 150 anni, ebbene, le menzogne sono diventate
verità e le verità sono diventate menzogne! E’ così solo in Italia? No, non
abbiamo questo primato. Quando al vertice dell’allora impero comunista russo
c’era Leoníd Il’íč Bréžnev, si raccontava di un esame di storia di uno studente
russo:
“Ci parli di Lenin”, chiedono i professori
allo studente.
Risposta: “Il compagno Lenin è stato un grande
statista ed è morto da eroe”.
“Bravo. Ora ci parli di Stalin”.
Risposta: “Il compagno Stalin è stato un
grande statista, poi ha commesso qualche errore ed è arrivato il compagno Chruščёv”.
“Bravo, ora ci parli di Chruščёv”.
Risposta: “Il compagno Chruščёv
è stato un grande statista, poi ha commesso
qualche errore ed è arrivato il compagno Bréžnev”.
“Bravo, ora ci parli del compagno Bréžnev ma
stia attento”, gli chiedono sempre i professori.
“Risposta: “Il compagno Il compagno Bréžnev è
stato un grande statista e…”.
Lo studente guarda in faccia i suoi professori
che lo fissano immobili. A un certo punto aggiunge:
“Il compagno Bréžnev dovrebbe commettere
qualche errore, il resto ancora non si sa…”.
I professori saltano dalle sedie:
“Bocciato, lei è andato troppo avanti!”.
Ma se la Russia piange, negli Stati Uniti non
si ride. Che dobbiamo dire degli Indiani d’America fatti passare per “selvaggi”.
C’è o no qualche legame con i patrioti del Sud che, all’indomani del 1860,
combattevano contro gli invasori piemontesi e, ancora oggi, nei libri di storia,
vengono chiamati “Briganti”, quando i veri briganti erano i Savoia? “Così, la
‘buona storia’ è la versione dei vincitori – scrive Pino Aprile – che narra come
necessaria per un alto fine una invasione senza dichiarazione di guerra, tace di
paesi rasi al suolo, di rappresaglie con migliaia di morti, centinaia di
migliaia di incarcerati e deportati senza accusa, processo e condanna. Quando
chi compie queste cose non vince, ma perde, si parla di crimini di guerra. I
fatti e i modi sono sempre quelli nel percorso dell’umanità, cambia il modo di
raccontarli: un passo avanti verso una più alta civiltà, nella versione dei
vincitori, un delitto in quella dei vinti”. “Così, la storia ufficiale –
prosegue Pino Aprile – finisce per giustificare le cose come sono andate, perché
così “dovevano” andare e il racconto attribuisce ai protagonisti un disegno
chiaro a loro e, a posteriori, a tutti (salvo botte di sincerità quale quella di
Oliver Cromwell, che quando gli chiesero come avesse costruito le basi della
potenza britannica, rispose, più o meno, che nessuno va così lontano come chi
non sa dove sta andando). Mentre il racconto dei vinti avviene attraverso
l’arte: la letteratura (“I viceré” di Federico De Roberto, “La conquista del
Sud” di Carlo Alianello, “Il gattopardo” di Tomasi di Lampedusa…), la musica
(basterebbe “Brigante se more” di Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò), la pittura
(si pensi a Goya, a Picasso con Guernica…)”. Il libro di Di Carlo dà la parola
vinti. E scopriamo – e non è una novità – che i vinti dicono la verità. La
verità è stata sempre negata? No. Pino Aprile cita alcuni “storici di
professione, da Roberto Martucci (“L’invenzione dell’unità d’Italia”) a Eugenio
Di Rienzo (“Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee”, pur con un
successivo rifacimento al ribasso, poco comprensibile), a John A. Davis (“Napoli
e Napoleone. L’Italia meridionale nelle rivoluzioni europee 1780-1860”)” e tanti
altri, “storici e no, da Paolo Mieli a Carlo Azeglio Ciampi. Ma l’opera di
Michele Eugenio Di Carlo – dice – è sistematica, onestamente distaccata, senza
timori di ‘sembrare’ squilibrata, quindi preconcetta, in un senso o nell’altro”.
Il nostro augurio è che a chi legge questo articolo venga la voglia di leggere
il libro di Michele Eugenio Di Carlo come di certo faremo noi.
PISACANE E
MAZZINI, AL DI LA’ DELL’AGIOGRAFIA RISORGIMENTALE.
Michele
Eugenio Di Carlo il 09.09.2020. Anche Ennio Lorenzini con il film Quanto è
bello lu murire acciso[i] del 1975, come Florestano Vancini tre anni prima
con Bronte, mette in scena un Risorgimento moderno, dove la realtà prende il
posto delle illusioni agiografiche e collega direttamente il fallimento degli
ideali e dei valori risorgimentali alla crisi sociale e politica degli anni
Settanta del Novecento. Il periodo in cui il film di Lorenzini è girato è quello
violento del terrorismo che renderà necessario la costituzione di un governo di
unità nazionale. Un periodo nel quale, in analogia a quello seguente il
Risorgimento, si spengono tante illusioni, quelle nate dalla stagione del
Sessantotto. Un periodo nel quale, come scrive Renato Ventura, Assistant
Professor presso l’Università di Dayton negli Stati Uniti, studioso della
letteratura italiana contemporanea, «… i protagonisti della vita politica e
sociale sono gli studenti, i lavoratori, le donne, che sulle piazze italiane
ripropongono diversi modelli interpretativi del Risorgimento, ovviamente in
controtendenza con la narrativa classica dei patrioti risorgimentali quali eroi
che si immolano per un ideale di patria e unità della nazione». Lorenzini
visualizza la spedizione di Carlo Pisacane del 1857 in netto contrasto con la
storiografia ufficiale sabauda e in antitesi con una letteratura che Ventura
elenca e giudica di «scarso valore artistico». Alla costruzione dell’identità
nazionale aveva contribuito non poco il poeta marchigiano Luigi Mercantini,
diventato noto scrivendo i versi de La spigolatrice di Sapri, dedicati alla
drammatica spedizione di Pisacane, graditi agli ambienti governativi per la
forte valenza patriottica e nazionalistica, divulgati attraverso la scuola per
il notevole valore didattico-pedagogico fino ai nostri giorni. Qualsiasi
studente delle Elementari e delle Medie era costretto ad imparare a memoria
almeno il celebre ritornello della poesia di Mercantini: «Eran trecento, eran
giovani e forti, e sono morti!», al fine di perpetuare nella memoria storica
popolare miti falsificati e di incidere intimamente nell’animo dei giovani
valori e ideali che proprio il Risorgimento aveva tradito. Utile a questo
proposito riproporre un breve excursus storico che si riferisce alla Spedizione
di Sapri, al di là della retorica risorgimentale. Appare significativo,
innanzitutto, che secondo lo scrittore di fine Ottocento Raffaele De Cesare, la
spedizione di Sapri, organizzata da Carlo Pisacane, non avrebbe turbato i sonni
di Ferdinando II quanto l’opuscolo di Antonio Scialoja, l’esule napoletano che
aveva criticato le finanze del Regno delle Due Sicilie. Lo storico Giacinto De’
Sivo ha raccontato i particolari dell’organizzazione dell’impresa che avrebbe
dovuto sollevare le popolazioni rurali contro la dinastia regnante dei Borbone,
sin da quando, in maggio, la giovane letterata inglese Jessie White proveniente
da Londra raggiungeva il Regno di Sardegna. Non da sola, visto che «con lei anco
era giunto, e travestito s’appiattava in Genova, il Mazzini stesso, che moveva
tutto». Pisacane, esule napoletano, aveva combattuto a Brescia e a Roma e nello
scontro di Velletri del 1849 era stato «capo dello stato maggiore» di Giuseppe
Garibaldi. Di idee socialiste e rivoluzionarie, era convinto che il regime
costituzionale piemontese nuocesse all’Italia più di quello del «Ferdinando
tiranno». È lo stesso de’ Sivo a ricordare che Pisacane, «a mostrar coscienza di
libertà», prima di partire per la sua impresa aveva scritto un Testamento
politico[4] del tutto slegato dalle idee mazziniane, che proponeva una vera
rivoluzione anche nei riguardi del regime costituzionale piemontese, che
Pisacane giudicava del tutto insufficiente a far risorgere l’Italia e
addirittura teso a ritardarlo. La storia avrebbe dato ragione a Pisacane per
come l’unità d’Italia sarebbe stata più tardi realizzata, lasciando da parte le
istanze popolari e piegandole agli interessi di aristocratici e borghesi. Già
dopo il 1849, il gruppo facente capo a Pisacane si era staccato da Giuseppe
Mazzini per percorrere la strada del socialismo rivoluzionario. La critica di
Pisacane a Mazzini, poco o affatto analizzata da storici e letterati liberali, è
feroce. Francesco Valentini ne ha evidenziato esattamente gli aspetti salienti:
«A Mazzini Pisacane rimprovera di non aver visto l’ascesa della plebe e il suo
irriducibile contrasto con la borghesia, cioè di non aver inteso la rivoluzione
come rivoluzione del povero, e, quanto all’ideologia mazziniana, la considera
come suscettibile di involuzioni aristocratiche-pedagogiche». Vista la distanza
da Pisacane, la presenza clandestina a Genova di Mazzini, richiamata da de’
Sivo, non sembra doversi collegare direttamente alla spedizione di Sapri,
giacché probabilmente finalizzata ad approfittarne per provocare tumulti in
alcune città del Regno di Sardegna, che – ricordiamo - aveva condannato Mazzini
alla pena di morte. Ma Pisacane per la storiografia ufficiale dell’epoca e per
la letteratura filo-sabauda doveva assumere solo le vesti di eroe, martire e
patriota, e oscurate dovevano apparire le profonde divergenze da Mazzini e
persino da Garibaldi. Nella prefazione del Saggio sulla rivoluzione di Pisacane,
pubblicata a Bologna nel 1894, Napoleone Colajanni scrive testualmente: «Carlo
Pisacane, come possono farlo oggi i più avanzati socialisti, combatte Giuseppe
Mazzini; ma se egli si mostra severo contro la sua dottrina (specialmente nella
parte che rispecchia il misticismo cristiano e la vana speranza di farne una
leva per la rigenerazione sociale) e contro il suo metodo (e non sempre le sue
accuse sono giuste), è sempre pieno di affetto e di rispetto per la persona»,
inoltre «nel propugnare la formola libertà e associazione da sostituirsi a
quella mazziniana Dio e popolo e all’altra francese libertà, uguaglianza e
fratellanza, che ai tempi di Pisacane erano in onore tra i repubblicani
italiani». Il 25 giugno 1857 il piroscafo Cagliari, appartenente alla compagnia
genovese Rubattino, salpava da Genova al comando del capitano Antonio Sitria con
trentadue uomini, tra i quali due macchinisti inglesi convinti all’impresa da
una lettera della White. L’epilogo della spedizione è noto, la mattina del 2
luglio gli scampati ad uno scontro del giorno precedente furono sorpresi nel
bosco di Sanza, dove le guardie urbane uccisero in uno scontro a fuoco Pisacane,
mentre i superstiti furono aggrediti dalla popolazione accorsa al suono delle
campane. Singolare destino per «quei liberatori di popolo cacciati dal popolo
come belve». Il 4 luglio il Conte di Groppello, ambasciatore piemontese a
Napoli, comunicava al Conte di Cavour la sorprendente resistenza della
popolazione: «La banda dovunque passò […] trovava avversione grandissima nella
popolazione»; circostanza che per de’ Sivo costituiva una testimonianza storica
manifesta «che i Borboni sì tiranni gridati fuori, eran nel regno amati, e
difesi dai tiranneggianti». Nel suo film Lorenzini valuta attentamente il
mancato coinvolgimento delle masse rurali e lo relaziona alla carente presenza
al Sud di una classe intellettuale, oltre che ad un Partito d’Azione non maturo
e scadente nell’elaborazione politica. Antonio Gramsci ne darà conferma
annotando che «Il Partito d’Azione era imbevuto della tradizione retorica della
letteratura italiana: confondeva l’unità culturale esistente nella
penisola ˗ limitata però a uno strato molto sottile della popolazione e
inquinata dal cosmopolitismo vaticano ˗ con l’unità politica e territoriale
delle grandi masse popolari che erano estranee a quella tradizione culturale e
se ne infischiavano dato che non conoscessero l’esistenza stessa». Una
disattenzione nei riguardi delle masse contadine del Sud che non sarà colmata,
nonostante Gaetano Salvemini, dal ceto dirigente e intellettuale del Partito
Socialista, poco propenso ad occuparsi fondatamente della irrisolta ripartizione
dei terreni per favorire la piccola proprietà contadina. La critica di Gramsci a
questo proposito sarà dura e definitiva. D’altro canto, il Conte di Cavour,
subito dopo la fallita impresa di Pisacane, tramite il Conte Groppello,
ambasciatore a Napoli, si era affrettato ipocritamente a far pervenire la sua
disapprovazione per un atto che fingeva di ritenere criminoso, mentre si
accingeva a chiedere la restituzione del piroscafo con l’aiuto dell’ambasciatore
inglese Hudson a Torino. Un atto sfrontato che non sfuggiva all’attento de’
Sivo, il quale avrebbe poi scritto che «chi facea professione di cacciar
d’Italia ogni mano straniera, chiamava or Francesi or Inglesi negli italici
piati». Infatti, il nuovo governo inglese, ritenuta illegittima la cattura del
piroscafo genovese, prendeva inaspettatamente le difese del Regno di Sardegna
chiedendone la restituzione tramite la mediazione del Governo svedese. L’8
giugno 1858, Ferdinando II, in maniera del tutto divergente dalla sua condotta
precedente nei rapporti con la Gran Bretagna, poneva fine alla contesa facendo
sapere di «non aver mai pensato d’aver forze da opporre ad Inghilterra».
Evidente come il diverso atteggiamento del sovrano napoletano era condizionato
dalla circostanza che il “nemico” Palmerston non era più il Primo Ministro alla
guida del Governo inglese. A distanza di un secolo e mezzo, uno degli storici
accademici più accreditati sui rapporti tra il Regno delle Due Sicilie e le
Potenze Europee tra il 1830 e il 1861, Eugenio Di Rienzo, ha scritto sulla
vicenda che la diplomazia napoletana si era rivelata incapace «di fronteggiare
le manovre di Cavour che, contra legem, aveva preteso e ottenuto, il 22 giugno
1858, la restituzione del Cagliari ». Società di Storia Patria per la Puglia
Quando il massone Garibaldi si mise a disposizione della
Chiesa di Roma. E gli "storici"? Tacciono… Ignazio
Coppola su I Nuovi Vespri il 10 febbraio 2017. Solo in Italia, per oltre 150
anni, verità storiche con tanto di testimonianze scritte possono essere nascoste
dagli storici di regime. Così, ancora oggi, i libri di storia continuano a
negare i fatti. Pensate: il ‘condottiero’ protagonista della breccia di Porta
Pia, anni prima, aveva messo la sua spada a disposizione della Chiesa di Pio IX
che gli disse no. In cambio di denaro era pronto, sono parole sue, “servire il
Papa, il Duca, il demonio, basta che fosse italiano e ci desse del pane”. E
l’hanno fatto ‘padre della patria’ intestandogli viene scuole…Forse non tutti
sanno che Giuseppe Garibaldi il massone dei due mondi e primo massone d’Italia
si mise per fame, per bisogno e necessità a disposizione del Papa e della
Chiesa. A tal proposito vi raccontiamo la storia dell’eroe dei due mondi e il
suo lungo e travagliato excursus di adesione alla massoneria e la sua
contraddittoria disponibilità, lui massone impenitente, di mettere la sua spada
al servizio di Pio IX e della Chiesa romana. Ma cominciamo dall’inizio. Appunto
dalla sua iniziazione alla “Fratellanza Universale” che avvenne nelle lontana
America del Sud, a 37 anni, nel 1844 per poi concludersi con la sua
consacrazione a Gran Maestro nel 1864. Il primo approccio di Giuseppe Garibaldi
alla Massoneria avviene nel 1835, ai tempi della sua permanenza in Brasile, in
seguito alla frequentazione dell’amico e compatriota Livio Zambeccari, a sua
volta affiliato alla loggia massonica di Porto Alegre, ai tempi della Repubblica
del Rio Grande do Sul. In seguito, prenderà maggiore dimestichezza con
“cappucci, grembiuli, mattoni e cazzuole”, iscrivendosi, nel 1844, a Montevideo
alla loggia L’asil de la virtude (loggia irregolare). Sempre nello stesso anno e
nella stessa città, aderisce alla loggia Les amis de la patrie sotto il Grande
Oriente di Francia. Nel 1850, frequenta le logge massoniche di New York, per poi
ritrovarsi negli anni 1853/54 “alloggiato” alla Philadelphes di Londra. Ma è nel
1859 che in Italia è autorevole protagonista della ricostituita loggia del
Grande Oriente d’Italia insieme, tra gli altri, a Cavour, a Filippo Cordova, a
Massimo D’Azeglio e al gran maestro Costantino Nigra. Siamo nella immediata
vigilia della spedizione in Sicilia e, come abbiamo visto, le massonerie di
Londra e Torino, preparandola a puntino, avranno un ruolo determinante e
incisivo per la buona riuscita dell’impresa.
A Garibaldi, entrato da “conquistatore” nella capitale
dell’Isola, nel giugno del 1860 verranno conferiti, dal Grande Oriente di
Palermo, tutti i gradi della gerarchia massonica (dal 4° al 33°) e la nomina a
Gran Maestro. Officianti della cerimonia, che si svolse a Palazzo Federico, in
via dei Biscottari, Francesco Crispi e altri cinque fratelli massoni. Alcuni
giorni dopo, sempre a Palermo, il neo Gran Maestro, in virtù del massimo grado
appena attribuitogli dalla gerarchia massonica, firma le proposte di
affiliazione del figlio Menotti (1 luglio 1860) e di alcuni autorevoli
componenti il suo stato maggiore: Giuseppe Guerzoni, Francesco Nullo, Enrico
Guastella e Pietro Ripari (3 luglio 1860). Il nostro eroe, da buon stakanovista
della Massoneria, come vediamo, ha il suo bel da fare. In una lettera inviata ai
“fratelli” di Palermo, il 20 marzo 1862 scriveva di “avere (…) assunto di gran
cuore il supremo ufficio conferitogli e ringraziava i liberi fratelli per
l’appoggio che essi avevano dato da Marsala al Volturno nelle grande opera di
affrancamento delle province meridionali. La nomina a Gran Maestro
rappresentava, come scrisse, la più solenne delle interpretazioni delle sue
tendenze, del suo animo, dei suoi voti, lo scopo per cui aveva mirato tutta la
sua vita. Ma il culmine della sua carriera massonica Garibaldi lo raggiungerà a
Firenze, nel maggio del 1864. I settantadue delegati della prima costituente
massonica, riunitisi nella città in riva all’Arno, lo elessero, a stragrande
maggioranza, Gran Maestro dei Liberi Muratori comprendente i due riti, scozzese
e italiano. Ma, a causa di divergenze e divisioni tra le varie anime del massimo
organo della Massoneria, non durerà che pochi mesi nella suprema carica. Gli
succederà Ludovico Frappolli. Nel maggio del 1867, in una successiva assemblea
tenutasi a Napoli, a sua parziale consolazione, verrà eletto Gran Maestro
Onorario. Nel 1881, infine, a poco meno di undici anni dalla sua morte, ottenne
la suprema carica del Gran Hierofante del rito egiziano del Menphís Misrain.
Come dicevamo all’inizio, da quanto abbiamo visto, Garibaldi più che eroe dei
due mondi può definirsi a pieno titolo il “massone dei due Mondi”. V’è da
credere che nella storia della Massoneria nessuno quanto lui abbia avuto più
affiliazioni nelle varie logge sparse nel mondo. Roba da guiness dei primati.
Eppure, i libri di testo delle nostre scuole, ipocritamente e in mala fede,
continuano a ignorare questa sua appartenenza, come protagonista e figura di
primo piano delle consorterie massoniche di mezzo mondo, e il ruolo pregnante
che la Massoneria ha avuto e ha continuato ad avere sino ai nostri giorni nella
storia del nostro Paese. Come altrettanto ipocritamente e in mala fede, nel
mancato rispetto della verità storica, tutto questo è stato sempre sottaciuto in
occasione delle celebrazioni del bicentenario della sua nascita e delle
celebrazioni di qualche anno fa dell’Unità d’Italia. In dispregio alle verità ed
alla trasparenza della storia, abbiamo bisogno di eroi a ogni costo sotto le
mentite spoglie di massoni, mercenari, avventurieri e predoni. Tra le mancate
virtù di Garibaldi a questo punto, ci piace infine sottolineare e ricordare
quella della sua incoerenza: come dire, era suo solito, del predicare bene e
razzolare male. Siamo a Montevideo nel 1847 mentre, con poca gloria, si sta
esaurendo la sua esperienza uruguaiana. Avendo nostalgia dell’Italia e alla
ricerca, da buon mercenario ed avventuriero, di un nuovo padrone cui mettere a
disposizione la propria spada e i propri compagni d’arme, non trova di meglio
che proporsi, egli massone, anticlericale e mangiapreti impenitente, al servizio
della Chiesa e di Pio IX. Nell’agosto di quell’anno così scrive a un suo amico:
“Io più che mai, siccome i compagni non aneliamo ad altro che al ritorno in
patria comunque sia. Dunque, mio amico, se vedeste fosse possibile servire il
Papa, il Duca, il demonio, basta che fosse italiano e ci desse del pane. Siamo
pronti a qualsiasi condizione purché non indecorosa”. E con questa propensione
all’asservimento alla Chiesa ed a Pio IX cosi scrive il 12 ottobre 1847 a
monsignor Gaetano Bedini, nunzio apostolico a Rio de Janiero con giurisdizione
sui paesi platensi: “Offro a Pio IX la mia spada e la legione italiana per la
patria e per la Chiesa. Ricordando (egli sempre massone, ateo e anticlericale) i
precetti della nostra augusta religione sempre nuovi e sempre immortali, pur
sapendo che il trono di Pietro riposa sopra tali fondamenti che non abbisognano
di aiuto, perché le forze umane non possono scuoterli”. Monsignor Bedini, a nome
di Pio IX, rispose con molti ringraziamenti e gentilezza, declinando l’offerta
di Garibaldi e della legione Italiana. Più avanti, Garibaldi, come era nella sua
indole, non dimostrando altrettanta cortesia, definirà Pio IX e i preti un
mucchio di letame. Salvo poi, dopo la conquista della capitale della Sicilia, il
15 luglio del 1860, in occasione della festa di santa Rosalia, non aver alcun
pregiudizio, egli mangiapreti e impertinente massone, a sedere sul più alto
trono della Cattedrale di Palermo per ricevere l’incenso dall’arcivescovo di
quella città, secondo la tradizionale cerimonia della così detta “cappella
reale” simboleggiante i poteri della Legazia Apostolica. E lo ritroviamo, poco
meno di un mese dopo, a Napoli, con altrettanto fervore religioso, rendere
omaggio, se pur Gran Maestro Venerabile della Massoneria, alla Madonna
Venerabile nella chiesa di Piedigrotta ed a un breve discorso del sacerdote
officiante rispose con parole di devoto amore alla religione cristiana e alle
sue grandi e sublimi verità. Il 10 giugno, infine, rispettando le consuetudini
religiose di questa città, dispose la celebrazione della ricorrenza del patrono
San Gennaro, presenziando autorevolmente assieme agli alti prelati della chiesa
napoletana al miracoloso scioglimento del sangue del santo. Misteri della fede
massonica o cattolica dell’eroe dei due mondi. Fate voi. Ai lettori l’ardua
sentenza.
L’altra
storia del Sud. Caro professor Barbero, su Garibaldi e l’unità diciamola tutta…
Michele Eugenio Di Carlo su Il Sud On Line il 4 marzo 2020.
Professor Alessandro Barbero, essendo lei uno degli storici medievisti più
accreditati, perché non lascia la storia del nostro processo unitario a
specialisti già in evidente difficoltà? In un suo famoso intervento divulgato
dal canale YouTube dal titolo “La verità su Garibaldi”, lei tentando di
riproporre la figura dell’ “Eroe dei due mondi” dice molte verità. Ma da quelle
stesse verità che lei racconta, omettendone altre che le dirò, il personaggio
Garibaldi al vaglio attento dello studioso e dello storico, al di là delle
“leggende truffaldine”, non esce affatto fortificato come repubblicano, come
patriota, come politico. Lasci allora che un modesto studioso non accademico,
non “educato” a frequentare studi televisivi importanti e spesso definito
impropriamente “neoborbonico”, spieghi cosa Lei non ha vagliato, forse
intenzionalmente, della figura di Garibaldi. Il Giuseppe Garibaldi, ricordato in
tutta Italia con statue, intitolazioni di vie e di piazze, godeva di uno stretto
legame che lo vincolava alla Gran Bretagna, potenza coloniale che aveva forti
interessi politici e commerciali da difendere nel Mediterraneo e che non si era
mai fidata di Ferdinando II scatenandogli contro una spietata campagna
denigratoria, i cui effetti persistono ancora oggi nei testi di storici
assurdamente ancorati ad una storiografia ufficiale liberale sabauda. L’idea di
preparare una invasione militare in Sicilia non era stata di Garibaldi. In una
lettera del 5 maggio ad Agostino Bertani, pubblicata l’8 maggio 1860 sul
“Pungolo”, è lo stesso Garibaldi a renderlo noto. Anche per Camillo Benso Conte
di Cavour, non era il momento propizio per sostenere i moti siciliani e
impegnarsi nell’organizzazione di una spedizione militare in Sicilia, per le
ragioni che lei stesso ha esposto. Infatti, il suo collega Pietro Pastorelli,
professore emerito di Storia delle relazioni internazionali all’Università di
Roma “La Sapienza” e presidente della Commissione del Ministero degli Esteri per
la pubblicazione dei Documenti Diplomatici Italiani, dopo aver consultato
l’ultima edizione completa dei Carteggi di Cavour e i documenti editi dagli
archivi inglesi, francesi, e prussiani, non ha lasciato alcun dubbio sul fatto
che sia stato il Regno Unito ad incoraggiare e sostenere l’azione militare in
Sicilia. Gentile professor Barbero, il ruolo della Gran Bretagna non è un
elemento irrilevante nella ricostruzione storica della figura di Garibaldi. Le
critiche della Gran Bretagna al trattato franco-sardo del 24 marzo erano note,
l’annessione della Savoia e di Nizza alla Francia aveva raggelato i rapporti tra
Londra e Parigi e indotto il Governo inglese ad emettere un giudizio di totale
inaffidabilità sul Conte di Cavour. Il pericolo che si potessero riaprire le
porte d’Oriente alla Russia a cui il Regno delle Due Sicilie era particolarmente
legato e che la Francia potesse allargare la sua influenza anche in Italia
meridionale, mettevano in discussione l’egemonia economica e commerciale della
Gran Bretagna nel Mediterraneo. Già il 5 aprile Cavour, sospettando l’azione
inglese nell’insurrezione di Palermo, contattava telegraficamente d’Azeglio,
ambasciatore a Londra, affinché indagasse su un’ eventualità del genere. Qualche
giorno dopo d’Azeglio, sempre in contatto con il Primo Ministro inglese
Palmerston, riferiva al Conte che l’atteggiamento di sfiducia nei suoi riguardi
non era affatto mutato e che ulteriori altre annessioni italiane favorite dalla
Francia non sarebbero state accettate dall’Inghilterra. Pastorelli deduce dai
comportamenti la linea seguita dagli inglesi; una linea che si risolse nel
sostenere con un accordo segreto l’operazione militare di Garibaldi nel sud
Italia senza nemmeno contattare il Primo Ministro sabaudo di cui Palmerston non
si fidava. Naturalmente, il sostegno a Garibaldi doveva essere negato anche di
fronte all’evidenza per evitare reazioni di Francia, Austria, Russia e Prussia.
Il 30 aprile, il ministro degli Esteri inglese Russel trasmetteva
all’ambasciatore Hudson le istruzioni sulla linea politica che il Governo
torinese avrebbe dovuto seguire per andare incontro agli interessi inglesi.
Londra desiderava il non intervento di Torino nelle questioni riguardanti il
Regno delle Due Sicilie, perché convinta che un intervento diretto del Piemonte
avrebbe comportato l’intervento armato dell’Austria e per reazione quello della
Francia a difesa di Torino. Un’eventualità del genere avrebbe comportato
l’ulteriore cessione di territori italiani alla Francia (Liguria o Sardegna) e
uno squilibrio nella prevalenza inglese del Mediterraneo. Questa la ragione
precisa per cui l’Inghilterra si apprestava a sostenere l’impresa azzardata e
“piratesca” di Garibaldi. Ed era questo anche il motivo per cui Garibaldi
cambiava diplomaticamente atteggiamento nei riguardi di Cavour, dopo la frattura
dei loro rapporti seguita alla cessione di Nizza. Finanche lo storico Giuseppe
Galasso ha apprezzato il comportamento opportunistico di Garibaldi in quel
frangente, scrivendo che aveva «lucidamente inteso le condizioni» che potevano
agevolare la sua impresa, mantenendo a ogni costo «il rapporto con Torino, per
averne l’appoggio diplomatico e militare». A questo punto professor Barbero, il
Garibaldi socialista, repubblicano di cui lei parla già appare come una figura
sfumata e dai contorni ambigui. Non solo perché tradisce i suoi ideali, ma
perché come scrive il suo compianto collega Galasso è costretto a dimostrare «di
non procedere nel Mezzogiorno ad alcuna sovversione dell’ordine sociale,
garantendo insieme l’opinione pubblica europea e la borghesia meridionale».
Garibaldi, temendo impedimenti e ostacoli, vince la forte inimicizia e scrive a
Cavour un messaggio per coinvolgerlo nell’impresa. Convocato il 2 maggio a
Bologna, incontra Vittorio Emanuele II e Cavour, illustra i piani dell’impresa,
conferma l’appoggio inglese, riceve l’approvazione sotto copertura del Re e del
Primo Ministro. Professor Barbero, l’altro suo collega Eugenio Di Rienzo,
accademico esperto, direttore della “Nuova Rivista Storica”, noto docente di
Storia Moderna presso l’Università “La Sapienza” di Roma, riprendendo una
lettera di Massimo d’Azeglio all’ammiraglio Carlo Pellion, conte di Persano,
riporta alla luce che il vero piano affidato da Cavour all’ammiraglio era quello
di condurre «una guerra non dichiarata, sotto neutralità apparente, contro
Francesco II». Da quanto riportato si evince chiaramente che il Conte sosteneva
un’azione illegale, contro il diritto internazionale, temendone le ripercussioni
a livello europeo. Quindi, il compito di Persano non era quello dichiarato di
avversare il progetto, ma di fornire assistenza a Garibaldi e a tutte le
spedizioni successive di uomini e di mezzi, ponendo tutti gli impedimenti
possibili alla reazione della flotta borbonica, anche al costo di continuare a
corrompere gli ufficiali napoletani favorendone il trasferimento sotto le
insegne della Marina dei Savoia. Professor Barbero, come Lei riferisce, i Mille
non erano Mille, ma è bene chiarire che Garibaldi è uno strumento in mano alla
Gran Bretagna, affiancata da un Regno di Sardegna che agisce in maniera indegna.
Professor Barbero, il tanto vituperato legittimista Giacinto de’ Sivo si sbaglia
forse quando, parlando di Cavour, afferma che era un «ipocrita istigatore di
guerra civile cui fingeva di deplorare, accennava a italianità, quasi non
fossero italiani i combattenti pel diritto. Per esso erano italiani e
compatrioti i ribelli, i traditori e i codardi che gli vendevano la patria […]
»? Prof. Barbero, Garibaldi nelle sue “Memorie” così descrive l’approdo a
Marsala dell’11 maggio 1860: «… la presenza di due legni da guerra Inglesi
influì alquanto sulla determinazione dei comandanti de’ legni nemici,
naturalmente impazienti di fulminarci; e ciò diede tempo ad ultimare lo sbarco
nostro. La nobile bandiera d’Albione contribuì, anche questa volta, a
risparmiare lo spargimento di sangue umano; ed io, beniamino di codesti Signori
degli Oceani, fui per la centesima volta il loro protetto». Professor Barbero,
non la colpisce profondamente constatare che «l’eroe dei due mondi», il
rivoluzionario Garibaldi, si riteneva «beniamino» di coloro i quali avevano
issato in mezzo mondo la bandiera di quella Gran Bretagna che era ritenuta la
più grande potenza coloniale e imperialistica al mondo, che solo da qualche anno
aveva abolito lo schiavismo e il traffico di carne umana, che non esitava a
passare per le armi i suoi nemici interni e esterni, che manteneva in condizioni
di estrema povertà le classi proletarie, che permetteva che milioni di suoi
sudditi emigrassero per la fame, che aveva un sistema carcerario tra i peggiori
al mondo? Professor Barbero, non desta in Lei nessuna impressione il fatto che
chi progettava di unificare l’Italia dal gioco straniero si affidava pienamente
alla Gran Bretagna nel tentativo di sopraffare una legittima monarchia
perfettamente italiana? Un Garibaldi non poteva andare oltre le semplici
dichiarazioni di affezione, amicizia, simpatia e rivelare chiaramente quale
fosse stato il ruolo degli inglesi nella spedizione anche se, come spiega ancora
il suo collega Di Rienzo, la presenza della flotta inglese non solo nel mare di
Sicilia era vista come una minaccia concreta sia dagli ufficiali della Marina
napoletana sia da Francesco II e quasi sicuramente la decisione di approdare a
Marsala era stata concordata da Garibaldi con i referenti del Governo inglese. E
a proposito dei soldi necessari all’impresa bisogna anche qui chiarire meglio il
ruolo della Gran Bretagna e della Massoneria. Infatti il 4 marzo 1861, quando
l’Italia stava per essere unificata, il deputato John Pope Hennessy riaccendeva
la discussione e contestava al Governo inglese di aver interferito nella
vittoriosa impresa garibaldina, sostenendola militarmente, finanziariamente e
diplomaticamente, mentre ufficialmente caldeggiava ipocritamente la linea del
non intervento negli affari italiani. Secondo Pope le due navi della flotta
inglese erano presenti nella rada del porto di Marsala col preciso compito di
fornire il supporto necessario ad assicurare lo sbarco a Marsala degli uomini in
camicia rossa. Pochi erano i dubbi sul coinvolgimento inglese nella conquista
militare del Regno delle Due Sicilie; dubbi che si affievolirono del tutto
quando lo stesso Pope rese nota la lettera con cui Vittorio Emanuele II aveva
ringraziato il Governo inglese. Professor Barbero, come Lei afferma, Garibaldi
“socialista” non piaceva a Karl Marx. Marx ed Engels seguirono con attenzione
l’azione di Garibaldi, ma solo inizialmente, anche perché sono noti i loro
giudizi negativi sull’evoluzione politica italiana. E d’altronde, come poteva
piacere a Marx il Garibaldi che supportato da ambienti finanziari e politici
inglesi finiva per consegnare il Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele II
e alla casta politico-militare dei Savoia, che trattarono il sud Italia come
fosse una colonia, instaurandovi un feroce regime repressivo? Professor Barbero,
anche sul fatto che la figura di Garibaldi è stata proposta più volte nella
storia dalla sinistra come icona positiva – da ultimi i comunisti svizzeri – ha
totalmente ragione, ma non c’è da esserne soddisfatti. Pensi quanto sia stata
potente la macchina della propaganda agiografica messa in piedi dai governi
liberali dopo il processo unitario, se anche la sinistra non è riuscita a
distinguere il Garibaldi “socialista” da quello che consegna la conquista
militare a Vittorio Emanuele II. Professor Barbero, non si può, d’altro canto,
non registrare l’utilizzo strumentale che ne fece anche il fascismo. Fulvio
Orsitto, docente accademico esperto di cinema, senza mezzi termini, considera la
seconda fase della cinematografia, quella definita «fascista», un periodo
storico in cui «la ricostruzione della storia patria si svolge in modo
funzionale agli interessi di un regime che intende essere considerato la logica
conclusione del processo risorgimentale». Un Risorgimento manipolato
strumentalmente al fine di nazionalizzare le masse, dato che non poteva sfuggire
all’intellettualità fascista come il cinema fosse un potente mezzo di
comunicazione, piegabile ad uso propagandistico, e che il potere poteva
efficacemente utilizzare per indottrinare e ideologizzare le masse. Emblematica
di questa maniera romantica e fantastica di rappresentare il Risorgimento è il
film “1860”, diretto da Alessandro Blasetti nel 1934. Daniele Fioretti,
peraltro, docente alla Miami University, non nutre alcun dubbio sulla
circostanza che Blasetti non si era affatto proposto di fornire un quadro
storico verosimile del Risorgimento, ma una banale celebrazione agiografica
dell’epopea garibaldina con un intento smaccatamente propagandistico. Il
pericolo concreto fu allora persino avvertito dal filosofo tedesco Walter
Benjamin: la storia e le tradizioni erano diventate lo strumento della classe
dominante, mentre compito dello storico era proprio quello di sottrarre la
storia a questo tipo di manipolazione. Egregio professor Barbero, non Le sembra
un ammonimento più che mai attuale. Per finire professor Barbero, – mi riferisco
ai suoi giudizi sulle “leggende truffaldine” della sua ultima visita a Napoli –
si convinca anche Lei relativamente a quanto ha affermato il suo collega
specialista della materia Eugenio Di Rienzo: il lavoro di ricerca degli studiosi
revisionisti non accademici del Risorgimento è prezioso. Infatti, tornando a
Garibaldi, su una delle questioni centrali della “avventura” in Sicilia, Di
Rienzo ha affermato che la longa manus del ministero whig ha «potentemente
contribuito (soprattutto ma non soltanto con un supporto economico) al successo
della "liberazione del Mezzogiorno"», aggiungendo lucidamente «che la
storiografia ufficiale ha sempre accantonato, spesso con immotivata sufficienza»
un’ipotesi «che ha trovato credito soltanto in una letteratura non accademica
accusata ingiustamente, a volte, di dilettantismo e di preconcetta faziosità
filoborbonica».
L’altra
storia. la verità su Mazzini e Pisacane.
Michele
Eugenio Di Carlo. Anche Ennio Lorenzini con il film Quanto è bello lu murire
acciso del 1975, come Florestano Vancini tre anni prima con Bronte, mette in
scena un Risorgimento moderno, dove la realtà prende il posto delle illusioni
agiografiche e collega direttamente il fallimento degli ideali e dei valori
risorgimentali alla crisi sociale e politica degli anni Settanta del Novecento.
Il periodo in cui il film di Lorenzini è girato è quello violento del terrorismo
che renderà necessario la costituzione di un governo di unità nazionale. Un
periodo nel quale, in analogia a quello seguente il Risorgimento, si spengono
tante illusioni, quelle nate dalla stagione del Sessantotto. Un periodo nel
quale, come scrive Renato Ventura, Assistant Professor presso l’Università di
Dayton negli Stati Uniti, studioso della letteratura italiana contemporanea, «…
i protagonisti della vita politica e sociale sono gli studenti, i lavoratori, le
donne, che sulle piazze italiane ripropongono diversi modelli interpretativi del
Risorgimento, ovviamente in controtendenza con la narrativa classica dei
patrioti risorgimentali quali eroi che si immolano per un ideale di patria e
unità della nazione» . Lorenzini visualizza la spedizione di Carlo Pisacane del
1857 in netto contrasto con la storiografia ufficiale sabauda e in antitesi con
una letteratura che Ventura elenca e giudica di «scarso valore artistico». Alla
costruzione dell’identità nazionale aveva contribuito non poco il poeta
marchigiano Luigi Mercantini, diventato noto scrivendo i versi de La
spigolatrice di Sapri, dedicati alla drammatica spedizione di Pisacane, graditi
agli ambienti governativi per la forte valenza patriottica e nazionalistica,
divulgati attraverso la scuola per il notevole valore didattico-pedagogico fino
ai nostri giorni. Qualsiasi studente delle Elementari e delle Medie era
costretto ad imparare a memoria almeno il celebre ritornello della poesia di
Mercantini: «Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!», al fine di
perpetuare nella memoria storica popolare miti falsificati e di incidere
intimamente nell’animo dei giovani valori e ideali che proprio il Risorgimento
aveva tradito. Utile a questo proposito riproporre un breve excursus storico che
si riferisce alla Spedizione di Sapri, al di là della retorica risorgimentale.
Appare significativo, innanzitutto, che secondo lo scrittore di fine Ottocento
Raffaele De Cesare, la spedizione di Sapri, organizzata da Carlo Pisacane, non
avrebbe turbato i sonni di Ferdinando II quanto l’opuscolo di Antonio Scialoja,
l’esule napoletano che aveva criticato le finanze del Regno delle Due Sicilie.
Lo storico Giacinto De’ Sivo ha raccontato i particolari dell’organizzazione
dell’impresa che avrebbe dovuto sollevare le popolazioni rurali contro la
dinastia regnante dei Borbone, sin da quando, in maggio, la giovane letterata
inglese Jessie White proveniente da Londra raggiungeva il Regno di Sardegna. Non
da sola, visto che «con lei anco era giunto, e travestito s’appiattava in
Genova, il Mazzini stesso, che moveva tutto». Pisacane, esule napoletano, aveva
combattuto a Brescia e a Roma e nello scontro di Velletri del 1849 era stato
«capo dello stato maggiore» di Giuseppe Garibaldi. Di idee socialiste e
rivoluzionarie, era convinto che il regime costituzionale piemontese nuocesse
all’Italia più di quello del «Ferdinando tiranno». È lo stesso de’ Sivo a
ricordare che Pisacane, «a mostrar coscienza di libertà», prima di partire per
la sua impresa aveva scritto un Testamento politico del tutto slegato dalle idee
mazziniane, che proponeva una vera rivoluzione anche nei riguardi del regime
costituzionale piemontese, che Pisacane giudicava del tutto insufficiente a far
risorgere l’Italia e addirittura teso a ritardarlo . La storia avrebbe dato
ragione a Pisacane per come l’unità d’Italia sarebbe stata più tardi realizzata,
lasciando da parte le istanze popolari e piegandole agli interessi di
aristocratici e borghesi. Già dopo il 1849, il gruppo facente capo a Pisacane si
era staccato da Giuseppe Mazzini per percorrere la strada del socialismo
rivoluzionario. La critica di Pisacane a Mazzini, poco o affatto analizzata da
storici e letterati liberali, è feroce. Francesco Valentini ne ha evidenziato
esattamente gli aspetti salienti: «A Mazzini Pisacane rimprovera di non aver
visto l’ascesa della plebe e il suo irriducibile contrasto con la borghesia,
cioè di non aver inteso la rivoluzione come rivoluzione del povero, e, quanto
all’ideologia mazziniana, la considera come suscettibile di involuzioni
aristocratiche-pedagogiche». Vista la distanza da Pisacane, la presenza
clandestina a Genova di Mazzini, richiamata da de’ Sivo, non sembra doversi
collegare direttamente alla spedizione di Sapri, giacché probabilmente
finalizzata ad approfittarne per provocare tumulti in alcune città del Regno di
Sardegna, che – ricordiamo – aveva condannato Mazzini alla pena di morte. Ma
Pisacane per la storiografia ufficiale dell’epoca e per la letteratura
filo-sabauda doveva assumere solo le vesti di eroe, martire e patriota, e
oscurate dovevano apparire le profonde divergenze da Mazzini e persino da
Garibaldi. Nella prefazione del Saggio sulla rivoluzione di Pisacane, pubblicata
a Bologna nel 1894, Napoleone Colajanni scrive testualmente: «Carlo Pisacane,
come possono farlo oggi i più avanzati socialisti, combatte Giuseppe Mazzini; ma
se egli si mostra severo contro la sua dottrina (specialmente nella parte che
rispecchia il misticismo cristiano e la vana speranza di farne una leva per la
rigenerazione sociale) e contro il suo metodo (e non sempre le sue accuse sono
giuste), è sempre pieno di affetto e di rispetto per la persona», inoltre «nel
propugnare la formola libertà e associazione da sostituirsi a quella mazziniana
Dio e popolo e all’altra francese libertà, uguaglianza e fratellanza, che ai
tempi di Pisacane erano in onore tra i repubblicani italiani». Il 25 giugno 1857
il piroscafo Cagliari, appartenente alla compagnia genovese Rubattino, salpava
da Genova al comando del capitano Antonio Sitria con trentadue uomini, tra i
quali due macchinisti inglesi convinti all’impresa da una lettera della White.
L’epilogo della spedizione è noto, la mattina del 2 luglio gli scampati ad uno
scontro del giorno precedente furono sorpresi nel bosco di Sanza, dove le
guardie urbane uccisero in uno scontro a fuoco Pisacane, mentre i superstiti
furono aggrediti dalla popolazione accorsa al suono delle campane. Singolare
destino per «quei liberatori di popolo cacciati dal popolo come belve». Il 4
luglio il Conte di Groppello, ambasciatore piemontese a Napoli, comunicava al
Conte di Cavour la sorprendente resistenza della popolazione: «La banda dovunque
passò […] trovava avversione grandissima nella popolazione»; circostanza che per
de’ Sivo costituiva una testimonianza storica manifesta «che i Borboni sì
tiranni gridati fuori, eran nel regno amati, e difesi dai tiranneggianti». Nel
suo film Lorenzini valuta attentamente il mancato coinvolgimento delle masse
rurali e lo relaziona alla carente presenza al Sud di una classe intellettuale,
oltre che ad un Partito d’Azione non maturo e scadente nell’elaborazione
politica. Antonio Gramsci ne darà conferma annotando che «Il Partito d’Azione
era imbevuto della tradizione retorica della letteratura italiana: confondeva
l’unità culturale esistente nella penisola ˗ limitata però a uno strato molto
sottile della popolazione e inquinata dal cosmopolitismo vaticano ˗ con l’unità
politica e territoriale delle grandi masse popolari che erano estranee a quella
tradizione culturale e se ne infischiavano dato che non conoscessero l’esistenza
stessa» . Una disattenzione nei riguardi delle masse contadine del Sud che non
sarà colmata, nonostante Gaetano Salvemini, dal ceto dirigente e intellettuale
del Partito Socialista, poco propenso ad occuparsi fondatamente della irrisolta
ripartizione dei terreni per favorire la piccola proprietà contadina. La critica
di Gramsci a questo proposito sarà dura e definitiva. D’altro canto, il Conte di
Cavour, subito dopo la fallita impresa di Pisacane, tramite il Conte Groppello,
ambasciatore a Napoli, si era affrettato ipocritamente a far pervenire la sua
disapprovazione per un atto che fingeva di ritenere criminoso, mentre si
accingeva a chiedere la restituzione del piroscafo con l’aiuto dell’ambasciatore
inglese Hudson a Torino. Un atto sfrontato che non sfuggiva all’attento de’
Sivo, il quale avrebbe poi scritto che «chi facea professione di cacciar
d’Italia ogni mano straniera, chiamava or Francesi or Inglesi negli italici
piati». Infatti, il nuovo governo inglese, ritenuta illegittima la cattura del
piroscafo genovese, prendeva inaspettatamente le difese del Regno di Sardegna
chiedendone la restituzione tramite la mediazione del Governo svedese. L’8
giugno 1858, Ferdinando II, in maniera del tutto divergente dalla sua condotta
precedente nei rapporti con la Gran Bretagna, poneva fine alla contesa facendo
sapere di «non aver mai pensato d’aver forze da opporre ad Inghilterra».
Evidente come il diverso atteggiamento del sovrano napoletano era condizionato
dalla circostanza che il “nemico” Palmerston non era più il Primo Ministro alla
guida del Governo inglese. A distanza di un secolo e mezzo, uno degli storici
accademici più accreditati sui rapporti tra il Regno delle Due Sicilie e le
Potenze Europee tra il 1830 e il 1861, Eugenio Di Rienzo, ha scritto sulla
vicenda che la diplomazia napoletana si era rivelata incapace «di fronteggiare
le manovre di Cavour che, contra legem, aveva preteso e ottenuto, il 22 giugno
1858, la restituzione del Cagliari » . (Pubblicato il 9 settembre 2020 © «Il Sud
On Line»)
·
Napoli e Sud poco
combattivi?
L’altra
storia del Sud. Napoli e Palermo, capitali contro.
Michele
Eugenio Di Carlo su ilsudonline.it l'8 ottobre 2020. Nella Sicilia del 1860, gli
intellettuali, gli esponenti del decaduto ma ancora vitale baronato, gli esuli,
preparavano da tempo il clima funzionale a liberarsi dalla dinastia borbonica.
Tra i più attivi cospiratori vi erano i mazziniani Francesco Crispi e Rosolino
Pilo; a Malta col consenso britannico agiva il modenese Nicola Fabrizi, mentre
il siciliano ex mazziniano Giuseppe La Farina, segretario dell’Associazione
Nazionale, in stretta amicizia con Cavour, si era piegato all’idea di un’unità
d’Italia sotto le insegne di Casa Savoia, anticipando su questo piano Giuseppe
Garibaldi. Già in agosto Crispi era giunto in Sicilia con un falso passaporto,
al fine di rassicurare i sovvertitori che Garibaldi e Mazzini avrebbero aderito
appoggiando in pieno la loro lotta di liberazione. Il 27 novembre 1859, il capo
della polizia Salvatore Maniscalco veniva pugnalato non mortalmente mentre
entrava nella cattedrale di Palermo. Il barone Giovanni Riso, nel suo palazzo di
via Toledo nel centro della città, organizzava feste danzanti allo scopo di
favorire segretamente incontri tra congiurati. Francesco II di Borbone, «stretto
fra le mene di famiglia e gli intrighi del partito piemontese, sospettoso nei
confronti di Napoleone III», intimorito dalle mire inglesi in Sicilia, decideva
di chiedere un parere al Consiglio dei Ministri, il quale giungeva alla
conclusione unanime che solo mezzi repressivi avrebbero garantito l’ordine
pubblico. Pertanto, quando il Ministro della Polizia mostrò le prove di una
vasta cospirazione siciliana contro la dinastia vennero eseguiti diversi
arresti. Salvatore Lupo, docente di Storia Contemporanea all’Università di
Palermo, ha chiarito gli aspetti del profondo solco che separava Palermo da
Napoli, capitali che nel 1816 contavano rispettivamente 114 e 322 mila abitanti.
Con la Restaurazione del 1815 e il ritorno di Ferdinando I a Napoli, il modello
amministrativo centralizzato francese non era stato disapplicato e non garantiva
le periferie. Nel biennio1816-17, Foggia era la seconda città continentale del
Regno con appena 20 mila abitanti; in un contesto demografico del genere Palermo
non solo passava in secondo piano rispetto a Napoli, ma rischiava di perdere la
supremazia isolana rispetto a città come Messina e Catania che già allora
superavano i 40 mila abitanti. A seguito dei moti carbonari del 1820, Ferdinando
I aveva concesso una costituzione di tipo spagnolo, mentre Palermo mirava a
tenersi stretta la Costituzione filo-aristocratica del 1812, oltre che una
completa autonomia. Le città orientali della Sicilia si erano schierate contro
Palermo, al fianco del governo costituzionale napoletano: «fu guerra civile dei
siciliani contro i napoletani, e guerra civile dei siciliani tra loro». La nuova
cospirazione siciliana era scattata all’alba del 4 aprile 1860, nella chiesa e
nei magazzini della Gancia dei Frati Minori. Andrea Aveto, in “Cronache
dell’Unità d’Italia” [4], riporta il racconto della sollevazione siciliana
tramite un articolo non firmato pubblicato il 29 aprile 1860 dal giornale «La
Nazione», associato ad una nota di redazione riconducente l’autore ad
«un’autorevole persona di Palermo» non meglio specificata. È una ricostruzione
di parte che viene spedita ad un esule siciliano che, mantenendo l’anonimato, la
trasmette alla direzione del giornale di Torino con l’evidente fine di mettere
in primo piano la crudeltà della Polizia e dell’Esercito Regio borbonico, oltre
che la crudezza di una repressione che si compie il 5 aprile a colpi di cannone
con uccisione di donne e bambini, saccheggi, incendio di case, nel sobborgo
meridionale di Palermo detto “i Porrazzi ”. La battaglia dei rivoltosi nei
giorni seguenti si sposta nei sobborghi e nei villaggi. Il 6 aprile nel
villaggio di Baida, l’8 aprile nei pressi della villa reale alla Favorita, il 9
aprile nei grossi comuni di Misilmeri e Bagheria, il 10 aprile a Mondello, l’11
aprile di nuovo a Baida, il 12 a Monreale, quando diventa chiaro al narratore
stesso che i rivoltosi hanno perso e che la sollevazione promessa e auspicata
dell’intera Sicilia non si è compiuta. Il 15 aprile i tredici arrestati alla
Gancia di bassa estrazione sociale vengono fucilati, mentre il barone Riso, il
principe Giandinelli, il Cavaliere di San Giovanni, il Principino Monteleone,
arrestati il 7 aprile, il Duca di Verduca arrestato alla vigilia dei moti, padre
Ottavio Lanza arrestato l’11 aprile, non subiscono lo stesso trattamento.
L’anonimo siciliano descrive anche una dimostrazione popolare pacifica avvenuta
il 13 aprile a Palermo, alle ore 17 al grido generalizzato ed entusiastico di
«Viva l’Italia, viva Vittorio Emanuele», non impedita misteriosamente dalle
forze di polizia in una città già posta sotto stato d’assedio e circondata
dall’esercito. Infine, l’articolo fa riferimento con soddisfazione alla
circostanza che l’insurrezione, seppur fallita a Palermo, si mantiene viva nella
provincia, contrastata dai «regii» che con «ferocia e rapacità» utilizzano da
lontano le artiglierie, «ammazzando gli inermi e le donne». Giacinto De’ Sivo ha
scritto che il Maniscalco era stato messo al corrente da un frate del convento
della Gancia della sommossa, organizzata dal «fontanaio» Francesco Riso. Lo
scrittore di Maddaloni, documentatissimo sugli avvenimenti di quei giorni, ha
accertato che durante la notte circa settanta rivoltosi erano stati fatti
entrare dal frate portinaio nel giardino del convento, mentre altri, accortisi
della presenza delle sentinelle, si erano dileguati temendo di essere scoperti.
Ciononostante, alle cinque del mattino i congiurati aprivano il fuoco uccidendo
il soldato regio Domenico Cipollone, la prima vittima degli scontri. Preso il
convento, il “popolino” si dava al saccheggio, impedito dall’intervento dei
soldati all’interno della chiesa. Appena giunta a Napoli la notizia dei tredici
arrestati alla Gancia, Francesco II dava disposizioni affinché fosse loro
concessa la grazia e fossero perdonati coloro che spontaneamente deponevano le
armi. Non sarebbe andata come Francesco II aveva raccomandato; infatti il 13
aprile, la manifestazione descritta dell’anonimo siciliano su «La Nazione»
(ridotta da de’ Sivo a 200 persone disperse dalla polizia) e l’eventualità di un
tumulto previsto per il giorno 15, spinsero verso la convocazione di un
Consiglio di Guerra e la condanna a morte dei tredici arrestati, quantunque
Francesco II avesse prospettato una soluzione diversa. Gli scontri nel
territorio di Palermo terminavano il 18 aprile a Carini con una grave sconfitta
dei rivoltosi. Nemmeno un mese dopo, la Gran Bretagna, armando Garibaldi, non
rinuncerà al pieno controllo della Sicilia e del Mediterraneo.
IL TRATTATO
DI FERDINANDO II CON L'ARGENTINA DEL 1857.
Michele
Eugenio Di Carlo il 30 settembre. Ferdinando II, re delle Due Sicilie, nel
gennaio del 1857, intraprese trattative con la Repubblica Argentina al fine di
confinare prigionieri politici condannati e reclusi e formare una colonia di
napoletani. Il Governo inglese, che aveva minacciato Napoli con la flotta da
guerra e ritirato la propria delegazione diplomatica, finse di considerarla una
soluzione che andava incontro ai propri consigli e inviti, che in realtà altro
non erano che minacce. I particolari del trattato con l’Argentina, concluso e
sottoscritto il 10 gennaio 1857, mettono in chiaro che il sovrano napoletano
avrebbe commutato la pena ai condannati, i quali avrebbero ricevuto in Argentina
terra e mezzi per coltivarla oltre a «cento patacconi» in denaro, solo e sempre
dietro loro disponibilità. Il trattato non entrò in vigore perché solo pochi
giovani si dichiararono disponibili all’emigrazione, mentre gli anziani
manifestarono la volontà di restare in carcere, tanto che Carlo Poerio sembra
abbia affermato: «lasciatemi morire in galera» . Dopo questo fallito trattato,
diventava più problematico per Gran Bretagna e Regno di Sardegna sostenere la
propaganda diffamatoria sulle carceri napoletane, ciononostante essa riprese
senza tregua alcuna.
Sicilia 1870: il tradimento raccontato ne "I Viceré". De
Roberto aveva capito tutto. I Nuovi Vespri il 7
ottobre 2020. Per capire lo schifo da nausea dell’Italia nata nel 1860
all’insegna di quel grande equivoco che fu il Risorgimento basta leggere il
romanzo "I Viceré" di Federico De Roberto. Lo scrittore napoletano che scelse di
essere siciliano descrive in modo magistrale l’inganno perpetrato dai piemontesi
con la connivenza dei siciliani che svendevano la propria terra ai nemici in
cambio di benefici personali. Da allora ad oggi cos’è cambiato? “A dargli retta,
i beni tolti alla Chiesa dovevano permettere di alleggerir le tasse, e far
divenire tutti proprietarii. Invece, le gravezze pubbliche crescevano sempre
più, e chi aveva ottenuto quei beni? Il duca d’Oragua, le gente più ricca, i
capitalisti, tutti coloro che erano dalla parte del mestolo!…L’opposizione al
deputato si confondeva così, a poco a poco, nel generale malcontento, nel
disinganno succeduto alle speranze riposte nella mutazione politica. Prima, se
le cose andavano male, se il commercio languiva, se i quattrini scarseggiavano,
la colpa era tutta di Ferdinando II: bisognava mandar via i Borboni, far
l’Italia una, perché di botto tutti nuotassero nell’oro. Adesso, dopo dieci anni
di libertà, la gente non sapeva più come tirare avanti. Avevano promesso il
regno della giustizia e della moralità; e le parzialità, le birbonate, le
ladrerie continuavano come prima: i potenti e i prepotenti d’un tempo erano
tuttavia al loro posto! Chi batteva la solfa, sotto l’antico governo? Gli Uzeda,
i ricchi e i nobili loro pari, con tutte le relative clientele: quelli stessi
che la battevano adesso!”. Tratto da I Viceré di Federico De Roberto
Quando Cavour scriveva a Vittorio Emanuele, invitandolo ad
“ammazzare” i meridionali e i siciliani. I Nuovi
Vespri il 7 ottobre 2020. Cavour – l’abbiamo scritto e lo ribadiamo – è stato
uno dei peggiori nemici del Sud e della Sicilia. Non conosceva l’Italia: né il
Sud, né il Nord. Era un malo-francese arrogante e detestava i meridionali pur
non conoscendoli. E senza conoscerli li definiva “corrotti”. Dimenticando che i
veri corrotti erano invece lui e il suo Piemonte. I primati mondiali del Sud
Italia prima della "disgrazia" del 1860. La storia ci racconta che Camillo
Benso, Conte di Cavour, era un uomo politico accorto e moderato. I più informati
(o quasi…) ci raccontano che, se non fosse morto un anno dopo la sciagurata
unità d’Italia (per la cronaca, Cavour passò a miglio vita nel Giugno del 1861),
mai e poi mai i generali-criminali di casa Savoia avrebbero messo a ferro e
fuoco il Sud Italia e la Sicilia.
Ebbene, questa è una grande falsità, perché Cavour, al contrario
di quello che hanno cercato di raccontarci, non solo considerava il Sud una
colonia conquistata, ma – se fosse vissuto – sarebbe stato perfettamente in
linea on i generali-criminali di Casa Savoia, da Enrico Cialdini a scendere.
Poche righe di una lettera che Cavour spedisce a Vittorio Emanuele il 14
Dicembre del 1860 – lettera che leggiamo su Malaunità, di P.Aprile, L. Del Boca
ed altri – Spaziocreativo edizioni, pag. 64, testo che abbiamo ritrovato su
Regno delle Due Sicile.eu – ci danno la misura esatta di che cosa Cavour pensava
del Sud, della Sicilia e degli abitanti del Sud e della Sicilia: “Lo scopo è
chiaro; non è suscettibile di discussione. Imporre l’unità alla parte più
corrotta e più debole dell’Italia. Sui mezzi non vi è pure gran dubbiezza: la
forza morale e se questa non basta la fisica…Ora che la fusione delle varie
parti della Penisola è compiuta mi lascerei ammazzare dieci volte prima di
consentire a che si sciogliesse. Ma anziché lasciare ammazzare me, proverei ad
ammazzare gli altri. Non si perda tempo a far prigionieri”. E, in effetti, il
consiglio di Cavour venne messo in pratica: perché furono tantissimi i
meridionali e i siciliani scannati dai piemontesi. E tanti furono anche i
prigionieri: basti pensare al lager di Fenestrelle. Insomma, per Cavour, nel
1860, a ‘presunta’ unità d’Italia appena raggiunta, il Sud e la Sicilia erano
già “parte più corrotta e più debole dell’Italia”. Le cose stavano esattamente
al contrario, perché se c’erano corrotti, ebbene, quelli erano i piemontesi di
Cavour che, per impadronirsi del Regno delle Due Sicilie, non avevano esitato ad
allearsi con i criminali dell’epoca della Sicilia, delle Calabrie e della
Campania. E se in Sicilia, durante la farsa dei Mille, i picciotti dell’onorata
società non si scoprivano troppo (anche perché non avevano la forza d’animo di
combattere: i mafiosi dell’epoca erano solo parassiti), in campania, senza la
Camorra, Garibaldi e i garibaldini sarebbero stati presi a calci nel sedere e
gettati in mare. Il Piemonte di Cavour non era soltanto corrotto: era anche uno
Stato squattrinato che pagò le spese dell’unificazione derubando il Sud (a
cominciare dalle banche della Sicilia e del regno delle Due Sicilie. Ma Cavour –
che non era italiano ma di fatto francese e che non conosceva nulla dell’Italia,
nemmeno dell’Italia del Nord (nella sua vita era stato una sola volta in Veneto
e Venezia gli era sembrata una città strana e non la capiva) – prende un’altra
cantonata quando definisce “debole” il Sud Italia: debole era il Piemonte,
Regione nella quale, ai tempi di Cavour, c’erano per lo più vacche e distese di
erba medica, mentre il Sud era una delle capitali della cultura europea. Ecco
quali erano i primati del Regno delle Due Sicilie (dati tratti da “Le industrie
del Regno di Napoli” di Gennaro De Crescenzo.
I primati del Regno delle Due Sicilie):
1735. Prima Cattedra di Astronomia in Italia
1737. Costruzione S.Carlo di Napoli, il più antico teatro d’Opera
al mondo ancora operante
1754. Prima Cattedra di Economia al mondo
1762. Accademia di Architettura, tra le prime in Europa
1763. Primo Cimitero Italiano per poveri (Cimitero delle 366
fosse)
1781. Primo Codice Marittimo del mondo
1782. Primo intervento in Italia di Profilassi Antitubercolare
1783. Primo Cimitero in Europa per tutte le classi sociali
(Palermo)
1789. Prima assegnazione di “Case Popolari” in Italia (San Leucio
a Caserta)
1789. Prima assistenza sanitaria gratuita (San Leucio)
1792. Primo Atlante Marittimo nel mondo (Atlante Due Sicilie)
1801. Primo Museo Mineralogico del mondo
1807. Primo Orto Botanico in Italia a Napoli
1812. Prima Scuola di Ballo in Italia, gestita dal San Carlo
1813. Primo Ospedale Psichiatrico in Italia (Real Morotrofio di
Aversa)
1818. Prima nave a vapore nel mediterraneo “Ferdinando I”
1819. Primo Osservatorio Astronomico in Italia a Capodimonte
1832. Primo Ponte sospeso, in ferro, in Europa sul fiume
Garigliano
1833. Prima Nave da crociera in Europa “Francesco I”
1835. Primo Istituto Italiano per sordomuti
1836. Prima Compagnia di Navigazione a vapore nel mediterraneo
1839. Prima Ferrovia Italiana, tratto Napoli-Portici
1839. Prima illuminazione a gas in una città città italiana,
terza dopo Parigi e Londra
1840. Prima fabbrica metalmeccanica d’ Italia per numero di
operai (Pietrarsa)
1841. Primo Centro Sismologico in Italia, sul Vesuvio
1841. Primo sistema a fari lenticolari a luce costante in Italia
1843. Prima Nave da guerra a vapore d’ Italia “Ercole”
1843. Primo Periodico Psichiatrico italiano, pubblicato al Reale
Morotrofio di Aversa
1845. Primo Osservatorio meteorologico d’Italia
1845. Prima Locomotiva a vapore costruita in Italia a Pietrarsa
1852. Primo Bacino di Carenaggio in muratura in Italia (Napoli)
1852. Primo Telegrafo Elettrico in Italia
1852. Primo esperimento di illuminazione elettrica in Italia, a
Capodimonte
1853. Primo Piroscafo nel Mediterraneo per l’America (il
“Sicilia”)
1853. Prima applicazione dei pricìpi della Scuola Positiva Penale
per il recupero dei malviventi
1856. Expò di Parigi, terzo paese al mondo per sviluppo
industriale
1856. Primo Premio Internazionale per la produzione di Pasta
1856. Primo Premio Internazionale per la lavorazione di coralli
1856. Primo sismografo elettrico al mondo, costruito da Luigi
Palmieri
1860. Prima Flotta Mercantile e Militare d’Italia
1860. Prima Nave ad elica in Italia “Monarca”
1860. La più grande industria navale d’Italia per numero di
operai (Castellammare di Stabia)
1860. Primo tra gli stati italiani per numero di orfanotrofi,
ospizi, collegi, conservatori e strutture di assistenza e formazione
1860. La più bassa mortalità infantile d’Italia
1860. La più alta percentuale di medici per numero di abitanti in
Italia
1860. Primo piano regolatore in Italia, per la città di Napoli
1860. Prima città d’Italia per numero di Teatri (Napoli)
1860. Prima città d’Italia per numero di Tipografie (Napoli)
1860. Prima città d’Italia per di Pubblicazioni di Giornali e
Riviste (Napoli)
1860. Primo Corpo dei Pompieri d’Italia
1860. Prima città d’Italia per numero di Conservatori Musicali
(Napoli)
1860. Primo Stato Italiano per quantità di Lire-oro conservata
nei banchi Nazionali (443 milioni, su un totale 668 milioni messi insieme da
tutti gli stati italiani, compreso il Regno delle Due Sicilie)
1860. La più alta quotazione di rendita dei Titoli di Stato
1860. Il minore carico Tributario Erariale in Euro.
Così, tanto per specificare come stavano le cose rima che il Sud
e la Sicilia diventassero la colonia della mala Italia – loro sì – di corrotti e
corruttori....
Vittorio Emanuele, Garibaldi, Nino Bixio, Cialdini: gli "eroi"
che hanno scannato gli abitanti del Sud e della Sicilia.
I Nuovi Vespri il 29 settembre 2020. Non c’è città italiana,
grande o piccola che sia, che non dedichi vie, piazze, scuole e monumenti
bronzei a questi signori che hanno occupato il Sud, ammazzando un numero
incredibile di persone e poi costringendone altrettante ad emigrare da una terra
diventata la colonia d’Italia. Ha torto la scrittore Nicola Zitara quando dice
che il tricolore è il simbolo della sconfitta del Mezzogiorno? “Non c’è
cittadina d’Italia dove non ci sia un bronzeo monumento a un qualche
risorgimentatore. Vittorio Emanuele, Garibaldi, Nino Bixio, Cosenz, Medici,
Lamarmora, Cialdini e tanti altri illustri guerrieri. Se ne stanno tutti su alti
piedistalli con la sciabola sguainata. Il bronzo del monumento non riproduce il
sangue, ma la sciabola lo presuppone. Questi bronzei signori hanno operato un
macello fra i nemici. Però essi non hanno avuto altri nemici da combattere se
non gli italiani del Sud. Quindi il sangue che cola idealmente da quelle
sciabole appartiene a un qualche mio antenato. Milite Ignoto o Milite Ignobile?
Non c’è una lapide che ne ricordi il nome. Mai un fiore è stato deposto sulla
sua tomba. Noi siamo i nemici di noi. Il nostro passato è più che brutto, è
osceno…Sventoliamo il tricolore. Ma il tricolore è il vessillo della nostra
sconfitta. Forse lo abbiamo amato e servito, ma non siamo stati mai ripagati…”
… e Garibaldi ammette: “Senza l’aiuto degli inglesi non sarei
mai sbarcato a Marsala…” I Nuovi Vespri il 5 ottobre
2020. In Italia, da oltre 150 anni, ci descrivono Garibaldi come un eroe senza
macchia e senza paura. In realtà, a cominciare dalla scuola, c’è stata tanta,
troppa disinformazione. Lo stesso nizzardo, infatti, quando ormai era su con gli
anni, ammetteva che, senza gli inglesi, non sarebbe mai arrivato in Sicilia e a
Napoli. “…la sua spedizione fu assai gradita e costantemente protetta
dall’Inghilterra. Paese che in generale (Garibaldi) non avrebbe mai dimenticato
di ringraziare, qualche tempo dopo, con un viaggio appositamente organizzato nel
1864. Durante la cerimonia di accoglienza, degna di un principe, (…) avrebbe
ammesso: ‘Senza l’ajuto di Palmerston, Napoli sarebbe ancora Borbonica, senza
l’Ammiraglio Mundy, non avrei potuto giammai passare lo Stretto di Messina”,
perché fu l’ammiraglio George Rodney Mundy che protesse lo sbarco a Marsala e il
passaggio dello Stretto di Messina’”.
P.s. E’ giusto aggiungere qualche considerazione, considerato che
l’ammissione arriva dallo stesso Garibaldi. Forse bisogna cominciare dal viaggio
di Garibaldi in Inghilterra, quando venne “accolto come un principe”. Uno
storico di regime – lasciamo perdere il nome – annette tanta importanza a questo
viaggio: gli serve per dimostrare che Garibaldi era, agli occhi degli inglesi e
del mondo, un “eroe”. E in effetti, per la parte che riguarda l’Inghilterra,
Garibaldi era un eroe, perché aveva consentito a questo Paese – che allora
considerava il Mediterraneo come “un grande mare inglese” in forza
dell’incincibilità della sua flotta navale – di conservare un ruolo centrale in
vista dell’apertura del Canale di Suez. Ma, fuori dai domini inglesi – e
soprattutto nell’Italia del Sud – Garibaldi non era affatto un eroe: anzi.
Sempre quando era ormai avanti con gli anni – gli uomini con il passar del tempo
possono diventare saggi e anche intellettualmente onesti – quello che veniva
definito l’Eroe dei due mondi ammetterà che, se fosse passato dalle parti del
Sud Italia, la gente di quei luoghi non avrebbe esitato a prenderlo a sassate. E
lo scrive in una lettera. Resta da capire perché, ancora oggi, l’Italia
officiale deve a tutti i costi conservare il falso mito di Garibaldi. Forse
perché si teme che questo possa minare l’unità nazionale? Ma se con l’Unione
europea dell’euro – a parte il regno Unito che si è giustamente chiamato fuori
dalla presunta Europa unita – esiste solo l’Unione della Germania detta
impropriamente Unione europea che problemi ci sono? Proprio in questi giorni i
tedeschi si sono impossessati del porto di Trieste: e sappiamo tutti che cos’è
stato per l’Italia – per la storia d’Italia dell’ultimo secolo – la storia di
Trieste. Eppure il Governo italiano, oggi, non ha esitato a cedere il porto di
Trieste alla Germania, che finalmente diventa l’affacciata tedesca nel
Mediterraneo… Insomma, se il porto di Trieste è ormai tedesco non sarebbe il
caso di raccontare la verità su Garibaldi, su Cavour e sui Savoia?
Il Regno delle Due Sicilie? Mai servo di inglesi e francesi.
Il Piemonte? Servo di Inghilterra e Francia! Michele
Eugenio Di Carlo su I Nuovi Vespri l'1 ottobre 2020. Nel 1860 il Regno delle Due
Sicilie viene conquistato dai piemontesi con l’appoggio dell’Inghilterra.
Motivo: negli anni precedenti Ferdinando II di Borbone, orgogliosamente, si era
rifiutato di sottomettersi o agli inglesi o ai francesi. Moralmente aveva
ragione. Ma in politica non sempre funziona la morale. Il conto lo pagherà suo
figlio Francesco II e, soprattutto, lo pagheranno i meridionali, compresi i
siciliani. Non è un caso se, ancora oggi, il Sud e la Sicilia sono colonie
italiane. Dopo la guerra di Crimea e la sconfitta russa, l’accordo di pace
siglato a Parigi il 30 marzo 1856 sanciva l’autonomia di Moldavia e Valacchia,
la cessione da parte russa della Bessarabia meridionale alla Moldavia, la tutela
dei diritti dei cristiani nell’Impero Ottomano e disponeva la libera
circolazione del fiume Danubio secondo principi concordati durante il Congresso.
Inoltre, la circolazione del Mar Nero era liberata da ogni restrizione in
riferimento alla marina mercantile ed era smilitarizzata, cioè vietata alle navi
da guerra di qualsiasi nazionalità. Nel protocollo di pace si faceva
impropriamente riferimento agli Stati italiani, al fine di ribadire la necessità
di avere regimi più tolleranti, in particolare per quanto riguardava il Regno
delle Due Sicilie. Lo storico Giacinto de’ Sivo concludeva in chiave sarcastica
che «il mondo vide una gran guerra fatta a difesa del Turco, chiudersi con
solenne atto minacciante il papa», mentre «l’Italia presentì ch’aveva ad essere
travagliata col consiglio, con l’oro, e col consenso Anglo-Francese» e «l’Europa
capì quella pace essere dichiarazione di guerra». Emidio Antonini, ambasciatore
di Napoli a Parigi, inoltrava immediate proteste a Walewski e notificava
l’indignazione della Corte di Caserta per aver permesso a rappresentanti
piemontesi di esprimere giudizi negativi su stati che non erano sotto il
protettorato di Torino, ma a buon diritto del tutto indipendenti. Tuttavia
Walewski, che era anche il presidente del Congresso, si limitava a ribadire il
punto di vista francese sull’opportunità di concordare con le grandi Potenze le
debite riforme. La risposta di Ferdinando II, dettata ad Antonini il 5 maggio,
manifestava tutta l’amarezza per la diffusione mediatica di prese di posizione e
conclusioni che non potevano che rimettere in agitazione gli attentatori della
monarchia borbonica. La risposta francese, basata sull’evidenza che piccole e
medie nazioni dovevano necessariamente sottostare alle ingerenze delle grandi
(«il Regno delle Sicilie deve sapere che soffrirà sempre una pressione Francese
o Inglese»), era l’occasione per puntualizzare che finalmente Walewski aveva
dimostrato quale fosse la vera natura delle pressioni franco-britanniche nei
confronti della monarchia borbonica: essa non consisteva nell’attacco ad un
governo ritenuto cattivo e dispotico, «negazione di Dio», ma nell’arroganza
delle due più grandi Potenze che pretendevano pretestuosamente «che il regno
servisse all’uno o all’altro». E non mancava a Gran Bretagna e Francia la
«stizza del vederlo non servire a nessuno», mentre l’«italianissimo Piemonte,
servo di tutti e due, meritava simpatie e aiuti, perché tutta s’asservasse
l’Italia». I “consigli” interessati di Francia e Gran Bretagna continuavano ad
essere trasmessi dagli ambasciatori Brenier e Temple tramite Antonini, finendo
sempre per essere sdegnosamente respinti da Ferdinando II, nonostante gli sforzi
di mediazione di San Pietroburgo, che lungo la scia di avvicinamento a Parigi
consigliava Ferdinando II di scarcerare con decisione autonoma i principali
prigionieri politici. In settembre tornava in discussione l’ipotesi di
aggressione militare franco-britannica al Regno delle Due Sicilie, mediante
l’utilizzo della flotta navale da guerra nel golfo di Napoli. Ferdinando II,
irremovibile e inflessibile, rispondeva di non «poter riconoscere nessuna
dipendenza del reame dallo straniero». Il Re avrebbe continuato a «perdonare chi
pentito grazia chiedesse»; non reputava di dover «concederla a chi pertinace non
la chiede né la vuole, ma la fa imporre da possenti stranieri». Nonostante i
buoni uffici di Austria e Russia e la piena disponibilità della Francia ad agire
a tutela del Regno delle Due Sicilie nei confronti della Gran Bretagna,
Ferdinando II restava fermo nella convinzione che, qualora fossero state
concesse alcune riforme e decisa la scarcerazione di alcuni dei maggiori nemici
politici, i rivoluzionari l’avrebbero intesa come un segno di debolezza e ne
avrebbero tratto ulteriore forza e vigore. Pertanto, la Corte di Caserta
rifiutava i tentativi di mediazione austriaci e russi e declinava l’invito
francese. La spedizione navale punitiva nel Golfo di Napoli allo stato delle
cose sembrava inevitabile, oltre che fortemente auspicava e sostenuta da Cavour,
il quale avrebbe voluto farne parte con una propria squadra navale. La
preoccupazione per possibili conseguenze militari su più larga scala a livello
europeo, consigliarono i governanti francesi e inglesi di andare incontro ad una
banale e meno impegnativa rottura dei rapporti diplomatici con Napoli. Un
articolo, apparso a Parigi sul «Moniteur» del 20 ottobre 1856, ribadiva la
condanna di un governo che negava «clemenza e riforme» e il cui «rigore» agitava
l’Italia e comprometteva la pace in Europa, confermando quanto Walewski aveva
riferito ad Antonini: «Napoli deve sottostare o a Francia o ad Inghilterra; e
deve impedire non si congiungessero a suo danno». Pur essendone consapevole,
Ferdinando II, pur di non diventare «servo ed ingrato» non fece nulla per
evitare quella nefasta congiunzione che qualche anno dopo sarebbe risultata
nefasta per il Regno delle Due Sicilie. Il Primo Ministro inglese Palmerston,
conscio del pericolo murattiano, nonostante «la flotta francese già dimorante ad
Aiaccio», rinunciò alla spedizione punitiva contro Napoli , preferendo la via
della rottura diplomatica. Il 21 ottobre, tolte le insegne, le delegazioni
francesi e inglesi lasciavano Napoli con la speranza vana di provocare una
reazione popolare di simpatia promossa dai liberali, ma «i Napoletani non si
scomodarono neppure a levarsi il cappello». Cavour, che aveva sostenuto
l’intervento contro Napoli, a metà novembre, visto che Ferdinando II aveva
resistito alle arroganti pressioni e alle brutali intimidazioni
franco-britanniche, propose un riavvicinamento al Piemonte. Giuseppe Canofari,
il rappresentante napoletano a Torino, rispose con le seguenti parole: «Il re
non è disgiunto da Torino, ma questo dal re. Napoli non ricetta nemici di
Torino, non ha officine occulte e riconosciute di calunnie e macchinazioni
sistematiche per rivoltare Sardegna». Il Conte, secondo la tesi di Nicola
Bianchi, diventato pessimista sulla concreta volontà di Palmerston e di
Napoleone III di favorire i disegni egemonici del Regno Sardo, era preoccupato
«che un successo del movimento insurrezionale a Napoli, promosso dal partito
mazziniano o dalla fazione di Murat potesse pregiudicare i disegni di Casa
Savoia», tentava di far quadrato contro un’eventuale, quanto credibile, «deriva
eversiva». L’ambasciatore Canofari trasmise al ministro Carafa un preciso
resoconto sull’incontro avuto con Cavour che conteneva anche sue personali
considerazioni comprovanti la scarsa considerazione e l’assoluta sfiducia nei
riguardi del Primo Ministro piemontese. Per Napoli la politica aggressiva e
spregiudicata del Regno Sardo non era meritevole di considerazione, anche perché
oltretutto cozzava frontalmente con quella borbonica attenta al rispetto del
diritto internazionale, improntata al rispetto di valori e principi, rispettosa
della tradizione cristiana e del Papa che la incarnava, non sollecita a cambi
improvvisi e immotivati del sistema di alleanze al solo fine di assecondare le
maggiori Potenze straniere. Ferdinando II, tramite il ministro Carafa e
l’ambasciatore Canofari, rispose in via ultimativa il 9 dicembre che il suo
governo desiderava buoni rapporti con tutti e «che niuno s’impacci de’ suoi
fatti interni». Secondo de’ Sivo, dopo questa ennesima prova di forza e di
orgogliosa autonomia dalle grandi Potenze, incominciarono per Ferdinando II «le
insidie in lunga serie» che avrebbero finito per punire la pretesa di
indipendenza di quella che era considerata solo una media Potenza. Con l’uso
della «forza sarebbe caduto un re, con le insidie si precipitò la nazione […]
col sangue e con la roba di nove milioni d’uomini innocenti».
1860: ecco
come con i soldi dei siciliani i Savoia pagarono le spese del Risorgimento! I
Nuovi Vespri il 24 settembre 2020. A risarcire il Piemonte che, grazie agli
inglesi, ha invaso e occupato il Sud Italia, hanno pensato – chiaramente senza
volerlo – i Sicilia. Garibaldi, da parte sua, rubò i soldi del banco di Sicilia.
E con lo scippo dei beni alla Chiesa e venduti ai mafiosi il nascente Stato
italiani ricavò 600 milioni di lire, una cifra enorme a quell’epoca!
Scrive Ignazio Coppola in Risorgimento e risarcimento – La Sicilia tradita: “In
Sicilia, i due terzi delle terre esistenti erano di proprietà delle
corporazioni, delle congregazioni religiose, dei conventi e della Manomorta, che
davano lavoro e occupazione a decine di migliaia di famiglie siciliane. La
confisca di questi terreni e la loro nazionalizzazione permise allo Stato
italiano di mettere all’asta in Sicilia ben 250.000 ettari. Una superficie
enorme di terreni fu, così, trasferita dal clero ai latifondisti. Con
l’intervento coercitivo della mafia, i contadini, che dovevano essere i
legittimi destinatari di queste terre come promesso a più riprese da Garibaldi
prima e dal nuovo Governo italiano dopo, furono esclusi dalla possibilità di
partecipare alle aste, i banditori sottoposti a intimidazioni, così che pochi
potenti compratori stabilirono degli accordi segreti, che eliminarono la
concorrenza mantenendo i prezzi a livelli bassissimi. Il ricavo della vendita
all’asta di tali terre, anche se a prezzi stracciati, permise al nuovo Stato
italiano di incamerare nelle proprie casse ben 600 milioni di lire, una cifra
enorme per quell’epoca che, aggiunta ai ducati d’oro rastrellati da Garibaldi
alla zecca di Palermo e trasferiti in Piemonte, permise di coprire i costi delle
guerre del Risorgimento e i debiti che i piemontesi avevano contratto nelle
guerre contro l’Austria, così da portare in pareggio il primo bilancio dello
Stato italiano. La Sicilia, ancora una volta rapinata del suo, di tutto questo
non ne ebbe nessun ritorno in termini di investimenti, di migliorie o di
servizi. Con l’aggravante che i terreni acquistati dai grandi proprietari, che
avevano appena i soldi per l’acquisto ma non per le migliorie fondiarie,
finirono in gran parte abbandonati e incolti. Le decine di migliaia di famiglie
che prima lavoravano tali terre, si ritrovarono improvvisamente senza lavoro,
15.000 unità nella sola Palermo, e furono costrette a emigrare. Fu così che
iniziarono i grandi flussi migratori dalla Sicilia verso le Americhe e verso
altri Stati europei”. – Ignazio Coppola, Risorgimento e risarcimento – La
Sicilia tradita, CNA Edizioni, pag. 97.
Con i 600 milioni di lire rubati alla Sicilia i Savoia e
Garibaldi pagarono le guerre del Risorgimento. di I
Nuovi Vespri il 4 ottobre 2020. In realtà, lo scippo ai danni della nostra Isola
fu maggiore. I 600 milioni derivavano dalle terre tolte alle corporazioni, alle
congregazioni religiose, ai conventi e alla Manomorta. A questi vanno aggiunti
i ducati d’oro rastrellati da Garibaldi alla zecca di Palermo e trasferiti in
Piemonte. Un grande flusso di denaro si trasferì dalla Sicilia al Piemonte,
lasciando i siciliani nella povertà e costringendoli ad emigrare. “In Sicilia, i
due terzi delle terre esistenti erano di proprietà delle corporazioni, delle
congregazioni religiose, dei conventi e della Manomorta, che davano lavoro e
occupazione a decine di migliaia di famiglie siciliane. La confisca di questi
terreni e la loro nazionalizzazione permise allo Stato italiano di mettere
all’asta in Sicilia ben 250.000 ettari. Una superficie enorme di terreni fu,
così, trasferita dal clero ai latifondisti. Con l’intervento coercitivo della
mafia, i contadini, che dovevano essere i legittimi destinatari di queste terre
come promesso a più riprese da Garibaldi prima e dal nuovo Governo italiano
dopo, furono esclusi dalla possibilità di partecipare alle aste, i banditori
sottoposti a intimidazioni, così che pochi potenti compratori stabilirono degli
accordi segreti, che eliminarono la concorrenza mantenendo i prezzi a livelli
bassissimi. Il ricavo della vendita all’asta di tali terre, anche se a prezzi
stracciati, permise al nuovo Stato italiano di incamerare nelle proprie casse
ben 600 milioni di lire, una cifra enorme per quell’epoca che, aggiunta ai
ducati d’oro rastrellati da Garibaldi alla zecca di Palermo e trasferiti in
Piemonte, permise di coprire i costi delle guerre del Risorgimento e i debiti
che i piemontesi avevano contratto nelle guerre contro l’Austria, così da
portare in pareggio il primo bilancio dello Stato italiano”.
“La Sicilia, ancora una volta rapinata del suo, di tutto questo
non ne ebbe nessun ritorno in termini di investimenti, di migliorie o di
servizi. Con l’aggravante che i terreni acquistati dai grandi proprietari, che
avevano appena i soldi per l’acquisto ma non per le migliorie fondiarie,
finirono in gran parte abbandonati e incolti. Le decine di migliaia di famiglie
che prima lavoravano tali terre, si ritrovarono improvvisamente senza lavoro,
15.000 unità nella sola Palermo, e furono costrette a emigrare. Fu così che
iniziarono i grandi flussi migratori dalla Sicilia verso le Americhe e verso
altri Stati europei”. Ignazio Coppola, Risorgimento e risarcimento – La Sicilia
tradita, CNA Edizioni, pag. 97.
1860: Garibaldi e Crispi si rimangiano la promessa di dare le
terre ai contadini siciliani. I Nuovi Vespri il 3
ottobre 2020. Occupazione militare, promesse non mantenute e inganni: così
l’Italia di Garibaldi e Crispi conquista la Sicilia. Ai contadini avevano
promesso la fine delle tasse ingiuste e l’assegnazione delle terre. Invece le
terre verranno assegnate ai ‘reduci’ della farsesca impresa del mille, mentre i
contadini rimarranno in balìa dei mafiosi amici e sodali di Garibaldi e Crispi.
Le città dell’Isola in rivolta. “In quella torrida estate del 1860 non pochi
furono i tumulti in vari paesi poveri della Sicilia a seguito delle mancate
promesse: Regalbuto, Polizzi Generosa, Tusa, Biancavilla, Racalmuto, Nicosia,
Cesarò, Randazzo, Maletto, Petralia, Resuttano, Montemaggiore, Castelnuovo,
Capaci, Castiglione, Collesano, Centuripe, Mirto, Caronia, Alcara Li Fusi,
Nissoria, Mistretta, Cefalù, Linguaglossa, Trecastagni, Pedara. Tumulti che
nascevano appunto dall’illusione, dalla constatazione della mancata promessa di
abolire la tassa sul macinato, e altre imposte e balzelli, nonché dal tradimento
dell’atto del 2 giugno 1860, firmato da Francesco Crispi, dall’inganno
relativamente alla divisione delle terre dei demani comunali, invece, assegnati
ai garibaldini combattenti o ai loro eredi, se caduti”. Tommaso
Romano, “Sicilia, 1860 – 1870 – Una storia da riscrivere”, ed. ISSPE, pag. 20.
Tratto da Regno delle Due Sicilie.eu
Dopo il 1860 in Sicilia i piemontesi bruciavano vivi i
familiari dei giovani renitenti alla leva. I Nuovi
Vespri il 2 ottobre 2020. Sette anni di servizio militare nell’esercito dei
Savoia che aveva invaso il Sud e la Sicilia. Bisognava regalare sette anni della
propria vita ai bastardi che, grazie agli inglesi, avevano conquistato e
rapinato il Regno delle Due Sicilie. Tanti giovani si rifiutavano e si davano
alla macchia. Per ritorsione i piemontesi scannavano e bruciavano vivi i
familiari di questi ragazzi. Così nasceva l’Italia…“Vennero chiusi in carcere
madri, mogli, padri, sorelle e parenti dei renitenti di leva e sottoposti alle
più feroci torture. Furono uccisi giovinetti a colpi di frusta e di baionetta,
fatte morire donne gravide. A Trapani, Girgenti, Sciacca, Favara, Bagheria,
Calatafimi, Marsala (dove fu distrutta anche la produzione vinicola), toccò la
stessa sorte di Licata. E che dire della criminale Barbarie di Petralia, dove,
in una misera capanna di contadini circondata dai regi, fu arsa viva una intera
famiglia che si era rifiutata di aprire la porta? E delle atroci torture
inflitte, a Palermo, al povero sordomuto Cappello, perché ritenuto dagli
ufficiali medici si fingesse tale per eludere il servizio di leva? Queste cose
vi rappresento in nome dei diritti, della giustizia e dell’umanità così
orrendamente violate”. Da un discorso del deputato Vito D’Ondes Reggio alla
Camera. Tratto da Regno delle Sue Sicilie.eu
1863: i piemontesi fucilano migliaia di meridionali e ne
tengono prigionieri circa 80 mila! I Nuovi Vespri l'1
ottobre 2020. Lo scrive sul giornale “De Naples a Palerme” Oscar De Poli tre
anni dopo la ‘presunta’ unificazione. “Cosa rispondono gli organi del
Piemontesismo a queste cifre? Essi non rispondono affatto”. E ancora anche in
televisione negano di aver ammazzato e fatti sparire nella calce viva migliaia e
migliaia di meridionali nella fortezza di Fenestrelle. “Il sedicente
“democratico” Regno d’Italia iniziò una politica di spoliazione delle risorse
nelle zone conquistate, opprimendo le culture locali e soffocando nel sangue le
rivolte popolari che nel Meridione assunsero alle dimensioni di guerra civile. …
secondo il ministro della guerra di Torino, 10.000 napoletani sono stati
fucilati o sono caduti nelle file del brigantaggio; più di 80.000 gemono nelle
segrete dei liberatori; 17.000 sono emigrati a Roma, 30.000 nel resto d’Europa,
la quasi totalità dei soldati hanno rifiutato d’arruolarsi… ecco 250.000 voci
che protestano dalla prigione, dall’esilio, dalla tomba… Cosa rispondono gli
organi del Piemontesismo a queste cifre? Essi non rispondono affatto”. Oscar De
Poli, giornalista, in un articolo pubblicato sul giornale “De Naples a Palerme”
1863 – 1864 (Tratto da Regno delle Due Sicilie)
Con l’arrivo dei piemontesi nel Sud e in Sicilia la
fucilazione dei meridionali diventa un "bisogno" del nuovo Stato! I
Nuovi Vespri il 30 settembre 2020. Oggi proponiamo ai nostri lettori la
riflessione amara di un molisano che, ventenne, aveva partecipato ai moti
liberali del 1848 e che, nel 1860, vivrà sulla propria pelle la cattiveria, il
razzismo e le ruberie dei piemontesi lanciati alla conquista del Regno delle Due
Sicilie con l’appoggio degli inglesi. “Il progresso e la civiltà, nei tempi
correnti, vengono interpretati diversamente da quello che si intendevano
innanzi. Oggi, progresso e civiltà all’uso piemontese vuol dire: abbassamento
della suprema autorità, della civiltà, della morale. Secondo la loro moda: la
proprietà è furto; il diritto è tirannide; la religione è inceppamento; la pietà
è delitto; il fucilare è bisogno; lo spoglio dei popoli è necessità. Chi è
dunque cieco anche nella mente, da non vedere in questo civiltà ed in questo
progresso l’abbruttimento della società?”. Teodoro Salzillo 1868. (L’autore di
questa riflessione è un molisano di Pozzilli. Era nato nel 1826. Il personaggio
merita perché ha provato sulla propria pelle la conquista regno delle Due
Sicilie da parte dei piemontesi. Di formazione liberale, nel 1848, poco più che
ventenne, partecipa ai moti rivoluzionari. Dodici anni dopo, quando i
piemontesi, con l’appoggio degli inglesi, cominciano a conquistare il Regno
delle Due Sicilie, capisce che c’è qualcosa che non va. E non esita a schierarsi
con Francesco II a difesa del regno che pure, da liberale, nel 1848, aveva
combattuto. Salzillo è testimone di eccidi e ingiustizie perpetrate ai danni
delle genti del Sud Italia. E lo scrive, perché oltre ad essere un valente
soldato era anche un valente scrittore. Combatte con tutte le sua forze
l’invasione piemontese e partecipa alla difesa di Gaeta. La testimonianza di
Salzillo è importante, perché vivrà fino al 1904 e avrà modo di vedere il
declino di un Regno che era uno dei più ricchi d’Europa, ridotto a colonia in
un’Italia nata sbagliata e cresciuta in peggio.
Quando nel 1860 i Savoia dovevano sbarazzarsi di mille e 600
meridionali. Li hanno mandati nel lager di Fenestrelle? I Nuovi Vespri il 28
settembre 2020. La domanda che poniamo è legittima se andiamo a leggere “Il
carteggio di Cavour”. Dove si parla di mille e 600 prigionieri del Sud Italia,
definiti senza mezzi termini “canaglia”, dei quali i generali piemontesi non
sapevano cosa fare. Li hanno rimandati al Sud o sono finiti massacrati a nella
fortezza di Fenestrelle? “… Non ti devo lasciar ignorare che i prigionieri
Napoletani dimostrano un pessimo spirito. Su 1600 che si trovano a Milano non
arriveranno a 100 quelli che acconsenton a prendere servizio. Sono tutti coperti
di rogna e di vermina, moltissimi affetti da mal d’occhi… e quel che è più
dimostrano avversione a prendere da noi servizio. Jeri a taluni che con
arroganza pretendevano aver il diritto di andar a casa perché non volevano
prestare un nuovo giuramento, avendo giurato fedeltà a Francesco secondo, gli
rinfacciai che per il loro Re erano scappati, e ora per la Patria comune, e per
il Re eletto si rifiutavan a servire, che erano un branco di carogne che
avressimo trovato modo di metterli alla ragione. Non so per verità che cosa si
potrà fare di questa canaglia, e per carità non si pensi a levare da questi
Reggimenti altre Compagnie surrogandole con questa feccia. I giovani forse
potremo utilizzarli, ma i vecchi, e son molti, bisogna disfarsene al più
presto”. Lamarmora; del Carteggio di Cavour, La Liberazione del Mezzogiorno,
Zanichelli (tratto da BRIGANTI).
Questo passo del Carteggio di Cavour è importante, perché ci dice
che cosa i militari savoiardi pensavano delle genti meridionali, in particolare,
in questo caso, dei “prigionieri Napoletani”. Dalle parole di questa lettera si
nota il disprezzo verso il Sud e i suoi abitanti che, ad esempio, ritroviamo
nella Lega di Bossi di fine anni ’80 primi anni ’90 del secolo passato. Ma c’è
un elemento che deve fare riflettere, là dove si legge: “… ma i vecchi, e son
molti, bisogna disfarsene al più presto”. Sarebbe interessante capire che fine
hanno fatto questi “vecchi” che si trovavano a Milano all’indomani della
‘presunta’ unificazione italiana. Sono riusciti a tornare nel Sud o, per
“disfarsene”, sono stati utilizzati altri metodi? Ce lo chiediamo perché, ancora
oggi, in Italia, si continua a negare le atrocità commesse dai Savoia
nella fortezza di Fenestrelle che il nostro Ignazio Coppola ha ben raccontato
su I Nuovi Vespri: atrocità che hanno anticipato i campi di concentramento
nazisti. Come già accennato, ancora oggi la televisione continua a nascondere la
storia di una strage ai danni della gente del Sud. La verità è che l’Italia,
nata male – con l’occupazione del Regno delle Due Sicilie da parte dei
piemontesi appoggiati dagli Inglesi – è cresciuta in peggio. E ancora oggi ne
paghiamo le conseguenze. Se, ancora oggi, il Sud viene sistematicamente derubato
dal Centro Nord Italia, questo è avvenuto anche perché si continua a negare i
fatti storici avvenuti. Gli stolti – e purtroppo non mancano – che dicono che
ormai, a oltre 150 anni di distanza, bisogna evitare i parlar male di Garibaldi,
dei Savoia e di quel grande equivoco che è stato nel Sud il cosiddetto
Risorgimento, rimangono tali: cioè stolti. E finiscono con l’avallare le
ingiustizie che, iniziate nel 1860, l’Italia continua a infliggere al Sud!
I soprusi e le torture dei Savoia nel Sud e in Sicilia: il
caso di tre sorelle buttate in carcere per una bandiera… I
Nuovi Vespri il 27 settembre 2020. Visitando le carceri del Sud Italia appena
"conquistato" dai piemontesi Lord Henry Lennox, parlamentare inglese, che era
stato un sostenitore dei Savoia, si accorse e denunciò gli incredibili soprusi
ai danni dei meridionali. La vicenda di tre sorelle – Francesca, Carolina, e
Raffaella Avitabile – che trovò rinchiuse in carcere da 22 mesi perché avevano
esposto alla finestra della propria abitazione il vessillo delle Due Sicilie.
“Sento il debito di protestare contro questo sistema. Ciò che è chiamata unità
italiana deve principalmente la sua esistenza alla protezione e all’aiuto morale
dell’Inghilterra, deve più a questa che a Garibaldi, che non agli eserciti
stessi vittoriosi della Francia, e però, in nome dell’Inghilterra, denuncio tali
barbarie atrocità, e protesto contro l’egidia della libera Inghilterra così
prostituita”. Così Lord Henry Lennox, parlamentare inglese, nel 1863, riferì
quanto aveva visto in Italia e, precisamente, nel Sud Italia, diventato tale
dopo l’unificazione, con la scomparsa del Regno delle Due Sicilie voluto proprio
dall’Inghilterra. Lord Henry Lennox era stato un sostenitore di Vittorio
Emanuele II di Savoia. Ma dopo essere stato in Italia e aver visitato il Sud
Italia, aveva cambiato opinione. E lo disse senza giri di parole in un discorso
alla camera del Comuni. Riprendiamo un articolo di Briganti che racconta molto
bene quello che Lord Henry Lennox vide e raccontò. “Ciò che il politico
britannico si trovò davanti agli occhi – il riferimento è alla visita del
politico inglese nell’Italia "unificata" – lo spinse a dubitare della veridicità
delle decantate condizioni di giustizia e libertà in cui avrebbe dovuto versare
lo Stato unitario. Egli criticò aspramente il nuovo governo sottolineando come
qualsiasi voce dissidente fosse immediatamente messa a tacere attraverso un
sistema di arresti arbitrari che contemplavano l’incarcerazione senza
processo. Per il carcere partenopeo di Santa Maria Apparente, Lennox dovette
constatare che, in quel penitenziario, erano reclusi, da oltre 18-24 mesi,
uomini, ritenuti rivoluzionari, che erano stati arrestati ed imprigionati senza
mai aver subito un interrogatorio, senza mai essere stati processati e senza che
fosse stato loro formalizzato alcun capo d’imputazione. Egli notò come molti
detenuti "politici", più che avere l’aspetto di pericolosi rivoluzionari,
apparissero come sventurati di umili condizioni e spesso in là con gli anni;
riportò inoltre, che le numerose petizioni che richiedevano lo svolgimento dei
processi per questi detenuti, una volta inviate a Torino, venivano puntualmente
ignorate”. Insomma, quando i Savoia non ricorrevano alla fortezza di
Fenestrelle, in Piemonte, si "arrangiavano" nelle stesse città del Sud Italia,
dove i soprusi con chi non la pensava come i piemontesi erano la norma. “La
situazione registrata al carcere della Concordia – leggiamo sempre su Briganti –
apparve, agli occhi del Lennox, ben più grave: gli accusati di reati politici
erano detenuti in condizioni promiscue con i criminali comuni, tra i quali vi
era, finanche, un omicida; tra i detenuti politici, invece, vi erano anche
religiosi, anch’essi prelevati dai propri domicili ed imprigionati senza
processo e imputazione di capo d’accusa. Nelle carceri femminili, invece, le
donne accusate di reati politici erano detenute promiscuamente con le prostitute
e le criminali comuni. Della visita al penitenziario femminile di Santa Maria ad
Agnone, Lennox riporta il caso delle sorelle Francesca, Carolina, e Raffaella
Avitabile, detenute da 22 mesi perché accusate di aver esposto alla finestra
della loro abitazione il vessillo delle Due Sicilie”. A Salerno le condizioni
dei detenuti apparvero al parlamentare inglese drammatiche: “Il direttore del
carcere – leggiamo su Briganti – riferì di un sovraffollamento del suo
penitenziario: il numero dei detenuti, 1359 persone, era più che doppio rispetto
alla capacità massima della struttura (650 detenuti); ciò aveva comportato lo
scoppio di una epidemia di febbre tifoide, che, solo nell’ultima settimana,
aveva ucciso, oltre che diversi detenuti, anche il medico della prigione ed un
secondino. In una prima cella erano stipate oltre 25 persone, tra civili
sospettati di reati politici, religiosi e delinquenti comuni. In un altro
locale, trascorrevano la loro intera giornata, fatta salva l’ora d’aria in
cortile, 157 uomini, sempre promiscuamente detenuti. Squallore e sporcizia,
ancora, erano evidenti in un altro stanzone che conteneva 230 prigionieri in
misere condizioni: gli abiti di costoro erano talmente logori, che taluni di
essi rasentavano la nudità. A parere di Lennox, il cibo portato ai prigionieri
era tale che, in Inghilterra, non sarebbe stato dato in pasto neanche agli
animali”. “Con circa 1200 prigionieri, anche il carcere della Vicaria – leggiamo
ancora nell’articolo – era sovraffollato, contenendo circa il doppio dei
detenuti di cui era capace, dei quali molti erano ancora in attesa di processo.
Il grosso di essi era stipato in 5 stanzoni intercomunicanti in pessime
condizioni di igiene. Inoltre, non veniva garantito il necessario grado di
sicurezza, poiché, rispetto alla mole di detenuti, il personale di sorveglianza
era insufficiente”. Lennox invitò Gladstone a intervenire, perché questa
vergogna coinvolgeva l’Inghilterra. Ma non intervenne nessuno. Correva l’anno
1863.
14 Agosto 1861: i Savoia del generale Cialdini ammazzano più
di mille abitanti di Pontelandolfo. I Nuovi Vespri il
26 settembre 2020. Però, 150 anni dopo la strage, lo Stato italiano ha chiesto
scusa. Anche se, ancora oggi, non c’è accordo sul numero degli abitanti
ammazzati. Per le cronache ufficiali non arrivavano a venti. Poi è stato detto
400. Oggi si scopre che sono stati più di mille. Perché? Per vendetta contro i
patrioti del Sud chiamati "briganti" che si difendevano dall’invasione
piemontese! La testimonianza di un bersagliere “Al mattino del mercoledì, giorno
14, riceviamo l’ordine superiore di entrare nel Comune di Pontelandolfo,
fucilare gli abitanti ed incendiarlo. Entrammo nel paese, subito abbiamo
incominciato a fucilare i preti e gli uomini, quanti capitava, indi il soldato
saccheggiava ed infine abbiamo dato l’incendio al paese, di circa 4500 abitanti.
Quale desolazione non si poteva stare d’intorno per il gran calore e quale
rumore facevano quei poveri diavoli che la sorte era di morire abbrustoliti e
chi sotto le rovine delle case”. Carlo Margolfo, bersagliere entrato a
Pontelandoflo, 1861.
GARIBALDI E I MILLE. Mercenari dei Massoni Britannici e
complici della Mafia armati contro la Chiesa. Fabio
Giuseppe Carlo Carisio l'11 Maggio 2020 su Gospanews.net. «Tutta la spedizione
garibaldina fu monitorata dalle massoneria britannica, che aveva l’obbiettivo
storico di eliminare il potere temporale dei Papi. Anche gli Stati Uniti, che
pur avevano rapporti diplomatici con il Vaticano, diedero il loro sostegno. Il
finanziamento proveniva da un fondo di presbiteriani scozzesi e gli fu erogato
con l’impegno di non fermarsi a Napoli, ma di arrivare a Roma per eliminare lo
Stato pontificio». Il ruolo della Grande Loggia d’Inghilterra, costituita nel
1717 a Londra da facoltosi Protestanti per sconfiggere i Cattolici nella lotta
per il Trono della Gran Bretagna, fu determinante nella Spedizione dei Mille –
in realtà oltre 20mila – con cui il guerrigliero Giuseppe Garibaldi, un Osama
Bin Laden ante-litteram, diede il colpo decisivo all’Unità d’Italia facendo
implodere il cristiano Regno delle due Sicilie. Siciliani e campani si pentirono
di aver tradito i Borboni per i Savoia quando era ormai troppo tardi e al loro
brigantaggio per fame il Regno Sabaudo rispose con fucilazioni di massa…
L’OLOCAUSTO ROSSO VOLUTO DAI COMUNISTI MASSONI. A pronunciare le
frasi sopra riportate tra virgolette non è stato uno studioso qualunque ma Aldo
Mola, docente di storia contemporanea di Milano e storico della massoneria e del
Risorgimento. E’ proprio lui a sostenere con fatti circostanziati che
evidenzierò l’intento degli incappucciati del Rito Scozzeze Antico e Accettato
per la distruzione della Chiesa Cattolica e, più in generale, del Cristianesimo
stesso. Questo torvo progetto si è effettivamente concretizzato con le
rivoluzioni in Francia e Russia e con i moti carbonari delle società segrete che
ubriacando il popolo bue con gli ideali di Liberté, Égalité, Fraternité hanno
consentito nel giro di due secoli alla Massoneria di controllare il mondo grazie
alle banche centrali degli alleati finanzieri ed usurai sionisti. Diventando
padroni della Lobby delle Armi quanto di quella delle Big Pharma. Oggi è san
Fabio e voglio farmi il regalo di smascherare con prove inequivocabili l’immonda
impostura di un’unificazione farlocca, del Regno d’Italia prima e della
Repubblica Italiana poi, ancora frantumata in regionalismi etnici insanabili dai
transalpini piemontesi ai tirolesi trentini, dai borbonici campani ai moreschi
sardi, dai bizantini veneziani ai berberi siciliani. A contenerne le istanze
secessioniste evitando contrapposizioni e frammentazioni ci ha pensato in due
secoli un Deep State alquanto originale costituito da un’amalgama tra potenze
militari, massoneria e mafia. Chi fa risalire questa triplice morsa in cui è
soffocata la libertà e democrazia dell’Italia allo scellerato patto del 1943 tra
l’esercito degli Stati Uniti, la Central Intelligence Agency (allora OSS) e
Lucky Luciano, il boss dei due mondi, commette un grosso errore. Perché lo
sbarco degli Alleati in Sicilia non fece altro che ripristinare quel dominio
occulto di militari stranieri, massoni e mafiosi realizzato dal mercenario dei
due mondi Giuseppe Garibaldi (Nizza 1807 – Caprera 1882). Di fatto fu l’inizio
di quei successi del Nuovo Ordine Mondiale e del cosiddetto Deep State di cui
stiamo sentendo le conseguenze anche oggi a causa di una pandemia da sospetta
bio-arma o esperimento pericoloso sfuggito di mano, quale appare il virus
SARS-Cov-2 dopo la conferma dell’inserimento di HIV al suo interno di un’ultima
clamorosa ricerca francese. Oggi invece che a lui, onorato con vie, piazze e
monumenti a celebrazione di quel periodo buio e sanguinario che fu il
Risorgimento, vorrei erigere un busto al collega giornalista Giovanni Greco,
dottore in Conservazione dei Beni Culturali con laurea in archeologia
industriale, dal 1998 direttore responsabile della rivista on
line “BelSalento.com – arte, storia, ambiente, politica e cultura della Terra
dei Due Mari – Servizi di Fruizione Culturale”. Se ben poco ho dovuto ricercare
per questo articolo sul generale corso dalla Giubba Rossa devo ringraziare il
meticoloso ed immane lavoro di ricerca condotto da Greco, non a caso freelance
internazionale dell’agenzia GNS Press tedesca visto che in Italia – chi tocca i
mostri sacri della Massoneria risorgimentale – non ottiene posti di prestigio
nel gotha del giornalismo nazionale. Il fatto che io sia corrispondente per il
sito americano di geopolitica e intelligence militare Veterans Today non è
pertanto ovviamente casuale: avendo rifiutato la cooptazione massonica nel
lontano 2000…Giuseppe Garibaldi. Proprio per premiare gli eroici reportages di
Giovanni Greco riferirò fatti essenziali invitando i lettori più appassionati a
leggersi tutta la saga sui garibaldini al soldo dei massoni britannici nella
versione originale. Onde attirare l’attenzione dei più scettici
anti-revisionisti sulla Spedizione dei Mille comincio con una citazione
imponente per la statura morale di chi la fece. «Prima di occuparci della mafia
del periodo che va dall’unificazione del Regno d’Italia alla prima guerra
mondiale e all’avvento del fascismo, dobbiamo brevemente, ma necessariamente
premettere che essa come associazione e con tale denominazione, prima
dell’unificazione non era mai esistita, in Sicilia. La mafia nasce e si sviluppa
subito dopo l’unificazione del Regno d’Italia». Queste frasi le pronunciò il
giudice Rocco Chinnici, il primo magistrato a morire ucciso da un’autobomba il
29 luglio 1983 a Palermo, che ho ricordato in un reportage insieme ad un’altra
vittima eccellente di un attentato: il presidente degli Usa Abramo Lincoln
guardacaso assassinato proprio da un Massone dopo che l’Unione Nordista
sconfisse i Confederati del Sud tra i quali spiccava per crudeltà il
generale Albert Pike, tra i fondatori del Ku Klux Klan ma destinato a diventare
il “papa” della Massoneria americana quando nel 1859 divenne Gran Maestro del
Rito Scozzese Antico ed Accettato (che più avanti chiameremo per brevità RSSA).
Pike fu anche fondatore della Young America grazie
all’ispirazione-collaborazione dell’allora terrorista, oggi ahinoi patriota,
Giuseppe Mazzini, che aveva creato Giovine Italia e Giovine Europa dando inizio
ai moti rivoluzionari nel vecchio continente prima di rifugiarsi a Londra dove
fu accoltò nella casa dello zio di Ernest Nathan e dove divenne intimo del
Segretario di Stato britannico, Henry John Temple, terzo visconte di Palmerston
(1784-1865), ed esponente di spicco della Gran Loggia d’Inghilterra. Nathan, è
importante ricordarlo, sarebbe poi diventato Gran Maestro del Grande Oriente
d’Italia, e Sindaco di Roma capitale (1907), parzialmente sottratta con armi e
spargimenti di sangue allo Stato Pontificio dopo la Breccia di Porta Pia.
Chiarito brevemente il contesto vediamo l’importanza di alcune date fatidiche.
Pike nel 1859 in Nord America diviene Sovrano Gran Commendatore del Supremo
Consiglio Circoscrizione Sud RSSA (Loggia Madre di Charleston poi trasferita a
Washington). Nel 1860 Mazzini fonda il Supremo Consiglio di Palermo.
IL RUOLO DELLA MASSONERIA NELLA SPEDIZIONE DEI MILLE. «L’11
maggio 1860 con la protezione delle navi inglesi Intrepid e H.M.S. Argus,
Garibaldi sbarca a Marsala. E dello stesso giorno è interessante anche la nota
di Garibaldi sull’arruolamento: “Francesco Crispi arruola chiunque: ladri,
assassini, e criminali di ogni sorta”» lo scrive appunto Greco nel primo dei
suoi due splendidi reportage. «Nella spedizione dei Mille, il ruolo della
massoneria inglese fu determinante, con un finanziamento di tre milioni di
franchi ed il monitoraggio costante dell’impresa. Lo sostiene la Massoneria di
rito scozzese, dell’Obbedienza di Piazza del Gesù, che nei giorni scorsi ha
ricordato la nascita nel luglio 1807 del nizzardo in una conferenza stampa ed un
convegno a Napoli, alla presenza del Gran Maestro Luigi Pruneti e del Gran
Maestro del Grande Oriente di Francia, Pierre Lambicchi» si legge ancora
nell’articolo che cita quindi ampi brani della conferenza dello storico Aldo
Mola. «I fondi della massoneria inglese – ha evidenziato lo storiografo del
Risorgimento – servirono a Garibaldi per acquistare a Genova i fucili di
precisione, senza i quali non avrebbero potuto affrontare l’esercito borbonico,
che non era l’esercito di Pulcinella, ma un’armata ben organizzata. Senza quei
fucili, Garibaldi avrebbe fatto la fine di Carlo Pisacane e dei fratelli
Bandiera». «La appartenenza alla massoneria – ha detto ancora il professor Mola
– garantì a Garibaldi l’appoggio della stampa internazionale, soprattutto quella
inglese, che mise al suo fianco diversi corrispondenti, contribuendo a crearne
il mito, e di scrittori come Alexandre Dumas, che ne esaltarono le gesta. Non
che lui non lo meritasse, ma tanti altri meritevoli non hanno avuto la stessa
notorietà». «In coscienza e sinceramente credo che l’Ordine massonico sia, se
non il più grande, uno dei più grandi mali morali e politici che grava su tutta
l’Unione» scrisse John Quincy Adams, VI presidente degli Stati Uniti d’America
nelle sue Letters on Freemasonry «Lettere sulla Massoneria», 1833. «C’è un filo
rosso che lega tutti i grandi delitti. Un unico progetto politico…» gli fecce
eco un secolo dopo ancora il giudice Rocco Chinnici seguendo la china di quel
Nuovo Ordine Mondiale di cui un ufficiale di marina canadese, il commodoro
William Guy Carr, svelò le trame nel suo celebre libro “Pedine nel Gioco” del
1956 dove trovano ampio spazio i carteggi tra Pike e Mazzini. Al di là degli
intrecci tra i registi vediamo però le prove che attestano il ruolo della
massoneria britannica nella spedizione dei Mille. Il più eclatante è una lettera
di credito rilasciata a Giuseppe Garibaldi dalla National Bank of Scotland nel
1860 e pubblicata nel secondo reportage di Greco sull’argomento che evidenzia i
numerosi passaggi che consentirono al documento emesso dalla Banca Nazionale
Scozzese di Edimburgo il 22 agosto 1860 di essere depositato per il pagamento
presso la Glyn & Co. Banking House di Londra. «In realtà, oltre questa lettera
di credito proveniente dalla raccolta fondi fatta in Scozia, vi furono molte
altre pubbliche sottoscrizioni per la raccolta di fondi a sostegno di Garibaldi,
o meglio, per sostenere l’invasione del meridione – aggiunge Greco – A Milano,
già il 24 gennaio 1860 commercianti milanesi avevano raccolto una offerta pari a
£ 70.226,85 per l’acquisto dei fucili per la spedizione. Ma anche Cavour aveva
fatto pervenire a Garibaldi prima della partenza, la somma di Lira Italiana
20.000. Mentre il 9 maggio 1860, tre giorni dopo la partenza da Quarto, un
telegramma dell’agenzia Reuter di Marsiglia trasmesso da “The Glasgow Herald”
comunicava che Garibaldi partiva e che prima dell’imbarco “l’eroe dei due mondi”
aveva acquistato tre milioni di franchi in oro dalla Banca San Giorgio di
Genova». Ecco i soldi della Massoneria inglese con cui il rivoluzionario reduce
deelle imprese di guerriglia mercenaria in Uruguay acquistò i fucili per la
spedizione. Ma questo non fu l’unico supporto inglese determinante al successo
della missione garibaldina. «Nel 1860 con l’ingegnosa scusa di una bella
“Escursione nel Sud” si invitavano volontari ad invadere il meridione. Infatti
presso gli uffici al No. 8 di Salisbury Street, London si poteva fare domanda
alla “Commissione Garibaldi” per partecipare alla “Escursione in Sicilia e a
Napoli per visitare l’Italia del Sud e aiutare la “Causa di Garibaldi e
dell’Italia» rammenta il giornalista del Salento in un terzo articolo. In esso
si fa riferimento alla cosiddetta Legione Britannica, un corpo militare di
volontari inglesi e scozzesi, che vennero definiti “Garibaldi Excursionists” per
evitare problemi di apparenze diplomatiche. I finanziamenti per l’invio della
legione in Italia provenivano dal “Garibaldi Special Fund”, nato dopo
l’istituzione nel 1859 del “Garibaldi Fund” per raccogliere fondi a favore della
causa per l’unificazione italiana, che in Inghilterra era molto sentita
(soprattutto in funzione anti francese) e sostenuta anche a livello popolare,
anche per la presenza di numerosi rifugiati politici italiani, che tenevano
conferenze e fondavano associazioni italo-inglesi per aiutare la causa
dell’indipendenza italiana. Non va infatti dimenticato che a livello
internazionale non si erano ancora del tutto sopiti gli attriti tra Gran
Bretagna e Regno delle Due Sicilie inerenti la cosiddetta Questione degli Zolfi
(1838-1840) quando Londra, guidata dal già citato segretario di Stato Temple,
minacciò una rappresaglia contro Napoli e la monarchia di Ferdinando II che
aveva cercato di svincolarsi da un’esclusiva commerciale per fornitura del
prodotto delle solfatare siciliane all’Impero Britannico stipulando un più
vantaggioso accordo con la Francia. Proprio nel momento in cui agli inglesi
coloniali serviva lo zolfo per la polvere da sparo con cui sterminare gli
indiani nativi nel Far West del Nord America…Quelle tensioni si incancrenirono
quando i soldati francesi intervennero nel 1948 in aiuto dello Stato Pontificio
e fecero cadere la brevissima esperienza della Repubblica Romana, guidata
politicamente da Mazzini e militarmente da Garibaldi, che aveva costretto Papa
Pio IX a rifugiarsi a Gaeta dopo l’attentato omicida al giurista Pellegrino
Rossi nominato ministro dell’Interno e della Polizia dal Vaticano nel tentativo
fallito di mediare con i golpisti liberali. Allora, come oggi in Medio
Oriente ed in Ucraina, l’astuzia sovversiva anglosassone fece affidamento anche
sui media. E come oggi con George Soros anche allora s’incuneò un infiltrato
magiaro…Nandor Eber (1825-1885) di discendenza Askenazita e origine ungherese ma
naturalizzato inglese, patriota per la libertà dell’Ungheria dall’Impero
Austro-Ungarico degli Asburgo, falliti i tentativi insurrezionali, si era
rifugiato con altri connazionali in Italia combattendo per la sua libertà e
dando vita, assieme al colonnello Istvan Turr, alla “Legione ungherese” che si
battè agli ordini di Garibaldi in molte sue imprese. «Nel 1860 lo troviamo
accreditato come corrispondente inglese del “Times” a Palermo e grazie ad
informazioni acquisite in tale veste, è in grado di fornire a Garibaldi giunto
in vista di Palermo l’esatta dislocazione delle truppe borboniche poste a difesa
della città» scrive Giovanni Zannini nel suo blog InformaStoria (fonte 4). Ciò
facilitò la sua conquista ed in premio della preziosa collaborazione Garibaldi
lo nominò subito colonnello brigadiere affidandogli il comando della 15°
divisione – di cui faceva parte la Legione ungherese – che attraversato il
centro dell’isola passando per Caltanisetta e Castrogiovanni, avrebbe poi
raggiunto il 25 luglio 1860 Catania, ormai abbandonata dai Borboni. «Altro
protagonista di tale singolare filone giornalistico-militare risorgimentale fu
Antonio Gallenga (1810-1895) nato a Parma, figlio di un ufficiale piemontese
dell’esercito napoleonico. Negli Stati Uniti insegnò italiano a New York ed a
Boston, in Inghilterra ebbe la cattedra d’italiano al Queen’s College di Londra
e della Nuova Scozia, insegnò a Eton, tenne corsi su Dante a Manchester, in
Italia insegnò a Firenze, tenne conferenze e scrisse un libro» riferisce inoltre
Zannini. Gallenga «come giornalista lavorò per il “Times” che alla fine lo
utilizzò come inviato all’estero. Politicamente inquieto, in gioventù
antimonarchico, aveva progettato di assassinare il re Carlo Alberto al grido di
“Lunga vita all’Italia, e muori!”: ma il regicidio era fallito perché
l’attentatore non era riuscito a procurarsi l’arma per metterlo in atto. Però il
comportamento di Vittorio Emanuele II a favore dell’Unità d’Italia gli fece
cambiare opinione, ne divenne entusiasta sostenitore tanto da partecipare alla
spedizione garibaldina in Sicilia». Era giunto a Messina a bordo del piroscafo
“Washington” mandato dal “Times” per sostituire Eber. «E siccome anche Antonio
Gallenga di guerra, di armi e di soldati se ne intendeva per aver menato le mani
nel 1848 a Milano ed a Mantova, Garibaldi nominò anche lui colonnello e gli
affidò, assieme ad un altro colonnello inglese, John Whitehead Peard, il comando
di una colonna di volontari inglesi con l’incarico di precederlo, dopo il
passaggio dello stretto di Messina, nella marcia di risalita della penisola». Il
riferimento di Zannini è alla famosa Legione Britannica. Accanto agli infiltrati
volontari, però, si mosse pure la flotta della Royal Navy. A sostenerlo è lo
stesso Garibaldi nelle sue memorie in riferimento alle navi da guerra Argus e
Intrepid, provenienti da Palermo, che entrarono nel porto di Marsala circa tre
ore prima della comparsa dei legni piemontesi pariti da Quarto. «La presenza dei
due legni da guerra inglesi influì alquanto sulla determinazione dei comandanti
dei legni nemici, naturalmente impazienti di fulminarci, e ciò diede tempo di
ultimare lo sbarco nostro. La nobile bandiera di Albione contribuì, anche questa
volta, a risparmiare lo spargimento di sangue umano; ed io, beniamino di codesti
Signori degli Oceani, fui per la centesima volta il loro protetto». Un ruolo
decisivo, infine, lo svolsero le bande di picciotti locali comandate da Antonino
Giovanni Francesco Currau, noto con il nome di Giovanni Corrao, passato alla
storia come patriota e rivoluzionario ma anche come primo presunto mafioso
menzionato dalle cronache ufficiali. Nel 1848 abbandonò il suo lavoro per
prendere parte alla rivoluzione siciliana, durante la quale si distinse per
coraggio e abilità; con il ritorno dei Borboni, dopo vari anni di detenzione, fu
costretto ad abbandonare la Sicilia e vagare per l’Europa; desideroso di far
annettere il Sud Italia da parte dei Savoia, nel 1860 tornò in Sicilia col
concittadino Rosolino Pilo, preparando il terreno all’impresa di Garibaldi. I
due partirono da Genova a bordo della tartana viareggina Madonna del Soccorso e
sbarcarono a Messina nella notte tra il 9 e il 10 aprile 1860. Quindi si
recarono a Palermo per organizzare un migliaio di volontari che si scontrarono
a Carini con le truppe borboniche.
IL COMPLICE MAFIOSO DIVENTA GENERALE IN SICILIA. Con lo sbarco
dei Mille il 14 maggio a Marsala prima guidò una manovra diversiva in cui Pilo
cadde in combattimento, poi, il 27 maggio, attaccò Palermo dal lato opposto da
quello delle truppe garibaldine. Grazie a ciò fu nominato da Garibaldi prima
colonnello dell’esercito meridionale e poi generale al comando della Brigata
Sicula. Entrò nell’Esercito Regio ma lo lasciò nel 1862 per seguire nuovamente
Garibaldi nella conquista di Roma, un sogno che si dissolse con la Giornata
dell’Aspromonte. Tornato in Sicilia, dopo essere stato più volte arrestato dalle
autorità locali per presunti coinvolgimenti in alcune azioni criminali, venne
misteriosamente assassinato nel 1863 alle porte di Palermo. Nel 1865 il Prefetto
di Palermo Filippo Antonio Gualtiero scrisse il primo documento ufficiale in cui
fu menzionato il termine “maffia” proprio in riferimento al Corrao. «Era
d’altronde noto al sottoscritto che queste relazioni [tra partito garibaldino
e maffia] erano tenute per lo innanzi dal noto general Corrao, e poi da tempo
era in cognizione che costui, senza che il Partito d’Azione lo dubitasse
neppure, era passato ai servigi del partito borbonico. Alla morte di costui
successe un tal Vincenzo Badia fabbro di cera, che era stato il suo primo
strumento, ed era altresì noto allo scrivente che costui aveva seguito le tracce
del suo facinoroso maestro ed ora si aveva esso posto al servigio dei Borboni».
Leonardo Sciascia, poeta e scrittore siciliano, in un suo studio apparso nel
1972 su Storia illustrata, ricostruisce con molta attenzione l’origine del
termine mafia. Egli riprende anche la teoria relativa all’introduzione del
vocabolo nell’isola, ricondotta all’unificazione del Regno d’Italia, espressa da
Charles Heckethorn (Charles W. Heckethorn, Secret Societies of All Ages and
Countries, London, G. Redway, 1897), il quale si sofferma sulla missione segreta
di Mazzini in Sicilia avvenuta nel 1860 l’anno prima dell’Unità d’Italia. Quando
fondò a Palermo il Supremo Consiglio massonico del Rito Scozzese Antico
Accettato. Questa teoria, poi ripresa dall’economista e sociologo Giuseppe
Palomba, afferma che il termine «MAFIA» non sarebbe altro che l’acronimo delle
parole: «Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti».
REGNO D’ITALIA E MAFIA, UN’ALLEANZA STORICA. «Perché il Regno
d’Italia sin dall’inizio sceglie il quieto vivere, la convivenza, la
coabitazione con camorra e mafia – che altro non sono che gruppi di uomini che
si organizzano e decidono di agire contro le leggi usando la violenza per
ottenere potere e ricchezza – mentre invece combatte i briganti fino alla loro
sconfitta finale?» è la domanda che si pone lo storico Enzo Ciconte nel libro:
“La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio”, Laterza. «È una
scelta precisa: lo Stato combatte i briganti fino alla loro distruzione mentre
per il fenomeno mafioso imbocca la strada opposta della tolleranza e della
convivenza i cui effetti si prolungheranno fino ai nostri giorni. La scelta è
fatta per assecondare i desideri della grande proprietà terriera meridionale che
non accetta di venire incontro alle richieste dei contadini di avere almeno uno
spicchio di terra delle immense distese di terreni demaniali usurpati con
l’inganno dai galantuomini. Queste erano le terre richieste, mentre non c’erano
rivendicazioni su quelle dell’aristocrazia il cui possesso legittimo non era
posto in discussione». «Ma la grande paura avvinse gli uni e gli altri
preoccupati del fatto che, intaccate le proprietà degli usurpatori, si finisse
col prendere di mira anche le altre proprietà. La conseguenza fu che tutte le
richieste contadine furono respinte. E ciò alimentò il grande brigantaggio
sociale che spinse alla macchia gran parte dei contadini che avendo occupato le
terre temevano di finire in prigione» rileva Ciconte. Le conseguenze furono
tremende culminando nella legge Pica. «Fu presentata come “mezzo eccezionale e
temporaneo di difesa” e, dall’opposizione parlamentare di sinistra valutata e
combattuta come una violazione dell’art. 71 dello Statuto del Regno poiché il
cittadino “veniva distolto dai suoi giudici naturali” per essere sottoposto alla
giurisdizione dei Tribunali Militari e alle procedure del Codice Penale
Militare» scrive invece Giovanni Pecora in un dettagliato blog sul fenomeno in
cui cita l’eloquente memoria di prebitero e patriota come Vincenzo Padula. «Il
brigantaggio è un gran male, ma male più grande è la sua repressione. Il tempo
che si dà la caccia ai briganti è una vera pasqua per gli ufficiali, civili e
militari; e l’immoralità dei mezzi, onde quella caccia deve governarsi per
necessità, ha corrotto e imbruttito. Si arrestano le famiglie dei briganti, ed i
più lontani congiunti; e le madri, le spose, le sorelle e le figlie loro,
servono a saziare la libidine, ora di chi comanda, ora di chi esegue quegli
arresti». Tremende e disumane le conseguenze. La legge Pica 1409/1863, fra
fucilazioni, morti in combattimento ed arresti, eliminò da paesi e campagne
circa 14.000 briganti o presunti tali, precisa sempre Pecora nel suo articolo.
Il complesso normativo protrattosifino al dicembre 1865 determinò 12.000 tra
arrestati e deportati, mentre furono 2.218 i condannati. Nel solo 1865, furono
55 le condanne a morte, 83 ai lavori forzati a vita, 576 quelle ai lavori
forzati a tempo e 306 quelle alla reclusione ordinaria.
L’AIUTO DELLE COSCHE AGLI ALLEATI. Nacque così l’intreccio
perverso tra la mafia, sostenuta successivamente anche da picciotti ribelli in
cerca di protezione, e le autorità dotate di poteri talmente eccezionali da non
dover rispondere a nessuno per i loro abusi criminali. A nessun’altro se non a
quegli uomini d’onore che furono scelti dai potentati locali per fare le veci
dei giudici. Tutto ciò fu temporaneamente spazzato via dall’arrivo del duce
Benito Mussolini che inviò il Prefetto di Ferro Cesare Mori a dare la caccia ai
mafiosi, facendo fuggire curca 500 famiglie di Cosa Nostra negli Stati Uniti
dove si consociarono nel Sindacato del Crimine, ma vietò anche le società
segrete interrompendo pertanto le occulte relazioni tra cosche e logge
massoniche.
CIA-MAFIA-MASSONERIA: L’ITALIA NELLA MORSA. Ciò tagliò fuori i
colonialisti anglosassoni che scesero a patti con il famoso boss malavitoso
Lucky Luciano, al secolo Salvatore Lucania nato a Lercara Friddi nel 1897, pur
di tornare in Sicilia, sbarcare senza troppe perdite ed avere una rete di potere
già consolidata. Fu creata anche con l’aiuto di Vito Genovese, l’altro padrino
mafioso da cui prende il nome l’omonima famiglia di New York, ritenuto uno dei
fondatori della rete distributiva di eroina negli USA ma divenuto l’interprete
ufficiale dell’AMGOT, il governo provvisorio anglo-americano di Palermo che
controllò la regione dal 1943 alla Liberazione d’Italia del 1945. Fu proprio
tale organismo amministrativo alleato a decretare l’inizio della carriera
politica di Bernardo Mattarella, spianando la strada al figlio Sergio divenuto
ai giorni nostri Presidente della Repubblica.
MATTARELLA, INTOCCABILI SICILIANI DA PALERMO A ROMA. Molti sono
gli intrighi siciliani narrati in precedenti reportage. Oggi vogliamo ricordare
solo un episodio eclatante come l’uccisione del generale dei Carabinieri Carlo
Alberto Dalla Chiesa nominato Prefetto di Palermo nel 1982 per combattere la
mafia. Vi morì il 3 settembre in un agguato di Cosa Nostra insieme alla moglie
Emanuela Setti Carraro. L’ordine di ucciderlo sarebbe giunto dal deputato
massone Francesco Cosentino, deceduto prima che i magistrati siciliani facessero
il suo nome davanti alla Commissione parlamentare antimafia in relazione agli
intrecci mafia-massoneria. Questo serve a riportarci al filo rosso menzionato
all’inizio… «L’uccisione del giudice Chinnici fu voluta dai cugini Ignazio e
Nino Salvo e ordinata dalla cupola mafiosa, per le indagini che il magistrato
conduceva sui collegamenti tra la mafia e i santuari politico – economici»
scrissero i procuratori antimafia di Palermo. Ma quali erano i santuari politico
– economici cui fanno riferimento i magistrati? Qualche tempo dopo la sua morte
di tumore, che gli evità di affrontare il maxi-processo, si è scoprì che Nino
Salvo era iscritto alla Massoneria universale di Rito Scozzese Antico e
Accettato. E non in una loggia qualsiasi ma nel “Supremo Consiglio d’Italia” di
via Roma a Palermo, la stessa che cent’anni prima aveva conferito il 33° grado a
Giuseppe Mazzini prima e a Giuseppe Garibaldi poi… «Nella Prima Costituente
Massonica Italiana (Torino, 26 dicembre 1861 – 1° gennaio 1862), in cui fu
eletto Gran Maestro Costantino Nigra, Giuseppe Garibaldi fu acclamato Primo
Libero Muratore d’Italia e gratificato di una medaglia d’oro massiccio, avente
da un lato l’iscrizione “Costituzione Massonica Italiana” e dall’altra la dedica
al “Primo Libero Muratore d’Italia Giuseppe Garibaldi”. Il massone ascolano
Candido Augusto Vecchi gliela consegnò al Varignano dove Garibaldi era
imprigionato dopo i fatti di Aspromonte» si legge nel sito del Grande Oriente
d’Italia. L’11 marzo 1862 il Supremo Consiglio del Rito Scozzese sedente in
Palermo conferì a Giuseppe Garibaldi tutti i gradì scozzesi, dal 4° al 33° e lo
nominò Presidente del Supremo Consiglio con il titolo di Potentissimo Sovrano
Gran Commendatore e Gran Maestro. Incarico che accettò il giorno 20 dello stesso
mese. Il 3 luglio successivo, Garibaldi fece diventare confratelli il figlio
Menotti e l’intero stato maggiore: pare nella Loggia palermitana “I Rigeneratori
del 12 Gennaio 1848 al 1860 Garibaldini”.
SUMMIT DI MASSONI IN SFREGIO AL PAPA PER CELARE I COMPLOTTI DI
MAZZINI. Giuseppe Garibaldi era entrato nella fila degli incappucciati già nel
1844 nella Loggia “Asil de la Vertud” di Montevideo (secondo altri del Rio
Grande del Sud), una loggia “spuria”, emanazione della Massoneria brasiliana e
non riconosciuta dalle grandi Comunioni mondiali. Nello stesso anno, il 18
agosto, fu regolarizzato nella Loggia “Amis de la Patrie” di Montevideo
all’obbedienza del Grande Oriente di Francia, nel libro matricola della Loggia
gli fu assegnato il numero 50. Frequentò anche la Loggia “Tompkins n° 471” di
Stapleton (New York). In tempi assai più recenti, nel marzo 2019, i Fratelli
Scozzesi RSSA italiani e stranieri si sono riuniti appositamente a Trento per
discettare di “complottismo” e farsi un po’ beffa della memoria del I Congresso
Antimassonico Internazionale che si tenne in quella città nel 1896 ed a cui
partecipò anche Papa Leone XIII, autore dell’enciclica Humanum Genus con cui il
20 aprile 1984 aveva scomunicato la massoneria. I confratelli del RSAA si
incontrarono per irridere le teorie dei complotti storici forse scordandosi di
una tremenda analogia storica… C’è infatti davvero quel filo rosso inquietante
che lega la massoneria britannica alla Sicilia della mafia. Sono i morti
ammazzati per la protezione del commercio della droga. Nel 1840 Lord Palmerston,
Henry John Temple, l’amico di Mazzini e ssponsor della spedizione dei Mille, con
una flotta di 40 navi intraprese la Guerra dell’Oppio contro la Cina che stava
perseguendo i i mercanti inglesi adusi al contrabbando del prezioso stupefacente
(fonte 8). Dopo due anni e tanti morti l’impero britannico ebbe la meglio ed
ottenne la firma di un Trattato di Pace secondo il quale i commercianti inglese
rimasero sotto la giurisdizione esclusiva dei loro consoli. Ciò consentì al
contrabbando di oppiacei di proseguire impunemente…Nel 1979 l’FBI avviò
l’operazione Pizza Connection anche l’iuto del giudice siciliano Giovanni
Falcone per smantellare il traffico della droga tra New York e Palermo. Falcone
fu poi ucciso con la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della sua scorta in
un attentato dinamitardo con esplosivo militare mentre si trovava in autostrada
nei pressi di Capaci il 23 maggio 1992. Se tutto questo è potuto accadere
bisogna senz’altro ringraziare anche Garibaldi e la massoneria britannica che
l’ha finanziato per fare dell’Italia una colonia anglosasassone prima, un feudo
della NATO poi. Dove ora si è potuta avviare anche la speculazione d’affari nel
mercato delle armi con dei pericolosi alleati quali i Fratelli
Musulmani, ovviamente soci di quella famiglia Rothschild che consentì agli
Illuminati di Baviera braccati dalla giustizia di affiliarsi alla massoneria e
farla franca. Fabio Giuseppe Carlo Carisio
MAGGIO 1860, IL RUOLO DELLA GRAN BRETAGNA NELL’ATTACCO ALLA
SICILIA E AL REGNO DELLE DUE SICILIE. Michele Eugenio
Di Carlo Giovedì, 28 Maggio 2020 su retegargano.it. Uno dei più dettagliati
resoconti della spedizione garibaldina - tanti ne hanno tratto informazioni
senza citare la fonte - resta quello di Giacinto de’ Sivo. Con precisione
assoluta lo scrittore di Maddaloni descrive l’apparato di sicurezza che il
Governo aveva disposto per proteggere la Sicilia dall’invasione ritenuta certa:
quattro fregate a vapore, due a vela, nove piroscafi da guerra, che navigavano
incessantemente lungo le coste siciliane. Considerate anche le forze di Polizia
e le Guardie Urbane, supporre che Giuseppe Garibaldi, nel caso fosse riuscito a
sbarcare, potesse andare oltre Marsala non era proprio possibile. Per de’ Sivo
era del tutto chiaro: la forza di Garibaldi era stata costruita a tavolino, in
particolare dalla potentissima macchina della propaganda inglese. E quanto
Cavour, convintosi a favorire la spedizione, cercò di metterne a capo Nino
Bixio, «allora dolentissimo il Nizzardo, scordò la venduta patria, e scrisse
umilissime lettere al La Farina, scongiurandolo d’aiutarlo… ». Sicuramente era
stata proprio l’azione di mediazione di Giuseppe La Farina a spingere Garibaldi
ad incontrare Camillo Cavour e Vittorio Emanuele II a Bologna il 2 maggio, al
fine di addivenire ad un accordo, come già supposto dallo storico Pietro
Pastorelli. Ed è così che «quel marinaio già dalla stampa mazziniana
magnificato, quasi promesso da’ fati, per patti segreti tra reggitori di popoli
potenti, con l’oro del Piemonte indebitato a posta, doveva lanciarsi a portar
guerra civile nelle Sicilie». Mentre tutta Genova era in fermento per i
preparativi della partenza, le proteste del ministro degli Esteri napoletano
ottenevano l’effetto di far sì che «Cavour si storcea, mendicava parole, e
prometteva d’impedire l’andata». E quando dalla Prefettura di Genova si
manifestarono le preoccupazioni circa le responsabilità di preparativi alla luce
del sole per una invasione militare che nessuno aveva autorizzato, «venne il La
Farina con lettere del Cavour al prefetto e nessuno fiatò; anzi s’ebbero aiuti
manifesti». De’ Sivo svela anche i retroscena dell’accordo segreto tra la
società di navigazione Rubattino. Un accordo che era stato siglato con un atto
di vendita dei bastimenti Piemonte e Lombardo a Torino nello studio del notaio
Badigni, mentre la propaganda sabauda faceva passare l’episodio della presa dei
due bastimenti come un’azione violenta di Bixio allo scopo, attestato dallo
stesso Garibaldi, di allontanare i sospetti di complicità dal Governo di Torino.
Informato della partenza della spedizione garibaldina, il Governo napoletano con
una comunicazione dell’8 maggio informava il luogotenente Castelcicala che, tra
le varie eventualità, Marsala era il luogo più probabile dello sbarco. Tra
l’altro, il generale Letizia, vecchio carbonaro, due giorni prima dello sbarco
si era portato a Marsala per poi, inspiegabilmente, ripiegare su Palermo via
Mazara del Vallo, mentre gli subentrava Landi. La costa marsalese era
controllata via mare dalla fregata a vela Partenope e da due navi a vapore,
la Stromboli al comando del capitano Acton e la Capri diretta dal
capitano Caracciolo, entrambi avvertiti della possibilità non remota di un
approdo dei garibaldini a Marsala. La sera del 10 maggio due vascelli inglesi
avevano avuto l’ordine di lasciare il porto di Palermo e di dirigersi verso
Marsala: l’Argo al comando di Ingrham e l’Intrepid al comando del
capitano Marryat. Il Piemonte e il Lombardo giunti nei pressi di Marsala erano
stati avvistati e la loro presenza era stata immediatamente comunicata ai
vascelli napoletani. Dopo l’una di pomeriggio, presenti i due “legni” inglesi,
Garibaldi dava l’ordine di sbarcare nel porto di Marsala. Al sopraggiungere
tardivo dello Stromboli, mentre erano in atto le operazioni di sbarco, l’inglese
Ingrham comunicava ad Acton che doveva necessariamente imbarcare personale
inglese presente a terra prima che iniziasse il cannoneggiamento dei legni
garibaldini. Un’operazione che richiese tanto di quel tempo da impedire l’azione
della flotta borbonica. De’ Sivo ha scritto che già il 12 maggio il
ministro Carafa protestava in tutta Europa « per l’atto di pirateria consumato
contro il reame, e preparato in territorio di Stato amico», non mancando di
elencare con precisione i fatti, i mezzi e le armi utilizzati, i luoghi della
raccolta fondi e dell’arruolamento dei volontari e chiedendo che fossero
denunciate le responsabilità di promotori, autori e complici dell’invasione
avvenuta in totale violazione del diritto internazionale che regolava i rapporti
tra Stati indipendenti. La replica all’appello delle Due Sicilie non si fece
attendere, infatti Prussia, Austria, Russia e Francia protestarono. Nonostante
le richieste di chiarimento e le accuse provenienti da tutta l’Europa, Cavour
«s’armò di bugie» e l’ambasciatore piemontese Villamarina a Napoli dichiarò che
i sospetti di complicità del Governo di Torino con l’avventura garibaldina erano
non solo falsi, ma ingiuriosi. Sul foglio ufficiale, il 17 maggio, il Governo
sardo-piemontese dichiarava sfacciatamente la propria estraneità, la totale
disapprovazione dell’impresa di Sicilia, oltre allo stretto rispetto per il
diritto internazionale. La documentazione registrata sin dai primi anni da de’
Sivo, comprovante le complicità di Torino e di Londra nella spedizione
garibaldina, non è mai stata presa in seria considerazione dalla storiografia
ufficiale liberale. I documenti di de’ Sivo non potevano essere diffusi, in
particolare nel periodo successivo all’unità acquisita, quando il Sud in
continuo stato d’assedio subiva l’oltraggio della Legge Pica e un medico al
seguito dell’Esercito Italiano lanciava spudoratamente le sue teorie
pseudoscientifiche sull’atavismo delle popolazioni meridionali. Eppure le fonti
documentali utilizzate da de’ Sivo sono quelle conservate oggi negli archivi
diplomatici di mezza Europa. La lettera del 12 maggio citata da de’ Sivo,
ripresa nei Carteggi di Camillo Cavour , come chiarisce lo storico Eugenio Di
Rienzo, fu consegnata da Carafa agli ambasciatori Salvatore Pes di Villamarina e
all’inglese Hudson, e inoltrata celermente alle diplomazie europee. Essa
esprimeva un «categorico e durissimo giudizio di condanna sulle responsabilità
della Mediterranean Fleet». La lettera ebbe, come sostenuto da de’ Sivo,
l’immediato sostegno di gran parte degli Stati europei, come documentato
peraltro da Nicodeme Bianchi. Il ministro degli Esteri russo Gorčakov, convocato
il 14 maggio l’ambasciatore inglese John Fiennes Crampton, elevava una vibrata
protesta, mentre l’ambasciatore russo a Torino comunicava minacciosamente che
solo la distanza geografica aveva impedito alla Russia di difendere con le armi
il Regno delle Due Sicilie (circostanza citata dallo stesso de’ Sivo). Il giorno
stesso, il ministro degli Esteri francese Thouvenel chiedeva spiegazioni
all’ambasciatore inglese Cowley sulla palese violazione del diritto
internazionale; il giorno 15, il Primo Ministro austriaco, Johann Bernhard
von Rechberg, trasmetteva una nota a Londra e Parigi dalla quale si evinceva che
Piemonte e Gran Bretagna erano ritenuti responsabili di aver organizzato e
favorito la spedizione garibaldina, mentre il 17 dello stesso mese la Prussia
proponeva un accordo ad Austria e Russia per tutelare il diritto internazionale
leso dal Piemonte con il beneplacito inglese. Sulla questione rimasta
controversa il ministro Russel fu costretto a difendersi nello stesso Parlamento
inglese. Il 17 maggio, come risulta nei resoconti dei dibattiti parlamentari
inglesi (Hansard’s Parliamentary Debates) citati da Di Rienzo, Russel andava
incontro ad un duro scontro che proveniva dai banchi parlamentari
dell’opposizione e dalla stessa maggioranza, a seguito dell’intervento del
deputato George Hope che chiedeva di far cessare l’ ignobile sottoscrizione su
suolo inglese a favore della Sicilia in rivolta promossa dal ferrarese Alberto
Mario, marito della giornalista del “London Daily News” Jessie White. Una
sottoscrizione alla quale avevano contribuito anche elementi in vista del
partito whig e, persino, alcuni ministri. La mancata risposta del Governo
spingeva il deputato tory Richard Malins a denunciare che la legislazione
vietava la raccolta di fondi su suolo inglese per finanziare imprese militari
straniere e che se il principio era applicato per le grandi Potenze straniere
non poteva non esserlo per il Regno delle Due Sicilie. Il deputato Ralph Bernal,
insoddisfatto delle repliche governative, poneva l’accento sulla gravità delle
informazioni riportate dalla stampa europea che vedeva un diretto coinvolgimento
della Gran Bretagna nell’illegittima spedizione armata di Garibaldi. Come spiega
ancora Di Rienzo, la presenza della flotta inglese nel mare di Sicilia era vista
come una minaccia concreta sia dagli ufficiali della Marina napoletana sia
da Francesco II, consapevoli che il Governo Palmerston non si sarebbe tirato
indietro qualora si fosse verificato un benché minimo incidente di natura
militare lungo le coste siciliane. Sicuramente la decisione di approdare a
Marsala, laddove vi era una discreta presenza di attività produttive e
commerciali inglesi, era stata concordata da Garibaldi con i referenti del
Governo inglese. Il 4 marzo 1861, quando nel Regno delle Due Sicilie ai
garibaldini mandati in congedo era subentrato l’Esercito Sardo-piemontese e
l’Italia stava per essere unificata sotto le insegne dei Savoia, il
deputato John Pope Hennessy riaccendeva la discussione contestando al Governo
inglese di aver interferito nella vittoriosa impresa garibaldina, sostenendola
militarmente, finanziariamente e diplomaticamente. Secondo Pope le due navi
della flotta inglese erano presenti nella rada del porto di Marsala col preciso
intento di fornire il supporto necessario ad assicurare lo sbarco a Marsala
degli uomini in camicia rossa. Pochi erano i dubbi sul coinvolgimento inglese
nella conquista militare del Regno delle Due Sicilie; dubbi che si affievolirono
del tutto quando lo stesso Pope, nella seduta parlamentare citata, rese nota la
lettera con cui Vittorio Emanuele II aveva ringraziato il Governo inglese. Non a
caso Eugenio Di Rienzo, accademico esperto, direttore della “Nuova Rivista
Storica”, noto docente di Storia Moderna presso l’Università “La Sapienza” di
Roma, rende i dovuti meriti al prezioso lavoro di ricerca degli studiosi
revisionisti non accademici: «Che la longa manus del ministero whig abbia
potentemente contribuito (soprattutto ma non soltanto con un supporto economico)
al successo della ‘liberazione del Mezzogiorno’ è un’ipotesi che la storiografia
ufficiale ha sempre accantonato, spesso con immotivata sufficienza, e che ha
trovato credito soltanto in una letteratura non accademica accusata
ingiustamente, a volte, di dilettantismo e di preconcetta faziosità
filoborbonica».
Tratto da un testo di Michele Eugenio Di Carlo in via di
pubblicazione sulla fine del Regno delle Due Sicilie
Un Giuseppe "re" di Sicilia avrebbe cambiato l'Italia.
La controcronaca di Alfio Caruso sull'impresa dei Mille. "Il
popolo si fidava soltanto di lui..." Stefania Vitulli, Sabato 25/04/2020 su Il
Giornale. L'Italia a due velocità, gli anticorpi politici mai fatti ai batteri
di una malattia ultracentenaria, il successo inspiegabile di maneggi e congiure:
avrebbero ricevuto un duro colpo, forse, se l'impresa dei Mille avesse avuto
diverso esito. Per capirlo vale la pena ripartire proprio dal racconto di quello
sbarco. Ci ha provato il giornalista e scrittore Alfio Caruso in Garibaldi,
corruzione e tradimento. Così crollò il Regno delle Due Sicilie (Neri Pozza,
pagg. 316, ebook disponibile a euro 9,99, cartaceo euro 18 in uscita il 21
maggio). Il tentativo qui - perfettamente riuscito dal punto di vista del
contenuto e anche della forma, cristallina per chiarezza e tono - è quello di
raccontare la spedizione dei Mille, al suo 160º anniversario, «vista dai due
lati della barricata», per bilanciare la storia scritta dai vincitori con una
gustosa «versione borbonica» dei fatti: «L'impresa dei Mille è forse l'episodio
fondante dell'Unità d'Italia», ci spiega Caruso, catanese classe 1950. «Cavour
capì che gli italiani andavano fatti anche se non sapeva nemmeno come erano
fatti e lo sbarco in Sicilia gli consente di puntare all'intera penisola.
Episodio fondante, sì, e tuttavia da sempre e ancora avvolto da scetticismo,
oltre che da mistero, perché stiamo parlando di mille ragazzi, pochi dei quali
avvezzi alle vicende militari, armati in maniera discutibile. Pochi che
riuscirono comunque a impossessarsi di un Regno dove l'esercito contava su
90mila uomini. Come poté avvenire e soprattutto che cosa accadeva nel frattempo
nel gustosissimo dietro le quinte? È questo che ho cercato di rievocare». A
testi divenuti ormai classici, come Noterelle di uno dei Mille. Da Quarto al
Volturno di Giuseppe Cesare Abba, I Mille. Da Genova a Capua di Giuseppe Bandi o
la ricostruzione di George Macaulay Trevelyan, Garibaldi e i Mille, Caruso
contrappone un resoconto pressoché sconosciuto: Un viaggio da Boccadifalco a
Gaeta, di padre Giuseppe Buttà, e su questo fonda le novità della sua
«ricostruzione borbonica». «Cappellano di quel 9º battaglione cacciatori
comandato dal colonnello Bosco, che con valore si batté contro garibaldini e
piemontesi... da Palermo a Gaeta, padre Buttà vide tanti e così eclatanti esempi
che inettitudine e avidità non bastano, nemmeno oggi, a spiegare»: così
raccontava Leonardo Sciascia con ammirazione nel saggio Garibaldi e il padre
Buttà, parlando di un uomo che, nato a Naro, provincia di Messina, nel 1826,
nemico giurato del liberalismo, resterà fedele a Francesco II fino all'ultimo
giorno. Da quell'osservatorio privilegiato, Buttà visse in prima linea gli
episodi cruciali che condussero alla dissoluzione del Regno: «Ne sono venuto a
conoscenza - dice Caruso - grazie a un lettore: il libro è sparito dalla
circolazione ma rimane un punto di vista originale. Buttà è molto più borbonico
di Francesco II, è acceso da un anti-italianismo sparato e da avversione totale
nei confronti dei garibaldini. Il racconto è pieno di pettegolezzi, dettagli,
voci, dissidi e tradimenti, soprattutto. Quei tradimenti che resero possibile
che mille sbandati - come li chiamavano i Borboni - mille farabutti potessero
impossessarsi del regno più ampio della penisola italiana, le Due Sicilie».
Generali ultrasettantenni, che avevano perso ogni voglia di rischiare, i maneggi
dei fratellastri di Francesco che tentano di scalzarlo, i soldi di Cavour che
corrono a fiotti, nel suo libro Caruso non ci risparmia nessuno degli aneddoti
più paradossali: «E poi le riverenze verso l'ambasciatore sabaudo a Napoli,
perché mentre la guerriglia di Garibaldi avanza i diplomatici continuano a
trattare sul modo migliori di accordarsi. E Francesco, che si fida, e fa sempre
la figura dello scemo. Per non dire dello stesso incontro di Buttà a Milazzo con
Garibaldi, che vuole arruolarlo coi Mille: Buttà fa finta di aderire ma alla
prima occasione scappa e se ne torna dai Borboni». Una controcronaca, dunque,
che Caruso inquadra anche per il peso avuto, oltre che nel dare uno Stato ai
Savoia, nella divisione mai sanata tra Nord e Sud: «Se i Savoia e Cavour
avessero lasciato mano libera all'amore per Garibaldi, che fu accolto a Palermo
come una novella Santa Rosalia, probabilmente tante divisioni non sarebbero
sorte. Garibaldi aveva il carisma necessario per far digerire tante soluzioni
antipatiche: era un figlio del popolo e il popolo lo sentiva suo. Nella parte
finale le operazioni vennero lasciate a Cialdini e Fanti, due generali cui il
razzismo scappava dalla pelle e che coi loro comportamenti diedero
giustificazione al brigantaggio. Una promessa tradita verso le classi meno
abbienti che avevano sperato che l'arrivo di Garibaldi coincidesse con il
miglioramento della loro situazione e con la distribuzione delle terre». Se
Garibaldi avesse trionfato, o ancora se il Regno delle Due Sicilie non fosse mai
stato preso: questi esercizi di immaginazione, oggi tanto in uso per le figure
di Hitler e Mussolini, si possono forse tentare anche qui, specie in riferimento
a una ricostruzione che tiene conto di vincitori e vinti: «Nel primo caso, con
Garibaldi al comando, avremmo avuto un'Italia forse meno settaria da tutti e due
i lati, meno segnata dai privilegiati», immagina Caruso. «Forse non saremmo
entrati nella prima guerra mondiale come voleva Giolitti. E se non fossimo
entrati in guerra non ci sarebbe stato il fascismo. Forse saremmo ancora una
monarchia, ma con Vittorio Emanuele IV e non so se ci guadagneremmo. Certo è
invece che il Regno delle Due Sicilie era destinato a implodere: condizioni
economiche miserrime, diabete già una pandemia, rivolte fatte solo per denaro. E
i Florio che non erano gli Agnelli: hanno sfavillato per un paio di decenni,
sono sprofondati alle prime vere difficoltà. L'unico che ci ha perso davvero è
Francesco II: poteva, per diritti dinastici, ambire a Torino ben più di Vittorio
Emanuele II».
NAPOLI E SUD POCO COMBATTIVI? Marco
Ascione il 13.04.2020 su movimento24agosto.it. Nell’immaginario collettivo
italiano, Napoli e il Sud sono indolenti, per nulla combattivi e restii, se non
rifuggenti, la lotta in genere. Si ritiene che essi opportunisticamente
preferiscano non sprecarsi in cause riguardanti la collettività per evitare
guai. E lo sconclusionato esercito napoletano di Francischiello ne è un esempio.
Proviamo a capire se le cose stanno davvero in questi termini. Tanto per
cominciare, l’esercito napoletano cosiddetto di Francischiello tutto è stato
fuorché sconclusionato. Lo stesso Francischiello, ovvero Francesco II di
Borbone, ultimo sovrano duosiciliano, combatté strenuamente fino alla
capitolazione nell’assedio di Gaeta, insieme alla regina Maria Sofia, ammirata
dai soldati e dal mondo come vera eroina e per questo celebrata da poeti del
calibro di Proust o D’Annunzio. Le milizie duosiciliane poi morirono eroicamente
resistendo fino alla fine ai subdoli attacchi sabaudi del Generale Cialdini che
non riuscendo a sgominarle durante l’assedio di Gaeta ricorse persino al metodo
sporco delle armi chimiche. Inoltre, come oramai oltremodo noto, quando
Garibaldi arrivò in Sicilia, ai soldati borbonici fu ordinato dai loro generali
(come Landi, Lanza ecc., vendutisi ai piemontesi e agli inglesi) di non
combattere e di ritirarsi dinanzi ai garibaldini. I soldati duosiciliani
all’arrivo di Garibaldi a Palermo furono addirittura chiusi, da detti generali e
ufficiali, nelle caserme della città per impedire loro di combattere. La voglia
di battersi, il valore e il coraggio, nonché lo zelo e il livore che li
animavano furono tali che in un caso essi, intuito il tradimento del loro
generale, lo giustiziarono. Circolava, infatti, in quel periodo, una sarcastica
vignetta, raffigurante gli ufficiali napoletani con teste da somari, i generali
privi di testa (perché venduti) e i loro soldati invece con teste di leoni. I
soldati duosiciliani poi, ironia della sorte, appena una dozzina d’anni prima
circa erano andati a liberare i lombardi e i veneti dal loro oppressore
austriaco. Fu infatti nel 1848, durante quella che è ricordata come Prima guerra
d’indipendenza, in cui tutti gli stati italiani scendono in campo contro
l’Austria. Ma le truppe del Regno delle Due Sicilie sono quelle che conseguono
le maggiori vittorie e si distinguono di più per prerogative di coraggio e
combattività. Infatti, i giornali L’Alba d’Italia e la Gazzetta di Genova, il 29
marzo di quell’anno, relativamente alla partenza delle truppe partenopee dal
porto di Napoli, avevano scritto [1]: “Quei prodi […] si dimostravano fra tutti
i più franchi e coraggiosi amici dell’Italia e della libertà”. L’esercito
napoletano era allora il più potente, meglio organizzato e, persino, più
disciplinato e corretto d’Italia. Il ligure Giuseppe Ugo Oxilia [1] riporta che,
nella seconda metà di aprile del ’48, i napoletani giunti a Pistoia ricevettero
una così calorosa accoglienza che i “Pistoiesi […] facevano a gara a invitarli a
pranzo”. Il contributo dei soldati duosiciliani durante tale guerra risultò
decisivo. In seguito alla loro vittoria in Lombardia, nella battaglia di
Curtatone del 13 maggio, il Governo Provvisorio di Milano nell’inviare le
proprie congratulazioni, tra le altre cose, scriveva: “O Napoletani,
rallegratevi di aver sì gloriosamente aperta la via al vostro valoroso esercito,
che […] viene a confermare gli antichi vanti dell’italica milizia nella guerra
dell’italica indipendenza!” Tuttavia, nuovamente a Curtatone e a Montanara,
stavolta il 29 maggio, l’immane sproporzione di uomini e mezzi tra l’esercito
austriaco e le truppe tosco-napoletane determinò la sconfitta di queste ultime.
Ciò nonostante, la strenua resistenza da esse opposta fu memorabile: i
napoletani e i toscani riuscirono a tener testa, per circa sei ore, ai ripetuti
assalti di uno dei più potenti eserciti d’Europa, evitando così che l’esercito
piemontese fosse preso alle spalle [1]. Infatti, grazie a questo, i piemontesi
riuscirono ad avere il tempo necessario per riorganizzarsi e vincere, il giorno
dopo, insieme alle truppe napoletane, la battaglia di Goito, sempre in
Lombardia. I cittadini di Goito, poi, nel loro “manifesto di commiato”,
esternarono la propria gratitudine alle truppe napoletane dichiarando [2]:
“Prodi napoletani del 10° di linea Abruzzo! Voi che appena arrivati vi uniste a
noi con fratellevole simpatia, voi che per tutto il tempo che abbiamo passato
insieme vi siete distinti per una condotta esemplare, voi che la memoranda
giornata del 30 maggio pugnaste [lottaste] così valorosamente nella battaglia
combattuta alle soglie del nostro paese e noi dall’alto delle case vi abbiamo
veduti e ammirati, accettate i ringraziamenti degli abitanti di Goito,
riconoscenti.” Mentre i commilitoni toscani, che con essi avevano combattuto
nella battaglia di Montanara, rivolsero ai soldati napoletani il loro saluto
dicendo: “Vi abbiamo amati come fratelli negli accampamenti, vi abbiamo ammirati
come prodi soldati sul campo di battaglia. Siete chiamati in Patria e noi
sentiamo la forza del vostro dovere.” La superiorità dell’esercitò napoletano in
Italia (il più potente e numeroso dello Stivale) si evinse anche in occasione
della sua risalita a settentrione al seguito di Gioacchino Murat che, per un
breve lasso di tempo, occupò, nel 1815, l’Italia intera fino al Po (esperienza
questa, poi, terminata a seguito dell’intervento austriaco). E lo sapevano bene
i liberali italiani che, nel 1831, “riuniti in congresso a Bologna, decidevano
di offrire al Re di Napoli [Ferdinando II] la Corona d’Italia”, identificandolo
peraltro come il monarca italiano dalle vedute più ampie e vicine ai loro
ideali. Ferdinando II, però - oltremodo rispettoso dei diritti e della dignità
degli altri sovrani e principi italiani -, non accettò mai. Finanche il
repubblicano veneziano Attilio Bandiera che, insieme al fratello Emilio e ad
altri al loro seguito, divenne protagonista del noto tentativo insurrezionale
unitario del 1844 – durante la sua detenzione in Calabria, come scrive lo
storico britannico Harold Acton, “in una ispirata lettera […] illustrò i suoi
ideali a Ferdinando II, promettendogli di servirlo corpo e anima se fosse
divenuto sovrano costituzionale di un’Italia unita”, esponendogli quanto il
Regno delle Due Sicilie fosse lo Stato italiano maggiormente all’altezza per
portare a compimento l’unificazione politica d’Italia [6]. Andando poi ancor più
indietro, in particolare, di 400 anni prima del tentativo di Murat, scopriamo
che l’esercito napoletano, al seguito del proprio re Ladislao, nel 1414 aveva
conquistato una grossissima fetta dell’Italia. Vale a dire, lo Stato Pontificio
(escluse Todi e Bologna) e parte della Toscana (con inclusa la presa di Valiano
e Cortona e l’occupazione navale dell’Elba e di Talamone del 1409). Firenze,
decisamente allarmata, temendo un imminente attacco da parte di Ladislao, con
febbrile fare diplomatico si fece in quattro pur di esser difesa o di
scongiurare l’offensiva napoletana; e da ultimo vi riuscì, strappando una
soluzione di pace al sovrano di Napoli, il quale dal canto suo pensò di
acconsentire con l’intento di vedersi anzitutto legalizzati i suoi nuovi domini.
Tale esperienza, però, si concluse per la morte del sovrano napoletano che, nel
luglio dello stesso 1414, improvvisamente, mentre assediava Todi, venne colpito
da una sinistra febbre, che nel giro di poche settimane lo portò, appena
trentottenne, alla morte (6 agosto 1414). Non lasciando eredi, gli successe la
sorella Giovanna, la quale non perseguì i disegni del fratello e ultima sovrana
angioina napoletana stette al trono fino alla sua morte.
La “tradizione” combattiva napoletana ha, però, radici ancor più
remote. Napoli già nel 615 d.C. approfittando della rivolta e dell’uccisione a
Ravenna dell’esarca, si dichiara indipendente da Bisanzio (da cui era dominata).
Sebbene tale tentativo sia poi vanificato dall’immediata ed energica reazione
dell’esarca Eleuterio, la progressiva sete d’indipendenza della città non verrà
ad arrestarsi. Tra l’altro, essa non riuscì a esser sostanzialmente mai
conquistata dai longobardi (i quali del resto d’Italia invece ne occuperanno
quasi l’intero territorio), ma addirittura liberò da essi altre città. Nel 711,
ad esempio, su richiesta del papa, Napoli viene in aiuto alla città di Cuma
riuscendo a liberarla dai longobardi che inaspettatamente l’avevano conquistata.
Successivamente, nel 763, il duca di Napoli Stefano II si ribella apertamente
all’autorità centrale di Bisanzio (riconoscendo il pontefice di Roma) rendendo
in questo modo il Ducato napoletano, di fatto, pienamente indipendente. Napoli
diviene così una vera e propria città-stato (con tanto di territorio
circostante, corrispondente orientativamente all’area dell’attuale provincia
metropolitana), anticipando di circa 430 anni l’esperienza dei primi comuni in
Italia centrosettentrionale, di circa 350 anni quella delle Repubbliche Marinare
di Pisa, Ancona e Ragusa (l’attuale Dubrovnik), di più di 300 anni quella di
Genova e di 200 anni quella delle Repubbliche Marinare di Amalfi e Gaeta (molto
vicine a Napoli, con, inizialmente, Amalfi inclusa in essa ma poi distaccatasi
nell’839). In molte occasioni Napoli riesce a contrastare e a respingere anche
le tentate invasioni da parte dei franchi e dei saraceni, affrancando o
sgominando dalla minaccia finanche di questi ultimi varie e ulteriori città,
inclusa la stessa Roma. Infatti, nell’849, con Napoli alla guida la flotta della
Lega Campana (formata da Napoli, Amalfi, Gaeta e Sorrento, fu, dal tempo dei
romani, la prima Lega di città italiane della storia sorta per opporsi a potenza
esterna), venendo in soccorso al pontefice a Ostia, respinge l’attacco saraceno
alla città eterna in quello che oggi viene considerato dagli storici il maggior
successo navale ottenuto da una flotta cristiana nei confronti di una musulmana
(celebrato da un affresco di Raffaello presente in Vaticano;
nell’illustrazione), prima di venire combattuta la battaglia di Lepanto (che
avrà luogo solo nel 1571). Ciononostante, l’ostilità tra islam e cristianesimo
non impedì che nel Sud della Penisola vi fossero avvicinamenti, intese e
finanche grande assonanza tra le due realtà, all’insegna del perseguimento dei
comuni interessi commerciali e per fini politico-strategici. E di qui nel tempo
essenzialmente si generò anche un’amicizia tra il mondo arabo, Napoli e un po’
tutto il Meridione. Prima di cadere in mano normanna (tra gli ultimi territori a
cadervi, nel 1137), Napoli oppose una strenua resistenza, addirittura,
conquistando l’ammirazione dei nemici; persino successivamente alla resa del
duca e alla sua morte, i napoletani insorsero contro il nuovo sovrano normanno
costituendo una repubblica aristocratica fino alla definitiva capitolazione che
avvenne nel 1139 a Benevento. E sebbene la conquista e la costituzione da parte
normanna del nuovo Regno di Sicilia fecero tutt’altro che penalizzare Napoli e
il Sud, diverso tempo dopo (oltre un secolo), in particolare sotto la reggenza
sveva, alcune realtà del Sud, come Caserta, Acerra, Capua, Napoli, ancora
bramanti autonomia, diedero vita a nuove insurrezioni, per poi ritornare (con da
ultima l’indomita Napoli) sotto il controllo di Corrado IV nel 1253. Investite
di forza economia e politica, per la posizione in sé strategica del Sud Italia
(collocato nel cuore del Mediterraneo), molte altre furono le realtà dell’Italia
meridionale che poterono permettersi di rivendicare autonomia già a partire
dall’Alto Medioevo (molto prima quindi di quelle del Centro-Nord). A maggior
ragione quelle della Sicilia che peraltro, più tardi, si distaccherà da Napoli,
in seguito alla rivolta dei Vespri Siciliani del 1282. Come non menzionare,
inoltre, in tale rapido excursus, la rivolta popolare sanfedista del Regno di
Napoli: la più energica e poderosa d’Italia, contro i francesi di Napoleone; e
quelle seguitate alla seconda occupazione francese (liquidate poi come fenomeno
di brigantaggio). Come pure la strenua difesa della città di Napoli opposta
dalla popolazione per impedire la prima occupazione francese. Riguardo a essa,
l’avversario, il generale francese Championnet, nella sua relazione per Parigi,
scriverà: “Mai combattimento fu più tenace: mai quadro più spaventoso. I
Lazzaroni, questi uomini meravigliosi [...] sono degli eroi rinchiusi in Napoli.
Ci si batte in tutte le vie; si contende il terreno palmo a palmo. I Lazzaroni
sono comandati da capi intrepidi. Il Forte S. Elmo li fulmina; la terribile
baionetta li atterra; essi ripiegano in ordine, ritornano alla carica, avanzano
con audacia, guadagnano spesso del terreno.” Il capo di stato maggiore francese,
il generale Bonnamy, al termine del suo rapporto invece scriverà: “L’azione dei
Lazzari farà epoca nella Storia!” Tantissimi sono gli esempi, come quello
eclatante dell’insorgenza antipiemontese (impropriamente definito “brigantaggio
postunitario”), divampata per la riduzione del Sud nuovamente a colonia, così
come era stato ridotto ai tempi di Masaniello. La rivolta di Masaniello scoppiò
nel 1647 e Napoli era colonia ormai da 146 anni. La liberazione tuttavia fu
effimera. Anzi, finì nel vuoto. Come forse “nel vuoto” è in qualche modo finita
un’altra liberazione: quella delle 4 giornate di Napoli del settembre 1943,
addirittura, prima insurrezione popolare di una grande città europea contro
l’occupante nazista. La Napoli e il Sud di Masaniello dovranno aspettare la fine
dell’Impero Spagnolo sul Vecchio Continente e dunque l’arrivo di Carlo di
Borbone che concretizzerà nuovamente l’indipendenza per il Sud (nel 1738). La
Napoli e l’attuale Sud, invece, stanno ancora aspettando.
·
La Grande Guerra.
Parigi 1919. Una vittoria mutilata.
Marco Valle il 15 dicembre 2020 su Il Giornale. La discussa e discutibile visita
del presidente Mattarella lo scorso luglio a Trieste culminata con lo strambo
omaggio ai quattro terroristi slavi del Tigr — fucilati nel 1930 dopo una scia
di sanguinosi attentati contro obiettivi civili italiani — e le commemorazioni
più o meno felici dell’impresa dannunziana di Fiume hanno fugacemente riportato
l’attenzione sulle intricate vicende del confine orientale d’Italia. Come al
solito i media ci hanno afflitto con narrazioni superficiali quando non
fuorvianti, riducendo la questione adriatica in schematismi talvolta nostalgici
e retorici o, troppo spesso, incredibilmente auto colpevolizzanti. Risultato: la
tragedia novecentesca delle terre istriane e dalmate rimane il terreno di
scontro per opposte tifoserie. Uno sterile gioco tra struggimenti per la piccola
patria perduta e insopportabili negazionismi. Fortunatamente la ricerca storica,
seppur faticosamente, prosegue con lavori innovativi e nuove chiavi
interpretative che permettono di comprendere lo “zeitgeist” e cogliere la somma
delle formidabili implicazioni politiche ed economiche che determinarono (e
ancor oggi determinano) confini e memorie. Di assoluto rilievo è il nuovo libro
di Paolo Soave “Una vittoria mutilata?” (Rubettino pp.157, euro 14,00) che
analizza uno dei nodi centrali quanto scomodi della nostra vicenda unitaria,
ovvero la contradditoria (e non pagante) partecipazione nel 1919 dell’Italia
alla Conferenza di Versailles, esiziale redde rationem fissato dalle potenze
euro-atlantiche ai nemici sconfitti e brusco rappel à l’ordre per agli alleati
minori: Italia, Belgio, Serbia, Grecia, Romania, Giappone, Portogallo. In guerra
presenze necessarie e, talvolta, indispensabili, in pace fastidiosi coriandoli.
Da premiare (Belgio e Giappone), usare (Serbia e Grecia) o marginalizzare. Fu il
caso dell’Italia. Soave, brillante docente di Storia delle Relazioni
Internazionali, affronta il problema italiano con minuzia archivistica,
larghezza di visione e (dato non scontato per un accademico…) scrittura fluida,
individuando con precisione le perduranti opacità nel rapporto (sempre
disuguale) tra Roma e le capitali occidentali. Il punto di partenza è il
Trattato di Londra del 1915, la travagliata decisione della rottura della
“Triplice” e l’adesione all’”Intesa” su un accordo segreto che assicurava al
regno sabaudo non solo l’arco Trento-Trieste ma anche e soprattutto il controllo
dell’Adriatico, un protettorato sull’Albania, il riconoscimento del possesso del
Dodecaneso e ampliamenti in Asia minore, diritti sul Mar Rosso, più vaghe
promesse per l’amministrazione del Canale di Suez e sull’Africa tedesca. Sulla
carta un magnifico bottino per la piccola Italia — “grande potenza solo a titolo
di cortesia” come ricordava Giovanni Volpe — ma anche un grande azzardo.
Salandra, Sonnino e Vittorio Emanuele (protagonista non secondario) non ebbero
troppi dubbi e imposero ad un Paese ancora largamente neutralista l’entrata in
guerra. Come nota l’autore uno spregiudicato “giro di valzer” in cui
s’intrecciava la tradizionale diplomazia “anfibia” sabauda con la ripresa «della
fase espansiva della politica estera unitaria avviata nel 1911 da Giolitti con
la conquista della “quarta sponda”. Impegnando le armi si sarebbe espresso il
tentativo dell’Italia liberale di costruire una patria comune e una sintesi di
nazione, libertà e modernità». Poi il 24 maggio. Il Carso, Gorizia, le Alpi,
Caporetto, il Grappa e il Piave e, infine, Vittorio Veneto. Seicentottantamila
morti, un milione e più di mutilati su 5.240.000 mobilitati, il 13,78 della
popolazione. Un conflitto lungo, sanguinoso che mise a durissima prova l’intero
Paese, suscitando energie impreviste all’interno — un inedito patriottismo
diffuso, i “ragazzi del ‘99” e l’arditismo — e fortissime diffidenze
all’esterno. Puntualmente i franco-britannici sottostimarono lo sforzo militare
ed economico del regno e il fronte italiano venne pervicacemente ignorato dalla
grande stampa alleata. Con un’unica eccezione Rudyard Kipling. Nel 1917 l’autore
del “Libro della Giungla”, premio Nobel per la Letteratura, raggiunse agli
alpini sulle vette delle Alpi Giulie e Carniche e si appassionò ai soldati di
montagna diventandone uno dei cantori più originali con un libro-testimonianza
“La guerra nelle montagne”. Una singolarità. Ancora oggi per la copiosa
storiografia anglo-sassone sulla Grande Guerra il teatro italiano rimane un
fatto secondario e l’impegno militare quasi risibile. Lo confermano, una volta
di più, le righe dedicate Margaret MacMillian nel suo poderoso volume “Parigi
1919”, dedicato appunto a Versailles. Per l’ex rettrice del Trinity College «i
soldati italiani, mal guidati e peggio equipaggiati, erano stati massacrati nel
corso delle battaglie svoltesi sulle Alpi, finché l’esercito era crollato a
Caporetto nel 1917. Nel 1918, di fronte a oltre mezzo milioni di morti e un
numero ancora maggiore di feriti gravi, la domanda che cominciava a circolare
era: a che scopo?». Per la MacMillian e i suoi dotti colleghi la resistenza
accanita sul Piave e il Grappa, la “guerra bianca” sull’Adamello e dintorni, le
battaglie del Solstizio, il Col Moschin, le imprese di Rizzo, l’armistizio di
Villa Giusti nulla contano. Nulla pesano. Una visione daltonica che, come ci
avverte Soave, arriva da lontano, dall’incessante lavorio delle cancellerie
durante il proseguirsi del conflitto. Mentre le “tempeste d’acciaio”
massacravano un’intera generazione, felpati diplomatici, astuti capitalisti e
callidi ministri preparavano il dopoguerra, il nuovo ordine post bellico. Un
gioco sottile quanto micidiale che non prevedeva le rivendicazioni italiane.
Sceso il silenzio sui campi di battaglia a Versailles, riprendendo il colonello
T. E. Lawrence, «gli uomini vecchi decisero la loro pace». Purtroppo a
rappresentare a Parigi l’Italia vittoriosa di Diaz e di D’Annunzio arrivarono
uomini culturalmente ancor più vecchi e, soprattutto, decisamente più inadeguati
dei loro agguerriti colleghi: il francese Clemenceau, il britannico Lloyd
George, lo statunitense Wilson. Il peggiore. Una volta seduti sulle comode
poltrone della “galleria degli specchi”, lustro della reggia di Luigi XIV,
Orlando e Sonnino si resero presto conto di contare poco o niente. Gli alleati
accusarono l’Italia d’egoismo, sminuirono il nostro apporto alla vittoria, si
dimenticarono con facilità estrema dei patti londinesi, rintuzzarono ogni
appetito coloniale e — con il sostegno dell’italofobico Wilson — cercarono di
bloccare ogni ambizione italiana sull’Adriatico e nei Balcani. Fiume compresa.
La nuova Jugoslavia monarchica divenne il contraltare, l’adeguato antemurale ai
progetti di Roma. Per i “grandi” lo Stivale doveva rassegnarsi ad un ruolo da
junior partner, rinunciare ad ogni ipotesi d’autosufficienza economica e a
miraggi d’autonomia politica e accettare una sorta di sovranità limitata. I
delegati — già scossi dalla ventura dannunziana a Fiume, preoccupati dai
conflitti sociali in atto e angosciati dai tanti debiti — non furono all’altezza
della situazione e inanellarono una serie di errori che indebolirono
ulteriormente la già debole posizione dell’Italia. Alla fine, come stigmatizza
l’autore, la conferenza si ridusse ad un problema di rapporti di forza tra
ineguali, un confronto impari che un personale politico ormai logorato non
poteva reggere. Salandra e Sonnino strillarono, minacciarono, partirono e poi
tornarono e, infine, firmarono. In patria il mito della “vittoria mutilata”
divenne facilmente argomento per le opposizioni nazionaliste — D’Annunzio si
scagliò contro “i divoratori di carne umana” — e alimentò il nascente fascismo
che nel ventennio alternò in politica estera revisionismo e anti revisionismo. I
risultati sono noti e ampiamente indagati. Come avverte Paolo Soave, a distanza
di un secolo il convegno di Versailles rimane un paradigma per tutti coloro —
invero pochi — che si preoccupano e si interrogano sul ruolo internazionale
dell’Italia nel terzo millennio. Evaporate le velleità imperiali, rimangono
sempre irrisolti i rapporti con gli alleati (veri o presunti) e il significato
della nostra collocazione nell’Adriatico, nel Mediterraneo (più o meno
allargato), nei Balcani, in Africa. Oggi come nel 1919.
La Grande Guerra italiana narrata da Gioacchino Volpe.
Marco Valle il il 17 gennaio 2020 su Il Giornale. Soffiano
alle nostre porte gelidi venti di guerra e, una volta di più, la classe politica
nostrana si rannicchia aspettando e sperando che la bufera passi in fretta.
Intanto, al di fuori dei palazzi del potere, le contrapposte tifoserie si
accendono, esasperando e volgarizzando ogni dibattito, ogni confronto, ogni
ragionamento. Il nostro peso sugli eventi mondiali è nullo ma quasi nessuno
sembra preoccuparsene. È il destino di un Paese a sovranità limitata che ha
scelto un’eterna vacanza della Storia. Amen. Eppure vi fu un tempo in cui le
élites misuravano con pragmatismo gli scenari globali e valutavano con
ponderazione e realismo quali e dove fossero gli interessi nazionali. Fu il
caso, come ci ricorda Gioacchino Volpe ne “Il popolo italiano nel primo anno
della Grande Guerra” (Piccola Biblioteca della Nuova Rivista Storica. Ppgg.303,
euro 10,00) dell’intervento del 1915. Si tratta di un prezioso inedito del
massimo storico italiano del Novecento, ritrovato e pubblicato da Eugenio Di
Rienzo — autore di una poderosa introduzione — e Fabrizio Rudi. Un testo
importante, per nulla agiografico e tanto meno retorico che ci riporta al clima
infuocato della prima fase del conflitto con riflessi evidenti — non a caso,
come nota Di Rienzo, fu redatto tra il 1942-43 — sull’ormai imminente catastrofe
bellica. Volpe, fedele alle lezioni di Tucidide e Weber, ben sapeva che solo la
coniugazione di coraggio e prudenza e dunque il giusto dosaggio di offensiva e
difensiva sono gli ingredienti dell’agire strategico. Una consapevolezza e una
lungimiranza che l’autore riconosce alla filiera liberal-risorgimentale stretta
attorno al governo Salandra e a lungo indecisa se restare neutrale, affiancarsi
agli austro-turco-tedeschi o combattere con l’Intesa. Al netto dell’irruenza
degli interventisti e delle narrazioni ideologiche scioviniste e germanofobiche,
Volpe offre infatti una lettura degli eventi basata sulla real politik:
l’opzione per Londra e Parigi fu il risultato di un freddo, razionale calcolo
dei rapporti di forza militari ed economici e le prospettive— allettanti e poi,
come noto, disattese dopo la vittoria— di vantaggi territoriali. Il «sacro
egoismo» teorizzato Salandra. Per l’Italia, «grande potenza solo a titolo di
cortesia», una scelta obbligata da affrontare con «un esercito povero di quadri
e con difficoltà a reclutarli, in una Nazione dove mancava vecchia nobiltà di
tradizione guerriera e solida borghesia industriale, abituata a comandare e
inquadrare gli uomini, la milizia territoriale esisteva solo sulla carta, e la
grande massa dei militarmente abili non era istruita». Accanto alle lacune
castrensi vi era poi un tessuto industriale modesto, apparentemente inadatto ad
affrontare un’economia di guerra, la cronica mancanza di materie prime e un
sistema infrastrutturale inadeguato. Per il regno sabaudo si prospettava — come
fu per il Portogallo e la Grecia — un ruolo marginale, subalterno agli alleati,
nella speranza di una guerra possibilmente brevissima. Ma incredibilmente,
sorprendendo alleati e nemici, la piccola Italia di Salandra e Cadorna (figura
ampiamente rivalutata dall’autore), di Sonnino e del socialista Bissolati
(«l’uomo nuovo dell’interventismo») seppe mobilitarsi e trasformarsi. Una classe
dirigente certamente imperfetta, anzi litigiosa e a volte ottusa, ma capace di
reggere e guidare dignitosamente l’immane sforzo bellico. Il merito principale,
come Volpe racconta con passione, fu però dell’armata al fronte — «il popolo in
grigio-verde» — a sua volta sorretta dall’intera società civile. Il popolo
italiano, per una volta coeso, seppe affrontare le inedite difficoltà con
dedizione ed entusiasmo, mettendo all’angolo le politiche disfattiste della
teocrazia romana e ignorando il «mormorio parlamentare». Tra le pagine più
interessanti del lavoro segnaliamo la parte in cui lo storico abruzzese analizza
lucidamente la diffidente distanza tra l’Intesa e il Regno. Volpe ritrova negli
esordi del conflitto i prodomi della «vittoria mutilata» fissando i continui
punti di disaccordo tra l’Italia e gli alleati, invero poco amici. Non a caso
la grande stampa e l’opinione pubblica occidentale si disinteressarono del
teatro italiano, ignorando la grama sorte delle popolazioni italofone in
territorio austro-ungarico (pari se non superiore al molto propagandato
“martirio” del Belgio) e il duro impegno del nostro esercito. Ricordiamo a
proposito che solo nel 1917 Rudyard Kipling — il cantore di Britannia e Nobel
per la letteratura — visiterà il fronte italiano appassionandosi talmente alle
imprese degli alpini da scrivere “La guerra nelle montagne”, rieditato qualche
anno fa da Mursia. Tornando alla diagnosi volpiana — e agli approfondimenti di
Di Rienzo — già nel primo anno di guerra erano evidenti la caducità del Patto di
Londra e le profonde divergenze sui futuri assetti postbellici riguardo
l’Adriatico, i Balcani, i possedimenti coloniali e le aree d’influenza. Nei
disegni imperiali dei franco-inglesi vi era poco, pochissimo spazio per le
disturbanti aspirazioni italiane e presto le solenni assicurazioni si ridussero
ad un chiffon de papier. Una somma di nodi irrisolti che s’ingroviglieranno
definitivamente nel 1919 alla conferenza di Versailles. Aprendo la strada
all’avventura fiumana e alla successiva esperienza mussoliniana che Volpe,
nazionalista liberale, affiancherà in modo critico per tutta la sua durata.
·
La Seconda Guerra.
L'impresa divenuta leggenda: così i Mas colpirono Alessandria.
La notte del 18 dicembre 1941, sei italiani su tre
siluri entrarono nella leggenda. E colpirono al cuore la flotta inglese ad
Alessandria d'Egitto. Lorenzo Vita, Venerdì 18/12/2020 su Il Giornale. La notte
del 18 dicembre 1941, Alessandria d'Egitto dormiva placida insieme alle navi
dell'Impero britannico ormeggiate nel suo porto. Il mare era calmo, il vento
completamente scomparso. La Luna illuminava con la sua tiepida luce le acque del
Mediterraneo, mentre le onde si infrangevano sulle pietre e il cemento del porto
di più importante dell'Egitto. Una notte perfetta, che presto si sarebbe
trasformata nell'incubo della marina britannica e in uno dei maggiori trionfi
per la Regia Marina. Tutto ebbe inizio la notte del 3 dicembre a La Spezia. Dopo
settimane di addestramento durissimo con l'obiettivo di lavare l'onta
dell'attacco a Taranto di un anno prima, il sommergibile Scirè, comandato dal
tenente di vascello Junio Valerio Borghese, prese il largo. L'ordine prevedeva
di simulare un'esercitazione per eludere le reti di spionaggio Alleate nel
Mediterraneo. Una questione di importanza fondamentale, dal momento che le
capacità di intelligence e le differenze tra i vari schieramenti potevano
significare la stessa vittoria in guerra. Mentre la notte calava sulle coste
liguri, Borghese diede l'ordine di imbarcare, senza farsi vedere da alcun occhio
indiscreto, tre "maiali", i siluri a lenta corsa che sarebbero diventati il
marchio di fabbrica della Decima Mas. I tre siluri vennero posizionati
all'interno dei cilindri a tenuta stagna posizionati nella pancia del
sottomarino. Una volta presi i maiali, l'ordine era quello di recarsi a Porto
Lago, nell'isola di Lero, dove lo Scirè avrebbe imbarcato i sei assaltatori
pronti a unirsi alla missione. Un viaggio non privo di pericoli: navi e aerei da
ricognizione britannici solcavano costantemente cieli e mari sulla rotta del
sommergibile italiano, rendendo particolarmente complesso il passare
inosservato. Un rischio che l'equipaggio decise non soltanto di accettare, ma
anche di prendere di petto, addirittura sfidando un aereo inglese, che venne
"salutato" dal sottomarino italiano rilanciando un codice che i servizi
segreti erano riusciti a intercettare nelle settimane precedenti l'operazione.
Sulla piccola isola del Dodecaneso italiano, Borghese e gli uomini della Mas
attendevano il loro destino e le notizie che arrivavano da Alessandria. Le
ricognizioni aeree sul porto egiziano avevano dato alcune indicazioni, ma
l'ordine tardava ad arrivare. Troppi i dubbi per una missione così complessa
come quella che si stava per compiere. Dopo giorni di attesa nella piccola isola
immersa nell'Egeo, l'quipaggio dello Scirè e gli assaltatori che erano giunti
nell'isola passano per Rodi, ricevettero l'ordine di partenza. Il sommergibile
di Borghese avrebbe preso il mare alle ore 7:00 del 14 dicembre: iniziava la
penultima fase dell'operazione G.A.3. Quella che sarebbe diventata l'impresa di
Alessandria. Il viaggio non fu affatto semplice. Il Mediterraneo orientale, in
questo periodo dell'anno, rischia di essere particolarmente tormentato e quel
tratto di mare non è protetto da alcuna barriera naturale. Da Lero a Alessandria
la rotta era libera da ogni tipo di "scudo" e le condizioni meteorologiche
furono considerate anche un funesto presagio dovuto alla scelta del 17 come data
per completare la missione. Quella sera, l'ultimo aereo da ricognizione aveva
confermato la presenza di due navi da guerra inglesi nel porto di Alessandria.
Ed era giunto l'ordine supremo: "DA SUPERMARINA: accertata presenza in porto due
navi da battaglia. Probabile portaerei: ATTACCATE". L'equipaggio di Borghese non
aspettava altro. Il 18 dicembre il mare si era improvvisamente calmato e il Sole
calava coprendo di oscurità le onde del Mediterraneo. Lo Scirè si caricò di
energia e di ossigeno e partì alla volta del porto egiziano. Scopo della
missione era quello di evitare mine e reti di sroveglianza britannici ed
emergere a 1.3 miglia nautiche da Alessandria, mantenendo una profondità al di
sotto dei 60 metri. Alle ore 20.47, lo Scirè iniziò ad affiorare e a rilsciare
i "maiali". Una volta abbandonati i siluri a lenta corsa, il sommergibile aveva
l'ordine di percorrere la rotta dell'andata per tornare a La Spezia. I sei
uomini della Decima Mas ora si trovavano soli al cospetto della Royal Navy. Gli
uomini della Regia Marina cominciarono ad avvicinarsi al porto di Alessandria.
La squadra si divise in questo modo: il tenente di vascello Luigi Durand de la
Penne con il capo palombaro Emilio Bianchi, il capitano del Genio Navale Antonio
Marceglia era in coppia con il sottocapo palombaro Spartaco Schergat, mentre il
capitano delle Armi Navali Vincenzo Martellotta era insieme al capo palombaro
Mario Marino. Sei nomi che dopo quella notte diventarono immortali. La svolta
arrivò quella stessa notte grazie a un clamoroso colpo di fortuna. I sei
assaltatori avevano un unico problema: quello di superare la rete
di sbarramento. Un problema non insormontabile, certo, ma che avrebbe potuto
ostacolare anche in maniera definitiva la buona riuscita dell'operaizone Per
fortuna per loro, le cose quella sera erano destinate ad andare diversamente. La
Marina inglese, in attesa del rientro di alcuni cacciatorpediniere, avevano
aperto la rete per dare loro modo di rientrare alla base. Una breccia che gli
uomini della Decima sfruttarono immediatamente, dando il via all'ultima fase
delle operazioni: avvicinarsi alle unità nemiche e affondarle. Durand de la
Penne e Emilio Bianchi avevano come bersaglio la Valiant. Alle 2 di notte del 19
dicembre, il maiale venne immerso per colpire lo scafo della nave britannica, ma
il siluro a lenta corsa iniziò a imbarcare acqua adagiandosi sul fondale. De la
Penne provò insieme a Bianchi a far ripartire le eliche, ma il secondo ebbe un
malore per un guasto al respiratore, perdendo i sensi. Tuttavia, il tenente di
vascello non si diede per vinto: trascinò il siluro da solo, per 40 minuti, fino
a raggiungere lo scafo della Valiant e lì piazzò la sua carica esplosiva. Una
volta tornato in superficie, De la Penne si ritrovò su una boa insieme a
Bianchi, ma furono individuati dagli inglesi che prima li portarono a terra per
interrogarli, poi, visto il loro silenzio, vennero condotti a bordo della nave
in attesa che svelassero i loro piano. Mezz'ora prima dell'orario
dell'esplosione, De la Penne chiese di parlare col comandante della Valiant per
dirgli di far abbandonare la nave e salvare l'equipaggio. Ma alle 6:15 la mina
esplose squarciando lo scafo della nave. Non troppo diversa fu la missione
dell'altro "maiale", il n. 222, con a bordo Vincenzo Martellotta e Mario Marino,
sul maiale nº 222. Il primo venne colto anch'esso da malore, costringendo il
siluro a navigare in superficie. Una scelta tanto coraggiosa quanto pericolosa,
dal momento che sarebbero stati più facilmente individuati dai nemici. I due
avevamo come obiettivo la petroliera Sagona. La scelta cadde su
quell'imbarcazione perché secondo gli ordini di Borghese, in assenza di
portaerei qualcuno avrebbe dovuto colpire il carico di petrolio di Alessandria.
Ma era una missione delicatissima, dal momento che far esplodere una petroliera
poteva avere conseguenze devastanti per la deflagrazione. I due riuscirono a
piazzare la carica esplosiva e una volta raggiunta terra furono catturati dalla
vigilanza del porto. Come per la Valiant, anche per la Sagona l'esplosione
avvenne verso l'alba, con un incendio così ampio da coinvolgere altre quattro
navi. L'ultimo maiale, il 223, aveva invece come obiettivo la Queen Elizabeth.
L'operazione di Antonio Marceglia e Spartaco Schergat fu da manuale: i due
marinai riuscirono ad agganciare la carica esplosiva alla nave britannica e a
raggiungere terra senza essere visti. Furono però catturati il giorno dopo per
un tragico errore del Servizio segreto militare: tra gli oggetti utili per la
fuga, i funzionari del Sim diedero alla Decima banconote che non avevano più
corso legale in Egitto, facendo così smascherare i due palombari. Ma
l'operazione era comunque andata a buon fine: alle 06.25 la carica esplose
devastando il locale caldaie. La Queen Elizabeth stava affondando. La
Mediterranean Fleet britannica aveva subito un colpo che avrebbe potuto essere
letale. Dopo l'impresa di Alessandria, gli inglesi sembravano aver perso
completamente il controllo del Mediterraneo e le parole di Winston Churchill ci
aiutano a capire, ancora oggi, il valore della missione: "Sei italiani
equipaggiati con materiali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l'equilibrio
militare in Mediterraneo a vantaggio dell'Asse". La Storia poi avrebbe dato
ragione a Londra: ma la gloria di quell'azione non è stata mai dimenticata nel
Regno Unito, tanto che lo stesso Times, quando morì Marceglia, dedicò al
valoroso nemico una pagina di necrologio. L'onore delle armi per un uomo che
insieme a suoi cinque compagni di viaggio segnò per sempre la Storia della
Marina e dell'Italia nella Seconda guerra mondiale.
Tragedia e eroismo dell'Armir: l'armata "sparita" nella
steppa. Il 16 dicembre 1942 iniziava la ritirata di
Russia. La tragedia dell'Armir ebbe nella battaglia dei corpi alpini contro
soverchianti forze sovietiche il suo apice. Andrea Muratore, Mercoledì
16/12/2020 su Il Giornale. Il 16 dicembre 1942, sul fronte russo che vedeva
opposta l'Unione Sovietica alle Potenze dell'Asse che l'avevano invasa un anno e
mezzo prima, l'Armata Rossa sferrò una poderosa offensiva ("Operazione Piccolo
Saturno") nel contesto del teatro del Don, di sostegno alle truppe impegnate
nella battaglia che da diverse settimane infuriava nella città di
Stalingrado, tenuta metro per metro dai russi durante l'assedio della Sesta
Armata tedesca trovatasi poi accerchiata dopo l'Operazione Urano di novembre.
L'8° Armata Italiana, nome in codice Armir (Armata italiana in Russia) fu
investita da una potenza di fuoco soverchiante da parte dei sovietici e dovette
cedere terreno. Iniziò dunque per le forze italiane, in larga parte truppe
alpine scarsamente equipaggiate per combattere nel contesto di un'ampia fascia
di territorio pianeggiante poco presidiata, una tragica ritirata, una vera e
propria Anabasi contemporanea in cui intere unità scomparvero nella battaglia,
nelle nevi e nel gelo della steppa, centinaia di migliaia di uomini morirono o
furono fatti prigionieri dai sovietici e per l'Italia apparve palese il dramma
di un'avventura bellica condotta senza raziocinio strategico dal governo
di Benito Mussolini alla semplice rincorsa del carro tedesco.
Dal Csir all'Armir. L'Armir era l'erede del Corpo di spedizione
italiano in Russia, attivo con una dotazione di 65mila unità tra il 1941 e il
1942 con la dotazione di due divisioni di fanteria (9° e 52esima) e con la Terza
Divisione Celere del Regio Esercito. Impegnato in azioni di attraversamento del
fiume Bug e di battaglie difensive nell'inverno nell'attuale Ucraina, il Csir fu
fortemente voluto da Mussolini che, nonostante la sempre precaria situazione del
fronte africano, ove erano i tedeschi a sostenere attivamente l'alleato
italiano, voleva cullare quella che Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri e
genero del Duce, definì "l'eterea illusione" di poter condurre la guerra
parallelamente alla Germania di Adolf Hitler con l'autonomia strategica persa
dopo la rovinosa rotta in Grecia e Libia tra l'autunno del 1940 e la primavera
del 1941. I generali tedeschi avevano a lungo ritenuto sovrabbondanti o
addirittura d'ostacolo le truppe italiane, ritenute una palla al piede del
corposo apparato militare della Wehrmacht, ma dopo che l'Operazione Barbarossa
fallì l'obiettivo strategico di mettere al tappeto l'Urss e i soldati di Stalin
furono in grado di contrattaccare scacciando i tedeschi da Mosca la previsione
di nuove offensive primaverili ed estive in un fronte sempre più ampio portò
l'Oberkommando e il governo di Berlino a cambiare idea e a chiedere forti
incrementi negli effettivi degli alleati dell'Asse (Italia, Ungheria, Romania)
stanziati sul fronte orientale. La minorità politica e la dipendenza strategica
di Roma dall'alleato tedesco impedì ai comandi italiani di controbattere facendo
presente le necessità del teatro nordafricano. Tra il maggio e il luglio del
1942 fu dunque allestita un'unità operativa assai più ampia del Csir, che in
esso fu ricondotto come componente, l'8° Armata che sarebbe divenuta nota come
Armir. Ne facevano parte il Csir assieme al II Corpo d'armata con le divisioni
di fanteria "Cosseria", "Ravenna" e "Sforzesca" e all Comando del Corpo d'armata
Alpino con le divisioni alpine "Cuneense", "Julia" e "Tridentina". Thomas
Schlemmer nel saggio Invasori, non vittime - La campagna italiana di Russia
1941-1943 ricorda come l'Armir assegnata in comando al generale Italo
Gariboldi fu dotata del miglior armamento a disposizione a quell'epoca per il
Regio Esercito. Oltre 10mila, alcune fonti affermano anche 12mila, automezzi,
dispositivi di montagna di ultima fattura per gli alpini, circa 230mila
effettivi, artiglierie di alta qualità e reparti d'élite come il Battaglione
Alpini sciatori "Monte Cervino" componevano l'unità. Il cui primo, tragico
problema fu la disposizione strategica. L'Armir, che dopo una lunga preparazione
e uno sforzo senza precedenti per l'industria bellica nazionale aveva preso la
via dell'Est, si radunò a Charkov per assumere operatività il 9 maggio 1942. In
quei giorni la Wehrmact stava avanzando a Sud, verso i pozzi petroliferi dal
Caucaso, ma l'ampliamento delle linee del fronte rendeva difficile per i
tedeschi presidiare le retrovie del fronte e i fianchi. L'Armir, assegnata
al Gruppo d'Armate B della Wehrmacht, protesse i fianchi alla Sesta Armata che,
dal 23 agosto, rimase impantanata nel tentativo di espugnare la città di
Stalingrado.
Dalla difesa al collasso. L'intera Armir fu dunque costretta a
coprire un fronte di oltre 250 km alla sinistra dello schieramento tedesco in
avanzata su Stalingrado. In più occasioni gli italiani dovettero rintuzzare i
tentativi sovietici di controffensiva. Particolarmente infelice fu la scelta di
schierare in piena pianura i reparti alpini, che bene avrebbero potuto
comportarsi nella corsa al Caucaso. Dal 20 agosto all'1 settembre l'Armir
combatté la Prima battaglia difensiva del Don, contrattaccando a un'azione di
alleggerimento sovietica; Stalin aveva dato ordine di non dare tregua alle
truppe dei Paesi alleati alla Germania, ritenute più vulnerabili, e con questo
primo attacco l'Armata Rossa poté saggiare le difese di armate che, soprattutto
per la carenza di mezzi corazzati, non potevano certamente competere con le
Panzerdivisionen della Wehrmacht. Nonostante l'entrata in linea della 3ª Armata
rumena sul fianco destro dell'Armir il fronte italiano nelle settimane
successive rimase molto esteso e poco presidiato e venne quindi rafforzato, su
ordine diretto di Hitler, con una serie di reparti tedeschi inquadrati assieme
alla divisione italiana "Vicenza" al comando di Gariboldi. Stalingrado, divenuta
per i tedeschi un simbolo per il suo stesso nome ancor più che per la sua
(rilevante) valenza strategica di snodo sul Volga, assorbiva nel frattempo
risorse umane, riserve e mezzi militari. La steppa alle spalle dell'Armir andò
gradualmente svuotandosi mano a mano che nel buco nero di Stalingrado la Sesta
Armata del generale von Paulus chiamava a sè il meglio delle riserve tedesche,
trasformando il fronte delle potenze dell'Asse in un'enorme patina di carta
velina, senza nessuna consistenza alle spalle. Avendo fatto il passo più lungo
della gamba, a novembre i tedeschi furono travolti dall'Operazione Urano,
l'offensiva sovietica nell'area di Stalingrado che, accerchiandola, trasformò in
assediata l'armata che stava tentando la conquista della città. Nella battaglia
che aprì al capovolgimento di fronte della guerra si decise il destino
dell'Armir: la scelta sconsiderata del Gruppo di Armate B del
generale Maximilian von Weichs, che aveva impostato l'intero assetto del fronte
sul sostegno all'offensiva di Stalingrado, si rivelò in tutta la sua
drammaticità.
La ritirata di Russia. Per le truppe italiane era solo questione
di tempo prima di esser investite a loro volta. A inizio dicembre i sovietici
consolidarono una testa di ponte oltre il Don, per poi dare il via, il 16
dicembre all'operazione "Piccolo Saturno". Fin dall'11 dicembre le truppe
guidate dai generali Voronov, Vatutin e Golikov avevano iniziato una serie di
azioni preliminari condotte da reparti di avanguardia per riconoscere le
posizioni difensive nemiche; questo privò i russi dell'elemento sorpresa, e
assieme a una serie di condizioni meteo sfavorevoli per l'offensiva aerea e
d'artiglieria (nebbia e gelo) portò l'attacco sovietico a risolversi in una dura
offensiva frontale cui gli italiani tennero testa finché non furono
letteralmente sommersi dalla preponderanza dei numeri sovietici e dalla carenza
logistica, materiale e organizzativa. A partire dai giorni successivi
l'offensiva sovietica, partita dal settore del 2º Corpo d'Armata del generale
Zanghieri (divisioni "Cosseria" e "Ravenna", 318º reggimento tedesco), si
avvalse anche di interventi in forza delle riserve corazzate guidate dai nuovi
carri T-34, contro cui la carenza di munizioni specifiche e la scarsa attitudine
alla lotta contro i mezzi corazzati delle truppe del Regio Esercito poterono ben
poco. Le divisioni di fanteria spesso affrontavano avanzate nemiche con forze
soverchianti, ma sulla distanza ben poco poterono per frenare i sovietici. Il
freddo estremo (si arrivava a -30°C) aveva messo fuori uso buona parte dei mezzi
motorizzati italiani, il tracollo di ungheresi e rumeni nelle aree circostanti
apriva al serio rischio di aggiramento o, addirittura, accerchiamento, e per
l'Armir non vi fu altra scelta che l'avvio di una tragica ritirata. Gariboldi e
i tedeschi non avevano appuntato alcun piano strategico per gestirla
ordinatamente, né altresì sarebbe stato possibile sotto l'incalzante avanzata
sovietica. Scarse erano state anche le dotazioni di divise invernali e nulle le
possibilità di organizzare una logistica e il recupero dei depositi strategici
nei capisaldi dell'Armir date le circostanze. La ritirata divenne inevitabile,
ma l'inverno sovietico, il crollo del fronte e l'assenza di ordine nella
reazione tedesca di sostegno alle truppe italiane la trasformarono presto in
una rotta. L'Armir si frammentò in miriadi di colonne di militari intenti
a indietreggiare nella neve, facendosi spazio combattendo tra i reparti
sovietici che rappresentavano le puntate avanzate dell'offensiva. Dopo settimane
di marcia, i fanti italiani decimati raggiunsero infine le retrovie tedesche.
Poche settimane dopo, nel gennaio 1943, fu la volta delle truppe alpine, che
subirono una nuova offensiva sull'asse Ostrogožsk-Rossoš', condotta dalla 40ª
Armata del Fronte di Voronež e la 6ª e la 3ª Armata corazzata del Fronte
Sud-Occidentale, che prima travolsero la Seconda Armata ungherese e poi si
avventarono contro le penne nere. La Julia si immolò per consentire alle truppe
italiane e a residui drappelli tedeschi e ungheresi di rompere una situazione di
vero e proprio accerchiamento. Una serie di colonne formate da truppe alpine,
soldati dell'Asse e pochi, strategici cingolati anti-carro e cannoni da 88
millimetri si mossero per uscire dal giogo sovietico. Fu questa la parte più
drammatica di una vera e propria Anabasi nella steppa. I nomi sono oramai
entrati nella memoria collettiva: Postojalyi, Seljakino, Varvarovka,
Nikolajewka furono i teatri di altrettante disperate battaglie di sfondamento
delle sacche sovietiche da parte delle truppe alpine. Nelle nevi russe, nella
steppa infinita, a migliaia di chilometri da quelle riarse sabbie nordafricane
dove l'Italia aveva in gioco i suoi interessi vitali e a centinaia dalle vette
del Caucaso gli alpini guidati dai generali Umberto Ricagno, Luigi Reverberi e
Emilio Battisti, comandanti rispettivamente della "Julia", della "Tridentina" e
della "Cuneense", scrissero pagine di eroica resistenza e di fatua e vana gloria
militare.
Fatua, perchè dettata dallo spirito di sopravvivenza, dal timore
di una lunga prigionia negli abissi della Russia e della Siberia, nella
consapevolezza che anche l'Armir era un esercito invasore e come tale sarebbe
stato trattato, nonostante i continui casi di ospitalità agli italiani in rotta
da parte della popolazione civile. Vana, perchè non necessaria ai fini
strategici del conflitto, figlia della sconsiderata strategia tedesca e delle
sue conseguenze di lungo termine, ma anche dell'irrefrenabile volontà del Duce
di assecondare e blandire l'alleato tedesco. L'Armir si dissolse in un'ampia
serie di colonne, unità, drappelli, singoli battaglioni in cerca della salvezza
di fronte alla marea montante sovietica. Gli attacchi "mordi e fuggi" degli
alpini sciatori del Cervino, le battaglie tra uomini e macchina a colpi di
molotov, gli sfondamenti operati con la forza della disperazione furono i segni
della volontà di non abbandonare l'armata ai destini già scritti della disfatta
e della prigionia. Quello che si ritirava nella neve non era più un esercito, ma
una somma di combattenti in disperata ricerca della sopravvivenza. La colonna
della "Tridentina" ruppe la sacca a Nikolajewka il 26 gennaio 1943, mentre sorte
peggiore toccò alle divisioni "Cuneense", "Vicenza" e ai sopravvissuti della
"Julia", costretti alla resa dai sovietici. Non mancarono casi di cedimento del
cameratismo con gli alleati tedeschi, che più volte sottrassero i mezzi
funzionanti che potevano rappresentare una speranza di salvezza agli italiani o
peccarono di scarsa cooperazione in battaglia. A fine gennaio 1943 l'Armir non
esisteva più. Poche settimane dopo, con la resa italo-tedesca in Tunisia, si
chiudeva il fronte africano e si apriva la strada all'invasione della Sicilia,
che sarebbe scattata il 10 luglio. L'Anabasi in terra russa segnalò il
definitivo fallimento del progetto bellico di Mussolini, la sconsideratezza
della scelta di affidare in mani tedesche, per ragioni di puro prestigio e di
presenza nella "crociata contro il bolscevismo", le sorti di unità di punta del
Regio Esercito. L'Unione nazionale italiana reduci di Russia (UNIRR) sostiene
che i caduti e i dispersi furono in quel drammatico inverno circa 95.000, mentre
decine di migliaia di prigionieri morirono nelle marce verso i campi o in
detenzione. Giorgio Scotoni in L'Armata Rossa e la disfatta italiana
(1942-43) parla di circa 85mila morti e dispersi e poco meno di 30mila feriti e
congelati. Un bagno di sangue per i cui superstiti la vittoria fu, dopo la
rottura dell'accerchiamento, il definitivo rimpatrio. La tragedia dell'Armir,
tra le più ricordate nella storia militare italiana, ha generato una memoria
collettiva che vive ancora. Da quando l'illusione di potenza del regime fascista
perì congelato nella steppa russa, assieme a decine di migliaia di militari
mandati allo sbaraglio in una battaglia dove il loro ruolo strategico poté
essere minimo e in cui furono consegnati a un destino già scritto.
·
Carmine Crocco, il
Brigante Generale.
CARMINE CROCCO, IL BRIGANTE GENERALE.
Imgpress.it il 19 Marzo 2020 Culture. Domenico Bonvegna su
Ilsudonline.it il 5 maggio 2020. Chi è Carmine Crocco? Ce lo spiega il
professore Tommaso Pedio, in «Come divenni brigante», di Carmine Crocco, Lacaita
Editore (1964, Manduria Taranto). Nacque a Rionero in Volture, il 5 giugno 1830,
pastore, soprannominato “Donatelli”, si arruolo nell’esercito borbonico, disertò
nel 1852, costituì con Ninco Nanco una banda armata. Arrestato e condannato, ma
ben presto evase dal carcere e nel 1860 aderì al movimento insurrezionale
garibaldino, ben presto ritornò alla vita di fuorilegge, nel 1861, formando una
banda armata, di soldati sbandati, disertori e malcontenti. Il libro dopo
un’introduzione di Pedio, raccoglie l’autobiografia di Carmine Crocco. Nel 1903,
quando fu annunziata la pubblicazione della autobiografia, molti dei superstiti
di quei galantuomini che, direttamente o indirettamente, erano stati coinvolti
nei fatti svoltisi in Basilicata tra il 1860 ed il 1864, erano abbastanza
preoccupati. Temevano che il “sepoltovivo”, adesso poteva cominciare a fare i
nomi di quelli che lo avevano incoraggiato, favorito, sorretto, sovvenzionato.
Che cosa avrebbe scritto il generale brigante «nei confronti della classe
dirigente lucana i cui maggiori esponenti, pur schieratesi con il movimento
liberale, ad eccezione di pochi, sostanzialmente contribuito a favorire e ad
alimentare il brigantaggio». Il vecchio pastore semianalfabeta di Rionero in
Volture, che aveva terrorizzato un’intera regione portando ovunque terrore e la
desolazione dell’assassino crudele e vendicativo, ora «magnanimo e generoso, non
rivelò i nomi di coloro che, sin dall’ottobre del 1860, avevano promosso in
Basilicata la resistenza armata contro il nuovo regime […]». La lettura
dell’autobiografia di Crocco «non stanca, anzi appassiona, scrisse Basilide del
Zio, contiene pagine splendide, episodi sorprendenti, considerazioni sociali e
più di tutto ironia lenta, continua, caustica…pel caduto governo borbonico».
Tuttavia la ricostruzione dei fatti porta pochi contributi per una vera storia
del brigantaggio in Lucania, anche perché Crocco spesso mentisce in molti punti,
ed esagerando in altri. Sostanzialmente Crocco resta un brigante, anche se
comprese «l’enorme vantaggio che mi sarebbe venuto facendomi banditore d’una
lotta reazionaria – scrive nelle Memorie – Seppi in breve accaparrarmi tutti
coloro ai quali la rivoluzione era stata di danno, dai più sfegatati borbonici,
ai mellifui liberali, dagli impiegati, che avevano perduto il lauto stipendio,
ai preti e ai frati, resi furibondi dalla legge contro i possessi del clero».
Pedio sintetizza egregiamente il pensiero di Crocco, nonostante l’apparente
entusiasmo, il Crocco, sente di lottare per una causa perduta. «Promettevo a
tutti mari e monti, onore e gloria a bizzeffe; ai contadini facevo balenare la
certezza di guadagnare i feudi dei loro padroni, ai pastori la speranza di
impadronirsi degli armenti affidati alla loro custodia […]». Alla fine
sostanzialmente scrive Carmine Crocco, «a poco a poco io mi trovai quasi
involontariamente a capo dei moti reazionari e m’ingolfai in essi, sicuro di
ricavarne guadagno e gloria». In questa biografia Crocco, intende smentire
quella leggenda che ne hanno fatto come di un essere bestiale e feroce per il
quale era inconcepibile la pietà e il perdono. Non credo che ci sia riuscito.
L’autobiografia è composta di otto capitoli, nell’appendice si possono leggere
il Verbale di interrogatorio, reso da Crocco il 3 e 4 agosto 1872, preso
dall’Archivio di Stato di Potenza.
Il I° capitolo descrive la sua infanzia a Rionero, il suo forte
legame con la madre, disgraziatamente interrotto da quel tragico episodio del
cane che venne ferito mortalmente da una randellata. Poi l’intervento del
padrone del cane che infierì violentemente contro la povera donna che da quel
momento rimase menomata fino a diventare pazza. Da questo momento la vita di
Carmine cambia bruscamente, cresce in lui un odio forte nei confronti di tutti i
ricchi, possidenti e cosiddetti galantuomini.
Nel II° capitolo, racconta il suo primo delitto, commesso contro
il signorotto che aveva cercato di disonorare una sua sorella. Il III° capitolo
comincia a raccontare la sua vita da brigante politico. Crocco riesce a
descrivere i luoghi della sua vita di fuorilegge, i terreni eminentemente
boschivo, le campagne, le montagne. Cominciano le sue azioni di assalti e di
guerriglia, non sempre ricorda tutto precisamente.
Il IV° e il V° capitolo sono quelli dove racconta le sue intense
battaglie contro l’esercito regolare sardo piemontese e soprattutto contro la
Guardia Nazionale. Prima di ogni scontro il generale brigante abitualmente
scrive al sindaco o chi per lui comanda il paese da conquistare. E’ interessante
la descrizione dei suoi “briganti”, ci tiene a precisare che non tutti
erano pastorelli. Il suo piccolo esercito aveva quadri completi, erano
presenti: «un capitano, un luogotenente, un medico, sergenti maggiori, caporali
tutti appartenenti al disciolto esercito borbonico. Avevo seicento soldati di
tutti i corpi, cioè cacciatori, cavalleria, artiglieria, volteggiatori,
zappatori […]». Anche se lui preferiva combattenti provenienti dal ceto
contadino e non studenti.
Il V° capitolo affronta il suo rapporto con il generale spagnolo
Josè Borjes, naturalmente dal suo punto di vista. «Quest’uomo forestiero che
veniva da noi per arruolare proseliti e reclamava in conseguenza l’ausilio della
mia banda, destò sin dal primo momento nell’animo mio una forte antipatia poiché
compresi subito che a petto suo dovevo spogliarmi del grado di generale
comandante la mia banda, per indossare quello di sottoposto». Ecco
sostanzialmente qui ci sono tutte le motivazioni della sconfitta della reazione
legittimista del Mezzogiorno d’Italia. «Era un povero illuso – scrive Crocco
– venuto dal suo lontano paese per assumere il comando di un’armata, aveva
creduto trovar ovunque popoli insorti, e dopo un primo colossale fiasco dalla
Calabria alla Basilicata, voleva convincere me ed i miei che non sarebbe stato
difficile provocare una vera insurrezione […]». Borjes nelle sue memorie è stato
esplicito quando ha capito che difficilmente sarebbe riuscito a portare a
termine la missione che gli ha affidato il generale Clary. Mi manca un mio
esercito di 300 o 400 uomini, allora si che si poteva tentare di conquistare il
Regno e consegnarlo a Francesco II. Comunque Crocco nelle sue risposte
dell’interrogatorio racconta che il generale spagnolo doveva venire in suo aiuto
con un suo corpo di truppe di sette od ottomila uomini. Una volta che Borjes ha
lasciato il territorio lucano, Carmine Crocco continua la sua guerra banditesca
con attacchi isolati contro gli agguerriti eserciti di Pallavicini. «Attacchi
parziali n’ebbi a centinaia, non mi ricordo le date ed i luoghi con precisione,
poiché in quei giorni non prendevo appunti […] espongo, perciò, senz’ordine
cronologico, quanto mi si affaccia alla memoria lasciando da parte il futile ed
il superfluo». Negli ultimi capitoli Crocco descrive la sua fuga dai boschi
lucani e poi la sua prigionia.
·
Re galantuomo o Re caporale?
Re
galantuomo o Re caporale? Di certo Savoia sino al midollo.
Si avvicina il genetliaco di Vittorio Emanuele II, primo monarca d'Italia.
Riuscì a conciliare liberalismo e dinastia. Francesco Perfetti, Mercoledì
11/03/2020 su Il Giornale. Fu una felice invenzione di Massimo d'Azeglio la
fortunata etichetta di «Re Galantuomo» che insieme a quella di «Padre della
Patria» accompagnò il processo di «mitizzazione» della figura di Vittorio
Emanuele II durante tutto il Risorgimento e diffuse l'idea di lui come di un Re
garante delle libertà costituzionali e paladino del processo di unificazione
nazionale. E, fra tutti i politici del suo tempo, D'Azeglio, chiamato alla
presidenza del Consiglio dal nuovo Re subito dopo l'abdicazione di Carlo
Alberto, fu, probabilmente, il più vicino a Vittorio Emanuele II. Non è un caso
che questi, al di là e al di fuori di ogni rigida regola o etichetta di corte,
lo trattasse con grande familiarità entrando senza preavviso nel suo studio e
sedendosi informalmente sulla sua scrivania per discutere di politica, ma anche
di altro. L'espressione «Re Galantuomo» venne coniata agli inizi del nuovo
regno, quando, dopo la sconfitta di Novara e l'abdicazione del padre, il giovane
Vittorio Emanuele si incontrò a Vignale con il generale austriaco Radetzky per
discutere i termini dell'armistizio. Di quell'incontro non si hanno resoconti
diretti perché i due si parlarono da soli, l'uno di fronte all'altro in uno
spiazzo, mentre gli ufficiali e le persone al seguito osservavano la scena da
lontano attenti a cogliere sui volti dei due espressioni rivelatrici dei loro
sentimenti. Di ciò esiste traccia nell'iconografia coeva perché gli artisti, a
seconda che fossero austriaci o piemontesi, rappresentarono la scena in modo da
trasmettere sensazioni contrastanti. Quel che è certo è che il Re di Sardegna
rifiutò di abolire lo Statuto concesso dal padre, il che sarebbe stato possibile
con l'aiuto delle baionette austriache. Lo fece, probabilmente, soprattutto per
realismo politico. Ma l'immagine del «Re Galantuomo», del sovrano che non si
lascia convincere dalle lusinghe austriache di trasformare la sconfitta in una
vittoria e che riesce a tener testa al feldmaresciallo dell'imperial-regio
governo, divenne popolare. E tale immagine finì per indicare, nell'immaginario
collettivo, una vera e propria identificazione in Vittorio Emanuele II del
programma liberale e costituzionale con le pulsioni nazionali e unitarie.
Vittorio Emanuele II era cresciuto, per così dire, nell'assolutismo ed era poco
propenso agli studi umanistici, storici o filosofici. Sanguigno ed esuberante,
amava la caccia allo stambecco così come le avventure galanti e la vita all'aria
aperta. Disinibito nei rapporti sociali, era insofferente alle rigide regole
dell'etichetta di Corte e, comprensibilmente, non nutriva simpatie per teorie e
movimenti politici democratici o liberali che potessero mettere in discussione
la pienezza dei poteri sovrani. Non a caso, ancora Massimo D'Azeglio,
accennandone alle idee, parlò di un «malcerto liberalismo» del sovrano. La
verità è che Vittorio Emanuele II fu un uomo sostanzialmente pragmatico e
realista capace di conciliare le aspirazioni di unità e indipendenza dei
patrioti, fossero anche liberali e democratici, con gli interessi della propria
antichissima dinastia cui, malgrado il suo anticonformismo comportamentale, egli
era legato da un sentimento di orgogliosa appartenenza. È sintomatico il fatto
che, con l'andar del tempo, il processo di identificazione tra i Savoia e il
processo risorgimentale andò sempre più rafforzandosi come conferma, per
esempio, l'esortazione dalle carceri borboniche di un liberale moderato, il
napoletano Carlo Poerio, a vedere «sempre e solo nel Piemonte la nostra stella
polare». All'immagine iconica del «Re Galantuomo» se ne aggiunse un'altra, che
contribuì a rafforzare la leggenda del «padre della patria», quella del Re
ardimentoso che non si risparmiava in battaglia e che, malgrado le
raccomandazioni e gli inviti alla prudenza, voleva essere vicino ai suoi soldati
condividendone gli sforzi e le sofferenze. L'episodio più significativo si
svolse all'epoca della seconda guerra di indipendenza, in occasione della
battaglia di Palestro il 31 maggio 1859. Quel giorno Vittorio Emanuele II si
gettò a capofitto nella mischia guidando all'assalto i bersaglieri piemontesi e
gli zuavi francesi capovolgendo le sorti dello scontro. A notte inoltrata un
ufficiale francese, accompagnato da una delegazione di zuavi, si presentò presso
l'alloggio da campo di Vittorio Emanuele II offrendogli simbolicamente i galloni
di caporale. E, a quanto si racconta, da allora in poi, ogni sera per tanti
anni, il Terzo zuavi chiamava regolarmente all'appello «il caporale Vittorio
Emanuele di Savoia» e il sergente anziano rispondeva: «assente perché Re
d'Italia». Solo la sera del 9 gennaio 1878 il sottufficiale francese rispose
commosso alla chiamata: «il caporale Vittorio Emanuele di Savoia è morto questa
mattina». Non è da escludere, come ha ipotizzato qualche studioso, che
l'agiografia abbia colorito l'episodio ma rimane il fatto che i galloni di
caporale degli zuavi sono conservati nell'Armeria Reale di Torino. La seconda
guerra di indipendenza era giunta al termine di quel «decennio di preparazione»
che aveva visto, grazie all'azione del conte Camillo Benso di Cavour, prima, la
partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea e l'internazionalizzazione
della «questione italiana» e, poi, gli accordi di Plombiéres con Napoleone III.
E questi accordi erano costati sacrifici di non poco conto come il matrimonio
della figlia di Vittorio Emanuele II, la devota e giovanissima Clotilde, con
l'attempato e libertino Gerolamo Napoleone, oltre alla promessa della cessione
di Nizza e della Savoia. La guerra con l'Austria si concluse, lasciando l'amaro
in bocca, con l'armistizio di Villafranca, voluto dall'imperatore dei francesi,
preoccupato dal paventato intervento delle armate prussiane ma ancor più dalla
prospettiva di un eccessivo ingrandimento del Piemonte. In questi anni il
pragmatismo di Vittorio Emanuele II si era incontrato, ma anche scontrato, con
il pragmatismo del conte di Cavour. I due uomini erano profondamente diversi se
non per altro per la diversa concezione che essi avevano del ruolo dei ministri
e dello stesso Parlamento, ma in comune avevano, entrambi, l'idea della
necessità della guerra all'Austria. E, malgrado le differenze fra i due, il
«decennio di preparazione» aveva gettato le basi per portare avanti il processo
risorgimentale. Anche di fronte alla spedizione dei Mille le posizioni dei due
erano state inizialmente diverse con un Vittorio Emanuele II da subito
favorevole all'impresa forse affascinato dalle personalità guerriera di Giuseppe
Garibaldi, il quale, messe da parte le suggestioni mazziniane e repubblicane,
avrebbe inalberato l'insegna «Italia e Vittorio Emanuele» a avrebbe, poi,
riconosciuto che il Re era stato «il perno» attorno al quale lui e i suoi si
erano raggruppati e avevano fatto quel che avevano fatto. Il maggior contributo
al Risorgimento, però, Vittorio Emanuele II lo dette non solo e non tanto con il
suo pragmatismo ma anche, e soprattutto, con la sua azione in politica estera.
Qui egli e lo hanno riconosciuto storici del calibro di Gioacchino Volpe e di
Federico Chabod ebbe la capacità, affiancando e talora sovrapponendo la sua
diplomazia personale alla diplomazia di governo, di rassicurare le Corti europee
sull'esito non destabilizzante, a livello di equilibri internazionali, del
Risorgimento italiano. Sotto questo profilo, almeno, egli fu davvero il «padre
della Patria».
·
Anche le donne a
capo del casato.
Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera” il 17 dicembre
2020. «Il cancello». Vent' anni dopo quel primo giorno da militare è ancora
quella l'immagine che torna negli occhi di Carla Brocolini: il momento in cui,
da volontaria in ferma breve del primo corso di donne soldato, ha varcato
l'ingresso della caserma. «Un'emozione fortissima, che ancora sento sulla
pelle», confessa, mentre disegna un circoletto rosso sulla foto che la ritrae
con quel plotone. Ragazze che nel 2000, alla caserma Emidio Clementi di Ascoli
Piceno, marciarono sopra un tabù: le caserme non erano più un posto per soli
uomini. Come le era venuto in mente? Una sfida? Un gioco? «Mi aveva affascinato
mio fratello, allora 16enne, che frequentava la Nunziatella. Mi parlava di
valori, ideali, sacrificio, spirito di corpo, cameratismo. Io ne avevo 18, volli
provare e mi ritrovai a vivere un'esperienza difficile, che mi avrebbe messo
alla prova sia dal punto di vista fisico che mentale, ma assolutamente positiva,
come mi aveva detto mio fratello. Tanto che riconfermai la scelta, entrai in
Accademia e diventai ufficiale», racconta Carla, ancora vibrante per la passione
di un mondo, dice, che «mi ha insegnato disciplina, sacrificio, sudore, ma anche
la soddisfazione di raggiungere i risultati sperati». Quella scelta le avrebbe
cambiato la vita. Ora è ufficiale pilota militare dell'Aviazione dell'esercito,
sposata con un militare, «elicotterista e facciamo sempre a gara a dire chi è il
vero pilota», con un bambino di due anni e mezzo. Ma non fu una scelta indolore.
Il padre non gradì. «Quando arrivò la cartolina sfiorò l'infarto. Era in
polizia, ma avrebbe preferito facessi altro. E anch' io pensavo di fare
l'avvocato. Ma, soprattutto, ero all'ultimo anno di liceo classico. Non voleva
che lasciassi la scuola. Litigammo, poi raggiungemmo un compromesso: mi
permisero di partire a patto che mi fossi diplomata a luglio da privatista».
Promettere fu un attimo. Mantenere «una delle cose più difficili della mia vita.
Perché mio padre aveva la costanza di darmi ogni giorno i compiti da fare. Ma
dopo le sette di sera, dopo aver fatto ginnastica, marcia, topografia,
esercitazioni, ero distrutta», ricorda. «Però feci uno sprint finale e sono
contenta di aver tenuto fede a quella promessa. Anzi, due anni fa sono anche
riuscita a laurearmi in Giurisprudenza». Per lei e la sua compagnia ci furono
flash, telecamere, e domandine maliziose su come venivano trattate in caserma.
«Anch' io avevo un'idea di un mondo maschilista, dovuta ai filmetti anni
Settanta. Ma ho trovato un ambiente di professionisti, dove al centro della
formazione e dell'addestramento c'era il militare. Non una donna o un uomo».
Nulla venne risparmiato alle allieve nel Rav: circuiti alla Platoon, salti,
muretti da scavalcare, armi, lezioni. I primi tre mesi di addestramento,
comunque, furono solo femminili. E da quelle ragazze del plotone Carla non si
separò mai più. «Sono le mie amiche più strette. Due sono state le mie testimoni
di nozze. È un legame difficile da spiegare. Al Rav ho compreso il profondo
significato e la forza della parola insieme. E ancora oggi abbiamo una chat dove
ci scambiamo foto e ricordi». Ancora ridono per quello più buffo: «Ad Ascoli
Piceno faceva freddo e pioveva, alla continuativa, il percorso più pesante, non
vedevamo l'ora di fermarci a mangiare la razione K. Ed eravamo così stanche che
una ragazza scambiò la diavolina con una zolletta di zucchero e la addentò».
Ottavio Fabbri per Libero Quotidiano il 2 luglio 2020. 1991. Il
mio amico Serge di Yugoslavia, già mio aiuto regista in Viaggio d'Amore, mi dice
che ha convinto sua nonna Maria Jose' a fare una intervista sulla sua vita. La
Rai è interessata e la nonna è già pronta nella sua villa vicino a Ginevra dove
abita da tanti anni. La regina ci riceve in una sobria e un po' maliziosa
eleganza: è nel suo carattere mi bisbiglia Serge, sottolineata da uno sgargiante
foulard tenuto in fronte alla moda hippy. Mi è subito molto simpatica e
riconosco in lei, più che ottantenne, tutte quelle leggende o verità di una
donna eccezionale che ha tenuto la testa alta in difficili momenti della Storia.
Mentre la piccola troupe prepara macchinari e luci per l'intervista e Maria
Jose' si è già accomodata sul suo divano preferito, appare in fondo alla sala
uno smilzo ragazzo dall'aria timida e gentile. «Ciao Carletto ... scusa stiamo
facendo una intervista importante a mia nonna». «Figurati Serge ... intanto mi
faccio una canna in cucina». «Eh no ... vai in giardino o ci vediamo un'altra
volta». Tutto è pronto per l'intervista in cui la nonna racconta tanti episodi
più o meno noti della sua straordinaria esistenza. Mi colpisce uno in
particolare. «Un giorno mi chiama Einstein. Buongiorno professore...». «Madame,
sono a Ginevra, posso venire a renderle omaggio?». «Ma certamente professore
...». «Porto anche il violino!». «Allora non venga professore». La sua famosa
schiettezza contrasta con le sue maniere di straordinario garbo. Chiede
scusandosi se qualcuno della troupe ha una Marlboro rossa, le viene subito
offerta dall'elettricista che poi vorrà un autografo per i parenti a Viterbo
ancora monarchici. La nonna fuma con sguardi persi nella memoria, poi allunga il
collo. «Serge ...viene uno strano odore da quella parte, forse nelle cucine».
«Nonna, non so ... sarà l'arrosto che brucia», e mi guarda ridendo. «No. No, vai
a vedere». intervista storica Senza scampo Serge si dirige verso l'origine dello
strano odore e spunta Carletto con un lungo spinello in mano. «Vai via!!!».
«Serge,non mi presenti il tuo amico?». Che tabacco fuma? L'odore è buono...mi
faccia sentire». Carletto intimidito allunga lo spinello alla regina che lo
aspira incuriosita mentre con la mano sinistra tiene la sua Marlboro. «Nonna
basta, adesso passami quello che stai fumando, magari ti fa male», e lei con
nonchalance veramente regale gli allunga la Marlboro e si tiene lo spinello.
Intervista conclusa. «Adesso non so perché ma mi viene tanto da ridere, grazie a
tutti e vado a fare un riposino». Ciao nonna... grazie a te». Carletto è già
fuggito. Serge felice.
La svolta dei Savoia dopo mille anni «Anche le donne a capo
del casato». Pubblicato martedì, 14 gennaio 2020
su Corriere.it da Enrica Roddolo. Casa Savoia apre alle donne. Dopo mille anni
di storia, la svolta. Vittorio Emanuele e il figlio Emanuele Filiberto
anticipano al Corriere la decisione. «Addio legge Salica. Oggi sarà comunicato
per scritto alle sorelle dopo una telefonata in serata, alla Consulta dei
senatori del regno e agli Ordini dinastici, un cambio delle regole di
successione che era tempo di aggiornare». Dunque, dopo Emanuele Filiberto, la
prima in linea di successione ora è sua figlia, Vittoria, 16 anni. Il principe
ha due figlie, qualcuno dirà che la decisione l’avvantaggia. «In realtà Clotilde
ed io potremmo ancora avere un maschio... — replica lui —. E di certo era
anacronistico, in una società che vuole riconoscere la parità di genere, pensare
che in Casa Savoia si discriminassero le donne». Può suonare anacronistico anche
parlare di successione al trono, in una Repubblica, ma i Savoia ci sono ancora e
vogliono innovarsi. Vittorio Emanuele, figlio di Umberto II, il «re di maggio»
che lasciò l’Italia dopo il referendum Monarchia-Repubblica, spiega che «la
decisione è stata meditata e non è frutto di particolari circostanze o urgenze,
la società va verso la parità tra i sessi e la stragrande maggioranza delle case
reali sono andate in questa direzione». E cosa avrebbe detto nonna Maria Josè,
donna di grande intelligenza e autonomia? «A guerra finita si ipotizzò una
reggenza in suo favore mentre mio padre era bambino, e lei avrebbe avuto
quell’intuito e sensibilità che solo le donne hanno — dice Filiberto —. E poi
quante donne forti nel Novecento, da Elisabetta II a Madre Teresa». Chissà se a
sua figlia Vittoria piace l’idea del nuovo ruolo nel casato, che invece sta
scomodo alla duchessa di Sussex... «La prima cosa che mi ha chiesto è stata
“papà, dovrò studiare di più?” Le ho detto che l’aiuterò. Anche se sogna l’arte,
la moda, mentre la piccola Luisa vuole fare la Nunziatella, l’Accademia
militare: ha una passione per Esercito, Polizia, Nuclei speciali». Ma è
realistico immaginare Vittoria con la corona? «Mai dire mai — risponde il
principe — e intanto si tratta di guidare verso il futuro un casato con mille
anni di storia, gli ordini dinastici, le charities. Poi ci sono i rapporti con
gli altri casati: mio padre comunicherà la svolta a case reali regnanti, e non.
Il rapporto è stretto con re Felipe di Spagna, l’erede Leonor e Sofia sono quasi
coetanee di Vittoria e Luisa, e poi con Belgio, Svezia, Norvegia, Alberto di
Monaco e i Windsor. Triste vedere ora qualcuno che vuole allontanarsi dalla
famiglia Windsor: reale o no, una famiglia». Per la verità tra Savoia non sono
mancate tensioni. «Troppi veleni e io sono sempre stato un pacificatore — dice
Filiberto —. Ma noi cugini della nuova generazione andiamo d’accordo e papà ha
passato il Natale con Maria Gabriella. Anche se sulla sepoltura dei Savoia la
mia idea resta che Vicoforte è una soluzione transitoria: ho scritto al premier
Conte per chiedere di portare le salme di re Umberto II e Maria José, i miei
nonni, al Pantheon. Ma ora penso a Vittoria, alla sua prima uscita pubblica il
14 marzo ad Altacomba. E per lei la priorità deve restare lo studio. Meno male
che c’è Clotilde che è severa nel gestire orari delle uscite con gli amici,e
tempo con il telefonino!». Lui capì di essere l’erede da piccolo. «Avevo 5-6
anni, vennero a Ginevra dei monarchici e quando presero il pulmino per tornare
in Italia dissi “salgo anch’io”. Mi dissero che no, io non potevo andare in
Italia». Il padre Vittorio Emanuele ricorda invece «c’era la guerra, ero in
Svizzera con mamma, Hitler aveva un piano per rapirmi. Sentivamo le notizie
dalla radio... infine l’esilio durato 57 anni».
Vittoria di Savoia, chi è la sedicenne erede del casato dei re
d’Italia. Pubblicato mercoledì, 15 gennaio 2020
su Corriere.it da Enrica Roddolo. Vittoria di Savoia, da oggi erede del casato
dei re d’Italia dopo il padre Emanuele Filiberto, nata il 28 dicembre del 2003 a
Ginevra, ha conosciuto presto l’Italia dalla quale papà Filiberto, nonno
Vittorio e il bisnonno Umberto II sono invece rimasti lontani per anni. Per
l’esilio che dal referendum Monarchia-Repubblica del giugno 1946 impedì loro di
rientrare in patria per 57 anni (qui la storia della dinastia). Vittoria è stata
infatti battezzata nella basilica di Assisi il 30 maggio 2004, per amore dei
Savoia per l’Italia e perché Vittoria ha per secondo nome anche quello di
Chiara, il nome della Santa che ad Assisi è celebrata. Cresciuta tra Ginevra,
Montecarlo, Francia e Italia, studia a Parigi. È la primogenita di Emanuele
Filiberto e Clotilde Courau che si sposarono a Roma nella Basilica di Santa
Maria degli Angeli nel settembre del 2003, con il principe Alberto II di Monaco
testimone di nozze della coppia. La tredicesima disposizione transitoria finale
che per quasi sessant’anni aveva tenuto lontano dai confini italiani ormai era
stata abrogata ed Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo sovrano d’Italia, il
«re di maggio» Umberto che aveva lasciato l’Italia su un Savoia Marchetti «per
non far spargere sangue sull’Italia» come dirà, poté quindi dire sì nella
Capitale dove aveva vissuto bambino, papà Vittorio Emanuele nella Manica lunga
del palazzo del Quirinale. Vittoria che come ha detto al Corriere il padre
Filiberto «ha subito chiesto che cosa comporterà il nuovo ruolo di erede del
casato, se dovrà studiare di più?» ha una sorella minore, Luisa (secondi nomi
Giovanna Bianca Agata Gavina Maria) nata il 16 agosto del 2006. E se con la
nuova disposizione ora emanata dal Capo di Casa Savoia, Vittorio Emanuele, la
primogenita Vittoria diventa erede della storia millenaria del casato, prende
anche nuovi titoli. «Come tratto di speciale benevolenza confermiamo alla nostra
diletta nipote Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria il trattamento di Altezza
Reale, la qualità di Principessa Reale e le conferiamo il titolo di principessa
di Carignano seguito dal titolo di marchesa d’Ivrea», ha infatti disposto
Vittorio Emanuele. Nominandola anche Dama di Gran Croce, decorata del Gran
Cordone, dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Mentre la sorella minore è
principessa di Chieri e contessa di Salemi. Perché questi titoli? «In
particolare, Carignano, Ivrea e Chieri richiamano territori da sempre sabaudi,
nel cuore dell’antico Piemonte — ha spiegato al Corriere il nonno Vittorio
Emanuele —. Il titolo relativo alla contea di Salemi, creato da re Umberto I nel
1889, estinto e successivamente tornato alla corona, richiama invece una
splendida città del Mezzogiorno d’Italia, omaggio alla bellissima terra
siciliana che mi è particolarmente cara».
Vittorio Emanuele: «Vittoria di Savoia? Sui social è già
regina, ma per me lei e la sorella sono uguali».
Pubblicato sabato, 18 gennaio 2020 su Corriere.it da Enrica Roddolo. «Viva la
regina, brava. Mia figlia Vittoria credo sia rimasta lei per prima sorpresa,
guardando il suo account Instagram dove ha ricevuto tanti messaggi che la
incoraggiano ad affrontare la sua nuova vita, o meglio il suo nuovo ruolo di
capofila di Casa Savoia. È un po’ impaurita dalla responsabilità, dalla novità,
ma direi felice delle reazioni. Dei messaggi da ragazzi giovani, come lei»,
racconta al Corriere il papà Emanuele Filiberto, mentre l’Italia si appassiona
alla saga del casato che — come annunciato in anteprima da Filiberto con
Vittorio Emanuele — ha deciso di aprire alle donne la guida del casato. Sui
social c’è chi la chiama Altezza Reale e dice «sarete sempre Regina dei cuori di
tutti coloro che credono nella libertà e che sono disposti a dare la loro vita
per il loro paese e per la loro unica sovrana: Vittoria Di Savoia»
(Monarchicoliberale). Su Instagram la sedicenne Savoia si firma con la bandiera
tricolore italiana. Nessuno stemma sabaudo, solo il tricolore. «Perché sempre
quegli occhi tristi? Facci sentire orgogliosi della dinastia Savoia, forse
politicamente non sarai mai chiamata a guidare il nostro Paese, ma rimarrai
sempre Regina nei nostri cuori, e non siamo in pochi» (Roberto tr59). Molti i
complimenti sulla bellezza. Qualcuno chiede: «Ma parli anche l’italiano?».
Ad appassionare gli italiani, per la verità, non c’è solo
l’apertura alle donne, ma pure le liti. Se le aspettava, così tante e velenose,
principe?
«Mah un po’ me le aspettavo e perlopiù sono legate alle vecchie
generazioni».
In che senso?
«Tra cugini, con Aimone, si ragiona, so che è una persona di buon
senso e gli apro le braccia. Dobbiamo avere tutti un unico obiettivo: lavorare
per traghettare nel futuro la storia del nostro casato... poi la storia non si
cambia e il nostro è il ramo principale. Ma gli dico: lascia perdere l’antica
polemica tra i nostri genitori, di tuo padre Amedeo d’Aosta con mio padre
Vittorio Emanuele, e pensiamo al futuro. Noi, nuove generazioni Savoia dobbiamo
andare oltre le divisioni. Possiamo lavorare bene assieme, spero lo faremo. In
fondo è quel che già sta funzionando con i figli delle sorelle di mio padre,
Serge, Dimitri, Elena...anche la figlia di Maria Gabriella».
Principe, andrà domani a Roma al Pantheon al raduno delle Guardie
d’Onore?
«Certo sarò lì alle 9 per onorare i re d’Italia. E al Pantheon
spero presto possano arrivare anche gli ultimi re , il nonno Umberto II e la
nonna Maria José. E poi...decaduta la XIII disposizione transitoria finale non
c’è ormai più alcun divieto a riportare in patria i morti». Pensa già nel 2020?
«Per Umberto II e Maria José spero che questo sia un anno decisivo, sì. Anche
con il Vaticano abbiamo già affrontato questo tema portato all’attenzione anche
del premier Conte. E a proposito del Vaticano, ricordo quando con Vittoria
abbiamo incontrato il Papa, a Torino in occasione dell’ostensione della Sindone
anni fa — continua Filiberto —. Vittoria e la sorella più piccola Luisa erano
emozionatissime, come se dovessero incontrare il loro personaggio di cartoni
animati preferito...erano piccole e sono rimaste molto impressionate dal Santo
Padre».
Due sorelle, due destini. Però solo una erediterà il casato.
«Sono due sorelle e da loro mi attendo infatti un bel gioco di
squadra, l’ho visto in questi giorni in cui hanno capito il crescere
dell’attenzione attorno a loro — dice al Corriere Filiberto —. Con la piccola a
incoraggiare la più grande. E poi per me saranno sempre sullo stesso piano. Casa
Savoia passa alla maggiore ma lavoreranno assieme per portare il casato nel
futuro».
Suo padre, contesta la Consulta dei senatori, non può cambiare le
regole con un motu proprio.
«E perché mai? Umberto II non ha mai detto di voler cambiare,
intendo il ramo di discendenza, dunque sono io con Vittoria il legittimo
discendente dell’ultimo re... e poi dicono che servirebbe una pronuncia del
parlamento di una monarchia costituzionale? Ma se non c’è una monarchia oggi, il
casato ora è continuato da papà che in quanto capo della Real Casa può
intervenire con una norma di sua iniziativa». Intanto domani al Pantheon si
vedrà la reazione dei monarchici. Oltre a quella delle Consulte.
Donne e Savoia, monarchici divisi. I Duchi d’Aosta: «La legge
Salica non si tocca». Pubblicato mercoledì, 15 gennaio
2020 su Corriere.it da Enrica Roddolo. Le reazioni dopo l’apertura alla
successione femminile al trono. I Borbone d’accordo: «Escluderle una
discriminazione». «Legge Salica? Anch’io come casa Savoia l’ho abolita perché
per il diritto internazionale ed europeo tenere fuori dalla successione al trono
le donne è una discriminazione... impugnabile», dice al Corriere Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, capo della real casa che guidò il regno di Napoli.
«Anzi, proprio Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Filiberto di Savoia mi
hanno chiesto un parere mesi fa su questa questione, sui tempi e le modalità: io
l’ho fatto il 12 maggio del 2016 in occasione della cresima di mia figlia Maria
Carolina, ho aspettato che lei ne avesse la consapevolezza e l’ho fatto con un
documento, l’Atto di Roma, che cita il Trattato di Lisbona del 2007, la
Convenzione di New York delle Nazioni Unite nel 1979 e il trattato dell’Unione
Europea modificato nel 2009». Così, come indica l’Atto di Roma, Carlo di Borbone
modificò «le regole di successione sinora in vigore nella Real casa di Borbone
delle Due Sicilie, allo scopo di renderle compatibili con l’ordinamento
internazionale ed europeo vigente che proscrive qualsivoglia forma di
discriminazione tra uomo e donna, non solo nel godimento dei diritti e delle
libertà, ma anche nell’esercizio di qualsiasi funzione pubblica. D’ora in poi
sarà applicata alla sua diretta discendenza la regola della primogenitura
assoluta». E non ha mai pensato che potesse suonare anacronistico modificare la
legge di successione a un trono che non c’è? «Non solo non c’è ma per farlo
tornare bisognerebbe dividere nuovamente il Paese in due — fa notare il principe
che è zio di Felipe di Spagna, nel suo albero genealogico ci sono anche i re di
Francia e mezzo Gotha europeo —. Lo so che sembra incredibile nel 2020 parlare
di Ordini dinastici, di fondazioni legate alla storia del casato, ma si tratta
di storia, storia che mia figlia ora deve proseguire. E lei, che come tanti
ragazzi giovani ha un’attrazione per l’arte, le professioni creative, si è resa
conto dell’importanza storica del suo ruolo per il futuro». L’erede del casato
dei Borbone delle Due Sicilie studia a Parigi, privatamente, per conseguire un
Baccalaureat internazionale. E come ha detto al Corriere la mamma Camilla (che
ha sposato nel 1998 Carlo, il fidanzamento fu annunciato a Palazzo Reale), Maria
Carolina e la sorella Maria Chiara «frequentano corsi di napoletano quando siamo
a Napoli, perché torniamo spesso a Napoli dove è comunque rimasta una certa
simpatia verso il casato: la città sotto i Borbone prima del 1860 era la terza
grande capitale d’Europa, dopo Londra e Parigi». Dopo la decisione del principe
Vittorio Emanuele di Savoia, i monarchici della Consulta dei senatori del regno
e quelli più vicini al ramo Savoia-Aosta hanno risposto che «no la legge Salica
non si può cambiare». «Mah qualunque decisione si prenda ci saranno sempre delle
voci contro, io quando scelsi così lo feci dopo essermi consultato con la
famiglia allargata e non ho trovato obiezioni. E ripeto, da un punto di vista
giuridico c’è un diritto internazionale ed europeo che va nella direzione della
parità di possibilità per le donne». Ma è già lite sotto le insegne di casa
Savoia. Questa volta non tra i figli dell’ultimo re, per la verità, ma tra i
vari rami del casato che da Umberto Biancamano arriva fino ad oggi. A contestare
la decisione di Vittorio Emanuele di mandare in pensione la legge Salica che da
sempre blocca la strada al trono alle donne nel casato — mossa anticipa al
Corriere ieri da una doppia intervista con Vittorio Emanuele ed Emanuele
Filiberto di Savoia — è adesso la Consulta dei senatori del regno con il
principe Aimone di Savoia, duca delle Puglie, e la duchessa Silvia di Aosta,
consorte del principe Amedeo di Savoia, duca di Aosta. «Fino alla restaurazione
della monarchia costituzionale, la legge Salica è immodificabile». E dunque,
sostengono i monarchici vicini agli Aosta, non essendoci un trono «operativo»,
il trono resta ereditario secondo la legge salica che esclude la discendenza
femminile. Per giustificare la posizione, il presidente della Consulta Aldo A.
Mola, cita una lettera del 25 gennaio 1960 di Umberto II da Cascais sulla
immutabilità e inviolabilità «della legge della nostra Casa, vigente da ben 29
generazioni». Per la Consulta dei senatori la parola di Umberto II resta l’unica
valida. Già, ma quale Consulta considerare? Perché l’uscita allo scoperto della
Consulta guidata da Mola ha sollevato la reazione dell’altra Consulta dei
senatori del regno guidata da Pier Luigi Duvina (le due entità da anni si
contendono il ruolo): «Vittorio Emanuele ha adattato le leggi dinastiche alla
normativa europea». Intanto Vittorio Emanuele, figlio del «re di maggio» da
Ginevra sta in queste ore comunicando a tutte le altre case reali regnanti, e
non, la svolta: «Da oggi e poi in futuro, la successione nella qualifica di capo
della nostra real casa e Gran maestro dei nostri Ordini dinastici, sarà
riservata alla nostra discendenza di ambo i sessi, in infinito, secondo il
criterio della primogenitura assoluta». Dietro allo scontro c’è l’antica
contrapposizione tra ramo Savoia Carignano (quello dei re d’Italia) e ramo
Savoia Aosta. Una rivalità antica che ebbe nella contrapposizione di stili e di
vita di due donne, entrambe di nome Elena, la sua espressione più immediata.
Elena di Montenegro moglie di Vittorio Emanuele III re d’Italia, ed Elena
d’Orleans, della quale cantò in versi il Vate d’Annunzio, che sposò a Londra
Emanuele Filiberto di Savoia Aosta. Da Elena d’Orleans discende anche l’attuale
principe Aimone di Savoia Aosta, che ha due figli maschi. «Eppure la legge che
adesso abroga la legge Salica in casa Savoia non è stata varata per questo —
ribatte Emanuele Filiberto —. Non è proprio così, a parte che mio padre aveva in
mente questo aggiornamento già tre anni fa ma sono io che ho rallentato perché
volevo che Vittoria raggiungesse i 16 anni e capisse che cosa stava succedendo,
ma un conto sono i rami cadetti un altro il ramo principale, così è la storia. A
volte ci sentiamo con Aimone... suo figlio primogenito sarà l’erede legittimo
del ramo dei Savoia Aosta. Ma i Savoia Carignano, il ramo principale, continuano
con Vittoria». Aimone di Savoia, manager per Pirelli a Mosca, intervistato dal
Corriere della Sera a proposito delle infinite divisioni tra cugini aveva detto
di «guardare al futuro, ai piccoli Umberto, Amedeo e Isabella... e con Emanuele
Filiberto, dopo una causa che ci ha divisi per anni, potremmo riavvicinarci».
Già, ma adesso, ancora una volta è Savoia contro Savoia.
Guerra tra i monarchici: "Emanuele Filiberto non può passare
la corona a sua figlia Vittoria". I Senatori del Regno
contrari all'apertura del Savoia che ha annunciato di abbandonare la legge
salica scritta mille e cinquecento anni fa. Paola Griseri il 15 gennaio 2020 su
La Repubblica. I Senatori del Regno non ci stanno. E scoppia la guerra tra i
Savoia. Il primo ad attaccare è stato Emanuele Filiberto che ha annunciato oggi
al Corriere della Sera l’intenzione di dire “addio alla legge salica”. Così le
donne potranno diventare regine ereditando il potere dai maschi e violando la
regola scritta ai tempi di Clodoveo (scritta, forse, intorno al 495 dopo
Cristo), che in casa Savoia stabilisce l’ereditarietà solo per via maschile.
“Legge di altri tempi ormai superata, provvedimento anacronistico”, dichiara
Emanuele Filiberto annunciando che, di conseguenza, la figlia Vittoria, 16 anni,
sarà la sua erede designata. Terremoto che non poteva rimanere senza conseguenze
dopo un millennio di strettissima osservanza salica da parte dei Savoia. E
infatti poche ore fa la Consulta dei Senatori del Regno ha detto no ricordando
che “solo nell’esercizio effettivo dei loro poteri e nell’ambito di una nuova
Costituzione la Corona e le legittime Rappresentanze degli italiani potrebbero
procedere a eventuali modifiche dello Statuto”. Il riferimento è allo Statuto
Albertino del 1848 che confermava la legge salica. Un principio, ricordano i
Senatori del Regno, confermato nel 1960 da Umberto II nel suo esilio di Cascais,
in Portogallo: “Tale legge (la Legge salica ndr) io, 44esimo capo famiglia, non
intendo e non ho diritto di mutare”. Dibattito appassionante quanto, ovviamente,
del tutto inutile. Fino a quando l’Italia sarà una Repubblica.
Dagospia il 16
gennaio 2020. Da “la Zanzara - Radio 24”. A un certo punto si parlava di Sanremo
a La Zanzara su Radio 24 con il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Perché
non va lei a Sanremo, Principe, al posto di Rula Jebreal?: “Perché costo
troppo”. Ma lei dovrebbe andarci gratis, per la patria: “No, Sanremo non è la
patria. Vado a San Patrignano ad aiutare per la patria, ma non a Sanremo. Sono
due santi diversi. Io ho già fatto il mio Sanremo. E l’ho stravinto”. Avevate
vinto tu e Pupo e vi hanno fregato, diciamola tutta: “Ma questo lo sappiamo dai,
era scritto a tavolino, ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire il pubblico.
C’è stato un piccolo trucco finale che è il famoso trucco della linea chiusa,
no?”. Dunque ti hanno fregato come nel referendum sulla monarchia. Anche la
monarchia fu fottuta, no? : “Beh, questo si sa. Sicuro. Parenzo obietta? Ma sei
un cocciuto della Madonna, Parenzo. Incontrai Andreotti e mi disse la stessa
cosa”. Ma il tuo cuore è ancora monarchico?: “I valori sono monarchici, il cuore
è monarchico, però voglio dire guardo l’attuale Repubblica Italiana e mi sento
bene lì dentro. Però quello che sono, lo sono. Io ho un nonno che ha sofferto
nel ’46 lasciando l’Italia, ho un trisavolo che ha unificato questo bellissimo
paese, non può essere altro che monarchico il mio cuore”. In questo casino
italiano la monarchia sarebbe un elemento di stabilità?: “Io ho sempre detto una
cosa. Poi non voglio parlare dell’Italia perché poi entriamo nelle polemiche e
non finiamo più. Quando guardo fuori dalla finestra e guardo altri paesi che
hanno la monarchia, oggi la monarchia è simbolo di stabilità. Un simbolo
malgrado da dove tu provenga, destra, sinistra, alto o basso, come vuoi, sei
sempre attaccato ad una persona, ad una famiglia che è apolitica”. Interviene
Parenzo e dice: “Ma se in Italia la monarchia non è rispettata ci sarà un motivo
o no?”: “Parenzo, che cazzo stai dicendo? O la storia la impari oppure passiamo
ad altre cose. In Italia c’è stata una Repubblica che ha riscritto la storia
dopo un po’, no?”. Ancora Parenzo: “Forse perché c’era ‘sciaboletta’ che è
scappato nottetempo?: “Amore mio, non sto dicendo adesso niente su nessuno, ma
non dimenticare una cosa. Che l’Italia all’epoca non era una monarchia assoluta.
Era una monarchia costituzionale. E allora le merde di legge che avete avuto, le
ignobili leggi razziali che avete avuto, che ha avuto l’Italia, son ostate
votate non dal re, dal parlamento. Ma erano controfirmate dal re? Era obbligato
a controfirmare le leggi. Ci sono ancora molte persone in Italia che guardano
positivamente alla monarchia”. Oggi chi voteresti in Emilia Romagna, la
Borgonzoni o Bonaccini?: “Io sempre le donne. E’ anche una bella figliola? Lo
so, lo so, non è male. Ma poi è anche una persona intelligente e preparata. Io
parlo solo per Emanuele Filiberto, a titolo personale”. Mettiamo che il Re
potesse avere un potere assoluto, come ai vecchi tempi. Lei legalizzerebbe la
prostituzione, riaprirebbe i bordelli?: “Sì. Io preferirei vedere una
prostituzione controllata e chiusa, perché per la strada ci sono delle cose
ignobili, malattie e tossicodipendenti”. E le droghe leggere?: “Questo no. No,
no. Su questo non sono d’accordo. Per me non esiste droga leggera o droga dura.
Le droghe sono droghe. E si sa che una porta all’altra. Ho molti amici che sono
passati dall’uno all’altro”. E della vicenda dei reali inglesi che pensa?: “E’
sempre triste una famiglia che si rompe o si divide. Ma hanno fatto bene, anche
se l’hanno fatto in un modo brutto”.
Aimone
d’Aosta: «Per ora non alimento la polemica». Intanto è guerra di carte tra i
Savoia.
Pubblicato venerdì, 17 gennaio 2020 su Corriere.it da Enrica Roddolo. Dopo la
svolta che ha aperto alla successione femminile al trono, il principe risponde:
«La monarchia non tornerà in Italia». Aimone di Savoia — Juan Carlos il suo
padrino di battesimo con re Costantino II di Grecia — è un uomo riservato. E
preferisce tirarsene fuori, per ora, dall’ultimo scontro in Casa Savoia.
«Preferirei non alimentare ulteriormente la polemica — risponde al Corriere da
Mosca dove da anni è impegnato per Pirelli — in quanto la dichiarazione fatta
dalla Consulta copre già la posizione che avrei assunto e che avrei potuto
esprimere direttamente se fossi stato consultato in simultanea con mio cugino.
Continuare la polemica, a questo punto, non serve». Principe manager, che parla
il russo. «Sono rientrato due volte in Italia per brevi periodi ma il mio
destino evidentemente era a Mosca, una realtà che in 25 anni ho conosciuto bene.
Continuo a studiare il russo, adesso mi dedico a Dostoevskij perché un Paese si
capisce a fondo studiandone la cultura». È lui il Savoia che parte dei
monarchici vorrebbe a capo del casato. «Realisticamente? Non credo che la
monarchia tornerà mai in Italia e non ho avuto alcuna esitazione a giurare
fedeltà alla repubblica quando, dopo il Morosini a Venezia e i corsi
dell’Accademia navale, sono salito a bordo della fregata Maestrale...», ha detto
al Corriere. «Quanto al rientro delle salme Savoia è la cosa giusta: ricordo che
15 anni fa mio padre si interessò per far rientrare anche la salma del duca
degli Abruzzi sepolto in Somalia, oggi la sua tomba è stata profanata e
distrutta. Dunque era giusto, specie considerata l’instabilità dell’area del
Nord Africa, rimpatriare la salme di re Vittorio Emanuele III da Alessandria
d’Egitto e quella della regina Elena. E dovrebbero andare al Pantheon, dove
riposano i re d’Italia». Sposato con Olga, secondogenita di Michele di Grecia,
che conobbe «a un ricevimento reale, al matrimonio dell’Infanta Elena, figlia di
re Juan Carlos. Ci siamo sposati nel 2008», racconta. Aimone è vegetariano: «ai
fornelli mi metto sempre io: preparo la pasta e anche il ragù per i bambini con
i quali parliamo italiano, francese, russo, inglese». Umberto, il primogenito
(10 anni) dice di amare scherma ed equitazione e porta il nome dell’ultimo re
Umberto II, mentre Amedeo, nato nel 2011 (poi c’è la piccola Isabella), alla
storia e alla scherma dice di preferire il calcio e l’hockey. E confessa: «Da
grande vorrei fare l’esploratore o lo scienziato». Sulle orme del prozio Luigi
Amedeo duca degli Abruzzi. Papà Aimone, intanto, insegna loro la storia di casa
Savoia: «non che sono principi, ma la storia di famiglia sì. Poi dovranno
trovare anche loro un mestiere, non abbiamo le risorse per vivere senza
lavorare, ma anche se le avessimo non credo che un principe possa rinunciare
oggi a un lavoro». Amedeo (ramo Savoia Aosta), padre di due maschi e una
femmina, ed Emanuele Filiberto (ramo Savoia Carignano), padre di due femmine
(Vittoria e Luisa) «a volte si sentono», come racconta il cugino Emanuele
Filiberto, precisando «come il figlio primogenito di Aimone sarà l’erede
legittimo del ramo dei Savoia Aosta. Ma i Savoia Carignano, il ramo principale,
continuano con Vittoria. Un conto sono i rami cadetti, un altro il ramo
principale, così è la storia». Sul «pensionamento» della Legge Salica i
monarchici intanto si sfidano a colpi di lettere, dopo la doppia intervista al
Corriere di Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto. Dalla tenuta di Castiglion
Fibocchi dove vive Amedeo d’Aosta il messaggio è perentorio: «La titolarità
della Real casa di Savoia spetta al principe Amedeo duca di Savoia e d’Aosta, e
ai suoi successori dinastici». E la Consulta dei senatori del regno vicina ad
Aimone di Savoia, Silvia e il principe Amedeo di Savoia, duca di Aosta dice che
«fino alla restaurazione della monarchia costituzionale, la legge Salica è
immodificabile». E dunque, sostengono i monarchici vicini agli Aosta, non
essendoci un trono «operativo», il trono resta ereditario secondo la Legge
Salica. Tagliando fuori la discendenza femminile. Per giustificare la sua
posizione, il segretario della Consulta dei senatori Gianni Stefano Cuttica e il
presidente della Consulta Aldo A. Mola, citano una lettera del 25 gennaio 1960
di Umberto II da Cascais sulla immutabilità e inviolabilità «della legge della
nostra Casa, vigente da ben 29 generazioni e rispettata dai 43 Capi Famiglia,
miei predecessori, succedutisi secondo la legge Salica (…) Nessuno potrebbe
riconoscere valido il mio operato». Per la Consulta dei senatori la parola di
Umberto II resta l’unica valida. Perché secondo la fronda che contesta la scelta
di Vittorio Emanuele «solo nell’esercizio effettivo dei loro poteri e
nell’ambito di una nuova Costituzione la corona e le legittime rappresentanze
degli italiani (i due rami del Parlamento) potrebbero procedere a eventuali
modifiche dello Statuto». Adesso è una «legge perpetua ed irrevocabile della
monarchia come dichiarò re Carlo Alberto», dicono. E intanto hanno chiesto
parere a giuristi e storici. Pier Luigi Duvina, presidente della Consulta vicina
(invece) a Ginevra, al ramo Savoia Carignano ribatte che «la Consulta dei
senatori del regno che io presiedo è l’unica riconosciuta... e Vittorio Emanuele
non ha abrogato la legge Salica ma l’ha adeguata, in base al Trattato di Lisbona
del 2009 (nel 2007 la firma) che impone ai Paesi dell’Unione Europea
l’uguaglianza di genere e quindi la parità dei diritti tra uomo e donna. Legge
recepita anche dalla Repubblica italiana». Il 19 gennaio Emanuele Filiberto
dovrebbe intervenire all’Assemblea annuale delle Guardie d’Onore al Pantheon a
Roma, e si vedrà la reazione dei circoli monarchici che già si stanno dividendo
sulla questione.
·
Liberatori d’Italia
dal nazifascismo: pellerossa e non comunisti.
Quei "buoni scalpi" che liberarono l'Italia.
Tremila pellerossa erano volontari nelle truppe canadesi e molti
combatterono nella penisola. Luca Crovi, Mercoledì 24/06/2020 su Il Giornale.
Quando il regista Quentin Tarantino nel film Bastardi senza gloria raccontò le
gesta di un gruppo di soldati americani capitanati da Brad Pitt che agiscono in
Francia atterrendo le truppe tedesche scalpandole, alcuni spettatori pensarono
subito a un'esagerazione e a un falso storico. Eppure ci sono stati davvero
momenti in cui le truppe alleate si sono dovute misurare con la riapplicazione
di quella terribile tortura e sono state invitate a praticarla. Lo racconta nel
dettaglio il giornalista Matteo Incerti nel volume I pellerossa che liberarono
l'Italia (Corsiero Editore, pagg. 398, euro 18). Il 4 luglio del 1943 a bordo
della His Majesty Transport Circassia in mezzo all'Oceano Atlantico venne fatto
ascoltare agli uomini diretti verso le coste della Sicilia meridionale un
messaggio speciale del generale Christopher Vokes che scosse non poco
l'equipaggio: «Il nostro motto è: siamo la divisione dei buoni scalpi! Alla
vigilia del nostro battesimo del fuoco, per il quale ci siamo tutti addestrati
così duramente e a lungo, desidero indicare lo spirito che guiderà tutti noi
fino alla fine di questa campagna e le successive. Primo: siamo uomini liberi,
in lotta per una giusta causa; quindi siamo invincibili. Secondo: snideremo e
distruggeremo il nemico ovunque si troverà. Terzo: saremo duri e spietati; non
dovremo mai rilassarci o arrenderci fino a quando la vittoria sarà nostra.
Quarto: non dovremo fare prigionieri fino a che non sarà nostra prerogativa
essere clementi. Quinto: solo i codardi si arrendono. Presenterò a ogni unità
una copia del secondo stendardo della brigata, sarà conosciuto come George
Baker. Lo porteremo con noi attraverso l'Italia e la Germania. Buona fortuna e
buoni scalpi a tutti voi!». La Brigata Baker comprendeva nelle sue forze molti
soldati di origine pellerossa che si erano arruolati nelle forze canadesi come
volontari. Uomini coraggiosi che si illusero come già accaduto ai loro padri che
schierandosi con l'Impero britannico avrebbero difeso i loro diritti. Fra gli
uomini reclutati per quello sbarco, che in codice era stato battezzato come
Operazione Husky, c'era anche Jerry Brant, un ventisettenne Irochese Mohawk
della Baia di Quinto nell'Ontario, che si sentì offeso dalle parole del generale
Vokes e sfogò tutta la sua rabbia con Roy Durnford, il cappellano dei Seaforths:
«Siete giunti dall'Europa accusando tutti noi di essere selvaggi che
scotennavano donne e bambini. Ma è falso. Solo pochi guerrieri prendevano scalpi
dei nemici uccisi in battaglia. E solo di uomini già morti e in segno di onore e
rispetto... L'uomo bianco ha iniziato alla fine dello scorso secolo uno
squallido mercato di scalpi, non noi. Anche se ucciderò un tedesco, io non
prenderò mai uno scalpo dei miei nemici». Jerry Brant, che portava sul suo corpo
le cicatrici del suo lavoro di stalliere, faceva parte degli oltre tremila
pellerossa di diverse tribù del Canada che si erano arruolati volontari. «Lo
aveva fatto sulle orme di chi aveva combattuto sui fronti europei nella Grande
guerra. Ora i pellerossa erano di nuovo pronti a sacrificare la propria vita per
l'Impero di Sua Maestà. Vestire la divisa dell'esercito dell'acero, oltre a una
paga più dignitosa di quella offerta per gli umili lavori nelle riserve, era
anche l'inizio di un rischioso percorso di riscatto sociale». E così centinaia
di indiani Mohawk, Creek, Irochesi, Ojibwa, Cherokee sbarcarono in Italia e
contribuirono con il loro coraggio a liberarla, battaglia dopo battaglia, da
Agira a Salerno, da Ortona ad Anzio, da Cassino fino alla Linea Gotica orientale
in Romagna. Eroi presto dimenticati. Una cinquantina di loro morirono sul suolo
italiano e vi vennero seppelliti con onore. I pellerossa che sopravvissero alle
missioni di guerra, tornati in patria cercarono di ricostruirsi un'identità di
uomini liberi come operai, capi tribù, attori, pittori. Molti di loro compresero
però che la loro battaglia avrebbe avuto inizio e fine solo in Italia, come il
Creek Joseph Flavien St. Germain che, decorato sul campo dal maggiore Stone,
confessò amaramente: «Prima che questa guerra sia finita spero di morire
maggiore. Tutti qui mi chiamano il Santo ma quando tutto finirà, quando
torneremo a casa, sarò di nuovo un cittadino di seconda classe. Sarò nuovamente
quello che voi chiamate un indiano e non potrò nemmeno entrare in un bar».
Quelli che…o tutti o nessuno e poi vogliono la secessione!
Lo sproloquio
del saggista e sociologo storico Antonio Giangrande. Da far riflettere…
2 e 3 giugno:
Si festeggiano il giorno della Repubblica ed il giorno della libera circolazione
tra regioni.
Il tutto sotto
diktat della Padania.
I Padani hanno
voluto l’Unità d’Italia per depauperare l’Italia meridionale.
I Padani
comunisti hanno voluto la Repubblica per continuare a saccheggiare l’Italia
Meridionale.
I Padani con
le sedi legali delle loro aziende nei paradisi fiscali vogliono continuare a
dettar legge con la scusa della secessione.
L’Italia
divisa in due.
MAGGIO 1860, IL RUOLO DELLA GRAN BRETAGNA NELL’ATTACCO ALLA
SICILIA E AL REGNO DELLE DUE SICILIE. Michele Eugenio
Di Carlo, Giovedì, 28 Maggio 2020 su retegargano.it. Uno dei più dettagliati
resoconti della spedizione garibaldina - tanti ne hanno tratto informazioni
senza citare la fonte - resta quello di Giacinto de’ Sivo. Con precisione
assoluta lo scrittore di Maddaloni descrive l’apparato di sicurezza che il
Governo aveva disposto per proteggere la Sicilia dall’invasione ritenuta certa:
quattro fregate a vapore, due a vela, nove piroscafi da guerra, che navigavano
incessantemente lungo le coste siciliane. Considerate anche le forze di Polizia
e le Guardie Urbane, supporre che Giuseppe Garibaldi, nel caso fosse riuscito a
sbarcare, potesse andare oltre Marsala non era proprio possibile. Per de’ Sivo
era del tutto chiaro: la forza di Garibaldi era stata costruita a tavolino, in
particolare dalla potentissima macchina della propaganda inglese. E quanto
Cavour, convintosi a favorire la spedizione, cercò di metterne a capo Nino
Bixio, «allora dolentissimo il Nizzardo, scordò la venduta patria, e scrisse
umilissime lettere al La Farina, scongiurandolo d’aiutarlo… ». Sicuramente era
stata proprio l’azione di mediazione di Giuseppe La Farina a spingere Garibaldi
ad incontrare Camillo Cavour e Vittorio Emanuele II a Bologna il 2 maggio, al
fine di addivenire ad un accordo, come già supposto dallo storico Pietro
Pastorelli. Ed è così che «quel marinaio già dalla stampa mazziniana
magnificato, quasi promesso da’ fati, per patti segreti tra reggitori di popoli
potenti, con l’oro del Piemonte indebitato a posta, doveva lanciarsi a portar
guerra civile nelle Sicilie».
Dopo l’unificazione artefatta e truffaldina dell’Unità d’Italia
venne la nascita della Repubblica, altrettanto artefatta e truffaldina voluta
sempre dalla gente del nord.
L’Italia divisa in due.
Referendum 2 giugno 1946, Monarchia o Repubblica? Come
votarono le regioni. Circa 25 milioni di cittadini
(gli aventi diritto al voto erano 28 milioni) si recarono alle urne: il
risultato fece emergere un’Italia divisa tra Nord e Sud. Silvia Morosi il 2
giugno 2020 su Il Corriere della Sera. Ogni anno, il 2 giugno, l’Italia ricorda
il referendum del 1946 con cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra la
Monarchia e la Repubblica. Esaurito il ventennio di dittatura fascista, per la
prima volta la società italiana visse l’esperienza di libere elezioni a
suffragio universale maschile e femminile: si votò (domenica 2 e lunedì 3
giugno, ndr) per l’elezione di un’Assemblea Costituente, alla quale sarebbe
stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale (come
stabilito con il decreto legislativo luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944),
e contemporaneamente si tenne un referendum istituzionale per la scelta —
appunto — tra Monarchia (che ottenne 10.719.284 voti) e Repubblica (12.717.923).
Un milione e mezzo furono le schede bianche e nulle. Nel 1946 gli aventi diritto
al voto erano 28 milioni, i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878 per la
precisione), pari all’89,08% (qui i dati sul sito del Quirinale). Certo, è bene
ricordare che non tutti gli italiani poterono recarsi alle urne: ad essere
esclusi furono, ad esempio, i militari prigionieri di guerra nei campi degli
alleati; gli internati in Germania; gli abitanti della provincia di Bolzano; e
nemmeno a Trieste, Pola, Fiume e Zara.
Un'Italia divisa in due. La Repubblica ottenne, quindi, poco più
del 54 per cento dei voti. A esprimersi, fu un’Italia spaccata tra Nord e Sud.
Ma come si espressero gli allora «compartimenti»? Il Nord votò a maggioranza
repubblicana mentre il Sud confermò la tradizionale fedeltà all'istituto
monarchico. Qualche esempio? In Piemonte, culla dei Savoia, la repubblica
ottenne 1.250.070 voti, in Toscana 1.280.815. In Sicilia, al contrario, furono
1.301.200 i voti per la monarchia e «solo» 708.109 quelli per la Repubblica. In
Campania, ancora, 1.427.038 quelli per la monarchia, 435.844 quelli per la
Repubblica. Una curiosità? La Repubblica ottenne il risultato più ampio a
Trento, dove conquistò l’85 per cento dei consensi; mentre Napoli fu la città
dove la Monarchia ottenne il risultato migliore (79%).
La Repubblica parlamentare. Da monarchia costituzionale l'Italia
diventava, così, una Repubblica parlamentare. Il primo luglio fu nominato il
primo presidente della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola, mentre Alcide De
Gasperi fu il primo presidente del Consiglio, e con il primo gennaio del 1948
entrò in vigore la nuova Costituzione.

|
REGIONE NORD |
SEZIONI |
REPUBBLICA |
MONARCHIA |
|
Piemonte |
3529 |
1.250.070 |
938.945 |
|
Liguria |
1470 |
633.130 |
284.692 |
|
Lombardia |
5241 |
2.270.335 |
1.275.183 |
|
Venezia Tridentina
(Escluso Bolzano e Trieste) |
465 |
191.450 |
33.728 |
|
Veneto |
3636 |
1.403.441 |
954.372 |
|
Emilia Romagna |
2928 |
1.526.838 |
454.589 |
|
Toscana |
2781 |
1.280.815 |
506.167 |
|
Marche |
1126 |
498.607 |
213.621 |
|
Umbria |
631 |
301.209 |
117.755 |
|
TOTALE |
21.807 |
9.355.895 |
4.779.052 |
|
REGIONE SUD |
SEZIONI |
REPUBBLICA |
MONARCHIA |
|
Lazio |
2212 |
753.978 |
795.501 |
|
Abruzzo e Molise |
1264 |
347.578 |
459.478 |
|
Campania |
2770 |
435.844 |
1.427.038 |
|
Puglie |
1950 |
465.620 |
954.754 |
|
Lucania |
394 |
107.653 |
158.210 |
|
Calabria |
1337 |
337.244 |
514.633 |
|
Sicilia |
2827 |
708.109 |
1.301.200 |
|
Sardegna |
859 |
206.098 |
319.557 |
|
TOTALE |
13613 |
3.362.124 |
5. 930.371 |
Con la Repubblica inizia il declino dell’Italia Meridionale e la
differenza tra le due Italie si perpetua.
Lo scippo della Spesa Storica che toglie al Mezzogiorno e regala
al Nord è l’origine del declino italiano. E tutti i Governatori del Sud
tacciono. Come sempre. Roberto Napoletano il 30 aprile 2020 su Il Quotidiano del
Sud. Tutti tacciono. Come hanno fatto negli ultimi venti anni. Hanno sempre
qualche emergenza di cui occuparsi. Spicciano pratiche. Hanno una conference
call dietro l’altra (prima incontravano gente). Zitti e muti. I soldi loro vanno
da un’altra parte, ma loro non se ne accorgono. Se glielo spieghi, ti guardano
strano. Preferiscono il silenzio. Dopo diranno che non hanno capito. Si
spartiranno le briciole – se ci sono – che i ricchi lasceranno cadere dai tavoli
imbanditi con le pietanze rubate ai poveri. Che sono loro. Quelli che stanno
zitti quando dovrebbero urlare e strepitano o piagnucolano quando non serve a
nulla. Facciamo presente che se avere chiuso un occhio con 60 e passa miliardi
di spesa pubblica dovuti al Sud e regalati al Nord ogni anno negli ultimi dieci
anni è stato grave. Lo scippo della Spesa Storica che toglie al Sud e regala al
Nord – è l’origine del declino italiano – lo si vuole replicare approfittando
della Pandemia, nonostante il disastro della superforaggiata Lombardia. Mi
raccomando – lo dico provocatoriamente ma vale per tutti e per chiunque abbia
un po’ di sale in zucca della classe dirigente meridionale – non disturbiamo il
manovratore e occupiamoci di distanze in casa e al bar.
Quando il Governo Letta penalizzò le Università del Sud per
favorire quelle del Nord. Michele Eugenio Di Carlo su
I Nuovi Vespri il 6 maggio 2020. La sottrazione di risorse alle Università
povere (quelle del Sud) per favorire le università ricche (quelle del Nord, che
non sono affatto le migliori) ha determinato la migrazione di studenti (e di
risorse finanziarie) dal Sud al Nord. Una vergogna infinita e uno scandalo
ignorato. Sentire che tanti nostri studenti universitari, e i propri familiari,
in questi giorni si lamentano di dover pagare affitti mentre le università sono
praticamente chiuse, mi fa proprio male e mi costringe a riferire quello di cui
pochi sono a conoscenza. Fu un provvedimento del governo di Enrico Letta e della
ministra dell’Istruzione di allora, Maria Grazia Carrozza, a penalizzare
fortemente le università del Sud con una sorta di decreto ammazza università
meridionali che ha dato soldi alle università ricche e li ha sottratti a quelle
povere. Badate bene, non a quelle migliori, a quelle più ricche. Lo scrive
peraltro l’amico Pino Aprile nel suo ultimo testo “L’Italia è finita”, come
sempre una miniera di informazioni. Tanto che l’economista barese Gianfranco
Viesti – ricordo che è anche cittadino onorario della città di Vieste – ne
scrisse un libro di denuncia: “La laurea negata”, arrivando a dire che tanto
valeva farle chiudere. Un decreto che andò a peggiorare le già antimeridionali
norme dei precedenti ministri Profumo e Gelmini. Ora uno studente meridionale su
due (8 su 10 in Basilicata) sceglie un università del Nord e questo comporta
l’ennesimo esborso di miliardi che passano da Sud a Nord, quasi non bastasse la
tristissima e abominevole emigrazione sanitaria.
Michele Emiliano a Stasera Italia su Rete4 (Rete Lega) del 3
maggio 2020. «Innanzitutto noi abbiamo aumentato di millecinquecento posti i
posti letto autorizzati da Roma. E abbiamo subito approfittato di questa cosa.
Devo essere sincero: il sistema sanitario pugliese è un sistema sanitario
regolare. Noi non abbiamo mai avuto problemi sulle terapie intensive. Quindi
però, Pomicino evidentemente è intuitivo, capisce che questo è il momento per
cui le sanità del Sud…siccome i nostri non possono più andare al Nord per
curarsi perché è troppo pericoloso, devono essere rinforzate per limitare la
cosiddetta mobilità passiva. Quindi io l’ho detto chiaro: io non terrò più conto
dei limiti, posti letto, assunzioni, di tutta questa roba, perché non siamo in
emergenza. Farò tutte le assunzioni necessarie, assumerò tutte le star della
medicina che riuscirò a procurarmi, cercherò di rinforzare i reparti. Manterrò i
posti letto in aumento. Anche di più se possibile. Chiederò ai grandi gruppi
privati della Lombardia per i quali c’è una norma che li tutelava in modo
blindato. Immaginate: io potevo pagare senza limite i pugliesi che andavano in
Lombardia presso queste strutture, se queste strutture erano in Puglia c’era un
tetto massimo di spesa fatto apposta…Siccome questo tetto deve saltare, io sto
proponendo a questi grandi gruppi di venire e spostarsi al Sud per evitare il
rischi Covid, ma soprattutto per evitare il rischio aziendale per loro. Perché è
giusto che questa mobilità passiva: 320 milioni di euro di prestazioni sanitarie
che la Puglia paga alla Lombardia in prevalenza, solo perché quel sistema è
stato supertutelato. Adesso tutti dovremmo trovare il nostro equilibrio e la
nostra armonia».
Tgnorba Il Fatto del 29-05-2020. Editoriale a cura del direttore
Enzo Magistà di venerdì 29 maggio. Nel presentare il “decreto rilancio” e le
riaperture del 18 maggio il presidente Conte annunciò che il 3 giugno, cioè da
mercoledì prossimo, sarebbe stato possibile prevedere la ripresa anche della
libera circolazione tra le regioni italiane. Però precisò: tutto sarebbe stato
collegato alle condizioni della pandemia territorio per territorio, regione per
regione. Tanto che si creò una specie di misuratore che indicava il rischio:
alto, medio, oppure, assente. Le regioni a rischio alto, disse Conte, sarebbero
rimaste chiuse; quelle senza rischio sarebbero state riaperte. Avrebbero potuto
collegarsi fra loro. In pochi giorni, però, le cose sono cambiate. Ieri le
regioni hanno fatto sapere al Governo di non essere d’accordo sulle riaperture
differenziate. O tutti o nessuno. Il Governo si è un po’ spazientito, però,
sembra essere disponibile. Però non tutte le regioni italiane sono a rischio
controllato, è molto probabile che la libera circolazione sull’intero territorio
nazionale possa slittare di una settimana: non più il tre, ma il 10 giugno. Non
ci cambia la vita, però ci fa rabbia lo stesso. Perché ancora una volta ci si
inchina al volere, per non dire al diktat, delle regioni del nord: Lombardia e
Veneto in particolare. Sono le regioni italiane più a rischio. E quindi Fontana
e Zaia sono stati loro a cavalcare la tesi del “tutti o nessuno”, perché,
altrimenti, sarebbero rimaste chiuse. A loro, stavolta, fa comodo, sposare
questa tesi, “tutti o nessuno”. Ma in altre occasioni non è stato così. Anzi, in
tantissime altre occasioni non hanno fatto altro che rivendicare il contrario,
fino a chiedere una autonomia esagerata. Vogliono l’autonomia su tutto: sulle
tasse, sulla salute, la scuola, ecc.. Però quando si deve riaprire, siccome loro
non possono riaprire: no! O tutti o nessuno. Sarebbero le sole a restare chiuse:
allora no! O tutti o nessuno. Purtroppo, però, questo è il dramma: vincono
sempre loro.
Gli strani risultati del referendum del 2 giugno 1946:
Repubblica sconfitta dalla Monarchia al Sud. Redazione
Bufale.net il 2 Giugno 2020. Ci state segnalando in massa una foto riguardante
il referendum del 2 giugno 1946, quello che a conti fatti ha segnato la storia
recente del nostro Paese. Stiamo parlando della sfida tra Repubblica e
Monarchia, con la vittoria davvero risicata del fronte repubblicano e l’addio ai
Savoia per l’Italia. Insomma, una vera e propria votazione “costituzionale“, ben
diversa da quelle che abbiamo analizzato in questi anni anche sul nostro sito,
come probabilmente avete notato con alcuni nostri approfondimenti.
I risultati per regioni con referendum del 2 giugno 1946 tra
Repubblica e Monarchia. Come sono andate esattamente le cose con il referendum
del 2 giugno 1946? Vi diciamo subito che la foto in questione è reale. La
battaglia elettorale tra Repubblica e Monarchia è stata estremamente tirata
soprattutto per le scelte che sono state fatte al Sud. Sorprendono, ma sono
reali, i numeri riscontrati dal Lazio in giù, visto che più si scende nello
stivale, più si nota la propensione degli italiani a preferire la seconda
opzione. Nonostante il particolare e complesso momento storico che si stava
vivendo in quella fase. Se da un lato i dati del Lazio sono tutto sommato molto
equilibrati, con una leggera preferenza per la Monarchia, dalla Campania in poi
si assiste ad un vero e proprio dominio. Addirittura, in questa regione i voti
per la Repubblica risultano tre volte inferiori rispetto all’altra opzione.
Dunque, le foto che stanno circolando in queste ore sui social a proposito del
referendum del 2 giugno 1946 sono reali, coi dati che possono essere consultati
più da vicino tramite il sito Storiologia. Negli anni, i sociologi non hanno mai
seguito una linea comune nell’analisi dei risultati riguardanti il referendum
del 2 giugno 1946. C’è chi parla di meno scolarizzazione al Sud, chi imputa alla
presenza degli Alleati nel Mezzogiorno, per anni, la voglia di tornare alla
Monarchia, o più semplicemente della scarsa propensione al cambiamento con
l’opzione Repubblica.
Referendum 02/06/1946 Area ITALIA
Elettori 28.005.449
Votanti 24.946.878 89,08%
Voti validi 23.437.143
Schede bianche 1.146.729
Schede non valide (bianche incl.) 1.509.735
Repubblica 12.718.019 54,27%
Monarchia 10.709.423 45,73%
2 GIUGNO 1946 L'ITALIA E' REPUBBLICANA (LO SDEGNO NEL PROCLAMA DI
UMBERTO) (dal Libro-Agenda "FINO AL 2001 E ....RITORNO" di Francomputer-
Copyright - deposito SIAE)
2 GIUGNO - "Roma - Notizie pervenute all'Ansa dai più importanti
centri italiani confermano che le operazioni di voto
si sono svolte ovunque regolarmente e con notevolissima affluenza
di votanti".
DA NOTARE QUESTA ANOMALIA, CHE AL REFERENDUM NON HA PARTECIPATO
LA POPOLAZIONE DI BOLZANO, DI TRIESTE E TUTTE QUELLE LOCALITA' ASSEGNATE
ALL'ITALIA DOPO IL TRATTATO DI PACE DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE, E CHE POI
SONO STATE TOLTE O ASSEGNATE ALL'ITALIA SOLO DOPO IL TRATTATO DI PACE DEL 10
FEBBRAIO 1947.
INSOMMA LA PROVINCIA DI BOLZANO NEL 1946 NON ERA ITALIA !!
NE' LO ERANO I TERRITORI ASSEGNATI NEL 1919.
NESSUNO - NE' ALLORA NE' DOPO - HA MAI TROVATO DA RIDIRE SU
QUESTA ANOMALIA.
E LO SCRIVENTE NON LO HA MAI CAPITO, ANCHE PERCHE' NESSUNO LO HA
MAI SPIEGATO.
Totale definitivo comunicato il 18 giugno dalla Corte di
Cassazione in Parlamento. Dopo i controlli le cifre sopra subiscono queste
variazioni:
1) da apportare le seguenti modificazioni
a) sottrarre ai voti attribuiti alla Repubblica 4 voti;
b) sottrarre ai voti attribuiti alla Monarchia 30 voti;
c) aggiungere ai voti attribuiti alla repubblica 18 voti;
d) aggiungere ai voti attribuiti alla monarchia 25 voti.
2) Integrare i risultati delle varie sezioni mancanti
a) aggiungere voti alla repubblica 45.142;
b) aggiungere voti alla monarchia 30.384.
A FAVORE DELLA REPUBBLICA VOTI 12.717.923
A FAVORE DELLA MONARCHIA VOTI 10.719.284
SCHEDE VOTI NULLI 1.498.136 ( scarto di 1.998.639 )
(il dato esatto con le correzioni successivamente apportate fu
l'originario (per la monarchia) 10.688.902 , più 30.384 e meno 30, più 25 -
totalizzando un totale a favore della monarchia in 10.719.281 anzichè 10.719.284
voti).
I comunicati ANSA.
11 GIUGNO - Roma - Il consiglio dei ministri si consulta. Ha
interpretato nel senso più corretto l'art. 2 del decreto del 15 marzo 1946 il
quale fa sì che, proclamato l'esito del referendum, "ope legis" i poteri del
capo dello stato debbano essere assunti dal presidente del consiglio.
Nessun'altra interpretazione è possibile. La Corte di cassazione ha respinto le
eccezioni riguardanti il quorum e la mancata votazione a Trieste e Bolzano, che
non costituisce motivo per invalidare i risultati del referendum. (Ag. Ansa, 11
giugno, ore 15.30)
11 GIUGNO ORE 14.30 - L'opinione di re Umberto espressa al
presidente del consiglio, è che la Corte di cassazione debba emettere in un
altra adunanza il necessario giudizio definitivo prima dei passaggi dei poteri.
- ORE 21.00. Difficile passaggio dei poteri dopo vari incontri del presidente
del consiglio De Gasperi con il re. I partiti invitano De Gasperi a uscire
dalla situazione, prendendo rapidamente una decisione perchè l'incertezza è
pericolosa per il Paese. La seduta prosegue nella nottata. (Ag. Ansa. 11-6- ore
14,30)
12 GIUGNO ORE 01.50 - Conflitto di interpretazione tra governo e
Corona. - ORE 02.40 Il governo prende atto della proclamazione dei risultati
comunicati dalla Corte di Cassazione. (Ag. Ansa. 12-6- ore 02.40)
13 GIUGNO ORE 01.45 - Il governo riafferma la promulgazione dei
risultati fatti dalla Corte di cassazione ha portato automaticamente alla
instaurazione di un regime transitorio durante il quale, fino a quando
l'Assemblea costituente non abbia nominato il capo provvisorio dello stato,
l'esercizio della funzione del capo dello stato medesimo spetta "ope legis" al
presidente del consiglio in carica. Tale situazione costituzionale, creata dalla
volontà sovrana del popolo nelle forme previste dalle leggi luogotenenziali, non
può considerarsi modificata dalla comunicazione odierna di Umberto II al
presidente del consiglio.(Ag. Ansa. 13-6- ore 01.45)
13 GIUGNO ORE 18.45 - "Roma - Umberto II è partito oggi in aereo
dall'aeroporto di Ciampino alle ore 16.07. farà scalo a Madrid e proseguirà
domattina per Lisbona" (Ag. Ansa, ore 18.45 . Seguiranno particolari).
PROCLAMA di UMBERTO (testo integrale) (Ag. Ansa, ore 22.30)
13 GIUGNO ORE 22.30 - "AG. Ansa - Roma - Ecco il testo del
proclama lanciato da Umberto II agli italiani prima di partire: --- "Italiani!
Nell'assumere la Luogotenenza generale del Regno prima, e la Corona poi, io
dichiarai che mi sarei inchinato al voto del popolo, liberamente espresso, sulla
forma istituzionale dello stato. Eguale affermazione ho fatto subito dopo il 2
giugno, sicuro che tutti avrebbero atteso le decisioni della Corte di
cassazione, alla quale la legge ha affidato il controllo e la proclamazione dei
risultati definitivi del referendum. Di fronte alla comunicazione di dati
provvisori o parziali fatta dalla Corte di cassazione; di fronte alla sua
riserva di pronunciare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far
conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli; di fronte alla questione
sollevata e non risolta nel modo di calcolare la maggioranza, io ancor ieri ho
ripetuto che era mio diritto e dovere di re attendere che la Corte di
cassazione facesse conoscere se la forma istituzionale repubblicana avesse
raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente, questa notte, in spregio alle
leggi ed al potere indipendente e sovrano della magistratura, il governo ha
compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo con atto unilaterale ed arbitrario
poteri che non gli spettano e mi ha posto nell'alternativa di provocare
spargimento di sangue o di subire violenza. Confido che la magistratura, le cui
tradizioni di indipendenza e di libertà sono uno delle glorie d'Italia, potrà
dire la sua libera parola; ma non volendo opporre la forza al sopruso, nè
rendermi complice della illegalità che il governo ha commesso, io lascio il
suolo del mio paese, nella speranza di scongiurare agli italiani nuovi lutti e
nuovi dolori. Compiendo questo sacrificio nel supremo interesse della Patria,
sento il dovere, come italiano e come re, di elevare la mia protesta contro la
violenza che si è compiuta: protesta nel nome della corona e di tutto il popolo,
entro e fuori i confini, che aveva il diritto di vedere il suo destino deciso
nel rispetto della legge in modo che venisse dissipato ogni dubbio e ogni
sospetto. A tutti color che ancora conservano la fedeltà alla monarchia, a tutti
coloro il cui animo si ribella all'ingiustizia, io ricordo il mio esempio, e
rivolgo l'esortazione a voler evitare l'acuirsi di dissensi che minaccerebbero
l'unità del Paese, frutto della fede e del sacrificio dei nostri padri, e
potrebbero rendere più gravi le condizioni del trattato di pace. Con l'animo
sereno colmo di dolore, ma con la serena coscienza di aver compiuto ogni sforzo
per adempiere ai miei doveri, io lascio la mia Patria. Si considerano sciolti
dal giuramento di fedeltà al re, non da quello verso la Patria, coloro che lo
hanno prestato e che vi hanno tenuto fede attraverso tante durissime prove.
Rivolgo il mio pensiero a quanti sono caduti nel nome d'Italia e il mio saluto a
tutti gli italiani. Qualunque sorte attenda il nostro paese, esso potrà sempre
contare su di me come sul più devoto dei suoi figli. Viva l'Italia!" (Ag. Ansa,
ore 22.30)
13 GIUGNO ORE 24 - LA REAZIONE DEL GOVERNO - (Com. Ag. Ansa, ore
24)- "Roma - La Presidenza del Consiglio comunica: "La partenza del re, avvenuta
alle ore 15,40 da Ciampino, è stata con ogni cura tenuta nascosta al governo.
Gli organizzatori della partenza, dovendo chiedere l'aeroplano al ministro
dell'Aeronautica, gli telefonarono all'ultimo momento di non avvertire il
presidente del consiglio, al quale avrebbero essi stessi fatta comunicazione. Il
presidente invece ne fu avvertito da altra parte. Poco dopo la partenza si è
sparsa la voce che si stesse formulando un proclama. Questa sera infatti l'Ansa
trasmetteva alle ore 22.30 il proclama del re al popolo italiano. "Il proclama è
un documento penoso impostato su basi false e su argomentazioni artificiose.
Esso afferma il falso quando definisce come semplice comunicazione di dati la
proclamazione dei risultati del referendum fatta dalla Cassazione il 10 giugno.
Esso mente quando parla di una improvvisa affermazione del Consiglio dei
ministri avvenuta nella passata notte, circa gli effetti costituzionali della
proclamazione. E' vero al contrario che già nella notte del 10-11 giugno il
Consiglio "prese atto della proclamazione dei risultati del referendum che
riconosceva la maggioranza alla repubblica, riservandosi di decidere sui
provvedimenti concreti che ne derivano. Dopo ciò e nonostante questa
affermazione risolutiva il sovrano continuò a trattare col presidente del
consiglio per i due giorni successivi circa la proposta di una delega dei poteri
regi al presidente non denunciando in tale presa di posizione del Consiglio
alcun "gesto rivoluzionario nè alcun "atto unilaterale e arbitrario". Ieri
mattina il sovrano mandava la nota lettera, la quale ignorava la proclamazione
avvenuta dalla Corte di cassazione e costringeva così il governo a ribadire il
suo punto di vista circa gli effetti costituzionali della proclamazione. A
proposito di questo secondo ordine del giorno del Consiglio che il proclama del
re parla di "gesto rivoluzionario e dell'assunzione unilaterale e arbitraria di
"poteri che non gli spettano", mentre nel testo dell'ordine del giorno non si
parla affatto di effettiva assunzione di poteri, cioè dell'esercizio di essi, ma
si fa solo la questione di principio circa la competenza. Anzi risulta evidente
che il governo per far opera di concordia aveva differita la deliberazione dei
provvedimenti, già annunziati lunedì scorso. Nessun pretesto quindi nè di
accusare "di spregio alle leggi e al potere indipendente e sovrano della
magistratura nè di aver posto il sovrano "nell'alternativa di provocare
spargimento di sangue o di subire la violenza". Egli avrebbe potuto
tranquillamente continuare le discussioni e le consultazioni, oppure mantenere
semplicemente le sue riserve. Gli uomini che stanno al governo e in particolare
il presidente del Consiglio gli avevano dato fino all'ultimo la prova che
desideravano e ricercavano tenacemente una soluzione pacifica. Bisogna
aggiungere che il re personalmente aveva riconosciuto più di una volta la lealtà
e la correttezza di tale atteggiamento, cosa che i compilatori del proclama
sembrano ignorare. Il re poteva quindi attendere con serenità il giudizio sulle
contestazioni e sui ricorsi da parte della Cassazione (la cui libertà il governo
intende rispettare pienamente) senza temere soprusi e senza essere costretto a
partecipare all'illegalità. I due ultimi periodi del proclama, quello che
scioglie dal giuramento e quello che rivolge un saluto ai caduti ed ai vivi sono
due periodi superstiti del proclama che Umberto aveva in precedenza preparato
per un pacifico commiato. Ameremmo credere che quanto di fazioso e di mendace vi
si è aggiunto in questa definitiva sciagurata edizione sia prodotto dal clima
passionale e avvelenato degli ultimi giorni. La responsabilità tuttavia è
gravissima e un periodo che non fu senza dignità si conclude con una pagina
indegna. Il governo e il buon senso degli italiani provvederanno a riparare a
questo gesto, rinsaldando la loro concordia per l'avvenire democratico della
Patria.
(Ag. Ansa, ore 24) (Facciamo qui presente che Re Umberto II non
ha mai abdicato ed anzi in base alle dichiarazioni fatte successivamente dal
medesimo durante il suo lungo solitario ed estenuante esilio forzato (a seguito
del discusso referendum istituzionale che lo stesso Massimo Caprara segretario
dell'on. Palmiro Togliatti ha rivelato che vi fu un aiutino di oltre tre milioni
di schede), ha sempre affermato che si trattò di un golpe del governo che non
avrebbe riconosciuto neppure l'esito del referendum in caso di vittoria per la
monarchia. Sia il testo di Luciano Regolo, sia le dichiarazioni dello stesso
Umberto registrate dalla Rai, sia i testi di Gigi Speroni, Silvio Bertoldi e
dello stesso Amedeo Duca d'Aosta, mai smentite da nessuno eccetto da stampa di
parte, sono a sostegno di ciò, nonchè numerosi testi di storia costituzionale e
di diritto, tra i quali in dotazione in numerosi atenei. Inoltre la Repubblica
non è stata mai Proclamata all'indomani da parte della Suprema Corte di
Cassazione che aveva competenza giurisdizionale per il risultato dei voti e per
la pronuncia dell'esito del referendum.)
18 GIUGNO - Alle ore 18.00 nell'aula di Montecitorio, il
Presidente della Corte di cassazione, Giuseppe Pagano, ha dato lettura del
verbale relativo al giudizio definitivo e ha comunicato i risultati dopo le
contestazioni, le proteste e i reclami dei monarchici. (le cifre che abbiamo già
riportato sopra). Rimase sempre il mistero sul numero complessivo degli aventi
diritto al voto, conteggiati in 28.005.449 contro (dicono alcuni - vedi "Il Re
di Maggio", accurata biografia scritta da Lucio Lami) i 24.000.000 effettivi; e
il numero delle schede nulle non conteggiate nella definizione del quorum di
maggioranza. (vedi l'anomalia di Bolzano, Trieste ecc. citata sopra) "La Corte
di Cassazione, alla quale competeva de jure legis di verificare la regolarità
del voto e di proclamare ufficialmente i risultati referendari, fu "intimidita
e sopraffatta" - come spiega nei dettagli Lami - da Togliatti. E il Governo, con
un colpo di mano (che fu in effetti un vero e proprio colpo di Stato) nella
notte tra il 12 e il 13 giugno s'impadronì del potere, nominando Alcide De
Gasperi capo provvisorio dello Stato". Lo riportiamo come dovere di cronaca.
"Le schede truccate del referendum del '46, mio padre vide
tutto". Negli scantinati del Viminale "pacchi di fogli
con la croce per la Repubblica". Parla il figlio del brigadiere testimone dei
brogli. Luca Fazzo, Lunedì 12/12/2016 su Il Giornale. Pacchi su pacchi di
schede: «Così grossi, raccontava mio padre, che ci si potevano infilare le
braccia». Tutte schede già votate, e tutte con la croce sullo stesso segno: a
sinistra, sull'Italia turrita che simboleggiava la Repubblica, contro la
monarchia rappresentata dallo scudo dei Savoia. Il giovane brigadiere Tommaso
Beltotto vide quelle schede, negli scantinati del ministero degli Interni. Era
la notte del 4 giugno del 1946, e i risultati del referendum non erano stati
ancora annunciati, ma la voce nei palazzi romani già girava: vittoria alla
Repubblica, Umberto II si preparava all'esilio di Cascais. Di ombre su quel
risultato si è sempre parlato. Ma ora, a settant'anni di distanza, arriva il
ricordo di un testimone oculare dei brogli. Tommaso Beltotto allora aveva
venticinque anni, e già alle spalle una vita intensa. Controfirmò la relazione
del duca Giovanni Riario Sforza, comandante in capo dei corazzieri reali, con la
descrizione minuziosa di quei sacchi nelle cantine del Viminale. E proseguì la
sua vita da carabiniere. Sono passati settant'anni, Beltotto è morto nel 2001.
Di quei sacchi non ha più parlato, se non in famiglia. Oggi è suo figlio
Gianpiero a raccontare in presa diretta al Giornale l'immagine quasi fotografica
del referendum truccato, così come riferita da suo padre. A cosa dovessero
servire quei sacchi di schede truccate, Beltotto non lo sapeva, e non lo
sappiamo noi oggi: erano già state conteggiate come vere, o dovevano servire in
caso di bisogno per ribaltare un risultato sgradito? Di sicuro, erano la prova
concreta di un referendum fasullo. Suo padre si era scandalizzato? «Era un uomo
concreto, realista. Semplicemente, quando in televisione o sui giornali qualcuno
ipotizzava brogli nel referendum del 1946, sorrideva: c'è poco da ipotizzare, i
brogli li ho visti con i miei occhi». Il brigadiere Tommaso Beltotto non era lì
per caso, la notte del 4 giugno. Nel settembre del 1943, quando comandava la
stazione dell'Arma a Monterotondo, aveva avuto l'ordine di arrendersi ai
tedeschi e consegnare le armi: se ne era ben guardato, e si era unito alla
Resistenza con i suoi fucili e i suoi carabinieri. Durante la guerra civile
aveva fatto da collegamento tra le truppe partigiane di montagna e i reparti che
operavano a Roma: e fu testimone dei tentativi vani del Cln di bloccare
l'attentato di via Rasella. «Insomma - dice suo figlio - aveva una fama di
persona equilibrata e devota. Sono convinto che il maggiore Riario Sforza quei
sacchi di schede truccate li avesse già visti prima, e che avesse bisogno di un
testimone affidabile». Qualcuno, cioè, che non andasse a raccontare al bar
l'incredibile scoperta: e che però fosse pronto, nel momento del bisogno, ad
attestarne la verità. Così quando il duca Riario Sforza (che pochi giorni dopo
verrà ritratto in foto rimaste storiche, mentre saluta per l'ultima volta
Umberto che lascia il Quirinale) dovette scegliere qualcuno che controfirmasse
il suo rapporto, la scelta cadde quasi inevitabilmente su Beltotto, che non era
un suo subalterno, ma che aveva avuto modo di conoscere in quei frangenti
delicati e complessi. Erano due uomini perbene e rigorosi, il duca e il
brigadiere. Il primo devoto di casa Savoia. Il secondo carabiniere fin nel
midollo, «ma al referendum - dice il figlio - aveva votato Repubblica». Mettono
per iscritto ciò che hanno visto, e sanno di avere fatto il loro dovere.
Dell'esistenza del rapporto si è saputo nel settembre scorso, nell'aula del
processo a Palermo per la presunta trattativa Stato-mafia, ormai evoluto in una
bizzarra ricognizione giudiziaria dell'intera storia della Nazione. Un generale
in congedo dei carabinieri, Niccolò Gebbia, ha raccontato che la relazione di
Riario Sforza venne trasmessa al generale Romano Dalla Chiesa. L'originale, o
una copia, arrivò nelle mani del figlio del generale, Carlo Alberto: che proprio
per questo sarebbe stato corteggiato dal capo della P2, Licio Gelli, cui quel
rapporto avrebbe fatto gran gioco; ma evidentemente non lo ottenne. E i fogli
erano forse nella cassaforte della prefettura di Palermo che venne svuotata nel
1982 poco dopo che Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato ucciso. Che fine abbia
fatto il rapporto, insomma, non si sa: e potrebbe essere uno dei tanti misteri
delle nebbie impenetrabili che avvolgono quegli anni. D'altronde Riario Sforza è
morto da tempo, e sono morti anche i suoi due figli: e la nuora, Elisa, racconta
che «in casa di questa vicenda non ho mai sentito parlare». Ma per fortuna nelle
cantine del Viminale il duca non era da solo. C'era con lui il brigadiere
Beltotto. Era nato nel 1918 a Trinitapoli, in provincia di Foggia: e l'unica
vera marachella della sua vita era stata alzarsi l'età, per arruolarsi nell'Arma
prima ancora di essere maggiorenne. La sua biografia negli anni convulsi dopo
l'armistizio è simile a quella di tanti italiani disabituati a decidere dal
ventennio fascista, e che pure al momento di fare una scelta non si tirarono
indietro. Ma Beltotto ad orientarlo aveva una stella polare: l'Arma. Perché gli
alamari da carabiniere li aveva sulla pelle. E scelse la sua strada liberamente
solo perché era stato il Re a scioglierlo dal giuramento che aveva prestato.
D'altronde proprio Monterotondo, dove Beltotto era comandante, era stato teatro
di uno dei primi e più cruenti scontri tra reparti italiani e truppe tedesche,
paracadutate dalla Luftwaffe sulla cittadina per conquistare Palazzo Barberini,
sede provvisoria dello Stato Maggiore. Fece la sua parte, con semplicità e
concretezza, e non immaginava che di lì a poco si sarebbe trovato, in quella
cantina del Viminale, a fare da testimone a un crocevia della storia. Della
sorte del suo rapporto probabilmente non si preoccupò più, perché il suo dovere
lo aveva fatto e concluso firmandolo. Di come una copia, o l'originale, potesse
essere arrivata nelle mani di Dalla Chiesa forse non seppe niente, e comunque a
casa non ne parlò. «Ma io sono convinto - dice il figlio Gianpiero - che un
esemplare fosse comunque approdato a re Umberto, e che se si cercasse
attentamente nelle carte di Cascais qualcosa forse salterebbe fuori». Una sola
volta Beltotto ne parlò con un politico: avvenne a Ortisei, dove negli anni
Sessanta, ormai maresciallo, indagava sugli attentati degli indipendentisti. Un
politico passava spesso le vacanze in zona, e Beltotto confidò a lui la storia
dei sacchi di schede. Ma il politico si chiamava Giulio Andreotti e, ovviamente,
non lo disse a nessuno.
2/6/1946: repubblica a ogni costo, tra inganni e minacce. La
storia non detta. Antonio Pannullo giovedì 2 giugno
2020 su Il Secolo d'Italia. In questi giorni assistiamo a solenni celebrazioni
della Repubblica, convegni, mostre fotografiche, e lo stesso capo dello Stato ha
parlato della festa della Repubblica invitando gli italiani a riaffermarne i
valori. Ma quali sono questi valori? E soprattutto, come nacque questa
repubblica, quell’ormai lontano 2 giugno di 70 anni fa? Non è corretto, verso i
nostri giovani, nascondere loro la metà della storia. I nostri governanti, ormai
tutti repubblicani da tempo, sanno benissimo come nacque la repubblica e in
quale clima di guerra civile si svolse il referendum, e con quali garanzie di
trasparenza. Anzi, non era un clima di guerra civile, era ancora guerra civile.
Nel nord Italia le bande partigiane comuniste continuavano ad assassinare chi
non la pensava come loro: preti, fascisti, possidenti, cattolici, e anche
semplici nemici personali. La guerra non era finita da un anno, e ancora si
regolavano i conti con coloro che si pensava avessero potuto essere di ostacolo
alla dittatura comunista che si pensava di installare in Italia quanto prima,
con la complicità, l’appoggio, le armi e i soldi dell’Unione Sovietica.
2 giugno 1946: la vittoria repubblicana non era certa. Sconfitto
il fascismo, ora bisognava cacciare la monarchia, e non sembrava facile farlo,
in quanto la maggioranza degli italiani era attaccata alla vecchia istituzione.
Si pensò, per far apparire le cose in regola, di indire un referendum in cui il
popolo italiano potesse esprimersi. Ma la vittoria non era certa, tutt’altro.
Per cui, con la regia degli occupanti americani, e d’intesa con il Cln (Comitato
di Liberazione nazionale), si stabilirono le regole: si privavano del diritto di
voto gli abitanti della Venezia Giulia, della Dalmazia, dell’Alto Adige, della
Libia; inoltre non poterono votare tutti i prigionieri, gli sfollati, gli
epurati, e tutti i loro familiari. In tutto il nord le bande armate non
permisero un solo comizio elettorale dei monarchici, e allora esporsi e fare
propaganda equivaleva a morte certa. Le settimane precedenti alla consultazioni
si svolsero tra tensioni e incidenti gravissimi: il ministro dell’Interno, il
socialista Giuseppe Romita, trovandosi a corto di uomini per le forze
dell’ordine, pensò di inquadrare nella polizia ausiliari provenienti dalle bande
partigiane comuniste del nord, i quali trattavano la popolazione, soprattutto
quella del Sud, come un nemico. Furono soprannominate dal popolo “le guardie
rosse di Romita”. I nuovi vincitori insomma, con l’ombrello americano, avevano
deciso di istituire la repubblica a qualsiasi costo. Lo disse chiaramente il
leader socialista Pietro Nenni con la sua frase “O la repubblica o il caos”. Lo
disse il ministro comunista delle Finanze Scoccimarro in un comizio, che in caso
di vittoria della monarchia a referendum i comunisti avrebbero scatenato la
lotta armata; e tutto mentre Pertini chiedeva la fucilazione di re Umberto di
Savoia. Per evitare un’altra guerra civile molti italiani pensarono di votare la
repubblica. Ma ancora poteva non bastare: non si disse quanti erano gli aventi
diritto al voto, le schede uscite dalle urne sembra fossero un po’ troppe, molti
ricevettero più di un certificato elettorale, defunti compresi. Ovviamente, in
uno Stato uscito da una guerra devastante e flagellato da una guerra civile
strisciante, non si poteva pretendere uno svolgimento corretto, anche se vi
fosse stata buonafede. Nessuno sapeva bene cosa fare, le schede furono inviate a
Roma con mezzi di fortuna, chiunque poteva toccarle, chiunque poteva immetterne
di nuove, non c’era controllo, anche perché non ci poteva essere. Dopo il
referendum, le cose andarono ancora peggio: man mano che le istituzioni
dichiaravano la vittoria della repubblica, molte città insorsero, conscie della
scarsa regolarità delle consultazioni, come Palermo, Taranto, Bai, Messina, ma
soprattutto Napoli, dove per giorni centinaia di migliaia di persone
dimostrarono in favore della monarchia. Tutte queste proteste furono soffocate
nel sangue, e in particolar modo a Napoli, dove gli ausiliari mitragliarono la
folla assassinando una dozzina di persone, perlopiù giovanissimi. L’episodio è
noto come la strage di via Medina, ma non la si insegna a scuola né ci fu un
processo né c’è una lapide che ricordi le vittime. Era l’11 giugno 1946, e i
feriti furono oltre cento. Pochi giorni prima uno sconosciuto aveva tirato una
bomba a mano contro un corteo di monarchici, causando un morto e numerosi
feriti. Perché la popolazione era insorta? Perché si erano sparse notizie, e
forse qualcuno le aveva anche verificate, relative ai brogli di cui si parlerà
per gli anni a venire, prima che la cortina del silenzio calasse anche su questa
vicenda, come era calata per le foibe, per i crimini dei partigiani, per l’esodo
degli istriani. Su 35mila sezioni elettorali furono presentati 22mila ricorsi,
tutti respinti in pochi giorni. Lo spoglio delle schede pervenute
avventurosamente nella capitale si svolse nella sala della Lupa a Montecitorio
alla presenza della corte di Cassazione e degli ufficiali angloamericani
occupanti. L’Italia risultò ancora una volta divisa in due: il centronord per la
repubblica, il sud per la monarchia, tanto che dopo il referendum ci fu chi
propose di separare il sud dal Paese per creare un regno con a capo re Umberto.
2 giugno 1946: il senso di responsabilità di re Umberto. E mentre
la proclamazione ufficiale era attesa per il 18 giugno, e mentre la corte di
Cassazione stava ancora esaminando i ricorsi, il governo la notte del 12 giugno,
a scrutinio non ultimato, trasferì i poteri del capo dello Stato – che fino
allora era il re – al presidente del consiglio in carica. Il giorno dopo, il 13,
re Umberto lasciò per sempre l’Italia per andare in esilio in Portogallo. Lo
fece per non far precipitare in una nuova guerra civile la sua Patria,
dimostrando un altissimo senso di responsabilità e amore verso gli italiani. La
Stampa di Torino titolò: “Il governo sanziona la vittoria repubblicana”,
mettendo in dubbio la proclamazione stessa della repubblica. Perché neanche
allora lo si era capito. Poche ora prima di partire per il Portogallo, re
Umberto in un proclama denunciò l’illegalità commessa dal governo e partì dopo
aver affidato la patria agli italiani (e non ai suoi rappresentanti
eletti). “Confido che la Magistratura, le cui tradizioni di indipendenza e di
libertà sono una delle glorie d’Italia, potrà dire la sua libera parola; ma, non
volendo opporre la forza al sopruso, né rendermi complice dell’illegalità che il
Governo ha commesso, lascio il suolo del mio Paese, nella speranza di
scongiurare agli Italiani nuovi lutti e nuovi dolori. Compiendo questo
sacrificio nel supremo interesse della Patria, sento il dovere, come Italiano e
come Re, di elevare la mia protesta contro la violenza che si è compiuta;
protesta nel nome della Corona e di tutto il popolo, entro e fuori i confini,
che aveva il diritto di vedere il suo destino deciso nel rispetto della legge e
in modo che venisse dissipato ogni dubbio e ogni sospetto”.
2 giugno 1946: a scuola si insegni tutta la storia. Come finì la
storia? Che il 18 giugno la corte di Cassazione respinse tutti ricorsi e stabilì
che per “maggioranza degli elettori votanti” si dovesse invece intendere “la
maggioranza dei voti validi” e che quindi aveva vinto la repubblica. La vicenda
ha una coda, perché nel 1960 in un’intervista il presidente della suprema corte
quel 18 giugno, Giuseppe Pagano, disse che in quelle ore «l’angoscia del governo
di far dichiarare la repubblica era stata tale da indurre al colpo di Stato
prima che la Corte Suprema stabilisse realmente i risultati validi definitivi».
Secondo l’alto magistrato, tuttavia, non vi furono brogli. Tra gli altri
“gialli” di questa storia vi sono anche il fatto che Tito aveva pronte le sue
truppe per invadere l’Italia dalla Jugoslavia in caso della vittoria della
monarchia; si disse che l’allora segretario del Pci Togliatti intervenne presso
Mosca per ritardare il rientro delle decine di migliaia di prigionieri italiani
in Urss; i primi rapporti dei carabinieri, presenti nei seggi, sia
al Vaticano sia al governo, indicavano una netta vittoria della monarchia,
posizione poi invertitasi in poche ore; il numero degli elettori è sembrato poi
superiore a quello degli aventi diritto al voto, comprensibile nel disordine
dovuto al periodo bellico. Possibile anche che molti abbiano votato più volte
con documenti di identità falsi o appartenenti a defunti o dispersi. Lo stesso
Togliatti, infine, ministro della Giustizia, di fronte alle migliaia di ricorsi,
disse che probabilmente le schede non sarebbero potute essere controllate perché
alcune erano andate distrutte… Meglio la monarchia della repubblica? Certo non
la monarchia italiana, meglio forse quella inglese. Però almeno, che ai nostri
figli sia raccontata anche l’altra metà della storia.
2 giugno 1946: come andò veramente il referendum istituzionale
monarchia repubblica. Giovanni Bortolone e Giovanna
Canzano il 04/02/2008. Fonte: politicamentecorretto.
GIOVANNA CANZANO INTERVISTA GIOVANNI BARTOLONE.
CANZANO. Come giudichi il libro del prof. Aldo Mola: “Declino e
crollo della monarchia in Italia?”
BARTOLONE. E’ un’opera molto importante perché contribuisce a far
chiarezza, alla luce di nuovi documenti della Corte di Cassazione, sul
referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Ci sono molti dubbi sulla vittoria
della repubblica. Per molti la repubblica è nata nel sangue e nella truffa.
Altri aggiungono grazie ad un colpo di stato commesso dal governo, in un clima
di guerra civile strisciante. Il ritorno alla democrazia non significò il
suffragio universale. Moltissimi, troppi, italiani furono privati del diritto di
voto.
CANZANO. Puoi spiegarti meglio? Si dice che il voto fu regolare,
a parte qualche disfunzione dovuta al lungo periodo di non voto, dovuto alla
dittatura, ai registri elettorali non aggiornati, all’inesperienza degli
scrutatori e dei presidenti di seggio ecc.
BARTOLONE. Andiamoci in ordine. Il referendum si svolse in un
Italia sconfitta, che avrebbe firmato qualche mese dopo il trattato di pace, il
famoso Diktat. Era un'Italia ancora sotto il controllo di un governo militare
straniero d’occupazione. In intere regioni dell’Italia centro-settentrionale,
dove il predominio delle sinistre era assoluto, non si tenne nessuna
manifestazione monarchica.
CANZANO. Vuoi dire che in qualche modo la sinistra non ha
permesso manifestazioni di propaganda elettorale?
BARTOLONE. Propagandare il voto per la Monarchia avrebbe
significato esporsi a rappresaglie, minacce e violenze d’ogni tipo. In queste
zone operavano ancora le “volanti rosse”, che quasi impunemente assassinavano
gli avversari politici nei numerosi “triangoli della morte”. Nella stessa Roma
le manifestazioni di massa monarchiche, come ad esempio quella del 10 maggio
1946, erano assaltate dagli “ausiliari di Romita”, ex partigiani inquadrati
nella polizia. A Napoli i cortei monarchici erano attaccati a colpi di bombe a
mano come accadde in Via Foria il 15 maggio 1946.
CANZANO. Come si svolsero le operazioni di voto?
BARTOLONE. Vero è che il 2 giugno si votò nella massima calma. Ma
il clima delle settimane precedenti era stato, per dirla con il socialista
Pietro Nenni: “O la repubblica o il caos”. Il ministro comunista delle Finanze,
Mauro Scoccimarro, parlando a Frascati minacciò la rivoluzione in caso di
vittoria monarchica al referendum. Sandro Pertini chiedeva la fucilazione del
Luogotenente Umberto di Savoia. In molti benpensanti per evirare il caos
decisero di votare repubblica.
CANZANO. Però il 2 giugno votarono per la prima volta tutti gli
italiani.
BARTOLONE. Non è vero. E’ falso. E’ un’altra leggenda da
sfatare. Vero è che per la prima volta poterono votare le donn e per elezioni
politiche. Per favorire la vittoria della repubblica, il governo composto nella
quasi totalità di repubblicani, emise un decreto legislativo, il numero 69/1946,
contrario Re Umberto – dalla caduta del fascismo al 1948, il governo godeva
anche del potere legislativo – nel quale si privavano del diritto di voto gli
abitanti della Venezia Giulia, della Dalmazia e dell’Alto Adige. Questi
cittadini sarebbero stati consultati “con successivi provvedimenti”. In altre
parole mai più. Si dimenticarono della Libia – allora territorio metropolitano.
I cittadini italiani residenti in Libia furono privati del diritto di voto.
Forse erano già convinti di cedere queste parti del territorio nazionale a stati
esteri, oppure pensavano che gli abitanti potessero votare “Monarchia”,
ritenendo che un'Italia monarchica potesse difendere meglio la permanenza delle
loro terre all’Italia. Meglio non rischiare, fac endo votare questi cittadini
italiani. Furono inoltre esclusi dal voto i prigionieri, gli sfollati, gli
epurati. Gli epurati erano coloro che essendosi compromessi con il Regime,
furono privati del diritto di voto. Idem i loro familiari. Ma chi, a parte una
piccola minoranza, non si era compromesso col Fascismo durante il Ventennio? Non
è contraria ad ogni civile principio di civiltà giuridica una legge con effetto
retroattivo in materia penale? E i loro familiari che colpa avevano? Nei comuni
c’era molta faziosità. Molti degli esclusi dal voto non erano fascisti, ma erano
monarchici. In totale furono privati del diritto di voto circa il 10 percento
degli italiani, esclusi i “libici”.
CANZANO. Però la repubblica ottenne la maggioranza dei voti.
BARTOLONE. Non è detto. Il governo non comunicò in anticipo, come
avviene in tutte le elezioni del mondo, il numero degli aventi diritto al voto.
Anzi, secondo molti stu diosi, dalle urne non potevano venir fuori tutte quelle
schede. In ogni Paese del mondo, c’è un rapporto costante tra gli aventi diritto
al voto e la popolazione. I numeri sono numeri. Le leggi della demografia non lo
consentono. I conti non tornano tra i “risultati” del referendum, i probabili
aventi diritto al voto e la popolazione italiana del tempo. Ci sarebbero stati
circa 2 milioni di voti in più nelle urne. Numerose persone ricevettero 2 o 3
certificati elettorali. Lo stesso accadde per molti defunti. Due operai
comunisti impiegati ai Monopoli furono arrestati, mentre trafugavano pacchi di
schede elettorali prima del voto. Prendendo per buoni i “risultati” ufficiali la
repubblica avrebbe vinto per circa 250 mila voti in più rispetto al numero dei
“votanti” ufficiali. Su circa 35 mila sezioni elettorali, furono presentati
circa 21 mila ricorsi. Furono esaminati e respinti tutti in meno di 15 giorni.
Mentre la Corte di Cassazione esaminava i ricorsi, il governo, prendendo per
buoni i risultati provvisori del referendum, emise la notte del 13 giugno 1946,
una dichiarazione con la quale trasferiva le funzioni di Capo dello Stato al
Presidente del Consiglio in carica. Si poteva aspettare il 18, data della
proclamazione dei risultati definitivi. Forse si sarebbe potuto avere una
repubblica proclamata per decreto reale. Invece, forse per paura che i brogli
sarebbero stati scoperti, il governo pose Umberto II di fronte al fatto
compiuto. Il Re, con i risultati ancora provvisori e sub judice, fu ridotto al
rango di privato cittadino e posto di fronte al dilemma: partire per l’esilio o
scatenare una nuova guerra civile. Una nuova guerra civile avrebbe comportato,
oltre a nuovi lutti, la probabile perdita di parti del territorio nazionale a
favore della Francia, della Jugoslavia e dell’Austria e forse la secessione
d’alcune regioni. In poche ore a Napoli furono raccolte decine di m igliaia di
firme a sostegno di un manifesto del Movimento Separatista del Mezzogiorno
d’Italia, dell’ing. Carlo Rispoli. I promotori sostenevano che con la vittoria
repubblicana si era sciolto il Patto del 1860 con il quale si era accettata
l’Unità d’Italia sotto la dinastia dei Savoia. Volevano ricostituire il Regno
delle Due Sicilia con Re Umberto. Una simile dichiarazione emise ad Enna il 10
giugno il Movimento per l’Indipendenza Siciliana. Volevano un Regno di Sicilia
con sovrano Umberto di Savoia. Incidenti, con morti e feriti, scoppiarono a
Palermo, Taranto, Bari, Messina, e soprattutto a Napoli. A Napoli ci furono una
dozzina di morti e moltissimi feriti.
CANZANO. Perché a Napoli i disordini furono più numerosi?
BARTOLONE. La situazione era particolarmente critica a Napoli. La
città aveva votato per più dell’80%, in favore della Monarchia. Per controllare
la situazione napoletana il governo, nel la persona del ministro dell’Interno,
il socialista Giuseppe Romita, non aveva trovato niente di meglio che
militarizzare la città, facendovi affluire numerosi reparti di polizia
ausiliaria. Questi reparti, alle dirette dipendenze dello stesso ministro, erano
formati per la maggior parte da ex partigiani comunisti del nord. Da qui
l’appellativo di “guardie rosse di Romita”. Usarono sempre con la mano pesante
nei confronti della popolazione, considerata alla stregua di un nemico
ideologico.
CANZANO. Quale fu il bilancio?
BARTOLONE. Il sangue a Napoli ricominciò a scorrere la sera del 6
giugno 1946, quando uno sconosciuto lanciò una bomba a mano, vicino la chiesa di
Sant’Antonio a Capodimonte, contro un numeroso gruppo di giovani, reduci da una
dimostrazione monarchica. Sono ferite otto persone. Una, Ciro Martino, morirà
agli Incurabili. CANZANO. Come si organizzarono i napoletani? BARTOLONE. Quella
stessa notte , al numero 311 di Corso Umberto I si costituisce il Movimento
Monarchico del Mezzogiorno (uno dei nuclei fondatori del futuro Partito
Nazionale Monarchico) e si adotta il simbolo di “Stella e Corona”. La mattina
del 7 giugno, a Napoli si diffonde la notizia dell’arrivo d’Umberto. Il Re ha
deciso di battersi per il suo buon diritto e ha scelto la città come suo
quartiere generale. E’ un’esplosione di gioia popolare. Tutti i monarchici
napoletani sono in piazza. Bisogna accogliere degnamente il Sovrano. Si forma un
imponente corteo che, accompagnato dalle note solenni della “Marcia Reale”
suonata da un’improvvisata banda musicale o da alti inni della Patria, avanza
lungo il Rettifilo, diretto Palazzo Reale o a San Giacomo, ove si pensa che sia
il Re. Si ricongiunge con il grosso concentramento degli universitari, in attesa
presso la Federico II. A Piazza Nicola Amore c’è un largo, impenetrabile
sbarramento di camionette degli “ausiliari di Romita”. Alla testa del corteo,
che nel frattempo si è fermato dubbioso, un giovane scugnizzo di 14 anni, Carlo
Russo, completamente avvolto in un grande tricolore con lo stemma sabaudo.
E’armato solo di quella bandiera. E’ deciso a passare, nonostante i celerini.
Avanza deciso. I mitra degli ausiliari sparano ad altezza d’uomo. Si contano
molti feriti. Uno dei primi a cadere è Carlo Russo. Con la fronte squarciata,
s’abbatte avvolto nel tricolore, diventato ora il suo sudario. Solo il deciso
intervento dei Reali Carabinieri permetterà poi agli ausiliari di sfuggire al
linciaggio della folla inferocita. Carlo Russo morirà, dopo un’atroce agonia,
due giorni dopo. L’8 giugno muore lo studente Gaetano D’Alessandro, d1 16 anni.
Il ragazzo stava tornando a casa dopo una manifestazione monarchica di protesta
per le violenze del giorno prima. Aveva alle spalle un grande tricolore con lo
stemma sabaudo. Nei pressi di Piazza dei Vergini, è fermato da una camionetta
piena d’ausiliari. Gli intimano provocatoriamente di consegnare la bandiera. Il
ragazzo sfugge ai poliziotti e si arrampica sul cancello di una vicina chiesa,
sventolando la bandiera e gridando a squarciagola: “Viva il Re!” Alle grida
accorre numerosa la popolazione, che subito circonda minacciosa la camionetta. I
celerini devono abbandonare, scornati, il campo sotto un subisso di fischi e
pernacchie provenienti da una schiera di giovanissimi scugnizzi. Un celerino,
rabbioso, però vuole vendicarsi. Con fredda determinazione, con una raffica di
mitra uccide il ragazzo ancora aggrappato al cancello. Nel cadere, il suo corpo
si avvolge in quel tricolore che ha difeso a con la vita. Ora anch’egli ha una
bandiera per sudario.
CANZANO. Ci furono ancora molti morti per la bandiera tricolore?
BARTOLONE. L’11 giugno è una gi ornata di passione e di sangue.
Al balcone della Federazione del PCI di Via Medina, accanto alla consueta
bandiera rossa con falce e martello, è esposta una strana bandiera tricolore. Si
vede l’effigie di una testa di donna turrita nel campo bianco al posto del
tradizionale stemma sabaudo. Per Napoli, che ha votato per l’80% Monarchia, è
una vera e propria provocazione. Fulminea si sparge la notizia per la città. A
migliaia, spontaneamente, si dirigono a Via Medina. La stragrande maggioranza è
composta di giovani e giovanissimi. In molti hanno partecipato con coraggio nel
1943 alle cosiddette “quattro giornate “contro l’occupazione tedesca. Qualcuno
ha le stesse armi di allora: pietre, solo pietre. L’obiettivo è: strappare e
distrugge quel vergognoso vessillo, poi si tornerà festeggiando a casa.
Dall’altra parte c’è qualcuno però che ha deciso di farla finita una volta per
sempre e di soffocare nel sangue le proteste popolari. In Via Medina ora, oltre
le camionette, vi sono decine di blindati e celerini in assetto di guerra. La
sede comunista è difesa da numerosi militanti armati. I primi gruppi di
dimostranti appena arrivati, rovesciano i tram per rendere difficoltosi i
micidiali caroselli degli automezzi della Celere. Seguono salve di fischi, urla,
insulti all’indirizzo della bandiera esposta. Poi un giovane marinaio di leva,
Mario Fioretti, aggrappandosi ai tubi e alle sporgenze inizia a scalare il
palazzo della federazione per arrivare al 2° piano e asportare quella bandiera.
In minuto è quasi giunto al drappo conteso. Basterà allungare la mano,
impadronirsene e tutto sarà finito. Da una finestra della federazione comunista
però spunta un braccio armato di pistola, che a bruciapelo spara sul giovane
marinaio. Mario Fioretti stramazza cadavere sul selciato, mentre dai presenti si
levano urla d’orrore e di rabbia. Altri giovani, per nulla spaventati dalla
morte del loro coetaneo, cominciano anch’essi la scalata verso quel balcone. Un
gruppo di dimostranti duramente contrastato da un gruppo di celerini, cerca di
guadagnare le scale per salire al piano superiore. Tra poco i dimostranti
avranno la meglio, ma dalla caserma di polizia, posta quasi di fronte al palazzo
assediato, s’incomincia a sparare contro i nemici che sono quasi arrivati alla
bandiera. Sparano per uccidere. Cadono uno dopo l’altro e si sfracellano a
terra: Guido Bennati, Michele Pappalardo, Felice Chirico. Michele Pappalardo
doveva sposarsi l’indomani e invece della fidanzata è andato a sposarsi con la
morte. Aveva detto alla madre: “Mammà piglio ‘a bandiera e po’ torno…’ Una
bandiera tricolore con lo scudo sabaudo diventa il suo sudario. A Via Medina
scoppia l’inferno. I feriti si contano a decine. Muore in un lago di sangue,
sempre colpi to da pallottole, l’operaio monarchico Francesco D’Azzo. Le
autoblindate della Celere hanno avuto finalmente ragione delle rudimentali
barricate, alzate dai monarchici, e stanno per avventarsi con i loro terribili
caroselli sui dimostranti, quando la studentessa Ida Cavalieri fa barriera col
proprio corpo inerme nel disperato tentativo di fermarne la corsa. L’ordine è
disperdere la folla, costi quel che costi. A Napoli, quel giorno, la vita umana
non vale niente. Così Ida Cavalieri è stritolata dagli automezzi repubblicani.
Non accade il miracolo di Piazza Tienanmen, a Pechino. Un appartenente alla
Regia Marina, Vincenzo Guida cerca di organizzare la resistenza, innalzando una
grande bandiera sabauda su di un palo. E’ colpito mortalmente alla nuca da un
colpo di un moschetto, sparato da un celerino. Quando la strage è finita arriva
la polizia militare americana che, insieme ai Reali Carabinieri, a stento riesce
a sottrarre i celer ini e gli attivisti comunisti alla collera popolare. Alla
fine della tragica giornata di sangue, si conteranno, oltre i morti circa 50
feriti gravi. Tra questi ultimi, tutti colpiti da armi da fuoco, Gerardo Bianchi
di 15 anni, Alberto De Rosa di 17, Gianni Di Stasio di 14, Antonio Mariano di
12, Giovanni Vibrano di 11, Raffaele Palmisano di 10 e Tino Zelata di 8. Gli
altri feriti avevano in media 20-30 anni.
CANZANO. Che successe dopo?
BARTOLONE. Il Re partì. Non voleva avere sulla sua coscienza di
cattolico osservante i lutti di una nuova guerra civile e la fine dell’Unità
nazionale conquistata durante il Risorgimento. Vi furono promesse e pressioni
sulla Cassazione. Alla fine fu accolta a maggioranza, 12 contro 7, compreso il
voto favorevole alle tesi monarchiche del presidente della Corte, Giuseppe
Pagano, sostenute dal parere favorevole del procuratore generale Massimo
Pilotti, la tesi repubblicana: è “votante” solo colui il q uale abbia compiuto
“una manifestazione positiva di volontà”. In pratica un milione e mezzo circa di
votanti, in bianco o nulli, non avevano votato. Sicché la presunta maggioranza
per la repubblica si ridurrebbe a 200 mila voti circa. La prova inconfutabile
che fu un colpo di stato, è desumibile dalla Gazzetta ufficiale della repubblica
italiana del 1° luglio 1946. Pubblicando il decreto del passaggio dei poteri di
Capo dello Stato da De Gasperi a De Nicola, si precisò che De Gasperi deteneva
tali poteri dal 18 giugno, cioè dal giorno in cui la Corte emise la sentenza
definitiva.
BIOGRAFIA.
Giovanni Bartolone, nasce a Palermo nel 1953, ove insegna Diritto
ed economia nelle Superiori. Vive a Bagheria (PA). E’ laureato in Scienze
Politiche, indirizzo Politico Internazionale, con una tesi sul Referendum
istituzionale del 1946. E' da molti anni impegnato in ricerche sulla II guerra
mondiale, il Fascismo, il Nazionalsocialismo, il fenomeno della mafia, la
Sicilia dallo sbarco Alleato alla morte di Salvatore Giuliano. Ha pubblicato nel
2005 a sue spese il libro “Le altre stragi”, dedicato alle stragi alleate e
tedesche nella Sicilia del 1943/44 e il saggio Luci ed ombre nella Napoli
1943-1946, ISSES, Napoli, 2006.
·
Le oche
starnazzanti.
La conferenza stampa del governatore. De Luca contro le
Regioni del Nord: “Campania per il massimo rigore, pronti alla battaglia per
impedire il furto di risorse al sud”. Redazione su Il
Riformista l'11 Dicembre 2020. Vincenzo De Luca è per la linea del massimo
rigore. Sempre. Il Presidente della Campania nella consueta diretta del venerdì
lancia come al solito accuse e strali. Al governo, soprattutto, chiede rigore in
questa fase dell’emergenza coronavirus. Se la Campania si è salvata, ha detto
sottolineando che la Regione è quella con la densità abitativa più alta
d’Italia, è stato per le decisioni prese dalla Regione stessa, prima
dell’esecutivo. E non per il dpcm delle Zone Rosse, Arancioni o Gialle.
“Fesserie”, le ha definite. E quindi è infastidito dall’informazione che vuole
le Regioni premere contro il governo per ottenere più riaperture. “Secondo i
media c’è un assedio delle Regioni nei confronti del Governo per chiedere
provvedimenti meno rigorosi. La Regione Campania chiede provvedimenti più
rigorosi, non meno. Mi auguro che anche il sistema informativo trasmetta notizie
rispondenti alla realtà”. Insomma, De Luca auspica che il governo non ceda alle
richieste di aperture, in occasione delle festività natalizie, sulle pressioni
delle Regioni del Nord. “Siamo talmente abituati a considerare ‘le Regioni’
soltanto le due, tre o quattro del Centro Nord – ha aggiunto De Luca – che
scambiamo le posizioni di tre o quattro Regioni come le posizioni delle Regioni
d’Italia. Non è così. La Campania sostiene una linea di rigore, è contraria al
rilassamento, all’apertura della mobilità, a queste manfrine alle quali stiamo
assistendo su Comuni grandi o piccoli, su che dobbiamo fare a Natale, alla
vigilia, a Capodanno”.
RECOVERY FUND – Un passaggio, che sottolinea ancora uno sfondo
tra Regioni del Nord e del Sud, anche sul Recovery Fund, il fondo europeo da 750
miliardi miliardi di euro sbloccato dall’accordo dei ventisette. “Sullo sfondo
c’è un problema che riguarda noi meridionali: e cioè le ipotesi del Governo
configurano l’ennesimo furto nei confronti delle Regioni del Sud – ha aggiunto
De Luca – I 209 milioni stanziati dall’Europa arrivano per recuperare il divario
del sud rispetto al nord, mentre il Governo invece di dare il 66% al sud e il
34% al nord, ipotizza di fare tutto il contrario. Dobbiamo prepararci a una
battaglia politica chiara e forte per impedire che questo ennesimo furto a danno
del Sud sia consumato nell’indifferenza del Paese e, quello che è peggio, delle
Regioni meridionali stesse”. E quindi ha anticipato come “nei prossimi giorni
vedremo di proporre un incontro con altre regioni del sud per mettere in campo
una risposta istituzionale forte, anche per verificare se i parecchi ministri
campani diano cenni di esistenza oppure no”. Un’altra stoccata al governo e in
particolare ai ministri campani come quello degli Esteri Luigi Di Maio, agli
Affari Europei Vincenzo Amendola, all’Università Gaetano Manfredi, allo
Sport Vincenzo Spadafora, all’Ambiente Sergio Costa.
Il dibattito sul Recovery Fund. Recovery Fund, l’Europa è
contro il divario tra Nord e Sud. Luigi Famiglietti su
Il Riformista il 17 Dicembre 2020. L’Italia ha ottenuto i 209 miliardi
del Recovery Fund innanzitutto perché la Commissione ha riconosciuto come
il divario Nord-Sud sia un punto critico per l’economia nazionale e, quindi, ha
posto lo sviluppo del Mezzogiorno come prima condizione per l’utilizzo dei
fondi. Nella bozza del Piano di resilienza portata in Consiglio dei ministri dal
premier Giuseppe Conte si fa riferimento alla clausola del 34% come tetto per
l’utilizzo dei fondi al Sud. In realtà, tale clausola, ancora non rispettata, è
stata introdotta nel nostro ordinamento per fare in modo che, rispetto agli
investimenti in conto capitale interni al Paese, almeno il 34% riguardi il Sud.
Tale quota rappresenta la percentuale di popolazione meridionale rispetto al
dato complessivo nazionale. Perciò c’è stata una levata di scudi degli istituti
meridionalisti. In particolare, il presidente di Svimez, Adriano Giannola,
ritiene che, in base alle linee-guida del Recovery Fund, debba essere
riconosciuto al Sud almeno il 60% delle risorse a disposizione dell’Italia
proprio perché il divario con il Nord è stato riconosciuto tra i più ampi tra i
Paesi europei. Il Governo precisa che i fondi destinati al Sud nei prossimi anni
saranno più che sufficienti in quanto va considerato anche il Piano Sud 2030 e
la programmazione dei fondi strutturali 2021/2027. Mai come in questa occasione,
tuttavia, il problema non sta tanto nella quantità dei fondi messi a
disposizione del Sud, quanto nella qualità dei progetti anche rispetto agli
effetti che produrranno. Diventa fondamentale curare non solo il supporto alla
progettazione, ma soprattutto il monitoraggio sul corretto utilizzo delle
risorse. Bisognerà coniugare al futuro questo intervento straordinario che non a
caso si chiama Next Generation. L’Europa ci chiede nuove politiche di sviluppo
basate sull’innovazione digitale, sulla transizione ambientale e
sull’eliminazione del divario Nord-Sud sia dal punto di vista infrastrutturale
che nella fruizione dei cosiddetti diritti di cittadinanza: istruzione, sanità e
mobilità. Nel Rapporto del G30 Mario Draghi spiega bene come per lo sviluppo
servano uno sguardo lungo e progetti ad alto rendimento tali da giustificare
l’investimento pubblico e garantire la crescita e la diminuzione del debito.
Tuttavia, stando alla bozza del Piano italiano circolata nei giorni scorsi,
sembrerebbe che ben pochi tra i progetti indicati possano garantire quei
rendimenti elevati auspicati da Draghi. Intanto, buona parte dei crediti europei
servirà a coprire programmi di spesa già esistenti, come nel caso della ferrovia
Napoli-Bari, per liberare risorse nazionali già impegnate ed evitare un
significativo aumento del debito pubblico. Rispetto ai nuovi investimenti, nella
bozza circolata, si parla, per esempio, del potenziamento dei porti di Trieste e
di Genova e non si fa cenno ai porti meridionali e alla funzione del Sud come
grande piattaforma logistica integrata proprio quando, nel nuovo contesto
internazionale, per l’Europa diventa fondamentale guardare al Mediterraneo. È
scomparso dal dibattito il ponte sullo stretto di Messina che pure sarebbe
utilissimo per estendere la rete alta capacità/alta velocità alla Calabria e
alla Sicilia. L’Italia non eccelle nell’utilizzo dei fondi europei e le regioni
del Sud hanno il dovere di fare autocritica per la gestione delle risorse
comunitarie. Tuttavia la soluzione non può stare nella nomina
dell’ennesima task-force nazionale che andrebbe a sovrapporsi all’Agenzia per
la Coesione e alle strutture ministeriali. Il ministro Giuseppe Provenzano e il
direttore di Svimez Luca Bianchi, in una pubblicazione del 2010 dal titolo Ma il
cielo è sempre più su?, di fronte alla scarsa efficienza delle Regioni e delle
amministrazioni centrali avevano suggerito una terza via: concordare
con Bruxelles poche priorità da finanziare, definire obiettivi da raggiungere
chiari e verificabili e accettare un sistema di valutazione indipendente,
europeo. Già Carlo Trigilia, nel 2009, aveva invocato una Maastricht per
il Mezzogiorno con un intervento su Il Mattino e considerazioni simili erano
state espresse nel rapporto predisposto da Fabrizio Barca per la Commissione
europea in vista della definizione della nuova politica di coesione per il post
2013. Quindi, per sfruttare al meglio i fondi europei stanziati per le prossime
generazioni e provare a ridurre il divario Nord-Sud in un disegno unitario con
una logica di sviluppo nazionale, bisogna ripensare il sistema
di governance delle politiche pubbliche attraverso l’imposizione di vincoli
esterni assai più stringenti che nel passato: occorre un rafforzamento della
capacità di indirizzo e controllo da parte della Commissione europea sia nella
fase di progettazione che in quella di monitoraggio della spesa.
TUTTI CON DE LUCA PER SCONGIURARE «IL FURTO AI DANNI DEL SUD».
Giovedì 17 dicembre, ore 17. Il Sud s'è desto. La
sommossa istituzionale contro la ripartizione dei fondi europei a fondo perduto
diventa sempre più concreta. Michele Inserra su Il Quotidiano del Sud il 17
dicembre 2020. Giovedì 17 dicembre, ore 17. Il Sud s’è desto. Questa volta si fa
sul serio, almeno così sembra dai buoni propositi. Lo sceriffo si è svegliato,
detta la linea per il Mezzogiorno, si mette di traverso, contesta il governo e
il suo partito, il Partito democratico, che supporta e sostiene il percorso
politico dell’esecutivo nazionale. Così su invito del governatore della
Campania, Vincenzo De Luca, oggi si ritrovano i presidenti delle regioni
meridionali per confrontarsi sul riparto nazionale dei fondi previsti
nell’ambito del programma “Next Generation” che, secondo le ipotesi di governo,
destina al Sud la misera quota del 34%: Marco Marsilio (Abruzzo), Vito Bardi
(Basilicata), Nino Spirlì (Calabria), Donato Toma (Molise), Michele Emiliano
(Puglia), Christian Solinas (Sardegna) e Nello Musumeci (Sicilia). De Luca
sollecita i colleghi a fare fronte comune al di là dei partiti, per scongiurare
“un vero e proprio furto ai danni del Sud” e contrastare le “inaccettabili ed
estemporanee ipotesi di governance tecnocratica e centralistica”. Fanno
benissimo adesso i governatori del Sud a “sposare” la campagna di questo
giornale, condotta in assoluta solitudine e avallata dalle principali
istituzioni economiche, statistiche e contabili della Repubblica italiana. Un
sussulto di dignità per tutelare i diritti di cittadinanza delle proprie
popolazioni affinché cessi lo sconcio della spesa storica e si riconoscano
finalmente gli investimenti dovuti in sanità e scuola. Un cammino comune quello
intrapreso dai governatori che ha ne Il Quotidiano del Sud-L’Altra voce
dell’Italia la sua casa naturale per promuovere un atto istituzionale formale.
La sommossa istituzionale contro la ripartizione dei fondi europei diventa
sempre più concreta. Era l’ora, dopo un soporifero letargo delle istituzioni
meridionali. «Gli Stati membri potranno beneficiare di un contributo finanziario
sotto forma di un sostegno non rimborsabile. L’importo massimo per Stato membro
sarà stabilito in base a un criterio di ripartizione definito. Tali importi
saranno calcolati in base alla popolazione, all’inverso del prodotto interno
lordo (Pil) pro capite e al relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato
membro». Alle pagine 8 e 9 della proposta di regolamento, il parlamento europeo
fissa i paletti sui criteri di ripartizione delle risorse a fondo perduto del
Recovery Plan. Sono tre gli indicatori: popolazione, tasso di disoccupazione e
Pil pro capite. Dovranno essere destinate maggiori risorse a quei territori con
più residenti, con maggiore disoccupazione e prodotto interno lordo inferiore.
Seguendo i criteri Ue, il governo Conte deve investire per il Nord Italia il
21,20% dei 65,4 miliardi a fondo perduto previsti dal Piano nazionale ripresa e
resilienza; il 12,81% deve andare al Centro e il 65,99% al Sud, ben oltre,
quindi, il 34% previsto dal piano dell’Esecutivo nazionale. Quasi il doppio.
Anziché 22,23 miliardi, quindi, al Sud dovrebbero andare 43,15 miliardi, una
differenza di 20,9 miliardi; mentre al Centro-Nord, anziché 43,16 miliardi
dovrebbero essere destinati 22,24 miliardi, secondo i criteri dell’Unione
Europea. Un «vero e proprio furto in danno del Sud e delle sue Regioni» di
fronte al quale «si rende urgente e necessaria un’iniziativa forte delle Regioni
meridionali che devono ritrovare una comunità di visione e di azione, al di là
delle rispettive collocazioni di schieramento politico» ha scritto De Luca nella
lettera di invito ai colleghi. Un programma «imponente – spiega il governatore
campano – che prevede l’impegno di ben 209 miliardi di euro, di cui 193 miliardi
del solo Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) , a loro volta divisi in 65,4
miliardi a fondo perduto e 127,6 miliardi a titolo di prestito da rimborsare.
Risorse che l’Europa rende disponibili per un rilancio economico finalizzato, in
primo luogo, a colmare il divario tra aree più sviluppate ed aree con Pil molto
al di sotto della media europea e con più alto tasso di disoccupazione. Del
resto, se l’Italia è il Paese cui è destinata la maggiore quota di risorse è
proprio perché comprende una consistente area con tali requisiti di debolezza:
il Mezzogiorno». Di tutto ciò, sottolinea De Luca, «non vi è traccia del
dibattito politico di queste settimane, tutto incentrato su inaccettabili ed
estemporanee ipotesi di governance tecnocratica e centralistica. Anzi, vi è di
peggio. I criteri europei di riparto delle risorse sono totalmente occultati in
tutti i documenti ufficiali. Da ultimo, è circolato un Piano del governo che
capovolge i criteri europei e ripropone la banale distribuzione delle risorse
fra Centro-Nord e Sud secondo un criterio esclusivamente demografico, cioè il
contrario dei principi di coesione sociale e territoriale sanciti nel Trattato
di funzionamento dell’Unione e nella nostra Costituzione». Ecco perché, secondo
De Luca, «si prepara un vero e proprio furto in danno del Sud e delle sue
Regioni. Solo per la parte a fondo perduto del Pnrr tale furto assomma a ben
20,92 miliardi di euro. Peraltro – prosegue De Luca – anche la ripartizione
delle risorse nelle 6 missioni proposte dal Governo è davvero sconcertante.
Basti pensare alla mortificazione di settori importanti, in particolare per il
Sud, come la sanità, il turismo ed i servizi idrici. Si rende, pertanto, urgente
e necessaria un’iniziativa forte delle Regioni meridionali, che devono ritrovare
una comunità di visione e di azione, al di là delle rispettive collocazioni di
schieramento politico. Se non avvertissimo con forza questa responsabilità
comune non svolgeremmo il ruolo che le nostre comunità si attendono da noi
tutti». Da qui la proposta, rivolta dal presidente della regione Campania ai
governatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, di un incontro da remoto «per discutere insieme di questi temi e per
definire le più opportune iniziative in ambito nazionale ed europeo». Plauso
all’iniziativa Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania. «Ci
aspettiamo una forte sinergia fra tutte le regioni del Sud, che possano superare
le legittime divisioni sul piano politico e trovare alleanze profonde, anche per
dare un forte contributo nel ridisegnare politiche nuove per il Mezzogiorno e
per il Paese». L’iniziativa intrapresa da De Luca è riuscita anche ad incassare
il sostegno di Forza Italia nel consiglio regionale campano. «Ribadiamo al
presidente De Luca – ha detto il capogruppo consiliare degli azzurri, Annarita
Patriarca – la disponibilità da parte di Forza Italia a collaborare e a dare il
nostro apporto in termini di progetti e azioni politiche. Questa è una battaglia
comune, dell’intero Meridione, e per tale motivo siamo disposti ad affiancare il
governatore affinché la Campania sia alla testa delle regioni del Sud per
impedire quello che si configura come un furto ai danni del Sud». «Il Recovery
fund è una occasione irripetibile per il Mezzogiorno di vedere ridotto il gap
con le regioni del Nord – ha aggiunto – Per questo, non dobbiamo spaventarci di
ingaggiare una battaglia per far arrivare al Sud il 70% dei fondi, e non il 34%
come deciso dal Governo Conte, contravvenendo alle stesse disposizioni della
Commissione europea». Gli fa eco l’europarlamentare forzista, Fulvio
Martusciello. «La decisione del Governo di concedere al Sud solo il 34% dei 209
miliardi destinati al nostro Paese, contrariamente a quanto stabilito dalla
Commissione Europea, cioè di assegnare al Mezzogiorno il 70% delle risorse del
Recovery fund, è l’ennesima mortificazione che riceve il nostro Sud, dal Governo
Conte – ha detto – questo ennesimo furto va bloccato. Bisogna invertire questa
decisione inaccettabile del Governo e far in modo che il 70% dei fondi vadano al
Sud non al Nord. La Campania e tutte le regioni del Mezzogiorno hanno bisogno di
questi fondi. Ci batteremo fino alla fine coinvolgendo tutti i parlamentari
affinché il Governo cambi questa sua assurda decisione». Fa la voce grossa anche
Stefano Caldoro, il candidato alla presidenza sconfitto da De Luca alle scorse
elezioni regionali. «Le risorse europee vanno destinate in maniera massiccia ed
intelligente al Sud perché qui ci sono più margini di crescita per l’economia e
perché i trasferimenti statali di spesa corrente, negli anni, hanno penalizzato
le regioni meridionali – ha detto il capo dell’opposizione in Consiglio
regionale della Campania». I motori sono caldi. Si parte, a difesa del
Mezzogiorno.
CALABRIA SENZA SPERANZA. Emergenza
Covid, siamo al punto di massimo tradimento delle istituzioni. Roberto
Napoletano su Il Quotidiano del Sud il 7 novembre 2020. Possiamo tollerare che
il 27 ottobre, sette mesi dopo la prima ondata, il ministro della Salute si
ricordi di nominare il generale Cotticelli commissario attuatore per il piano
Covid in Calabria e che il medesimo generale non ritenga di dovere neppure
leggere la comunicazione che lo riguarda? Non sa che è commissario per la sanità
in Calabria e ritiene che il ministero debba fare il lavoro suo. Non sa che è
stato nominato commissario attuatore per il piano Covid. Non sa che tocca a lui
fare il piano B. Non conosce il numero dei posti letto in terapia intensiva
della Regione a lui affidata e chiede assistenza tecnica all’usciere del suo
piano. Non sa probabilmente neppure come si chiama. Non abbiamo la minima idea
di chi possa avergli dato le stellette di generale. Riteniamo un’offesa al
decoro delle istituzioni avere nominato una persona così incompetente alla guida
della sanità calabrese. Si chiama Saverio Cotticelli. Non può rimanere nemmeno
un secondo di più seduto su quella poltrona perché la sua sola presenza può
rappresentare un oltraggio alle donne e agli uomini della Calabria. Rimuoverlo
da quella poltrona è obbligatorio ma resta una decisione tardiva che nulla
toglie alle responsabilità di chi lo ha nominato e di chi lo ha fino ad oggi
mantenuto in questo incarico. Siamo molto oltre la barzelletta di un generale
chiamato da uno Stato patrigno a fare un mestiere che non conosce. Siamo al
punto massimo di tradimento delle istituzioni quando si decide che alle ruberie
della politica locale regionale, ai falsi in bilancio e alle corruttele delle
aziende sanitarie, si deve aggiungere un altro stipendio pagato da tutti noi per
non fare nulla. Anzi peggio. Per non leggersi neanche le carte che lo
riguardano. Per cumulare debiti su debiti. Per aggravare ciò che nessuno
riteneva possibile aggravare ancora di più. Possiamo tollerare che il 27
ottobre, sette mesi dopo la prima ondata, il ministero della Salute si ricordi
di nominare il generale Cotticelli commissario attuatore per il piano Covid e
che il medesimo generale non ritenga di dovere neppure leggere la comunicazione
che lo riguarda? Ministro Speranza, erano spariti tutti i manager di settore al
momento della nomina di Cotticelli, c’erano disponili solo uomini dell’arma? E,
soprattutto, che cosa ha fatto Lei da marzo a ottobre, forse era più urgente
leggere le bozze del suo libro che occuparsi dell’emergenza sanitaria calabrese?
Commissario Arcuri, possiamo ricordarLe che la Calabria fa parte dell’Italia e
che doveva essere la prima delle sue preoccupazioni? Che cosa Le fa ritenere che
dobbiamo sopportare ancora il peso della Sua tanto manifesta quanto presuntuosa
incapacità? Per quanto vi possa apparire paradossale ci tocca addirittura
assistere ad un Presidente facente funzioni della Regione, tale Nino Spirlì, che
scopre che la sua Regione è finita in codice rosso, occupa le tv da mattina a
sera ma non sa niente di quello che è avvenuto prima di lui e non trova mai un
minuto per informarsi che l’attuazione del piano Covid non doveva farlo la
Regione ma il commissario Cotticelli. Anche qui siamo alla farsa di una tragedia
vera. La tragedia vera è che a ogni cittadino calabrese vanno 15,9 euro per
investimenti fissi in sanità e a ogni cittadino emiliano-romagnolo ne vanno
84,4. La tragedia vera è che tutto ciò avviene da undici anni in un luogo
nascosto della democrazia italiana che si chiama Conferenza Stato-Regioni dove,
con il trucco della spesa storica, esistono cittadini di seria A e cittadini di
serie B grazie a una solida alleanza tra la Sinistra Padronale tosco-emiliana e
la Destra lombardo-veneta a trazione leghista. Siamo alla tragedia di un
misfatto che si ripete nel silenzio complice di tutti senza che un solo
presidente della Regione Calabria o di una qualunque delle Regioni del
Mezzogiorno abbia ritenuto di sollevare il problema in quella sede o, meglio
ancora, davanti alla Corte Costituzionale. Siamo nel caso della Calabria alla
tragedia supplementare di uno Stato che subentra alla Regione nella gestione
della sanità da oltre dieci anni per una serie di scandali che hanno riguardato
le aziende sanitarie locali, ma riesce a fare peggio di chi li ha preceduti.
Siamo allo Stato patrigno che non vede, non sente, non parla, e fa male. Molto
male. Non ha consapevolezza o non vuole avere consapevolezza che con un
finanziamento così ingiustificatamente ridotto non è possibile fare alcuna
azione di risanamento e, tanto meno, di riorganizzazione e di sviluppo delle
attività sanitarie. Lo Stato è fuori. Non ha la cassa. I soldi sono stati
trasferiti alle Regioni e, come questo giornale documenta in assoluta solitudine
da mesi e mesi, la ripartizione delle risorse di fatto non appartiene più alla
potestà nazionale, ma all’arbitrio negoziale tra i Capetti delle Regioni che si
sono autonominati “Capi di stato” e che hanno in mente loro una precisa
gerarchia. Per cui gli “Stati” del Centro-Nord lombardo-veneto e dei
“granducati” toscano e emiliano-romagnolo, quello piemontese di origine sabauda
e la consorella Liguria che contribuiscono insieme al primo e al secondo posto
alla realizzazione del deficit sanitario nazionale, sono tutti Stati di serie A,
lo staterello calabrese può giocare al massimo la sua partita nei campionati
minori. Il finale di questo circolo perverso di un Paese che è diventato terra
di nessuno, dove non si sa più chi comanda, dove non si sa chi decide, dove
tutto è opinabile, è che una regione come la Calabria dove il tasso di contagio
non è per fortuna esploso, deve subire la beffa di finire in codice rosso come
regioni infinitamente più foraggiate dallo Stato (Lombardia e Piemonte) che
hanno tassi di contagio infinitamente superiori, per la semplice ed esclusiva
ragione che non è stata messa nelle condizioni di assicurarsi un livello di
protezione ospedaliera adeguato. Il finale di questa maledetta storia italiana
che ne fotografa le ragioni profonde della sua crisi strutturale è che
un’economia già in ginocchio come quella calabrese viene rasa al suolo non
perché c’è una pandemia globale, ma per colpe che non appartengono a questa
comunità. Che cosa hanno fatto, mi chiedo, le donne e gli uomini della Calabria
per meritarsi un tale trattamento di “riguardo”? Ma vi rendete conto a quali
abissi di irresponsabilità ci ha condotto il federalismo incompiuto all’italiana
che mette insieme il miope egoismo del Nord e la rassegnazione al degrado del
Sud? Lo ripetiamo come un disco incantato ogni giorno, ma se non si mette mano
con urgenza immediata alla riforma dello Stato e della sua macchina
amministrativa, non abbiamo speranze. Se non si restituisce allo Stato ciò che è
dello Stato, se non la smettono i Capetti delle Regioni di muoversi come Capi di
Stato ombra, non solo non supereremo la crisi terribile del Covid ma faremo
lentamente precipitare il Sud intero nella povertà e il Nord intero in un regime
di sudditanza coloniale tedesca e francese come subfornitori di industria e di
finanza. Nel frattempo c’è una sola realtà che riguarda i cittadini calabresi.
Che hanno visto aumentare, di addizionale in addizionale, le loro tasse per
coprire i buchi della sanità. Cioè per non avere nulla. Come dire: “stracornuti
e stramazziati”. Questa realtà fa paura.
Andrea Bassi per “il Messaggero” il 6 novembre 2020. Un miliardo
di euro. Sull'unghia. Mentre il resto del Paese arranca tra la pandemia e la
crisi economica, c' è un pezzetto d' Italia che può viaggiare su un binario
parallelo, più veloce. O, se si vuole, in un' altra classe. Migliore ovviamente.
Basta prendere le parole spese dal ministro delle infrastrutture, Paola De
Micheli, che con un entusiasmo che stride con il momento, ha celebrato la sua
decisione di firmare il decreto che finanzia con il suddetto miliardo le
infrastrutture lombarde in attesa delle Olimpiadi invernali del 2026 di Milano e
Cortina. «Faremo compiere un salto di qualità infrastrutturale - è stata la
spiegazione della ministra - a una delle aree più sviluppate del Paese con una
ricaduta importante per la qualità della vita delle persone e anche un
miglioramento competitivo per le imprese». Che va bene. Chi prospera ha diritto
di stare meglio. Anche se a Milano non si scierà, perché montagne e piste non ce
ne sono. Ma nemmeno si può sorvolare sul fatto che, ancora una volta, il governo
ha deciso di sostenere la parte più ricca del Paese a scapito del Sud. Quelle
stesse Regioni settentrionali che sono state, come ha appena sottolineato la
Banca d' Italia nel suo studio sulle economie regionali, la culla della
recessione italiana. Recessione la cui onda d' urto, tuttavia, ha spiegato
sempre via Nazionale, ha messo al tappeto soprattutto le famiglie del
Centro-Sud. Basta pensare alla crisi nera del turismo, o all' ecatombe dei
lavoratori a termine e stagionali concentrati soprattutto nelle Regioni
meridionali. Il punto sta proprio qui. Nel continuare a pensare, erroneamente,
solo alla presunta locomotiva, mentre i vagoni deragliano. La prova? Proprio
mentre la ministra De Micheli celebrava il decreto pro-Milano, il governo ha
preso una decisione controversa, immediatamente contestata dagli interessati:
dichiarare il lockdown di una regione, la Calabria, non perché i contagi sono
fuori controllo, ma perché se lo fossero, avrebbe un sistema sanitario talmente
disastrato da non poter reggere l' onda d' urto. Insomma, lo stesso governo che
ha trovato un miliardo per i giochi invernali del 2026, ha alzato le mani
davanti al disastrato sistema sanitario calabrese, scegliendo la via più
semplice: la chiusura. Con le pesanti conseguenze economiche che questo comporta
per un territorio che ha il reddito medio più basso d' Italia: solo 15.430 euro
contro gli oltre 25.600 euro della Lombardia. La colpa, si potrebbe obiettare, è
in fin dei conti della stessa classe politica. La sanità calabrese è da oltre 10
anni commissariata con lo scopo di ripianare il debito. Solo che lo stesso
debito, da quando la Regione è sottoposta al piano di rientro, è passato da 150
milioni a quasi 1 miliardo. E ora il commissariamento è stato allungato di 3
anni. Il vero problema è che l' unica ricetta messa in campo sono stati tagli ai
posti letto e agli ospedali. Il risultato è che i commissariamenti non hanno
aiutato la Calabria a migliorare il sistema sanitario e se oggi si ritrova zona
rossa è più per la fragilità della rete degli ospedali e del tracciamento che
per una reale esplosione del contagio. La debolezza del sistema sanitario
calabrese negli anni è anche stata accentuata dall' effetto perverso del mancato
rilancio, perché i cittadini cercano assistenza in altre regioni. Secondo un
report della Fondazione Gimbe, diffuso a settembre, la Calabria ha uno dei saldi
peggiori nel calcolo che valuta la mobilità attiva e passiva: 287,4 milioni di
euro che finiscono soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana
dove i calabresi sono costretti ad rivolgersi per curarsi a causa delle carenze
della sanità locale povera di investimenti. Difficile che si possa uscire da
questa situazione senza un vero intervento emergenziale che possa contare su
finanziamenti straordinari cospicui. Magari gli stessi assegnati per rifare le
strade lombarde in vista delle olimpiadi. Anche perché, se da un lato non si
possono nascondere le responsabilità politiche, dall' altro il sistema sanitario
calabrese è andato in difficoltà, come altri del Mezzogiorno, anche per i
criteri di riparto del fondo sanitario che per anni hanno premiato le regioni
settentrionali. Alla Calabria, con quasi 2 milioni di abitanti, sono stati
destinati soltanto 3,6 miliardi. Dunque, 1.800 euro pro capite contro i 1.916
destinati alla salute di un cittadino del Friuli o, ancora, i 1.935 impiegati
per un piemontese. Un meccanismo che, secondo la Corte dei Conti, ha portato a
una distribuzione sbilanciata verso il Nord delle risorse. Dal 2012 al 2017,
nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale, sei regioni settentrionali
hanno visto aumentare la loro quota mediamente del 2,36%; mentre altrettante
regioni del Sud hanno visto lievitare la loro parte solo dell' 1,75%: significa
più o meno 1 miliardo in meno in 5 anni. Proprio la stessa cifra destinata ai
giochi del 2026.
ITALIA TERRA DI NESSUNO. Siamo al
punto finale di un Paese che si crogiola nell’eccesso di debito e nella carenza
di Stato. Roberto Napoletano su Il Quotidiano del Sud il 5 novembre 2020. Lo
Stato patrigno si permette di dare 84,4 euro pro capite a un cittadino
emiliano-romagnolo e 15,9 euro a un cittadino calabrese di investimenti nella
sanità come se nulla fosse, e poi che fa? Arriva a chiudere la regione, che lo
Stato ha commissariato da dieci anni e che i tedeschi hanno indicato come zona
meno infetta, perché non ha nulla o quasi per proteggersi sul piano sanitario.
Praticamente stracornuti e stramazziati. Otto mesi fa il commissario Arcuri la
conosceva o no la situazione delle terapie intensive della Calabria? Che cosa
hanno fatto lui e Speranza per acquistare posti letto e prepararsi alla seconda
ondata? Stracornuti e stramazziati. C’è un punto dell’Italia dove il Paese
Arlecchino dei Capetti Regionali che danno ai ricchi e tolgono ai poveri e il
rigore ottuso di ragionieri ministeriali graduati con le stellette e muniti di
poteri commissariali, possono decretare la morte sanitaria, economica e civile
di una intera nazione. Benvenuti in questa terra di nessuno che non è solo la
Calabria ma l’Italia dove non si capisce più chi comanda e tutti i poteri
istituzionali non sono impegnati a fare ma piuttosto a fare molto perché nessuno
di loro faccia qualcosa dentro un inverecondo scaricabarile di responsabilità.
Benvenuti nel pezzo estremo di questa terra di nessuno dove aziende sanitarie
che non presentano bilanci e altre accusate di infiltrazioni della criminalità
organizzata hanno portato giustamente al commissariamento della sanità regionale
senza che questo abbia migliorato di fatto qualcosa. Perché tra un piano di
rientro e l’altro dello Stato patrigno e un taglio alla fonte di investimenti
fissi in sanità che permette di dare 84,4 euro pro capite a un cittadino
emiliano-romagnolo e 15,9 euro a un cittadino calabrese come se nulla fosse,
l’unico risultato possibile è che si arrivi a chiudere la Regione che i tedeschi
hanno indicato come zona meno infetta perché non ha nulla o quasi per
proteggersi sul piano sanitario. Chiudendo la Calabria peraltro, forse, metti
ulteriormente in crisi anche il livello sanitario, ma soprattutto riconosci che
hai un deficit patologico strutturale e che tu Stato patrigno non hai fatto
nulla per risolverlo. Otto mesi fa, commissario Arcuri, la conosceva o no la
situazione delle terapie intensive della Calabria? Sì o no? Che cosa ha fatto
per acquistare posti letto e prepararsi alla seconda ondata? Otto mesi otto: che
cosa ha fatto lei, lo Stato, i suoi commissari sanitari perché la Calabria
venisse prima di tutti in quanto partiva da più indietro di tutti e non ha più
potestà regionali in materia? Che cosa ha fatto per fare capire ai commissari
che l’equilibrio finanziario che prevede la morte del paziente non guarisce la
sanità, ma condanna un popolo intero al turismo sanitario e la sua economia alla
disfatta? Che cosa può avere spinto a trattare il Piemonte, principale
responsabile del deficit sanitario nazionale, meglio della Puglia o la Liguria,
corresponsabile con il Piemonte dello stesso deficit, meglio della Sardegna?
Perché mai tutti questi soggetti regionali che hanno sempre avuto di più della
Calabria sono trattati meglio anche in piena Pandemia? Quale logica si è voluto
seguire? Ci troviamo di fronte al paradosso che le Regioni pluriforaggiate dalla
spesa pubblica e con un accesso al capitale privato molto più elevato diventano
zona rossa (Piemonte e Lombardia) perché nonostante tutte le risorse di cui
ingiustificatamente beneficiano non sanno fare prevenzione e hanno tassi abnormi
di contagio. Viceversa le Regioni svantaggiate come quella calabrese che hanno
comunque un basso tasso di contagio devono chiudere ciò che resta della loro
economia e della loro vita sociale. Perché prima il federalismo della
irresponsabilità li ha privati dei diritti di cittadinanza sanitaria e
scolastica e poi perché uno Stato patrigno – che indossa l’abito dei
commissari-ragionieri e di quello all’emergenza affetto da acuto strabismo
nordista – fa strame non delle sue pretese ma dei suoi più elementari diritti.
Come si spiega, commissario Arcuri e ministro Speranza, questa insopportabile
differenza tra Centro-Nord e Sud anche nella ripartizione degli interventi di
emergenza? Perché si comprano più letti di terapia intensiva per una parte
rispetto all’altra? Siamo, forse, al punto finale di un Paese che si crogiola da
troppo tempo nell’eccesso di debito e nella carenza di Stato come ammonivano
molto tempo fa in un libro famoso (L’economia italiana, edizioni il Mulino)
Ignazio Visco e Luigi Federico Signorini. Questo tentativo lombardo di buttarla
tutta in politica è deplorevole anche se il Governo deve essere in grado di
fornire tutte le spiegazioni necessarie per capire bene come funzionano i
criteri uguali per tutti. Un punto importante dell’Italia di oggi è quello di
decidere i progetti a partire dalla sanità e, ancora di più, l’esecuzione dei
progetti individuati come cruciali dalle strutture con team motivati. Non siamo
in grado di avere una capacità di intervento pubblico strutturale, ma solo
congiunturale che fa crescere il debito. Questa situazione è frutto anche della
cattiva disposizione dei politici nei confronti di chi lavora nelle
amministrazioni pubbliche dei ministeri e nei governi regionali e dal loro
conseguenziale, progressivo scadimento, ma ancora prima da un assetto
istituzionale che è fatto apposta per non decidere e aumentare gli squilibri
territoriali. Per questo mi viene spesso di pensare che solo l’Europa potrebbe
liberare il Mezzogiorno dallo Stato patrigno e dai feudatari regionali del Nord
che hanno messo le mani sulla cassa da dieci anni in qua e non la mollano più.
Il ministro Speranza è molto preoccupato per la salute della Calabria,
apprezziamo la sua preoccupazione, ma farebbe bene a chiedersi che cosa ha fatto
lui e che cosa hanno fatto i suoi collaboratori da otto mesi in qua per la
Regione Calabria.
LO STATO IN TERAPIA INTENSIVA.
Roberto Napoletano su Il Quotidiano del Sud il 6 novembre 2020. Con questo
groviglio di poteri di veto e venti “capi di Stato” ombra, uno per Regione, il
Paese non ce la fa. Se non si torna a dare allo Stato quello che è dello Stato
non si va da nessuna parte. Anche se nessuno ve lo dirà mai ufficialmente non si
chiude tutto come è stato fatto a marzo perché lo Stato italiano non ha i soldi
per risarcire tutti. Ma la fiducia si è esaurita e nessuno è più disposto ad
attendere. Uno Stato dove nessuno è in grado di imporre un ordine. Che dipende
al 100% dai soldi della Banca Centrale Europea. Uno Stato che è tenuto in vita
da quegli acquisti che dureranno a lungo, ma sapendo che senza di essi fallisce
un minuto dopo. Siamo al Pandemonium italiano. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo.
Le Regioni messe in codice rosso vivono una misura sanitaria come un fallimento
politico. Altre Regioni messe in codice giallo esigono il codice rosso. Altre
regioni finite nel codice arancione reclamano il giallo. Tutti la buttano in
politica. Tutti straparlano. Tutti quelli che straparlano hanno fatto poco e
male. Non è da meno il governo. Che arriva tardi, sei giorni dopo e senza soldi.
Che arriva male e, cioè, dopo avere bruciato credibilità e gran parte degli
effetti concreti delle nuove restrizioni per essersi rinchiuso in un conclave
eterno allo scopo di strappare un consenso impossibile su una regola comune ai
“padroni d’Italia” che sono i Capetti delle Regioni del Nord. Non si può
chiedere alla Conferenza Stato-Regioni, dove la regola è l’arbitrio e dove è
morto per miope egoismo lo spirito unitario del Paese, che improvvisamente
approvi una regola uguale per tutti. Una regola che prevede parametri uguali per
i cittadini lombardi e campani o per i cittadini emiliano-romagnoli e quelli
calabresi. Al massimo, come è accaduto, questa regola comune si può solo
imporla. Perché è l’esatto opposto di quello che ha fatto fino a oggi la
Conferenza Stato-Regioni da sempre saldamente nelle mani della Sinistra
Padronale tosco-emiliana e della Destra lombardo-veneta a trazione leghista in
combutta tra di loro. Sapete che cosa vuol dire tutto ciò? Che non è vero che è
stata tagliata la sanità come si sente dire in giro perché nel lungo termine la
spesa è cresciuta mediamente del 3,5 % l’anno. Chi lo sostiene dice una balla e
lo fa per nascondere i trasferimenti indebiti alle Regioni del Nord. Chi invece
dice che le Regioni del Sud hanno subito un taglio drastico soprattutto nelle
assunzioni non dice una balla. Questa è la sacrosanta verità. Ergo: quando la
Pandemia era solo nelle regioni del Nord si soffriva molto, ma si poteva
immaginare di resistere per gli ingenti trasferimenti avuti e il tasso presunto
di organizzazione, ora invece che la Pandemia è anche al Sud si sente sulla
pelle delle persone il morso di quei tagli ingiusti. Al punto che con i
parametri comuni adottati devi chiudere la Calabria che ha un contagio leggero
e, quindi, sei costretto a uccidere un’economia in ginocchio non per colpa delle
pandemia, ma per colpa di un sistema sanitario che non è in grado di affrontare
l’emergenza per almeno due ragioni. La prima: è stato spoliato
ingiustificatamente di risorse dalla ripartizione incostituzionale tra le
Regioni che lede i diritti di cittadinanza della comunità calabrese nel silenzio
complice dei suoi amministratori. La seconda: perché, una volta commissariata la
sanità regionale per scandali veri e presunti, si è deciso di affidarne la
gestione a uno Stato Patrigno che non ha saputo fare altro che tagliare,
tagliare, tagliare, con criteri ragionieristici. Questo significa abolire il
Mezzogiorno e, di fatto, l’Italia. Questo significa, di fatto, dire ai calabresi
che sono penalizzati due volte fino all’inverosimile. C’è una verità più
profonda, però, che nessuno dice. Siamo dentro un pasticcio di Stato che non ha
precedenti. Perché c’è un sistema istituzionale dilaniato dal federalismo
dell’irresponsabilità. Perché in cassa non c’è più un euro nonostante le balle
che abbiamo raccontato sulla ripresa portentosa italiana unica al mondo e sui
soldi europeiche arriveranno ma non ora. Se fai un decreto di cosiddetti ristori
per un paio di miliardi fai una scelta assolutamente sottodimensionata. Anche se
nessuno ve lo dirà mai ufficialmente non si chiude tutto come è stato fatto a
marzo pur avendo dati peggiori di marzo, perché lo Stato italiano non ha i soldi
per risarcire tutti i soggetti economici di cui decreta la cessazione delle
attività e dare quindi a loro tutto ciò che è dovuto. Non ha tutta la cassa che
serve per impedire che la tensione sociale già esplosa incendi l’intero Paese.
Siamo davanti a un Paese sfibrato che va in piazza. La gente non è più disposta
come la prima volta a eseguire l’ordine alla cieca. Per questo hanno chiuso i
negozi di vestiti, i bar, i ristoranti, questo e quello, ma non hanno toccato
l’altro lavoro, almeno per ora ci provano. Affrontiamo la seconda ondata della
più grande crisi sanitaria globale e conseguentemente del nuovo ’29 mondiale con
un dpcm post-datato e un governo che non ha o, peggio, addirittura non può avere
la mano ferma sulla leva di comando perché il sistema Italia si è infilato con
le sue mani in un tunnel di egoismi da cui sarebbe stato difficile vedere la
luce anche senza Covid. Figuriamoci oggi che tutto congiura contro. Per almeno
tre motivi. Punto uno. Tutti hanno capito che i soldi veri non ci sono. Per cui
se io faccio il barista e devo morire perché né Governo né Regione hanno risorse
reali per me, allora io combatto come un pazzo con tutti i mezzi possibili
perché non sono disposto a morire. Punto secondo. L’inefficacia evidente dei
risarcimenti della prima ondata di modesta entità arrivati tardi o mai rende
tutti diffidenti. La fiducia si è esaurita e nessuno è più disposto ad
attendere. I proclami ripetuti di ottimismo fuori dalla realtà del ministro
Gualtieri sono miscela esplosiva. Punto terzo. Ci è toccata anche la peggiore
opposizione europea che ha sbagliato toni e comportamenti fin dal primo momento.
Soffia sul fuoco e si salda con il protagonismo inconsulto dei Capetti delle
Regioni. Quando la curva dei contagi si aggraverà ancora e il morso della fame
supererà il livello di guardia i Capi delle opposizioni sovraniste e i
governatori che fanno oggi le star non sapranno dove andare a nascondersi.
Forse, a questo punto, è più chiaro a tutti perché si fa fatica a capire chi ha
la forza, l’autorità e i soldi per imporre quella disciplina civile che abbiamo
visto esprimersi a marzo e che si è rivelata fino a oggi l’unico modo per
ridurre i contagi. Perché si fa fatica a capire se chi ha la regia della
politica economica ha o non ha il controllo della barra e del motore per
condurre la barca italiana fuori dagli scogli dove marosi mai visti la hanno
scagliata. Con questo groviglio di poteri di veto e venti “capi di Stato” ombra,
uno per Regione, che si fanno belli con i soldi degli altri, il Paese è
destinato a uscire dal novero delle grandi economie industrializzate e la
Depressione mondiale può solo accelerare il processo. Questo giornale in
assoluta solitudine, dal suo primo giorno di uscita un anno e mezzo fa, sostiene
che se non si esce dal federalismo dell’irresponsabilità e non si torna a dare
allo Stato quello che è dello Stato non si va da nessuna parte. Se ci fosse la
politica con la P maiuscola avrebbe la doppia consapevolezza della gravità del
momento globale e della gravità del momento italiano. Il frastuono dei Capetti e
dei loro piccoli e grandi sponsor non impedirebbe a quella Politica di metterli
a posto.
I CALABRESI PAGANO TANTO PER LA SANITÀ. RICEVONO NULLA E I
SOLDI VANNO AL NORD. Dieci anni di burocrazia e commissariamenti, di piani di
rientro e scontri furibondi. Velerio Panettieri su Il
Quotidiano del Sud il 6 novembre 2020. La Calabria non è in zona rossa da oggi,
lo è da almeno dieci anni. Dieci anni di burocrazia e commissariamenti, di piani
di rientro dal debito sanitario e scontri furibondi tra politica e tecnici. Di
decreti speciali rinnovati ogni diciotto mesi e una gestione della burocrazia
sanitaria impossibile da controllare. Non è una questione di contagi (che ci
sono e preoccupano), o il problema del controllo dei tracciamenti e del numero
di posti letto che non soddisfa neanche gli standard basilari dettati dal
ministero della Salute. Tutto questo è una conseguenza, un problema radicato
dietro le cifre ragionieristiche, i tagli lineari che hanno chiuso reparti e
interi ospedali nel corso di un decennio e mandato a casa 3mila 700 operatori
sanitari che non sono mai stati rimpiazzati per effetto del blocco del turnover
imposto dallo stesso piano di rientro dal debito sanitario. La Calabria è un
buco nero se si guarda ai conti: lo è per l’emigrazione sanitaria, che genera un
saldo negativo allo stato attuale fermo sui 278 milioni di euro. Milioni che la
Calabria paga ad altre regioni. Lo è perché due aziende sanitarie, quella di
Catanzaro e Reggio Calabria sono state sciolte per infiltrazioni mafiose, per
una gestione assurda degli appalti sanitari affidati a ditte in chiaro odore di
mafia, per le doppie e triple fatture pagate ai privati e la contabilità
creativa che ha generato mostri, per anni di bilanci mai presentati che hanno
generato milioni di euro di debito. Lo è per un’altra azienda, la più grande di
tutte, che da anni si ostina a non presentare neanche un bilancio. Solo a Reggio
Calabria il volume dei contenziosi sfiora un miliardo di euro. Tutto messo nero
su bianco dalla commissione prefettizia che in questo momento sta reggendo
l’Azienda sanitaria provinciale. L’ultima rilevazione sul crack finanziario
della sanità calabrese ha certificato un debito di 200 milioni di euro circa,
parte del quale non risulta coperto né dal fondo sanitario nazionale né
dall’aumento progressivo del gettito fiscale Irap e dall’addizionale Irpef,
altra conseguenza puramente punitiva per non essere stati bravi a fare i conti a
casa. E poi ci sono i livelli essenziali di assistenza. In Calabria sono sotto
soglia da tempo, a gennaio 2020 finalmente abbiamo raggiunto la soglia dei 162
punti. Una soglia basata su 33 indicatori che raccontano lo stato della sanità
in Calabria dai ricoveri agli screening oncologici, passando per l’assistenza
alle fasce più deboli. E il fatto che negli anni siano piombati da ministero
dell’Economia e della Salute una marea di commissari non ha cambiato le carte in
tavola. Perché è la ricetta ad essere sbagliata: investimenti ridotti all’osso e
politica al risparmio. È innegabile che lo strumento del commissariamento dopo
oltre dieci anni, non abbia prodotto i risultati sperati. Men che meno adesso
che la regione si è trovata in mezzo ad una pandemia. L’ultima riunione
interministeriale con l’attuale commissario, il generale Saverio Cotticelli, è
finita letteralmente in un bagno di sangue. Una resa dei conti nei confronti
dello stesso commissario che non avrebbe fatto quello per il quale era stato
mandato da queste parti. Il debito è fermo sui 200 milioni di euro, non tutto
coperto dall’aumento delle tasse. E qui la beffa è doppia: i calabresi pagano
tanto per la sanità, ma ricevono sostanzialmente poco o nulla. E tutto è anche
frutto di una reiterata politica predatoria e clientelare che ha interessato
tutti i colori politici per oltre un decennio. Il risultato è sotto gli occhi di
tutti: ospedali che chiudono reparti per giorni perché non funziona un
ascensore, strutture con 2,5 posti letto ogni 100mila abitanti, ben al di sotto
di qualsiasi media nazionale e ritardi sul pagamento dei fornitori che superano
ampiamente i tre anni. Il punto è tutto qui, non sono le eccellenze mediche a
mancare in Calabria, spesso infilate in scenari di vera e propria guerra, c’è
uno sperpero continuo di risorse e una burocrazia tremenda che tutto fagocita.
Anche la nuova proroga al decreto Calabria, che dovrebbe consegnare ulteriori
poteri al prossimo commissario (Cotticelli ha già annunciato le sue dimissioni)
non fa dormire sonni tranquilli. Ma da questo labirinto del Minotauro fino ad
oggi nessuno è riuscito a trovare una via d’uscita.
PERCHÈ LE OPERE PUBBLICHE AL SUD FANNO RUMORE? LA
TRAGICOMMEDIA DELLA FERROVIA ADRIATICA E ALTRE STORIE.
Raffaele Vescera su movimento24agosto.it il 19.10.2020. “Fa più
rumore una scorreggia fatta a Napoli che una bomba esplosa a Milano”. E’ un
detto ormai proverbiale per denunciare la scarsa attenzione dei media italiani
verso quanto di clamoroso accade al Nord nel campo del malaffare, al contrario
del rilievo sovrabbondante che viene dato a quello del Sud, bollato come
Gomorra. Eppure i numeri diffusi dal ministero degli interni parlano chiaro: le
città con il tasso di criminalità più alto sono tutte al Nord, a partire da
Milano, seguita da Rimini, Bologna, Venezia, Firenze, Genova, etc. Per trovare
la prima città meridionale bisogna scendere a metà classifica, Napoli dopo il
30° posto. Ma queste sono altre storie. Quanto invece oggi ci sta a cuore, è
l’ennesima decisione di impedire la costruzione del raddoppio di binario
ferroviario sulla linea adriatica al Sud, tra Foggia e Pescara, dove un tratto
di 27 km tra Lesina e Termoli è ancora fermo al binario unico inaugurato 157
anni fa. Un binario unico che obbliga i treni a fermarsi alla stazione
precedente per permettere il passaggio del convoglio proveniente in senso
inverso, con attese che possono a volte superare il quarto d’ora, laddove oggi,
da Bologna in su, in 15 minuti i Tav a 300 km l’ora fanno 75 km di strada. Senza
dire che nel caso di lavori urgenti da farsi su quel vecchio binario
meridionale, triste e solitario, la circolazione si può bloccare per giorni
interi. Quale sarebbe la causa del nuovo impedimento alla costruzione del
secondo binario e perché la realizzazione, pur finanziata dal 2001 è ferma da
vent’anni? Farebbe troppo rumore. Sic! “La sottocommissione Via-Vas del
ministero dell’Ambiente ha chiesto a Rfi alternative progettuali in termini di
tracciato meno impattanti sul territorio e verso la popolazione: nella relazione
è evidenziata «l’inopportunità di risolvere il problema esclusivamente
attraverso il sistema delle barriere, unanimemente ritenuto inadeguato. È
opportuno che Rfi ponga in essere ulteriori opzioni risolutive innovative».”
Insomma, il nuovo tracciato risulterebbe insopportabilmente rumoroso per gli
abitanti. Eppure chi conosce quella zone sa che tra la cittadina di Lesina, dove
peraltro il binario passa ad alcuni km di distanza, e Termoli, non vi sono
centri abitati. Il vecchio binario, sempre triste e solitario, corre tra piatti
campi di grano con rare masserie e disabitate pinete marine. Allora chi
disturberebbe il rumore del ciuf ciuf elettrico in quelle desolate campagne? Ah,
sì, altro pretesto tirato fuori lo scorso anno, il rumore arrecherebbe fastidio
all’uccello fratino, tipico di quelle zone. Tanto sostiene il ministero
dell’ambiente e cotanto parere deve osservare Ferrovie dello Stato. Confesso la
mia tarda età. Quaranta anni fa, fermo a Termoli per una precedenza da dare a un
treno proveniente da Foggia, giovane insofferente, domandai a un anziano
capostazione il perché di tanta attesa. “Se ne parla dagli anni ’20, ma io credo
che noi il doppio binario, non lo vedremo mai." Mi rispose quell’uomo profetico.
Dunque, pur di non disturbare l’uccello fratino, anziché affiancare il secondo
binario a quello esistente, si è progettato una deviazione del percorso, dal
costo aggiuntivo di 170 milioni di Euro, per portare il binario nella valle del
Biferno, che a detta del ministero a causa del rumore diventerebbe una valle
dell’inferno, pur per gli scarsi abitanti del luogo, stante che l’intero Molise
conta meno abitanti della sola città di Bari. Il commissariamento dell'opera per
valenza strategica nazionale ed europea, no? Eppure, si è fatto in Val di Susa,
dove i binari attivi sono quattro e sottoutilizzati, e la devastazione
ambientale con la costruzione dell’inutile e dannoso tunnel, dal costo
astronomico di 12 miliardi di euro, va avanti, fregandosene delle proteste degli
abitanti, represse con manganelli e galera. Eppure anche il terzo valico ligure
(ne esistono già due) tra Milano e Genova, dall’altrettanto inutile, dannoso e
dall’astronomico costo di alcuni miliardi di Euro per risparmiare pochi minuti
di viaggio, va avanti indefesso. (Qui mi risparmio una battuta volgare.) In
conclusione, al Nord si deve investire purchessia, per volare sui binari in
concorrenza agli aerei, al Sud invece ogni pretesto è buono per non spendere un
centesimo e bisogna continuare a viaggiare a mezza velocità, in concorrenza alle
diligenze del tempo andato. Bari-Reggio Calabria in treno? Dalle 8 alle 14 ore,
fino a 4 cambi, sulla linea ionica per 450 km. Trapani Siracusa in treno? 11 ore
con tre cambi per 360 km. I conti della velocità fateli voi. In mezzo c’è lo
Stretto di Messina, con un ponte fantasma progettato da decenni. Ma questa è
un’altra storia.
Sudismi. Italia senza Lep da 10 anni, il Nord pensa
all’autonomia. Per la vera perequazione il Sud dovrà
imparare a lottare. Non sono bastati il fallimento della sanità lombarda e
l’anarchia delle Regioni per convincersi a tornare a un sano centralismo? Pietro
Massimo Busetta su Il Quotidiano del Sud il 23 ottobre 2020. Siamo rimasti fermi
per 10 anni alla spesa storica in attesa dei livelli essenziali di prestazioni
(Lep) e adesso sembra che dobbiamo correre per arrivare velocemente
all’autonomia differenziata chiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.
Forse dipende dal buon risultato che ha dato l’autonomia nel settore sanitario
che porta Francesco Boccia, in realtà il Pd, a spingere perché si arrivi al più
presto a vararla? Non è bastato il fallimento che anche in questi giorni
registra la sanità lombarda, ma in generale l’andare in ordine sparso delle
Regioni, per convincersi a tornare, per lo meno in alcuni settori chiave come la
scuola, la sanità e l’infrastrutturazione, a un sano centralismo?
ROBIN HOOD AL CONTRARIO. Troppo forte l’accordo tra la sinistra
padronale emiliano romagnolo e la destra leghista lombardo-veneta per potere
resistere? Certo, la battaglia condotta da parte della intellighenzia
meridionale, con in testa la Svimez, ha rallentato il percorso e ha fatto sì che
si siano poste alcune condizioni propedeutiche per il varo delle autonomie
differenziate, come la perequazione infrastrutturale e la definizione dei Lep,
che ora dovrebbero essere calcolati, dopo che per tanti anni la loro assenza ha
permesso uno scippo di 60 miliardi l’anno, distribuendo le risorse sulla base
della spesa storica. Anche se in molti non concordano su tale sottrazione,
compreso il “candido” Carlo Cottarelli, che in realtà, oltre a contestare i dati
dell’osservatorio dei Conti pubblici, non perde occasione per ribadire che la
distribuzione della spesa pubblica non debba avvenire sulla base della
popolazione esistente nelle varie zone, ma, come ancora sostiene in
un’intervista del 21 ottobre scorso al Mattino «le risorse devono essere
distribuite anche oltre la proporzionalità del Pil pro capite». Quindi, secondo
tale interpretazione, lo Stato diventa un Robin Hood al contrario, che dà di più
a chi più ha e meno a chi ha meno. Infatti quella parola “anche” sembra una
concessione, cioè vuol dire che normalmente dovrebbero essere distribuite in
base al Pil prodotto, ma si può anche qualche volta derogare, facendo entrare
dalla finestra quello che sembrava uscito dalla porta, quel concetto di residuo
fiscale che ormai sembra essere stato abbandonato da tutti, se Svimez in una sua
recente nota afferma: «Le motivazioni di quel rivendicazionismo sono
gradualmente uscite di scena perché troppo evidenti erano i limiti
dell’interpretazione “territoriale» . Sommessamente ricorderei che tale
distribuzione strana delle risorse avviene anche per le Università, per le quali
esse sono state date sulla base di un meccanismo che a prima vista premia i
migliori. Ma mettendo insieme i parametri di efficienza del sistema, della sua
capacità di competere nel mondo attraverso le citazioni internazionali e infine
sul placement dei propri studenti, sono state premiate le università ovviamente
penalizzando gli studenti, che senza colpa si ritrovano man mano, al Sud , a
studiare in super licei, mentre la parte di ricerca viene lasciata alle
Università del Nord. E questo è un altro capitolo della stessa storia.
FONDO DI PEREQUAZIONE. Ma torniamo alla autonomia differenziata.
Dopo l’inserimento della legge quadro nel Nadef, la nota di aggiornamento al
Def, come promesso dal ministro Boccia, arriva anche, sempre all’interno della
legge di Bilancio, il fondo di compensazione per il divario infrastrutturale.
«Le risorse sono state incluse nelle tabelle della manovra e saranno a
disposizione del Mezzogiorno, delle aree interne e delle aree di montagna non
appena sarà approvata la legge sull’autonomia». Si tratta di 4,6 miliardi. Vale
a dire quel «fondo di perequazione infrastrutturale» che è uno dei cardini della
legge quadro sull’autonomia firmata dal ministro per gli Affari regionali. II
principio è che l’autonomia vada a braccetto con il superamento del gap
infrastrutturale del Sud. Nella legge quadro si parla anche di «aree interne
montane» e di «aree disagiate». Quindi le risorse per la perequazione
infrastrutturale possono anche andare a finanziare aree a 20 km da Milano, che
abbiano problemi particolari. Al solito: una sorta di complesso di colpa del Sud
che, per far passare alcuni finanziamenti, deve estenderli anche al Centro
Nord. Ma al di la di tale aspetto, sembra molto ingenuo pensare di eliminare il
ritardo di infrastrutturazione con 4 miliardi e mezzo, con i quali al massimo si
potranno fare 90 , dico 90, chilometri di vera alta velocità ferroviaria. Anche
perché bisognerà vedere come andranno destinate. Si potrà dire che è un primo
passaggio, ma intanto è interessante vedere il dibattito tra De Menech,
coordinatore dei parlamentari veneti del Pd a Roma e la neo vicepresidente
regionale Elisa de Berti, chiamata “la doghessa”, il mastino che prenderà il
posto di Luca Zaia alla fine del terzo mandato. Il primo sostiene che il fondo
consentirà di finanziare opere per esempio in Lessinia Polesine altopiano di
Asiago e provincia di Belluno. «Convocherò presto i sindaci, le associazioni di
categoria e le parti con cui stabilire le priorità; spero la Regione capisca che
quei soldi servono a dire a Rfi e Anas che quei soldi non saranno destinati solo
sulla base del bacino di utenza». E la risposta della vice presidente che accusa
il parlamentare Pd di essere stato all’estero negli ultimi cinque anni: «Si è
perso per strada centinaia di milioni che negli ultimi anni, grazie anche ai
mondiali di Sci e Olimpiadi, stiamo spendendo nel bellunese. Ti ricordo che
elettrificazione delle linee ferroviarie verso nord l’abbiamo ottenuta puntando
i piedi. Con Anas vengono investiti una marea di soldi, sull’Alemagna, per gli
impianti a fune, per le varianti di Cortina Longarone. Su Lessinia, altopiano di
Asiago e Polesine si può fare di più, certo, ma ci vuole onestà intellettuale».
LOTTA PER LA PEREQUAZIONE. Illuminante questo scambio di battute
di come potrà andare la perequazione infrastrutturale e di come le risorse
potranno essere spese. E di come bisognerà lottare per non essere beffati. Ma
questa battaglia chi la dovrà fare? La nostra classe dominante estrattiva
occupata a raccogliere mancette per i propri clientes? Si può rimproverare ai
veneti di fare in modo che arrivino più risorse nelle loro zone? O vanno
premiati per l’impegno che pongono nel difendere i propri rappresentati?
Purtroppo le nostre responsabilità non sono poche e di certo dobbiamo competere
con chi ha fatto del proprio mandato una missione da portare a compimento,
sapendo che l’elettore lo premierà se avrà perseguito il bene comune. Forse
dobbiamo imparare.
STUDENTI IN FUGA DALLE CITTÀ SETTENTRIONALI. Si svuotano gli
appartamenti al Nord, ora conviene investire al Sud.
Luca La Mantia il 7 settembre 2020 su Il Quotidiano del Sud. Storie di anni a
spartirsi stanze e spazi comuni, di convivenze forzate dalla necessità, di liti
per il lavandino pieno o per i turni in bagno. Di festini improvvisati fra
quattro mura, di sogni e di nostalgie, di moke che sbuffano fumo di caffè
bruciato mentre gli occhi corrono sui libri. Di lavori occasionali per pagarsi
l’affitto, una serata in compagnia e per riempire frigo e dispensa di junk food;
giusto per andare avanti sino al prossimo ritorno a casa, per Natale e per
Pasqua, quando le valigie torneranno cariche di parmigiane, lasagne e vasetti di
pesto e ragù, stipati nei freezer. È una vera e propria generazione quella degli
studenti fuori sede Il dato che emerge da un’analisi dell’Ufficio studi di
Immobiliare.it secondo cui l’epidemia sta letteralmente svuotando le città
universitarie più quotate, in particolare quelle del Nord. La conseguenza è un
boom dell’offerta di stanze singole e posti letto in affitto nel 2020, con
picchi che sfiorano il più 300% rispetto al 2019. È il caso di Milano, la
metropoli maggiormente colpita dal fenomeno, dove l’incremento raggiunge il
290%. Segue la Bologna dell’Alma Mater, con un più 270% di vani sfitti. A Padova
in un anno l’offerta è quasi triplicata (+ 180%) e lo stesso vale per Firenze +
175%). Raddoppiata, invece, a Roma + 130%), Torino (+ 108%) e Napoli (+ 100%),
appena fuori dalla Top 5. Le altre città del Mezzogiorno che figurano nella
classifica sono Bari (+60%), Palermo (+ 43%) e Catania (+ 30%). I locatori meno
interessati sono quelli di Pisa (+ 12%), mentre la media nazionale segna un +
143%. «Didattica a distanza, smart working e South working hanno fatto
registrare quest’anno un boom dell’offerta di stanze e posti letto che in alcuni
casi, come a Milano, risulta quasi quadruplicata rispetto al 2019 – ha spiegato
l’Ad di Immobiliare.it Carlo Giordano – Studenti e lavoratori che sceglievano
soluzioni abitative transitorie, come quelle di una stanza singola o di un posto
letto in una doppia, hanno preferito in molti casi abbandonare momentaneamente
le città». La crescita dell’offerta ha frenato quella del caro prezzi, rimasti
sostanzialmente invariati. Anche perché nel 2020 non si è rilevata alcuna
impennata sui costi di questa tipologia di locazioni. La città più salata resta
Milano, dove la media del canone mensile richiesto è di 565 euro per una singola
e di 345 euro per un posto letto in doppia. Al secondo posto – a debita distanza
– c’è Roma; nella Capitale la media del prezzo richiesto è di 438 euro per una
stanza e di 287 euro per un letto. Seguono Bologna e Firenze dove per
affittare una singola sono necessari circa 400 euro. Sotto la soglia dei 400
euro si trovano poi Venezia – dove per una singola si chiedono in media 358
euro – Napoli (338 euro la singola) e Torino (330 euro). La maggior
convenienza delle città del Sud può offrire interessanti prospettive di
investimento e, quindi, di rilancio del Meridione. Se ne parla in un’altra
analisi di Immobiliare.it nella quale si sottolinea che con la progressiva messa
a sistema del lavoro agile potrebbe venir meno la necessità di trasferirsi
stabilmente nelle altre macroregioni. Piuttosto che mettere in conto 3/4mila
euro al metro quadro, richiesti ad esempio a Milano per comprare casa – sostiene
il portale – si potrebbe optare per le località del Mezzogiorno, dove il prezzo
spesso non supera i mille euro al metro quadro e addirittura, nelle realtà più
economiche, non raggiunge i 750 euro. Senza dimenticare, conclude l’articolo, le
politiche di quei comuni meridionali che promuovono il ripopolamento vendendo
immobili “a cifre simboliche o che addirittura pagano chi si trasferisce in un
piccolo centro con pochi abitanti”.
VETTE DA SCALARE PER CHI VIVE AL SUD. Il costo medio pro
capite della mobilità. Roberto Napoletano il 30 agosto
2020 su Il Quotidiano del Sud. Abbiamo calcolato quanto deve spendere di più o
di meno un cittadino a seconda dei territori in cui vive per muoversi e per
comprare merci. I primi risultati fanno tremare vene e polsi visto che tutte le
aree metropolitane del Mezzogiorno, esclusa quella di Napoli, non dispongono di
adeguate reti di trasporto su guida vincolata, cioè non sono supportate da reti
metropolitane. Non c’è peggiore sordo di chi non vuol sentire. Qualunque
indicatore si prenda della spesa pubblica italiana viene fuori l’anomalia miope
di una sperequazione abnorme nella spesa sociale e nella spesa infrastrutturale
tra Nord e Sud del Paese. Una sperequazione che, a suo modo, “urla” fino a
scassare i timpani degli interlocutori che non solo ci sono cittadini di serie
A,B,C…zeta ma che questa differenziazione voluta è l’origine del problema
competitivo italiano e, a seguire, del suo sviluppo negato. Non potremo mai
crescere se non fermeremo il pilota automatico con cui i capetti delle
cosiddette regioni forti estraggono ogni anno dal bilancio pubblico italiano
decine di miliardi dovuti alla popolazione meridionale per scuole, ospedali,
treni veloci, bus scolastici, trasporto locale e mobilità in genere e li
regalano alla popolazione settentrionale in parte per fare buona spesa sociale e
buone infrastrutture e in parte – purtroppo sempre crescente – sia per
alimentare clientele/assistenzialismo sia per finanziare indirettamente la
crescita delle attività criminali in combutta con mafie imprenditrici endogene
in settori sempre più estesi. Come rifiuti, movimento terra, grande e piccola
distribuzione, turismo, sanità, e così via. Questa è la malattia italiana e la
temperatura della febbre è salita di anno in anno nella Conferenza Stato-Regioni
dove la Sinistra Padronale emiliano-romagnola e la Destra lombarda a trazione
leghista hanno fatto e fanno il bello e il cattivo tempo. Ridurre il numero dei
parlamentari senza cambiare i compiti di Camera e Senato votando sì al
referendum, significa dare un altro colpo durissimo al Mezzogiorno non
assistenziale perché ne diminuisce le rappresentanze dei territori, ma
soprattutto aumenta indirettamente il tasso di inamovibilità dei “parlamentari
regionali” e di quel sistema di venti Staterelli che ha dato agli
“austro-olandesi” di casa nostra il potere incostituzionale di rapinare a loro
(ingiusto) favore le risorse pubbliche, ponendo le premesse del “crack italiano”
che riguarda Nord e Sud perché il primo è diventato una colonia franco tedesca e
il secondo – privato di tutto – è stato condannato al sottosviluppo. Se è vero,
come è vero, che sono gli unici due territori europei a non avere raggiunto i
livelli pre-crisi del 2007/2008, è chiaro che dobbiamo uscire in fretta da
questa spirale perversa. Se è vero, come è vero, che l’emergenza Covid mette a
nudo davanti agli occhi di chi vuol vedere gli effetti territoriali su scuole,
trasporti e ospedali pubblici di una distorsione così incredibile di
trasferimenti, a maggior ragione dobbiamo invertire totalmente la rotta. Questo
giornale in assoluta solitudine ha documentato, sulla base dei conti pubblici
territoriali della Repubblica italiana, il misfatto dello scippo di 60 e passa
miliardi di spesa pubblica lorda (ogni anno aumenta perché il pilota automatico
della spesa storica scava sempre più in profondità) operato dal Nord a sfavore
del Sud che ha determinato il record storico negativo di un reddito pro capite
dei cittadini del Mezzogiorno ridotto alla metà dei restanti due terzi del
Paese. Potremmo dire due nazioni separate in casa: una che è diventata Grecia
(il Sud d’Italia) una che è diventata Sud (il Nord d’Italia). Adesso con la
competenza tecnica indiscutibile di Ercole Incalza e di uomini di valore delle
istituzioni europee il Quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’Italia sta elaborando
quello che abbiamo voluto definire il CPCM e, cioè, il costo medio pro capite
della mobilità. Che cosa significa? Quanto deve spendere di più o di meno un
cittadino a seconda dei territori in cui vive per muoversi e per comprare merci.
I primi risultati fanno tremare vene e polsi visto che tutte le aree
metropolitane del Mezzogiorno, esclusa quella di Napoli, non dispongono di
adeguate reti di trasporto su guida vincolata, cioè non sono supportate da reti
metropolitane. La distanza tra costo di trasporto privato (5.000 euro l’anno) e
costo di trasporto pubblico (250 euro l’anno) determina un CPCM esplosivo – non
ha nulla a che vedere con i DPCM della stagione Covid – che si attesta su un
valore variabile tra 15 e 20 volte superiore per chi vive nei territori
meridionali rispetto a chi vive nei territori settentrionali. Sì, avete capito
bene, siamo ridotti così, e chi ne prescinde per interesse o ignavia è un pazzo
da legare. Capite allora perché l’Italia, non il Sud, si gioca tutto con il
piano Next Generation? Perché con questi differenziali interni o l’Italia si
presenta in Europa con un piatto unico che sono le reti digitali e materiali del
Mezzogiorno (fibra anche nel Comune più sperduto, treni veloci, porti e
retroporti, Ponte sullo Stretto) o continuiamo a fare i pasticci di prima (vedi
accordo Tim-Cdp) e allora facciamo il male irrimediabile dell’Italia. Anche
perché non si può giocare con la Commissione Europea che è fatta di persone
collaborative ma rigorose e di spirito critico. Se il 15 ottobre non dovessimo
superare l’esame perché non vogliamo dare al Sud la priorità che serve per
salvare l’Italia e che l’Europa ci chiede o perché siamo incapaci di fare
progetti in grande e preferiamo continuare a mercanteggiare con i capetti del
disastro Regioni, il segnale di poca credibilità italiana a livello europeo
avrebbe effetti devastanti in casa e ci procurerebbe problemi a livello
internazionale. Non ce lo possiamo permettere.
Faide tra Regioni e veti surreali fanno deragliare il treno
Italia. Claudio Marincola il 21 agosto 2020 su Il
Quotidiano del Sud. C’è un mistero che mette una contro l’altra due regioni del
Sud. Che fine ha fatto il Fratino? Chi l’ha fatto scomparire? Perché questo
volatile dagli occhi marroni e il becco nero non nidifica più in quello che fine
a qualche tempo era il suo habitat preferito? Sembrerebbe una questione
prevalentemente ornitologica, ma non lo è. L’uccellino, dalle piume grigio
cenere, è lungo appena 16 cm ma non sa di portare sulle ali una grande
responsabilità: da anni fa litigare Molise e Puglia. È una specie protetta. In
tutti i sensi. Blocca la realizzazione dell’Alta capacità ferroviaria adriatica,
una delle 130 opere infrastrutturali, una di quelle opere che secondo il governo
andrebbero fatte subito, senza perdere un solo minuto.
IL COLPO DI SCENA. È invece notizia di 40 giorni fa che la
valutazione di impatto ambientale del ministero dell’Ambiente ha dato parere
negativo. Quello che non si sapeva è che è bastato un solo voto contrario.
Quello del segretario della commissione, l’avvocato romano Sandro Campilongo,
esperto di diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo e
civile. Uno di che di volatili ne sa poco o niente. Era tutto pronto. Costo:
circa 500 milioni di euro. Raccolti i pareri, appaltati i 14 chilometri della
tratta pugliese, un bando da 106 milioni di euro. Mancava solo il via libera
agli altri 20 km in territorio molisano per completare il raddoppio della
Termoli-Ripalta, una tratta in cui da sempre si viaggia su binario unico. I
finanziamenti ci sono. Il cronoprogramma Rfi si sarebbe concluso nel 2022. C’era
l’ok della Ue per inserirlo nel quadro dello Spazio unico ferroviario e il sì di
tutti gli altri ministeri interessati. Aprire quel corridoio avrebbe effetti
benefici sul turismo e anche per il trasporto merci, che in questo modo verrebbe
trasferito su ferro alleggerendo l’autostrada da Tir e bisonti. Per il via
libera mancava solo la valutazione sull’impatto che la ferrovia avrebbe avuto
sull’ambiente avifaunistico. In quel tratto i binari potrebbero infatti
disturbare il Charadrius Alexandrinus, un migratore euroasiatico che viene a
svernare al Sud. Stesso dicasi per un’altra specie dai colori più vivaci, la
ghiandaia marina che ha la coda blu e riflessi verdastri.
L’UCCELLO FANTASMA. Qualcuno nel frattempo si è preso però la
briga di esplorare in lungo e in largo la zona interessata dal progetto per
trovare tracce di questi nidi. Steli, paglia, radichette. Appostamenti tra la
vegetazione, sabbia e sassi, fenditure di rocce. C’è chi ha provato persino con
i richiami: «Zit, tziu, tzi, zi, zirr…». Del Fratino nessuna traccia. Il parere
del ministero, arrivato con 90 giorni di ritardo, ha gelato le aspettative di
sviluppo e collocato l’opera su un (doppio) binario morto. Un’opera considerata
strategica boccata perché, come si legge nel dispositivo della commissione, 70
pagine di valutazioni e studi molto accurati, «manca la caratterizzazione
qualitativa e quantitativa della fauna nidificante e la sua distribuzione
nell’area di intervento». Nel frattempo, però, in quella specifica zona il
Fratino e la Ghiandaia (Coracius Garrulus), sono scomparsi. Chi li ha visti? Che
fine hanno fatto? «Il Fratino è una specie dunale e nidifica sulla spiaggia, non
arriva mai oltre la pineta – ha dichiarato al sito primonumero.it Nicola
Morante, presidente del Gruppo ornitologico molisano che da 40 anni frequenta la
zona e conosce quel territorio come le proprie tasche – Il Fratino non è mai
stato disturbato nemmeno dalla linea attuale, ben più vicina alla spiaggia di
quella che si dovrà fare e che corre a 300 metri dall’arenile nella zona a sud
di Campomarino, all’altezza del Saccione, e in alcuni punti a sole poche decine
di metri dalla spiaggia”. Anni e anni di progettazioni, studi, ricerche e lavori
buttati per il fantasma di un uccello che non c’è e se c’è vola indisturbato,
innocuo, accanto alla ferrovia. Una storia di veti incrociati, di ostruzionismo
tra Regioni. Di cavilli. I tecnici del ministero non avrebbero, tra l’altro,
raccolto alcun parere scientifico in materia di ornitologia. Con il risultato
che ora un uccellino fantasma blocca un’opera considerata strategica e di
interesse nazionale anche dal ministro della Cultura e del turismo, Dario
Franceschini.
UN SOLO NO CONTRO 30 SÌ BLOCCA TUTTO. Il Fratino: siamo sicuri
che la questione ambientale non sia solo un pretesto? Il presidente della
Regione Molise, Donato Toma, eletto nelle file del centrodestra, prende un
impegno: «È impossibile che ogni volta che insorge un problema ambientale ci
fermiamo. E una volta un uccello, un’altra una formica… serve uno sviluppo che
sia sostenibile. Noi il fratino lo abbiamo sulle dune di Termoli e lo tuteliamo.
Ho già programmato una giunta politica con il mio dirigente alle infrastrutture
per convocare un tavolo e invitare Rfi. Vogliamo trovare un soluzione per
riuscire a realizzare il raddoppio ferroviario». Ma chi è che non vuole il
completamento della linea? Tanto più che, a parte il segretario Campolongo,
l’intera commissione ministeriale Via e Vas, compreso il presidente, l’ingegner
Guido Monteforti Specchi, aveva dato parere favorevole: 30 sì contro un solo no
non bastano a togliere il freno. «È un’opera strategica non solamente per il
Mezzogiorno, ma per tutto il Paese – sostiene l’assessore ai Trasporti della
Regione Puglia, il dem Giovanni Giannini, in questi giorni in piena campagna
elettorale – realizzarla vorrebbe dire completare un lavoro iniziato con
l’innalzamento della galleria di Cattolica per consentire il passaggio dei
grandi container e raggiungere in quella tratta i 200 chilometri orari. Il
Molise ha preteso e ottenuto di trasferire la linea accanto all’autostrada e ora
tutti gli ostacoli si potrebbero superare».
MANDIAMO A CASA I PREDONI. Roberto
Napoletano il 19 agosto 2020 su Il Quotidiano del Sud. Avviso ai naviganti. Non
è possibile fare una legge dove è scritto che la crisi economica è vietata per
legge. Si possono vietare per un po’ i licenziamenti, ma non si può impedire
all’infinito alle aziende che non hanno più commesse di chiudere le loro
attività. I consumi sono crollati ai livelli di venticinque anni fa e sono quasi
tutti assorbiti dalle cosiddette spese obbligate. In silenzio hanno tirato giù
le loro saracinesche per non riaprirle più da un capo all’altro del Paese troppi
commercianti e artigiani. Precipita inascoltato e abbandonato negli abissi della
Grande Depressione quel pezzo di economia di mercato del Mezzogiorno che era
rimasto comunque in vita nonostante uno Stato che ha fatto figli e figliastri
nella spesa per infrastrutture e nella spesa sociale e un accesso al credito di
fatto negato. Diciamo le cose come stanno. La Grande Illusione sovranista
italiana che ha costretto il Paese a pagare un conto superiore a quello dei
danni prodotti da una terza guerra mondiale persa sull’altare delle due grandi
crisi globali – finanziaria e dei debiti sovrani – ha radici uniche nel panorama
europeo e mondiale. Sono le radici di un regionalismo predone che ha fatto
crescere nei territori padani la mala pianta di un egoismo miope che ha
aumentato il peso delle clientele e dell’assistenzialismo in economia mettendo
fuori mercato la grande impresa privata e allargando a macchia d’olio la
penetrazione della criminalità organizzata e della mafia imprenditrice endogena
in settori sempre più vasti come smaltimento rifiuti, movimento terra, sanità,
turismo, piccolo e grande commercio. Questo Paese Arlecchino dei mille conflitti
di interessi territoriali non regge più e ci espone al ridicolo. Tutte le
potestà legislative sono concorrenti fino alla paralisi. Il ricco è sempre più
ricco e il povero sempre più povero, senza rendersi conto il primo che l’eccesso
di povertà a cui il suo egoismo condanna il secondo alla lunga farà diventare
lui stesso povero. Dai tamponi alle discoteche per prendere la più banale delle
decisioni ci vogliono i tempi di una guerra punica moderna. Le decisioni
puntualmente impugnate davanti al primo giudice che si incontra per strada
arrivano quando metà del disastro è già avvenuto. A fare in modo che anche
l’altra metà si realizzi ci pensano strutture amministrative, sanitarie,
aeroportuali che non riconoscono l’autorità dello Stato e sono la degna
espressione della peggiore burocrazia mondiale che è quella delle Regioni e
delle società da esse controllate con primati sorprendentemente irraggiungibili
in Lombardia, come dimostrano gli ultimi casi di Orio al Serio e di Malpensa.
Parliamoci chiaro. Un cittadino lombardo riceve come spesa sanitaria pro capite
2533 euro e un cittadino emiliano-romagnolo 2142 contro i 1593 della Campania e
i 1701 della Sicilia. Sono i dati del settore pubblico allargato del 2018
elaborati dai conti pubblici territoriali a prezzi costanti del 2015. Con gli
stessi indiscutibili criteri sempre pro capite un cittadino emiliano-romagnolo
riceve 2069 euro per le reti infrastrutturali, un cittadino lombardo 1946 e un
cittadino campano 731. Sono i numeri, una minima parte, del regionalismo predone
all’italiana. Fino a quando il presidente della Conferenza Stato-Regioni,
Bonaccini, non risponde in Parlamento di queste vergogne civili, non rimuove
tali vincoli che sono macigni sulla competitività del Nord e del Sud del Paese,
e soprattutto continua a scappare dal suo dovere costituzionale di varare i
fondi di perequazione sociale e infrastrutturale ordinati dalla legge Calderoli
del federalismo fiscale del 2009, non potrà mai aspirare alla guida del Partito
democratico ma bensì della rediviva Lega secessionista del primo Bossi. Farebbe
bene nel frattempo a non chiedere più l’autonomia ma l’indipendenza degli
emiliano-romagnoli, come dice lui, magari insieme ai suoi “compagni di merende”
lombardi. Questo sistema perverso e iniquo inizia e conclude il problema
competitivo italiano. Perché ha azzerato la spesa per infrastrutture e tagliato
brutalmente quella sociale al Sud portando il reddito pro capite dei suoi
cittadini alla metà degli altri due terzi del Paese. Perché ha riempito di droga
assistenziale il Nord privandolo del suo primo mercato di esportazioni che sono
i consumi del Mezzogiorno e ha di fatto convertito all’assistenzialismo e ai
vizi della rendita pubblica settori sempre più vasti dell’impresa privata. Che,
non a caso, è deceduta alla voce grande impresa, se la passa non bene alla voce
media impresa, soffre terribilmente alla voce piccola impresa. Facciamola finita
prima che scadano i tempi delle leggi che bloccano i licenziamenti. Il Nord
faccia soffiare il suo vento, ma per chiedere che alla fiscalità di vantaggio
nel Sud e al piano di opere infrastrutturali sempre nel Sud – Alta velocità
ferroviaria, porti retroporti, Ponte sullo Stretto e rete unica in fibra – si
affianchi un massiccio piano di investimenti delocalizzati al Sud da parte di
ciò che è sopravvissuto delle imprese del Nord, ugualmente agevolati. Lo si
faccia cogliendo con convinzione l’occasione del Recovery Plan e sapendo che si
fa oggi quello che si doveva fare almeno venti anni fa. Ci si attrezzi
all’istante con una struttura centrale tipo prima Cassa del Mezzogiorno
scegliendo per una volta i migliori sul mercato e usando tutti i poteri
possibili: straordinari, speciali, commissariali. L’alternativa è che prosegua
il saccheggio interno e si consumi ogni reputazione residua in Europa. In mezzo
ci potrebbero essere un bel ricorso alla Corte Costituzionale e una sentenza che
obblighi le Regioni del Nord a restituire centinaia di miliardi alle Regioni del
Sud. Noi ci auguriamo che finisca questa sceneggiata di uno Stato diviso in
venti Staterelli, dove i governatori degli Staterelli a differenza di quello che
avviene in America non tassano e spendono, ma spendono solo. Quasi sempre male e
sempre “rubando” ai poveri per favorire i ricchi. Comunque, con soldi non loro.
IL PAESE ARLECCHINO NON ATTIRA TURISTI.
Roberto Napoletano il 21 agosto 2020 su Il Quotidiano del Sud. Se si vuole avere
turismo stanziale nel Mezzogiorno servono una buona sanità, un buono aeroporto,
treni veloci e una buona gestione dei rifiuti. Serve insomma tutto quello che è
stato rubato fino a oggi. Nord e Sud sono obbligati a crescere insieme, ma il
Paese Arlecchino delle venti Regioni, delle venti sanità, delle venti reti
digitali, delle venti reti ferroviarie, impedisce che ciò avvenga perché è
concepito su misura di ogni genere di egoismo e di miopia. Impedisce di fare
grandi opere. Ruba sistematicamente spesa pubblica sociale e di sviluppo alla
popolazione del Sud per regalare a piene mani assistenzialismo alle famiglie e
alle imprese del Nord. Scarica sui poveri il costo della rendita pubblica che
sostiene il reddito privato dei ricchi, non la produzione e la capacità di
produrre a livelli competitivi nell’arena globale. Di fatto ha messo fuori
mercato la grande impresa familiare del Nord in crisi di suo e drogata dai soldi
facili e ha condannato al sottosviluppo il Mezzogiorno desertificato di scuole,
ospedali, treni e fibra veloci, e così via. Siamo arrivati al capolavoro
assoluto di fare scendere il reddito pro capite di un terzo della popolazione,
venti milioni di persone, alla metà degli altri due terzi, privando il Nord del
suo primo mercato di “esportazioni” e l’economia italiana di quella dimensione
nazionale integrata minima per potere rimanere nel novero dei Grandi Paesi
industrializzati. Diciamo le cose come stanno: questo sistema insulsamente
regionalista dove perfino sulle discoteche – aperte, chiuse, aperte a metà –
ognuno si permette di fare di testa sua, per non parlare dei treni regionali e
locali, è cromosomicamente predisposto per fare dell’Italia quello che oggi è.
La grande malata d’Europa. Per capire quanto sia importante ristabilire con
urgenza la parificazione dei diritti di cittadinanza sociale e infrastrutturale
dove con il trucco della spesa storica ballano decine di miliardi l’anno tolte
ai territori meridionali e “regalate” ai territori settentrionali da almeno
dieci anni in qua, basti pensare alla questione del turismo e a quanto questa
dipenda dalla manomorta della Conferenza Stato-Regioni che toglie e dà a chi
vuole senza rendere conto a nessuno. Se si vuole avere turismo stanziale inglese
e tedesco non la settimana di vacanza, ma turisti che svernano tre mesi da
Londra o da Francoforte nelle perle del mare, delle campagne e dei monti del
Sud, che si innamorano dei suoi paesini e delle sue città piene di storia e di
cultura, servono una buona sanità con ospedali vicini e efficienti, un buon
aeroporto, treni veloci e una buona gestione dei rifiuti perché l’immondizia
sotto casa fa scappare perfino il turista giornaliero. Serve insomma proprio
tutto ciò che è stato rubato con il più clamoroso scippo della storia recente
alle donne e agli uomini del Sud. Si è fatto in Italia l’esatto contrario di
quello che si è fatto in Spagna, dove l’alta velocità ferroviaria è partita dal
Sud per arrivare al Nord, mentre da noi si è tornata a fermare all’altezza di
Eboli dimostrando che lo Stato non va oltre Salerno e “frega” così un pezzo di
Italia abbandonato dolosamente al suo destino. Quasi non lo riconosce. Per
questo la Conferenza Stato-Regioni deve tornare a essere ad horas un luogo di
consultazione non di decisione e il governo deve adottare il parametro della
spesa media nazionale in rapporto alla popolazione sulla base della serie
storica degli ultimi venti/trenta anni. Chi è sopra restituisce, chi è sotto
finalmente riceve ciò che gli spetta. Si utilizzi il Mes per consentire alle
Regioni ricche di avere una fase di transizione per provare a camminare con i
soldi propri non con quelli degli altri, ma si comincino a ammodernare e fare
ospedali e scuole nei territori meridionali e si rimettano in rete le loro
bellezze e le loro città con alta velocità, porti e retroporti. Questo significa
pensare al futuro dell’Italia e avere turismo di lunga durata negli angoli più
belli del suo Mezzogiorno. Non avere buoni ospedali, buoni treni, buona rete in
fibra è esiziale per vincere questa scommessa. Se si continua con l’andazzo
predatorio regionalista attuale averli oggi è impossibile. Liberiamo l’Italia
dal Paese Arlecchino e dalla sua furia masochista.
Pino Aprile aggiorna "Terroni" e chiama a testimone il virus.
Il presunto fallimento nella gestione dell'emergenza è
il pretesto per minacciare (nuovamente) la secessione. Carlo Lottieri, Venerdì
21/08/2020 su Il Giornale. Quello uscito a firma di Pino Aprile con il titolo Il
male del Nord. Perché o si fa l'Italia da Sud o si muore (Pienogiorno, pagg.
175, euro 16,90) può apparire un instant-book sulla pandemia. In realtà, il
pamphlet è un'altra, ennesima, riformulazione delle tesi di Terroni, solo che
ora il Coronavirus è sfruttato per sostenere la tesi che di fronte all'emergenza
il Nord è stato pessimo e il Sud eccellente. Il volume dedica tante pagine al
fallimento di un Nord che, in fondo, dinanzi al virus avrebbe mostrato tutta la
sua inefficienza. Uno degli epicentri non è stato forse quel Trivulzio da cui
partì l'inchiesta di Mani Pulite? Tutto torna. Il Nord riempitosi di bare ha
avuto, in fondo, quel che era inevitabile. L'altro aspetto su cui Aprile insiste
è l'eccellente prova offerta dalle istituzioni regionali di Campania e Puglia di
fronte all'emergenza, oltre che di quei sistemi sanitari. Al di là di questa
vittoria schiacciante (pochi morti al Sud, tantissimi al Nord), ad Aprile è
altro che interessa. Come già nei libri precedenti, all'autore preme soprattutto
evidenziare come troppi segnali ormai ci mostrino quanto «lo squilibrato, iniquo
sistema-Italia sia al capolinea, esasperato dall'ingordigia del Nord». Allora il
Sud non ha soltanto vinto il derby: lo ha stravinto, dato che ha retto dopo
molti decenni di sfruttamento territoriale. Anche qui quella del Sud
continuamente depauperato dal Nord è la vera tesi del libro. Aprile ha ragione
quando ricorda che l'unificazione italiana fu una criminale guerra di conquista,
ma mescola tutto ciò con mille altre cose. Ad esempio, afferma che la relativa
prosperità goduta dalle popolazioni settentrionali nei decenni passati sarebbe
stata conseguente al fatto - come disse il ministro Provenzano - che Milano e il
Nord prendono e non danno. Quel benessere non poggiava allora sul tessuto delle
piccole imprese e neppure sull'ingegno di Caprotti, Del Vecchio o Ferrero. No.
Se nel Settentrione si è avuta una certa agiatezza è perché si è sfruttato il
Mezzogiorno. Attenzione: Aprile non sottolinea - come sarebbe giusto - che
l'interventismo pubblico crea enormi opportunità per gli imprenditori che vivono
all'ombra della politica, ma colloca l'intero Settentrione entro questo schema.
Sullo sfondo c'è non soltanto un'evidente antipatia verso quanti vivono a una
certa latitudine, ma anche un'opzione socialista. E in effetti perfino l'Italia
giallo-rossa appare ad Aprile come iper-liberista. Così nelle sue pagine il
rapporto tra Nord e Sud d'Italia evoca la stessa relazione tra Nord e Sud del
mondo della letteratura terzomondista. In entrambi i casi i ricchi prosperano e
i poveri declinano, «al punto che il club dei super-ricchi diviene sempre più
esclusivo e se appena qualche decennio fa poche migliaia di paperoni avevano la
stessa ricchezza di metà della popolazione mondiale, oggi è una mezza dozzina di
loro a possedere altrettanto». Fin qui siamo nell'ambito di una scrittura
emozionale, che in qualche modo fa leva su una delle conseguenze più spiacevoli
dell'unificazione: avere creato una tensione identitaria tra popolazioni che in
passato si erano sempre rispettate e avere costruito (su questo Aprile ha
ragione) un astratto modello a cui adeguarsi, estraneo alle potenzialità del
Mezzogiorno. Queste pulsioni, però sono incompatibili con l'argomento cruciale.
Fin dal titolo, dopo aver maledetto (con moltissime ragioni!) l'unificazione
della penisola e dopo aver versato fiumi di bile su lombardi e veneti, Aprile
ripropone la medesima ricetta: «O si riparte dal Sud e dall'uguale diritto per
tutti o la prossima tappa è la secessione». La prossima tappa? Ma come fa Aprile
a immaginare di restare entro un universo così iniquo? O crede alle cose che ha
scritto, e allora deve pretendere l'immediata secessione, oppure l'intero volume
non ha alcun senso. Sarebbe come se gli schiavi neri delle piantagioni si
fossero rivolti ai loro padroni, a metà Ottocento, dicendo che o alla svelta
gettavano le fruste, oppure si sarebbero ribellati No: di fronte a
un'istituzione tanto ingiusta c'è solo la strada dell'abolizionismo. D'altro
canto, egli è contrario pure a modeste forme di autogoverno, dato che «con
l'Autonomia differenziata, le Regioni ricche puntano ad arricchirsi
ulteriormente, sottraendo ancora alle più povere oppure mirando alla secessione
per non dividere con chi ha meno». Insomma, nella visione politica di Aprile il
Nord usa l'Italia per sfruttare il Mezzogiorno e la risposta a tutto questo
sarebbe una strenua difesa della Repubblica unitaria d'impianto giacobino. Alla
fine, nonostante gli attacchi all'Italia «matrigna», con questo volumetto Aprile
appare davvero il prototipo dell'italianità: di quella mancanza di rigore e
coerenza che tanti, da fuori, giustamente ci rimproverano. Per fortuna nel
Mezzogiorno c'è moltissima gente che si rende perfettamente conto come sia
proprio il comunismo territoriale difeso da Aprile a distruggere il Sud, dato
che solo l'autogoverno implica responsabilità, riduzione del potere politico,
fine di ogni illusione statalista. Il Mezzogiorno non si merita questa
confusione di idee e per questo fa bene - nella sua maggioranza - a tenersi
lontano da tesi tanto discutibili.
FITTO, CANDIDATO GOVERNATORE DELLA PUGLIA PER IL CENTRODESTRA:
“I FONDI DEL RECOVERY FUND NON VANNO DATI AL SUD, BENSI’ AL NORD”.
Raffaele Vescera il 13.08.2020 Giovanni Palmulli su
movimento24agosto.it. Aberrante, raccapricciante! La dichiarazione di Raffaele
Fitto, candidato governatore in Puglia, fa accapponare la pelle e davvero tocca
il fondo dell’aberrazione politica in Italia.
Andiamo per ordine. Cosa ha detto Fitto nel corso del programma
“In onda” dell’altra sera?
“Io non sarei nemmeno d’accordo sul gruppo di parlamentari
meridionalisti perché è una iniziativa assolutamente sbagliata. Noi dobbiamo
intervenire sulle misure e le risorse per il Covid nelle parti del paese che
hanno subito questo tipo di impatto in modo molto maggiore. Nel Sud i problemi
sono diversi, sono molto più complessi e andrebbero affrontati con una logica
diversa”.
Insomma Fitto, allineandosi al politicamente corretto del copione
politico italiano, riserva soldi e l’indicativo presente al Nord (dobbiamo
intervenire nelle parti del paese…) lasciando al Sud promesse, al condizionale
e/o al futuro (nel Sud i problemi andrebbero affrontati…). Fin qui siamo nella
vecchia e logora prassi politica degli ultimi 160 anni. Ma Fitto va oltre. Fitto
prende posizione nel nuovo scenario della politica italiana. Mentre nasce uno
schieramento meridionalista trasversale in Parlamento, mentre il P.U.N. (il
Partito Unico del Nord, trasversale da sempre) si schiera lungo la linea Maginot
a difesa della vecchia politica di privilegio del Nord e sopraffazione verso il
Sud, lui, Fitto, dice a chiare lettere di stare dalla parte della fazione
politica che lo ha candidato. Fazione politica che sta a Nord, con il Nord, per
il Nord. E così il nostro bravo candidato salentino dichiara che sbagliano i
meridionalisti trasversali (ma non i nordisti trasversali – misteri della
politica italiana!) e che i Recovery Fund va destinato al Nord, come il Piano
Marshall e tutto il resto da 160 anni in qua. Perché lì il virus ha colpito
pesante! Fitto (e il sig. Senaldi) ignorano deliberatamente che il R.F. non
viene dato per curare le ferite da Covid (altrimenti la Spagna – ben più
pesantemente colpita dal virus – avrebbe ottenuto somme ben maggiori delle
nostre), ma per rilanciare le economie dei vari paesi europei. E l’Itala ha
avuto più di tutti perché ha al suo interno la più vasta Macroarea
economicamente depressa esistente in Europa. Il R.F. deve dunque servire a far
ripartire questa Macroarea (il nostro Sud) perché se riparte il Sud riparte
l’Itala e si salva la stessa Europa! Ma Fitto, (come hanno già fatto Bonaccini,
Sala, Malan, Martina, Zingaretti ecc…) non può né accettare né ammettere questo
assunto, peraltro evidente e messo per iscritto dalla Comunità Europea. Fitto,
come gli altri politici citati, deve portare acqua al mulino del Nord, lì dove
vivono i suoi politici di riferimento e i rimboccatori di maniche, quelli che si
sono fatti da soli, con il loro lavoro (trascurabili gli abbondanti
foraggiamenti statali!). E lo deve fare a costo di tradire la sua terra e
perdere la sua stessa faccia. Una considerazione va fatta: Fitto e similari
hanno sempre attuato questa politica, ma prima lo facevano senza che nessuno se
ne accorgesse. Ci davano una briciolina e la presentavano come una grande
vittoria. Ora questo non lo possono più fare perché li abbiamo smascherati, noi
del M24A-ET sicuramente, ma non da soli. Il ringraziamento è d’obbligo verso
tutta l’onda meridionalista iniziata da qualche anno in qua. Ora non lo possono
più fare, dicevamo, e sono costretti a schierarsi apertamente, o con la Puglia
(e il Sud) o con chi li candida e li sostiene politicamente, pazienza se ciò
comporta sostenere le loro assurde e arroganti tesi. Se si sono esposti, per noi
è un bene. Ora potremo chiedere ai candidati schierati con Fitto e a chi ha
intenzione di votarli: “Ora lo sai con chi sta il tuo capolista! Intendi restar
zitto? Intendi ancora votarlo?” Ma con questo non vogliamo affatto spezzare una
lancia a favore dell’altro candidato, indugiando in questo infimo teatrino di
periferia. L’altro candidato – lo facciamo notare – non ha parlato o perlomeno
noi non lo abbiamo sentito. Non si è esposto a dire: “Fitto ha sbagliato, invece
io…”. Perché non ha approfittato di questo assist? A voi la risposta, e entro
novembre. Il momento è topico, quindi. Con noi o contro di noi. Con il Sud o con
il PUN. Noi siamo convinti di aver scoperchiato un pozzo nero maleodorante e
pieno di scheletri. Se questo pozzo non viene bonificato al più presto, il
rischio è di veder inghiottita l’Itala intera!
LA LEZIONE DEL VIRUS A UN CERTO NORD: “L’ALTRO” SEI PURE TU,
PRIMA O POI. Pino Aprile il 4 Marzo 2020 … E, SFIDANDO
IL RIDICOLO, GRIDA AL “RAZZISMO”! ‘O munn è cagnate! Chelle ca stev ‘ngopp è
gghiute sotte, e chelle cha stev sott è gghiute ‘ngopp! Un certo Nord (la cui
prima vittima è il resto del Nord, coinvolto in un grossolano giudizio che tutti
accomuna nel peggio) fa i conti con i suoi comportamenti e scopre di non stare
simpatico e, anzi, proprio sulle palle. I fenomeni sociali sono di lenta
costruzione, ma di fulminea espansione: decenni di insulti padani, di
supponenza, prepotenza, arroganza, presunzione, “Prima il Nord” e presunto
diritto etnico all’offesa dell’altro, sino all’aggressione (zingaro, terrone,
migrante, poco importa), hanno tanto caricato il piatto della bilancia, che
l’arrivo di coronavirus (il “Cigno nero” l’imprevisto che sconvolge gli assetti
consolidati), lo ha fatto calare, ribaltando l’equilibrio.
INSULTATI E PICCHIATI CINESI AL NORD, QUANDO IL VIRUS “ERA
CINESE”. E SE DIVENTA PADANO? Ribaltare, vuol dire che le cose vengono viste e
valutate al contrario. Per esempio: Ci sono stati episodi di intolleranza nei
confronti di cinesi (presunti colpevoli di virus), alcuni di loro cittadini
italiani, ma di origine orientale. In qualche caso, l’inciviltà è giunta ad atti
di violenza. Un cinese che gestisce con la moglie un bar a Bassano del Grappa è
stato picchiato da un avventore in un locale, a Cassola; altri sono stati
offesi, dileggiati (una donna e i figli al supermercato), un adolescente
aggredito durante la partita, perché orientale… Poi si scopre che il ceppo di
coronavirus che imperversa in Lombardia e Veneto, e da lì dilaga, potrebbe
essere padano: autoctono. E se gli incivili che han “fatto pagare” ai cinesi la
presunta provenienza del virus fossero insultati, aggrediti, solo perché
lombardo-veneti? Razzismo? Chiamatelo come volete, ma sarebbe quella roba di
prima, all’incontrario (ricordando che l’imbecillità è universale e se
l’aggressore a Cassola è stato aiutato a dileguarsi, a Bassano il cinese
aggredito e sua moglie hanno avuto la solidarietà dei loro clienti).
LA PIÙ FLORIDA INDUSTRIA LOMBARDO-VENETA È QUELLA DEI
“RISARCIMENTI”, ANCHE PER I DANNI PROVOCATI AD ALTRI. Con il virus, puntuale
come le tasse, è riapparso il riflesso condizionato padano: l’Italia ci copra di
miliardi, per risarcirci (modello di moderazione, si accontenterebbero di
quattro volte quel che Trump ha chiesto per tutti gli Stati Uniti). Perché loro
“producono” e qualunque cosa interrompa o rallenti il flusso ininterrotto di
denaro pubblico, scatta il diritto a essere sovvenzionati (Tav, Mose, Expo,
Human Technopole, Pedemontane…, ora virus). Nella corsa a chi la spara più
grossa, politici di ogni schieramento, ma ugualmente privi di vergogna e senso
del ridicolo, si sono rincorsi nel reclamare “risarcimenti”: abolire tasse, non
pagare i mutui… Per ora, vince il campionato delle cazzate il Cazzaro Magno,
Matteo Salvini, arrivato (per adesso) a 50 miliardi, venti volte la cifra per
gli Stati Uniti (2,5 miliardi di dollari). Ma se gli date tempo (e altri
mojitos?) vedrete che saprà superarsi. Avviso: stabilite voi la cifra; al Sud
chiederemo il doppio, per i danni provocati dalla gestione dell’epidemia, che ne
ha favorito l’espansione al Sud.
DOPO FONTANA CON LA MASCHERINA E ZAIA CHE INSULTA I CINESI, CHI
INVESTE IN ITALIA? Perché, se sono i presidenti di Lombardia e Veneto, Attilio
Fontana e Luca Zaia a distruggere la nostra economia con le loro cretinate, si
può chiedere a Lombardia e Veneto di pagare i danni o no? Ha fatto il giro del
mondo la foto di Fontana con la mascherina (vabbe’ che è carnevale…) che si
autodenuncia a rischio infezione, perché una sua collaboratrice è stata (dice, e
noi ci crediamo. Non dovremmo?) trovata positiva al coronavirus. Che dite: ci
viene ora uno In Italia o ci pensa? Le esternazioni di Zaia su presunte,
discutibili abitudini alimentari dei cinesi mangiatori di i topi vivi hanno
arricchito lo stupidario della stampa internazionale e indotto Pechino a
intervenire. I veneti (“l’anno della fame”) i topi li preferivano essiccati
(forse per evitare che tale riserva alimentare si assottigliasse, altri veneti
sono mangiagatti)? Come vedete, a sparare cazzate siamo bravi tutti. Il guaio è
prenderle sul serio. E quelle da cabaret dei due presidenti sono state un danno
serio. Che fanno: ci risarciscono?
FAVORITA LA SANITÀ PRIVATA, QUANDO ARRIVA L’EPIDEMIA E QUELLA
PUBBLICA SOFFRE…I lombardoveneti hanno sempre vantato l’eccellenza della loro
sanità regionale, privilegiando, però (specie la Lombardia) quella privata. Ma
quando arriva l’epidemia, la sanità pubblica va in apnea e si cercano posti
letto per carità a Sud, in strutture pubbliche, confermandosi l’eccellenza
padana speculazione pura. E ora mandiamo fatture maggiorate come successo per i
nostri malati costretti a farsi curare al Nord? I campioni della diffamazione
del Sud via tv e carta (igienica) stampata si sono scatenati nella “denuncia del
razzismo” meridionale contro il Nord (certe facce non dovrebbero andare in giro
senza mutande). Hanno scatenato l’inferno contro “l’odio razziale” di chi, a
Ischia, protestò per l’arrivo di 150 turisti lombardi a rischio virus. I sindaci
dell’isola avevano vietato l’accesso; il prefetto lo ha imposto. Brutto sentirsi
discriminati, eh? Rita Dalla Chiesa, perdendo una buona occasione per tacere ha
criticato l’autodifesa dell’isola invitando a boicottarla come meta turistica.
Ma vogliamo scherzare: lombardi trattati come fossero terroni, migranti?
SI È IMPEDITO A ISCHIA DI TUTELARSI E FRA I TURISTI PADANI FATTI
SBARCARE A FORZA CE N’ERA UNO A RICHIO VIRUS. ECONOMIA DISTRUTTA. Poi si scopre
che uno di quei turisti potrebbe essere positivo al virus. Ischia ha un ospedale
con 60 letti, per 60mila persone, vive di solo turismo e ora è considerata
l’equivalente di un lazzaretto. Chi paga? Salvini fu accolto con entusiasmo, da
molti ischitani, ma i risarcimenti li chiede solo per il Nord, anche quando è il
Nord (inconsapevole: mica vorremo prendercela con i turisti lombardi) a rovinare
l’economia di una delle capitali turistiche italiane e del Mezzogiorno. La Lega
(punta di diamante di una comunità in larga parte consenziente, visti i voti che
prende) faceva le campagne contro i terroni che portano sporcizia al Nord, i
migranti con la peste, la lebbra, il colera e la scabbia, e chiedeva protezione
e…?: risarcimenti (come avete fatto a indovinare?); ora dal Nord arriva al Sud
l’epidemia e la distruzione di un sistema economico basato sul turismo, e la
Lega chiede risarcimenti. Ma al Nord, anche per i danni che produce agli altri
(mentre i governatori del Sud tacciono, come da costume coloniale e gregario).
MA NESSUNO HA CANTATO: “SENTI CHE PUZZA/ SCAPPANO ANCHE I CANI/
ARRIVANO I PADANI”. PER NAPOLI, INVECE…Ci si stupisce che gli altri si siano
rotti i coglioni di un Nord la cui capofila, la Lombardia (più il Veneto, ora),
è entrata nell’Italia unita con poco più dell’un per cento del denaro circolante
nella Penisola (contro il 66 del Regno delle Due Sicilie) e da allora cresce a
spese del Paese, vantando un credito inestinguibile e inesistente. Presumendo di
maturare su questo pure un diritto all’insulto, alla denigrazione. Che ora si
rivolta contro. Alle persone perbene (e non c’è latitudine che le distingua)
chiedo un giudizio sulla colpevole tolleranza verso “il folclore” leghista (vera
anima del peggior Nord, con propaggini coloniali a Sud); per farmi meglio
capire, applico la legge della reciprocità: immaginate che oggi un terrone un
po’ cretino (o… folcloristico?), si mettesse a cantare: “Senti che puzza/
scappano anche i cani/ dal Lombardo-Veneto/ arrivano i padani/ contagiosi,
alluvionati/ con l’amuchina/ non vi siete mai lavati/ coronavirus (o Po, a
scelta) pensaci tu!”. È ancora folclore? Brucia? E agli altri no? Immaginate di
esser chiamati da ministri: porci, topi da derattizzare, merdacce, colerosi…,
sol perché padani. E vedere quei figuri rimanere al loro posto, rispettati e
riveriti. Brucia? E agli altri no? (A proposito, se quel terrone cretino dovesse
davvero parodiare un “grande leader” del Nord e delle sue propaggini coloniali
del Sud, prima di censurarlo, pensateci bene: potreste ritrovarvelo vice
presidente del Consiglio). Ma io ho fiducia nella potente legge della
reciprocità che il virus sta ricordando a chi pensava che toccasse il peggio
sempre agli altri, perché gli altri se lo meritano; e ho fiducia nella gente per
bene, che se si vede e si sente poco, nel casino dei cialtroni (gli inglesi
dicono che è il barattolo vuoto a far rumore. Vale pure per i cervelli). C’è chi
mi oppone che il mio è una sorta di atto di fede. Non è vero: è un fatto di cui
si scorgono tracce. Ve ne suggerisco una: un’offesa al giornalismo ha titolato
“Virus alla conquista del Sud”. E millanta questo (godendoci, pare) come “Unità
d’Italia: ora sì che siamo tutti fratelli”. E capite cosa vuol dire: nel bene,
noi siamo il Nord e voi merdacce; diventiamo “fratelli” quando il male che vi
abbiamo portato ci accomuna (come nel 1860-61, con l’“Unità” intesa quale bagno
di sangue a Sud, carcerazioni, deportazioni, trasferimento a Nord delle
industrie, delle commesse e dell’oro meridionali).
MA I CAMPIONI DELLA DIFFAMAZIONE DEL SUD PERDONO COPIE IN EDICOLA
E ARRANCANO IN TV. Quella schifezza stampata è un insulto quotidiano al Sud e
suscita reazioni disgustate dei terroni. I quali, sbagliando, rischiano di
considerarla “la voce del Nord”. Non è così: il giudizio dei lettori si misura
in edicola. Sotto la guida del campione di tanto livore nei confronti dei
meridionali, la tiratura del fogliaccio è scesa da 120mila a meno di 25mila
copie. Ed è il Nord ad averlo schifato. Mentre i programmi di “approfondimento”
anti-Sud vedono boicottati i loro inserzionisti. Quindi, qualcuno sa e
comprende. Ora forse anche chi non sa e non comprende potrebbe porsi qualche
domanda. La reciprocità (a volte, anche tramite un virus) questo dice: attento,
che “l’altro” prima o poi, sei tu.
Ma se siamo così diversi! Domenico
Bonaventura, Giornalista, comunicatore, fondatore di Velocitamedia.it, su Il
Riformista il 21 Luglio 2020. Quella che la narrazione mediatica sta facendo
passare è la distanza, la differenza di approccio tra gli oculati e gli
scialacquoni. L’utilizzo di “frugale”, con riferimento ai Paesi nordeuropei, non
può che andare in questa direzione. Semplice, modesto, parco, parsimonioso. Sono
questi i sinonimi che si possono leggere in qualunque dizionario. Insomma, il
termine “frugale” – e lo dico da giornalista – sembra soltanto una scorciatoia
giornalistica per creare contrapposizione, per continuare a vivere di quel
racconto (che in parte poggia anche sulla realtà) che vede Sud e Nord Europa
l’un contro l’altro armati. D’altronde, “si è sempre meridionali di qualcuno”,
aforizzava il leggendario professor Bellavista parlando con il supermilanese
ingegnere Cazzaniga, il quale a sua volta descriveva le strambe abitudini della
sua signora tedesca. Un aforisma, ad esempio, ripreso e adattato anche dal
governatore De Luca, che nel suo politelling (come Francesco Giorgino definisce
lo storytelling politico) lo utilizza nel frame del “leghismo meridionale” (come
lo definiscono Alessio Postiglione e Angelo Bruscino in “Popolo e populismo”)
per provare a compattare – dalla sua parte – i campani contro i vichinghi
settentrionali. Mai come in questi giorni, l’Europa si sta rivelando una fusione
a freddo tra Paesi che nulla o quasi hanno da dividersi, se non la
consapevolezza della necessità di stare insieme per fare da contraltare alle
potenze sino-russo-statunitensi. Che esista più di qualche differenza tra il Sud
e il Nord del continente è un fatto solare. Differenze sociali, politiche e, di
conseguenza, mediatiche. Quelle politiche stanno venendo fuori in queste ore in
tutta la loro dirompenza. Ma non sono che lo specchio di una distanza relativa
alle altre due categorie. Ci fermiamo su quella mediatica, prendendo come
riferimento “Modelli di giornalismo” di Daniel Hallin e Paolo Mancini (2008,
Editori Laterza). Il saggio divide i Paesi, europei e non, in tre gruppi, in
base ai rapporti tra media e politica:
modello mediterraneo o pluralista-polarizzato;
modello dell’Europa centro-settentrionale o
democratico-corporativo;
modello nord-atlantico o liberale.
L’Italia, naturalmente, rientra nel primo, insieme a Portogallo,
Spagna, Francia e Grecia. Ciò che distingue questi Paesi è che le istituzioni
liberali, l’industrializzazione capitalistica e la democrazia politica sono
arrivate con ritardo rispetto al resto d’Europa (la Francia viene spesso
trattata come caso border-line). Si riscontrano esempi molto frequenti di
sovrapposizione tra media e politica, forte parallelismo politico e abbondante
intervento statale in ambito mediatico – come elargitore di fondi e come
regolatore -, oltre a uno sviluppo generalmente debole dei media commerciali.
Ciò ha condotto, nel tempo, a un giornalismo orientato più al commento che ai
fatti, a media fortemente politicizzati e a un notevole sviluppo del fenomeno
della partigianeria politica dei giornalisti, spesso considerata da questi
ultimi come un vanto, piuttosto che come un’anomalia (retaggio dell’enorme
sviluppo della stampa di partito e della peculiarità della politica sulla
televisione). Nel modello dell’Europa centro-settentrionale o
democratico-corporativo, che oggi in molti chiamerebbero “modello frugale”,
rientrano i Paesi che in queste ore a Bruxelles stanno rendendo il negoziato un
campo minato. Austria, Belgio, Finlandia, Olanda, Danimarca, Norvegia. E
Germania, che però ha presentato una propria proposta con la Francia. Anche qui
si ravvisa un forte intervento dello Stato, ma teso più alla tutela della
elevata professionalizzazione e della libertà di stampa. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è forte, caratterizzato dalla presenza della politica nella
televisione. Tutto questo per dire non che le differenze di tipo mediatico
influiscano sulle politiche (piuttosto sul racconto che gli stessi media ne
fanno). Ma che, al contrario, se ci sono tutte queste distanze nell’ambito di
tv, giornali e rete, non c’è da meravigliarsi se a livello politico gli abissi
che separano Sud e Nord d’Europa appaiano percorribili soltanto da compromessi
ad estremo ribasso.
Barbara Jerkov e Francesco Malfetano per “il Messaggero” il 14
agosto 2020. Prima il Nord, anche ad agosto. Appena 9 città meridionali (su un
totale di 29) potranno infatti accedere agli oltre 500 milioni di euro di
indennizzi a fondo perduto previsti per le attività commerciali delle città
d'arte colpite dal calo dei turisti stranieri. A penalizzare il Sud sono i
criteri adottati dal ministero per i Beni culturali e il Turismo. Questi
parametri, basandosi su dati statistici, non solo hanno finito per considerare
Verbania più meritevole di Roma o Napoli, ma soprattutto per escludere intere
Regioni (come Umbria e Calabria) e città che sono un fiore all'occhiello del
turismo made in Italy. Ad esempio tra tutti i centri storici pugliesi, l'unico
ad essere ammesso tra quelli che hanno diritto al bonus è Bari. Non c'è spazio
quindi per gli imprenditori tarantini, né tantomeno per quelli leccesi. Al
contrario sono invece ben 20 le città d'arte del centro-Nord che avranno accesso
«all'aiuto mirato» voluto dal ministro Dario Franceschini e in dirittura
d'arrivo in Gazzetta Ufficiale. A far discutere è dunque il curioso metodo
utilizzato dal ministero per selezionare le città d'arte che hanno diritto ai
fondi. Nel computo usato dal Mibact, infatti, sono inclusi i capoluoghi di
provincia e le città metropolitane che secondo l'Istat hanno registrato nel 2019
presenze turistiche tre volte superiori al numero di residenti oppure i comuni
capoluogo di città metropolitane che hanno ospitato un numero di viaggiatori
pari a quello dei residenti. Un sistema complesso che «abbiamo adottato per
individuare un certo numero di centri urbani su cui avere degli effetti
immediati in termini economici» spiegano con un certo imbarazzo dal ministero,
sostenendo che «la misura andava circoscritta e si necessitava di un parametro».
«Chiaramente - aggiungono - Verbania in termini di presenze assolute è al di
sotto della Capitale mentre in termini percentuali è sopra Roma». A
testimonianza che la statistica può ingannare e, soprattutto, penalizzare. Ciò
che non si comprende è perché mai questa riflessione non è stata fatta dal
ministro. Grazie a questo calcolo e alla decisione di escludere certe tipologie
di comuni, un centro come Sassari ad esempio resta tagliato fuori nonostante tra
le città della sua provincia abbia Alghero o Arzachena che contano tra i propri
turisti circa il 70% di presenze straniere ogni anno, più o meno come Roma e
Milano. E fuori resta anche Messina che, comprendendo Taormina nella sua città
Metropolitana, è una delle principali mete raggiunte dai viaggiatori non
italiani. A svantaggiarle in questo caso sembra essere il mancato riconoscimento
dello status di città metropolitana per quanto Alghero, ad esempio, vanti più
residenti e più turisti di Verbania. La classifica realizzata ad hoc dal Mibact
è quindi un'evidente semplificazione statistica dello scenario turistico
italiano e, in quanto tale, non rispecchia la complessità del settore. Sono ben
6 infatti le regioni ad essere escluse dal contributo che copre fino al 20% del
fatturato (tetto di 150 mila euro) per le imprese che hanno subito un calo di
almeno un terzo rispetto all'anno prima, e sono Valle d'Aosta, Friuli Venezia
Giulia, Umbria, Molise, Abruzzo e Calabria. Un caso limite è ad esempio
rappresentato da Perugia, capoluogo umbro, che stando alle stime effettuate
dall'istituto Demoskopica su dati di Banca Italia e Istat, è la più penalizzata
in assoluto di tutta la Penisola in termini di presenze turistiche (circa il 50%
in meno). Una specificità che il Mibact però non ritiene danneggi i
commercianti: «È vero che alcune città d'arte non avranno accesso al bonus -
spiegano - ma ciò non vuol dire che saranno abbandonate perché potranno
usufruire di altre misure previste nel decreto Agosto». Statistica permettendo.
Lo scippo al Sud continua anche sui centri storici: gli aiuti
a fondo perduto premiano quelli del Nord. Si perpetua
il trucco della spesa storica: tra le città selezionate, 20 su 29 sono
centrosettentrionali. Nessun aiuto per chi è indietro ma ha forti margini di
crescita. Pietro Massimo Busetta il 14 agosto 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Quando si pensa al “non rubare” del settimo comandamento si pensa immediatamente
ai ladri e agli scassinatori. In realtà, il “non rubare” si riferisce a tutto il
mondo dell’economia che permea la nostra vita. È un comandamento al quale chi
crede, ma anche chi non crede, si ispira come condotta di vita. E la prima
reazione alla scoperta di un furto è la pretesa della restituzione di quello che
si è sottratto al prossimo. Stupirsi del fatto che ciò non avvenga sarebbe da
ingenui. Ma vedere come con protervia e arroganza si continui da parte di alcuni
a far finta di nulla, rispetto allo scippo di 60 miliardi l’anno, anzi a
rivendicare, ogni volta che vi è un provvedimento a favore del Sud, una pretesa
questione settentrionale a cui verrebbero sottratte risorse dovute, mi pare
intollerabile. Il campione mediatico di tale atteggiamento, per ora, é quel
sindaco di uno dei lati del triangolo Milano-Bergamo-Monza, area più ricca
d’Italia, Giorgio Gori, anche esponente ascoltato del Pd. A cui si aggiungono
frequentemente Stefano Bonaccini e Giuseppe Sala. Non si fa riferimento a Luca
Zaia e Attilio Fontana o Giancarlo Giorgetti, perché è nella loro identità la
caratteristica di difendere gli interessi illegittimi del Nord bulimico.
I SOLITI FAVORITISMI. Stupisce invece che lo stesso principio,
che si rifà alla spesa storica, cioè che se tu hai avuto di più continuo a darti
di più, anche se ci si è resi conto che ad alcuni viene dato quello che non
spetterebbe, venga adottato da un ministro, che sembrerebbe più sensibile alle
esigenze e alle ragioni del Mezzogiorno che sono poi quelle di tutto il Paese.
Parlo del ministro Dario Franceschini e dell’aiuto di oltre 500 milioni di euro,
il contributo a fondo perduto che spetterebbe alle attività dei centri storici.
Perché l’ inserimento nel gruppo avviene sulla base dei dati di presenze (non di
arrivi) di turisti stranieri avuti nel 2019. La logica della legge è di
preparare i nostri centri storici, più frequentati dagli stranieri, alla fine
dell’emergenza, non facendo trovare un deserto di attività, nel frattempo
chiuse. La via dell’inferno però è lastricata di buone intenzioni. Perché
l’inserimento, in mancanza di correttivi, come per esempio la quantità di beni
culturali esistenti nelle zone o un calcolo di potenziale inespresso, arrivano a
coloro che hanno già sviluppato un dimensione turistica consistente. E i dati
parlano chiaro: tra le città selezionate, 20 su 29 sono collocate nelle regioni
del Centro Nord e resterebbero esclusi i Comuni di almeno tre regioni: Calabria,
Molise e Friuli Venezia Giulia. In realtà, anche questi aiuti seguono la logica
della cassa integrazione e degli altri sostegni: li dai a chi ha perso, sostieni
il reddito di chi ha avuto calo di fatturato, e chiaramente a Venezia, Firenze,
Milano o Roma le perdite sono state molto più consistenti di quelle delle realtà
meridionali. Ma è lo stesso gioco della spesa storica, se non metti dei
correttivi si aiuteranno i soliti più ricchi e non farai nulla per indirizzare
un aiuto alle realtà più indietro e con margini di crescita interessanti. Per
esempio non inserisci tra queste città la bellissima Lecce o Taormina o Caserta,
la cui reggia è l’ultima grande opera che sia sta fatta nel Mezzogiorno, ma ci
trovi Verbania.
IDEA COMPLESSIVA. Il modo più facile di distribuire risorse a
pioggia e di alimentare il consenso, non utilizzando questa occasione per
indirizzare verso una diminuzione dei divari, in questo caso di presenze
turistiche. Costretto magari poi a mettere il numero chiuso in alcune città
d’arte perché invivibili e lasciare abbandonate altre realtà, che sono scrigni
d’arte e che scoprì per caso dopo anni come Matera. Ma poi, quando devi
individuare la capitale italiana della cultura, stai attento che una volta
tocchi al Sud e una al Nord, invece di stabilire per legge che le capitali della
cultura italiane ed europea, quando ci tocca, per i prossimi dieci anni devono
essere solo al Sud. Perché i Gori si lamenteranno, anche se le loro comunità
hanno un reddito pro capite triplo di quello medio del Sud e in una famiglia
lavorano due persone contro meno di una in media al Sud. E anche se i grandi
eventi vengono tutti localizzati al Nord, come l’Expo recente e le prossime
Olimpiadi invernali, che in genere portano come dote qualche miliardo per
completare la rete infrastrutturale, di cui non si parla e un incremento di
presenze straniere che poi determinano l’inserimento delle città nel gruppo
delle città d’arte da finanziare. Guardare al singolo intervento senza una
visione di insieme è molto pericoloso ma è quello che si sta facendo: forse una
idea complessiva non sarebbe male.
L’Italia dei paradossi: il Sud perde soldi e il Nord si
lamenta…Marco Demarco su Il Riformista il 21 Luglio
2020. Molte “voci“ che si alzano dal Sud lamentano con crescente allarme la
sottrazione di risorse a vantaggio del Nord. Tra queste ci sono le voci di chi
non si accorge di muoversi in sostanziale sintonia con quanti in Europa fanno la
stessa cosa, cioè difendono aspettative e interessi particolari, maturati prima
dell’emergenza sanitaria, e agitati senza riguardi per la mutata
situazione post-Covid. Solo che le voci del Sud ci appaiono giustificate dalla
criticità del contesto sociale, e dunque legittime; mentre le altre risultano a
noi odiose, perché cariche di irresponsabile egoismo. Eppure, se in nome della
solidarietà censuriamo le spinte nazionali che tendono a insabbiare gli
obiettivi comunitari, non possiamo poi, asimmetricamente, assecondare tutte le
rivendicazioni che hanno origini localistiche e si alimentano di risentimenti e
frustrazioni risalenti nel tempo. Bisogna dunque valutare, distinguere, e non
farsi prendere dal manicheismo populista o dal riduzionismo demagogico. Del
tipo: è tutta colpa di Orban e di Salvini, per intenderci. Tanto più che fino a
ieri davamo per scontato che i “cattivi” fossero esclusivamente i paesi
dell’Europa dell’Est, in particolare quelli del gruppo di Visegrad (Ungheria,
Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia). Mentre oggi il quadro è molto cambiato:
nell’ambito del negoziato sul Recovery Fund, dall’Est arriva all’Italia un
imprevisto sostegno, e la minaccia più seria viene invece dal Nord, dai
cosiddetti “Stati frugali” (Paesi Bassi, Austria, Danimarca,
Svezia e Finlandia). Chi avrebbe potuto immaginarlo solo qualche mese fa? Non a
caso, su Repubblica, Ezio Mauro ieri ha scritto – ed è una novità significativa
– che «sta emergendo un nuovissimo nazionalismo non sovranista». È la riprova
che le cose si stanno complicando e che prendersela con Salvini e Orban può
rivelarsi una debole manovra diversiva. In questa situazione, specialmente se ci
caliamo dentro i confini nazionali, la posizione più imbarazzante diventa quella
di chi vuole furbescamente ricoprire tutte le parti in commedia; di chi prova a
stare con i buoni e con i cattivi contemporaneamente; di chi a parole difende le
ragioni del Sud e polemizza con “quelli del Nord”, ma sotto sotto fa in realtà
l’esatto contrario. Si scopre così che nell’ultimo provvedimento sulla
semplificazione, il cui valore è stato più volte sottolineato dal governo e
dalla maggioranza giallorossa, al comma b dell’articolo 47 si stabilisce che le
risorse del fondo Sviluppo e Coesione – come è noto in gran parte destinati al
Sud – sono ora a disposizione di “programmi nazionali”. Una svolta che implica
una scelta precisa: in nome dell’emergenza e della semplificazione, i fondi
vanno dove si possono spendere subito, senza alcun riguardo per la collocazione
geografica dei progetti. L’esatto opposto, insomma, di quel principio, ribadito
anche nel piano per il Sud del ministro Provenzano, secondo cui lo Stato è
impegnato a destinare il 34% degli investimenti pubblici alle Regioni
meridionali. Le due cose non si tengono, questo è evidente. Ma è così che si
procede in questa Italia dell’equivoco elevato a valore strategico. Il colmo,
poi, è dato da un Nord che ciò nonostante non si ritiene soddisfatto. E che
ancora l’altro giorno, per bocca di Elisabetta Gualmini, europarlamentare Pd,
docente di Scienze economiche e vice di Bonaccini, il governatore dell’Emilia
Romagna, ha tuonato contro «la sfumatura assistenzialista, a trazione
meridionale, del governo».
FAZIOSI, INCOMPETENTI E BUGIARDI. Le
balle della sinistra padronale: il Sud è stato come sempre abolito dai grandi
investimenti. Roberto Napoletano il 10 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Dicono che faranno l’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e
Palermo-Catania-Messina ma non è vero. C’è un solo cantiere già aperto:
Napoli-Bari. Una vergogna che blocca le potenzialità di crescita dell’Italia
intera perché senza la riunificazione infrastrutturale il Nord non riavrà il suo
mercato di consumi interno e si determina una situazione di pericolosità
estrema. Passano i giorni, la catastrofe economica italiana è sotto gli occhi di
chiunque vuole vedere, ma non succede niente. “Parole, parole, parole” abbiamo
titolato ieri. Oggi abbiamo il dovere di aggiungere che non solo, come ovvio, le
parole non sono fatti, ma in molti casi sono parole pericolose. Perché creano
illusioni destinate a tradursi in delusioni violente e sono benzina pura sul
fuoco della polveriera sociale italiana che ha le sue “capitali” nel
Mezzogiorno. Abbiamo un buco di cassa di 50 miliardi di cui abbiamo parlato per
primi nel silenzio opaco dei cosiddetti giornali di qualità. Non diciamo come lo
copriamo, facciamo gli spocchiosi con il Mes (tacciamo per carità di patria
delle opposizioni sovraniste e dei loro anziani mentori in malafede) e passiamo
le giornate a litigare su come spendere soldi che non abbiamo e che, quand’anche
li avessimo, non saremmo in grado di spendere. Questo giornale non nasconderà
mai ai suoi lettori la verità, non asseconderà mai nessun potere di turno. Il
Presidente Conte che gira l’Europa come una Madonna pellegrina per convincere
Capi di Stato e cancellerie europee che il Paese cambierà, farà le riforme,
aprirà i cantieri, deve sapere che ha in mano tanti due di picche e nessun re di
cuori. Una lista di priorità di grandi opere stilata da una ministra delle
infrastrutture e dei trasporti che ha conquistato il podio della Sinistra
Padronale – quella sdraiata come un tappetino al servizio del capitalismo
privato della rendita – e che è riuscita a bloccare una regione senza fare mai
marcia indietro, è il peggiore biglietto da visita che si possa esibire in
Europa e scava la fossa al governo Conte 2 che proprio grazie all’iniziativa del
suo Presidente ha affrontato bene l’emergenza sanitaria. Basta balle! Il
Mezzogiorno è stato come sempre abolito dai grandi investimenti infrastrutturali
e, come documenta Ercole Incalza della cui competenza nessuno può dubitare,
tranne il cantiere già aperto della Napoli-Bari, nulla si muoverà di concreto
per i prossimi due anni nell’Alta velocità ferroviaria del Mezzogiorno. Siamo in
una situazione di pericolosità estrema perché si dice che si faranno la
Salerno-Reggio Calabria e la Palermo-Catania-Messina ma non è vero perché al
massimo si butteranno un altro po’ di soldi pubblici per fare studi e progetti
già fatti. Una vergogna assoluta che blocca per sempre le potenzialità di
crescita dell’Italia intera perché senza la riunificazione infrastrutturale del
Paese il Nord non riavrà il suo mercato di consumi interno e diventerà
l’appendice meridionale del gigante tedesco a sua volta stretto nella tenaglia
cinese-americana. Una tragedia di cui tutti coloro che hanno responsabilità
politica nel Mezzogiorno saranno corresponsabili se continueranno a tacere come
hanno fatto negli ultimi venti anni. Questo giornale li stanerà uno a uno perché
la situazione di oggi è molto differente da quella di ieri e dell’altro ieri
perché la Grande Depressione mondiale prima non c’era. Abbiamo apprezzato il
realismo di Marco Tronchetti Provera che ha messo nero su bianco una previsione
del 15/20% di calo del fatturato della Pirelli avendo il coraggio di dire la
verità che è proprio quello che serve. Anche qui vogliamo ricordare che nel
silenzio generale, sulla base di mere analisi empiriche, ci siamo permessi di
parlare di una caduta del Pil italiano di almeno il 15%. Ovviamente lo abbiamo
fatto non perché siamo catastrofisti ma per spingere tutti a uno scatto fatto di
cose concrete che solo la consapevolezza della situazione può dare. Se tagliamo
il Sud, apriamo i cantieri forse tra due anni, prolunghiamo le “vacanze” degli
statali fino alla fine dell’anno, chiudiamo l’Italia e non la riapriamo più. Se
si vuole fare davvero l’alta velocità ferroviaria nel Mezzogiorno si lanci un
bando di gara internazionale, si faccia cadere il tabù del ponte di Messina, e
si segua da Palazzo Chigi il modello del progetto integrato e dei consorzi con
partner selezionati utilizzato per il piano strategico dell’alta velocità
ferroviaria del Nord di molti anni fa. Questo significa occuparsi del
Mezzogiorno e riparare ai torti che ha subito. Questo significa salvare
l’Italia. Con i cento e passa decreti attuativi mai adottati del Tesoro e la
ministra zerbino De Micheli ci possono anche riempire di soldi europei, ma non
ce la faremo mai. Perché siamo incapaci e a dettare legge saranno sempre i
Soliti Noti. Quelli che usano il bilancio pubblico per le loro porcherie e
rubano il futuro ai nostri giovani.
IL CONTO DELLA SINISTRA PADRONALE.
Per quanto tempo l'Italia potrà sopportare i disastri del Pd e della ministra De
Micheli? Roberto Napoletano l'8 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud. Ora tutti
hanno scoperto che in cassa c’è un buco da 50 miliardi e che la lista degli
appalti prende in giro metà Paese dando briciole al Sud e soldi veri al Nord.
Fanno bene i governatori del Mezzogiorno a chiedere conto dei soprusi miopi che
impediscono la ricostruzione dell’economia italiana. Ce la faranno i nostri
eroi, Francesco Boccia e Giuseppe Provenzano, ministri delle Regioni e del
Mezzogiorno, a fare ragionare la Sinistra Padronale che tiene in ostaggio Conte
e il Paese? Che cosa si deve fare per liberare le due Italie dall’ossessione del
codice degli appalti dell’ex ministro del Pd Delrio e liberare quel partito e
l’economia italiana dal più clamoroso calcio negli stinchi che un Paese può dare
a se stesso? Ci sarà qualcuno nel Pd in grado di ricordare a Delrio che aveva
preso l’impegno di ridurre le stazioni appaltanti da 35 mila a 5 mila e, cioè,
al doppio di Germania e Francia, ma che non è successo assolutamente nulla e
questa inerzia la paga un’economia paralizzata che non fa investimenti e
precipita in fondo a tutte le classifiche? Ma per quanto tempo ancora si può
pensare che l’Italia possa sopportare l’azione e i disastri del peggiore
ministro della storia repubblicana che risponde al nome di Paola De Micheli,
sempre del Pd, che si permette di prendere in giro i cittadini italiani
confondendo opere cantierabili con risorse disponibili e che arriva perfino,
cosa che non le perdoneremo mai, a prendere in giro i cittadini calabresi e del
Mezzogiorno scambiando progetti per cantieri, treni di media velocità per alta
velocità, sempre a favore del Nord e sempre subdolamente contro il Sud? È
riuscita a bloccare una regione intera, la Liguria, questa impresentabile
ministra senza chiedere scusa e ritirare ad horas le sue demenziali
disposizioni, riuscendo nel miracolo di fare apparire il predecessore grillino
Toninelli un pozzo di competenza al suo confronto. Con splendido tempismo è
riuscita a affidare la gestione del ponte Morandi ai Benetton nello stesso
giorno che la Consulta ha ritenuto legittimo escluderli dalla ricostruzione
dello stesso Ponte. Ma in che mani, ci chiediamo, siamo finiti? Che cosa aspetta
Zingaretti a prendere le distanze da questo pericolo pubblico che è la De
Micheli e il Presidente Conte a chiedere per impresentabilità e incompetenza
acclarate le sue irrevocabili dimissioni? Da Palazzo Chigi è uscito un documento
a firma del capo del Dipartimento, Antonio Scino, di designazione leghista, che
voleva fare saltare il vincolo del 34% delle risorse al Sud e destinarle come
sempre al Nord, possiamo chiedere, come giustamente ripete giorno e notte
Provenzano, per quale misteriosa ragione è ancora lì al suo posto? Ci fermiamo
qui. Non abbiamo voglia di proseguire. Quello che deve essere chiaro a tutti è
che esiste un giornale che si è permesso di segnalare nel silenzio servile dei
cosiddetti giornali di qualità che c’è un buco di cassa di 50 miliardi che ora
hanno scoperto tutti e che la lista degli appalti del decreto semplificazioni
(vero De Micheli?) continua a prendere in giro metà Paese dando briciole al Sud
per continuare a studiare e soldi veri ai cantieri nel Nord ovviamente con il
plauso di buona parte anche dell’informazione che nella migliore delle ipotesi
non capisce. Basta!!! Fanno bene i governatori del Sud a abbracciare la campagna
di questo giornale, condotta in assoluta solitudine e avallata dalle principali
istituzioni economiche, statistiche e contabili della Repubblica italiana, e a
dire chiaro e tondo che con i soprusi delle Regioni del Nord di Sinistra e di
Destra se la vedranno davanti alla Corte Costituzionale perché ogni limite ha
una pazienza. Come direbbe il grande Totò. A tutti i sapientoni del pensiero
unico ci permettiamo di ricordare che abbiamo sfondato il pavimento e distrutto
le cantine, siamo sotto gli ultimi in tutto perché continuiamo a fare regali a
un Nord assistenziale e togliamo risorse produttive al Mezzogiorno che può
salvare l’intero Paese. Se ne è accorta perfino la Merkel non i cosiddetti
giornali di qualità e la Sinistra Padronale con i suoi ministri impresentabili.
Presidente Conte questa volta o riuscirà a cambiare rotta con i fatti o salterà.
Sia chiaro: chi prenderà il suo posto o cambierà rotta o farà saltare l’Italia.
Questi sono i punti veri. Il resto sono chiacchiere. Penose.
I SOLDI DELL'EUROPA DIROTTATI AL NORD.
Siamo alla vergogna delle vergogne. Non sarà mai troppo tardi
quando gli amministratori delle Regioni meridionali avranno la dignità di
rivolgersi alla Corte costituzionale per tutelare i diritti di cittadinanza
delle proprie popolazioni. Roberto Napoletano il 6luglio 2020 su Il Quotidiano
del Sud. Noi vogliamo bene all’Italia e solo per questo ci siamo imposti di non
soffiare sul fuoco della polveriera sociale che può incendiare il Paese in
autunno. Siamo sull’orlo del baratro e ci comportiamo come se avessimo il
portafoglio pieno e i miliardi che ci ballano. Calpestiamo il Mezzogiorno e il
lavoro privato con la brutalità che solo l’ignoranza delle cose può consentire.
Non riapriamo il pubblico impiego, il sindacato tutela privilegi fuori dal
mondo, e raccontiamo la favola della didattica a distanza in una scuola
colpevolmente dimezzata. Lasciamo morire il commercio, chiudiamo l’economia a
partire dal turismo, e crediamo di potere ricominciare come se nulla fosse
ridando i soldi ai Soliti Noti e regalando spesa pubblica ai ricchi rubandola ai
poveri facendo l’esatto contrario di quello che ci chiede l’Europa. Facciamo
finta di cambiare la macchina pubblica per cui gli investimenti rischiano di non
partire mai e litighiamo su chi nomina i commissari e su quali opere devono
avere la priorità quasi che fosse discutibile il dato di fatto che negli ultimi
venti anni si è azzerata la spesa per investimenti nel Mezzogiorno (0,15% del
Pil) e si vuole addirittura proseguire con l’andazzo incostituzionale di fare
figli e figliastri nella sanità pubblica adesso addirittura anche con i fondi
europei del Mes che non abbiamo nemmeno il pudore di chiedere ma sottobanco già
ci dividiamo. Non so se si è capito bene quello che sto dicendo: con la consueta
miope arroganza vogliamo prenderci i soldi europei per fare regali a Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, la governance reale del Paese che unisce
Destra e Sinistra, quando l’Europa ci aiuta eccezionalmente per l’ultima volta
affinché facciamo finalmente gli ospedali pubblici, terapie intensive e ricerca
nelle regioni del Mezzogiorno arbitrariamente private dei loro diritti
costituzionali. Siamo alla vergogna delle vergogne. Non sarà mai troppo tardi
quando gli amministratori delle Regioni meridionali avranno la dignità di
rivolgersi alla Corte costituzionale per tutelare i diritti di cittadinanza
delle proprie popolazioni. Questo giornale con l’avallo delle principali
istituzioni economiche, contabili, statistiche della Repubblica italiana ha
condotto ben tre operazioni verità (mai smentite da chicchessia) che documentano
lo scippo da 60 e passa miliardi di spesa pubblica l’anno del Nord a danno del
Sud e che sono la base giuridica della necessaria azione davanti alla suprema
Corte. Ritenevamo che almeno il Coronavirus avrebbe consentito di bandire certe
pratiche da Nord ladrone. Non è così se è vero come è vero che si è predisposta
una bozza di ripartizione degli eventuali aiuti del Mes che continua a dare
smaccatamente di più alle Regioni del Nord rispetto a quelle del Sud e si litiga
sulle grandi opere da inserire nelle liste delle priorità con l’obiettivo della
Sinistra Padronale di continuare a privilegiare in modo miope il Nord a spese
del Sud. Questa è l’amara realtà e francamente siamo allibiti davanti allo
spettacolo di un ministro dell’Economia che ha un buco di cassa di 50 miliardi,
qualcosa che vale tre manovre, e non dice come intende coprirlo con
l’assestamento di bilancio né anticipa il Def. Si permette di dire che è
assolutamente urgente utilizzare le risorse comunitarie mentre continua a
fabbricare leggi inattuabili e a prevedere decreti attuativi che non vengono
adottati. Non perde una parola per ricordare a tutti che l’Europa pone una sola
condizione: dovete spendere bene i quattrini che vi diamo mettendo al centro il
Mezzogiorno. Dovete spenderli per fare quelle infrastrutture di sviluppo negate
al Sud che consentono di perseguire il riequilibrio territoriale e di fare
ripartire l’economia dell’Italia intera. Non lo dice, ma è così: dovete fare
l’esatto opposto di quello che avete fatto fino a oggi. Soprattutto, dovete
farlo in fretta. La Sinistra Padronale deve smetterla con il vizietto di aiutare
gli amici degli amici ovviamente sempre ricchi e deve dare una mano a Conte per
sbloccare poteri commissariali, alta velocità ferroviaria al Sud e smontare
senza ipocrisie abuso d’ufficio e codice degli appalti. A sua volta Conte deve
avere la forza di imporre ai grillini di uscire dal tunnel delle politiche
assistenzialiste e dalla pratica delle regalie agli amici incompetenti perché la
priorità è fare ripartire il lavoro. Sempre Conte deve abolire quota 100 per le
pensioni che è il frutto della stessa cultura assistenzialista ma di impronta
grillina. Se si vuole evitare il baratro, fatto di crollo dell’economia reale e
di sfiducia dei mercati, il percorso è obbligato. Per poterlo percorrere insieme
o con altri bisogna almeno capirlo.
Non bastano i soldi scippati al Sud: la Lombardia ha 320
milioni di buco. Claudio Marincola il 9 luglio 2020 su
Il Quotidiano del Sud. È proprio vero che nulla sarà più come prima. È caduto
infatti anche l’ultimo tabù: ora anche la Lombardia ha i conti in rosso. Perdite
straordinarie per circa 320 milioni di euro, da ripianare tagliando i costi e
risparmiando sul welfare. Cose mai viste da quelle parti. La cifra è scritta
nero su bianco nel Dfr, il Documento di finanza regionale 2020-2022 e fa un
certo effetto considerando che da sempre è la Regione che incassa la fetta più
grossa dei finanziamenti previsti dal piano sanitario nazionale. A determinare
l’insolito sforamento è stata ovviamente l’emergenza Codiv-19 che ha colpito
duramente la Regione del presidente Attilio Fontana. Più uscite ma anche minori
entrate per 33 milioni di euro pari a un – 11% circa, da attribuirsi per il 27%
ai minori introiti per il bollo auto, addizionale Irpef (-21%) e al decremento
dell’Irap, (-43%) sia per quanto riguarda il saldo del 2019 che il primo acconto
2020. Un ulteriore 9% lo si deve alle minori riscossioni dell’Agenzia delle
entrate per la tregua da lockdown. Il “buco” è chiaramente di derivazione
sanitaria. Dai tabulati della Regione si evince che degli 894.100.214,35 euro
spesi sono stati autorizzati finora solo 52.035.024,92 euro sul totale degli
oltre 566.035024,92 euro rendicontati, Il Pirellone ha richiesto al commissario
straordinario 502.808.621,77 milioni di euro. Ma ad oggi – sui fa notare
dall’assessorato al Bilancio della regione Lombardia – queste risorse non sono
state ancora assegnate. Si tratta di spese sostenute durante l’emergenza per
l’assistenza medica, per la sanificazione di strutture sanitarie, acquisto di
apparecchiature medicali, dispositivi di protezione e quant’altro è stato
necessario per fronteggiare l’esplosione dell’epidemia nei giorni più caldi.
Altri 63 milioni di euro sono stati richiesti al Dipartimento di Protezione
civile. Spese varie ma sempre prettamente sanitarie. Esempio; l’assistenza
alberghiera ai pazienti positivi o quarantenati e a medici e infermieri; la
distribuzione dei medicinali; il trasporto salme da presidi ubicati al di fuori
della provincia o della regione delle vittime e l’allestimento di strutture
temporanee. Un calderone, insomma, in cui c’è di tutto. Restano invece in capo
alla Regione Lombardia alcune spese che non sono state autorizzate. Tipo:
rafforzamento della pianificazione della prevenzione e i costi aggiuntivi di
personale, tra tutte quest’ultima resta la voce di spesa più importante:
148.246.093,69 milioni di euro. Mai come in questo esercizio finanziario ogni
voce di spesa racconta il dramma che si è consumato nella regione considerata
fino a ieri la Locomotiva d’Italia. Un ente locale, che a differenza di altre
aree geografiche, può contare su entrate consolidate, introiti stabili, solidità
finanziaria. Nel 2019 l’avanzo di bilancio ammontava infatti ad 1 miliardo e 324
milioni di euro, di cui 518 milioni provenienti dal bilancio di competenza. Una
riserva ingente a cui sarà necessario attingere ora che la crisi da Covid 19 ha
imposto una brusca inversione di tendenza. “Il nostro problema – conferma
infatti il consigliere regionale Dem Raffaele Straniero – è stato semmai il
contrario: la capacità di spesa”. Non la pensa così l’assessore al Bilancio
Davide Carlo Carapini, bresciano e leghista della prima ora che ha più volte
chiesto di accelerare le procedure dei rimborsi. La Conferenza delle regioni e
delle Province autonome ha fatto di recente la ricognizione delle spese
sostenute da tutti gli enti locali tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020 in
relazione all’emergenza Codiv-19 ma le procedure per applicare i rimborsi
previsti dal decreto Cura Italia viaggiano ancora molto al rilento. Arriveranno?
Ma quando? Nell’incertezza della copertura, il Pirellone non esclude di
utilizzare i proventi delle donazioni, circa 52 milioni di euro. Sono il frutto
di raccolte fondi tra i privati ma anche delle aziende territoriale della sanità
(Ats): Ats Brianza; Insubria; Val Padana; Bergamo e Città metropolitana. Risorse
sono arrivate anche dagli Irccs di Besta; San Matteo; Policlinico e
dall’Istituto nazionale dei tumori. Ognuno ha fatto la sua parte. Un discorso
diverso è quello delle donazioni arrivate per il padiglione di Rho Fiera
destinato alle terapie intensive. Pazienti che si contano sulle dita di una
mano: costo 20 milioni circa di euro. Secondo molti uno spreco inutile, risorse
sottratte al pubblico e regalate ai privati. Il nuovo ospedale messo su con la
collaborazione di Bertolaso e il contributo di Berlusconi, per intenderci.
Sebbene dei 52 milioni raccolti, ben 25 indicavano nella lettera di
accompagnamento o nella delibera di autorizzazione la preferenza per la
destinazione Rho, la Regione chiederà ai donatori l’autorizzazione a destinarle
ad altre “iniziative” legate comunque all’emergenza. Il Codiv 19 ha stravolto i
bilanci di tutte le regioni italiane, nessuna esclusa. Ma se quelle povere
saranno ancora più povere questa volta anche i ricchi piangono. Lacrime e sangue
è costato il coronavirus anche all’Emilia-Romagna, l’altra eccellenza. Un colpo
duro alle casse regionali non ancora del tutto quantificato. Si dà il caso però
che nel riparto delle risorse nazionali, la regione guidata dal governatore
Bonaccini aveva scoperto proprio a marzo, in piena emergenza, di poter incassare
175 milioni in più dell’esercizio precedente. Un tesoretto da cui ripartire.
Chissà certe sorprese nel Mezzogiorno non si verificano mai.
TRADITO IL SUD, TRADITA L'ITALIA.
Roberto Napoletano l'8 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud. I PAESI che fanno
parte dell’Unione Europea sono 27. Un bel numero. Una squadra di pallone con le
riserve e le riserve delle riserve più un’altra mezza squadra di titolari. Tra
tutti questi giocatori non c’è nessuno che va peggio di noi. Con il Regno Unito
impegnato in una eterna Brexit saremmo stati 28. Il risultato resterebbe
invariato. Sempre ultimi. Questo è l’unico risultato clamoroso certo che
riguarda l’Italia. Segnala il rischio Paese che è in cima alle preoccupazioni
dell’Europa che per scongiurarlo è pronta per la prima volta a dare all’Italia
non solo prestiti a tassi di favore ma anche fondo perduto ovviamente sempre a
fronte di progetti esecutivi attuati e rendicontati. Un Paese che ha un buco di
cassa di oltre 50 miliardi, non lo dice nessuno ma è così, e si appresta a
raggiungere vette inesplorate di debito pubblico non può consentirsi il lusso di
unire alla peggiore performance di crescita pre Covid, frutto di vent’anni di
scelte sbagliate di politica economica e di una macchina pubblica centrale e
regionale incapace di spendere, anche il record negativo di essere l’ultima
economia europea a ripartire dopo il Covid. Le previsioni del prodotto interno
lordo tutte negative e tutte per l’Italia ancora una volta da recordman tra i
Paesi sotto zero peccano, a nostro avviso, di eccesso di ottimismo. Questo
giornale sulla base di valutazioni empiriche, la somma dei mesi di chiusura
totale e di quelli a chiusura parziale delle attività economiche, ha parlato in
tempi non sospetti di un Pil negativo del 15% quando tutti, mettendo la testa
sotto la sabbia come gli struzzi, si trastullavano con previsioni inferiori di
un terzo. Non vogliamo tirarla lunga perché sull’orlo del baratro ci toccherebbe
occuparci di tanta vaghezza assortita, chiacchiere lunari di rimpasto, una
ministra delle infrastrutture (De Micheli) che riesce a bloccare una regione e
spicca per incompetenza, una squadra di ministri del Pd che difende il codice
degli appalti e non vuole i commissari perché bisogna difendere le riforme di
Delrio che hanno bloccato gli appalti in Italia senza scalfire il patrimonio
imbarazzante di 35 mila stazioni appaltanti contro le duemila di Francia e
Germania. Vogliamo invece dire una sola cosa che nessuno vuole dire, nessuno
vuole vedere, nessuno vuole sentire. Che è la sola cosa che blocca la crescita
del Paese da almeno un quarto di secolo: l’abolizione del Mezzogiorno dalla
spesa pubblica produttiva e sociale. Il vizietto dei ricchi della Sinistra
(Emilia-Romagna e Toscana) e della Destra (Lombardia e Veneto), di fare il pieno
di finanziamento pubblico a spese degli altri territori italiani. Purtroppo,
anche in un quadro di semplificazione oggettiva che è il massimo che Conte è
riuscito a strappare al Pd, i soldi europei finanzieranno al Nord subito opere e
al Sud studi di fattibilità, progetti. Se si vuole fare per davvero l’alta
velocità ferroviaria al Sud si fa come si è fatto ormai tanto tempo fa al Nord.
Non si finanzia uno studio di fattibilità ma si fa un atto concessorio per un
Progetto integrato per l’alta velocità ferroviaria con un bando di gara rivolto
a un pool di imprese selezionate. Se si vuole fare sul serio si fa così se no si
continua a prendere in giro il Sud e con i soldi di oggi del Sud a finanziare
assistenza e opere al Nord, avendo cura al Sud di assegnare sempre i soldi di
domani. Quelli che quando arriva l’oggi non ci sono più perché li ha già presi
il Nord. Sul capitolo sanità è addirittura peggio. Si è predisposta una bozza
per cui con i soldi del Mes si vuole dare alla Lombardia da sola quasi quanto
riceve tutto il Mezzogiorno continentale e si continua a non capire perché il
Veneto con un milione di abitanti in meno deve prendere più o meno quello che
prende la Campania e l’Emilia Romagna sempre più della Puglia. Siamo alla
violazione palese, insistita e scandalosa dei diritti costituzionali di
cittadinanza e siamo contenti che due presidente di Regione (Campania e Sicilia)
abbiano finalmente accolto il nostro suggerimento di rivolgersi alla Consulta
per tutelare i diritti violati e, cosa ancora più importante, dare contro tutti
e contro tutto l’ultima chance all’Italia per tornare a crescere. Fare, cioè,
l’unica cosa che deve fare da quasi trent’anni e non fa. La riunificazione
infrastrutturale delle due Italie. Serve al Nord per tornare ad avere il suo
mercato di consumi interno. Serve al sistema produttivo italiano per recuperare
una dimensione di impresa accettabile a livello globale che è cosa diversa da
essere l’appendice meridionale del gigante tedesco. Serve al Paese intero per
tornare ad essere la base logistica del Mediterraneo e recuperare la sua
leadership sui mercati strategici della sponda Sud del mondo. Serve all’Europa
che è stanca di dovere chiedere il permesso a Erdogan o a Abdel Fattah al-Sisi
per fare un investimento in Libia e non sa più come spiegare che apre i cordoni
della borsa perché l’Italia persegua e realizzi il suo riequilibrio strutturale
non altro. Chi glielo spiega a Bonaccini e Fontana che, causa Covid, hanno perso
sei mesi di “turismo sanitario” e hanno un buco di bilancio da sanare? Con i
giochetti di prima non si va da nessuna parte perché questa volta l’Italia
affonda e perché l’Europa non si vuole fare prendere in giro. Consigliamo al
Presidente Conte di sfidare i guappi di cartone del Pd per fare scelte più
radicali e condividere non a parole la priorità italiana del Mezzogiorno. Anche
perché se l’Italia non recupera questo pezzo così vasto di territorio esce dal
novero dei Paesi industrializzati.
Dagospia il 9 giugno 2020. QUANTO STARNAZZANO I LOMBARDI - E’
BASTATO METTERLI DUE MESI NEL RUOLO DI UNTORI-DISCRIMINATI PER ASSISTERE A UNA
REAZIONE FURIBONDA, DE BORTOLI IN TESTA - MA COME? IL SUD E I MERIDIONALI
VENGONO TRATTATI CON SPREGIO, SEMPRE. (DO YOU REMEMBER: “NON SI AFFITTA AI
MERIDIONALI”?) E ORA PER QUALCHE SFOTTO’ SI GRIDA ALL’INVIDIA SOCIALE?
L’ESAGERAZIONE DI FELTRI: “CONTRO LA LOMBARDIA, PROVENIENTI DAL MERIDIONE, SONO
STATI LANCIATI STRALI VELENOSI. UN PESTAGGIO SENZA PRECEDENTI CHE COLPISCE
POLENTONI QUASI FOSSERO DELINQUENTI”.
Vittorio Feltri per “Libero quotidiano” il 9 giugno 2020. È ora
di riaprire il fuoco che pure mi ha strinato. Un paio di mesi orsono, forse
meno, ero ospite del programma televisivo «Fuori dal coro» condotto dall'ottimo
Mario Giordano. Alle sette di sera registrai una intervista su temi di
attualità. Il Governatore della Campania, il simpaticissimo De Luca, aveva da
poco dichiarato l'intenzione di chiudere i confini della sua regione. Cosa
saggia. Chiamato a commentarla, mi chiesi se tale chiusura fosse solo in entrata
o anche in uscita. Precisando comunque che a me non importava trasferirmi a
Napoli per lavoro, visto che non avevo e non ho intenzione di fare il
posteggiatore abusivo, aggiunsi che il capoluogo vesuviano è abitato anche da
gente che non soffre di alcun complesso di inferiorità, ma è inferiore. Il
giudizio non era di tipo antropologico, dato che perfino io so che Benedetto
Croce non è nato a Cuneo e che Gabriele D'Annunzio non è venuto al mondo a
Sondrio. In discussione dunque non erano né potevano essere le virtù
intellettuali dei meridionali, bensì il loro livello economico, sociale e
civile. Chiunque sa che il Mezzogiorno soffre di arretratezza in campo
produttivo: il reddito dei suoi cittadini è la metà di quello dei lombardi, è
devastato dalla criminalità organizzata, è privo di infrastrutture idonee a
favorire lo sviluppo. Queste sono verità incontestabili. Nonostante ciò sono
stato linciato quasi avessi offeso il popolo del Sud, il quale peraltro si
lamenta proprio perché lo Stato non ha mai provveduto a colmare certe lacune che
lo rendono appunto inferiore (che non è una parolaccia) al settentrione. È un
fatto noto a chiunque conosca la realtà patria. Mi sono preso valanghe di
insulti. Addirittura Massimo Giletti, factotum dell'Arena della 7, ha
organizzato una puntata durante la quale i suoi ospiti, da Luca Telese al
sindaco di Benevento, mi hanno brutalizzato volgarmente, accusandomi di
antimeridionalismo, ignorando la mia storia. Solamente Alessandro Sallusti mi ha
generosamente difeso. Non contento, Giletti ha incaricato la ex ministra De
Gregorio di raccogliere le contumelie dirette a me ad opera di un considerevole
numero di sudisti che hanno parlato per sentito dire, cioè senza avere udito il
mio intervento tv. Più scorretti di così è impossibile. Naturalmente me ne sono
infischiato. Alla superficialità di certa gente sono avvezzo. Ora però si dà il
caso che si è scatenata una bufera contro la Lombardia, accusata di aver
commesso ogni nefandezza in occasione del Covid, come se il virus fosse stato
realizzato da Attilio Fontana e dai suoi collaboratori. Contro questa regione
pilota, provenienti dal meridione, sono stati lanciati strali velenosi. Un
pestaggio senza precedenti che colpisce polentoni quasi fossero delinquenti
oltre che untori indefessi. Il migliore dei settentrionali è dipinto quale un
bastardo intento solo a impestare i connazionali e ad accumulare denaro,
speculando su tutto, anche del virus. Ma le offese sanguinose sparate sui
lombardi non hanno suscitato polemiche: solo approvazioni. Non c'è stata e non
c'è anima che si indigni e invochi punizioni nei confronti dei detrattori dei
miei conterranei. Niente, neanche un sospiro. Se io dico che i napoletani sono
spettinati, vengo infilato nel tritacarne e ridotto a polpetta, se invece il
Paese intero imputa ai lombardi di essere un popolo di gentaglia arraffona,
avida e senza dignità, tutto va bene madama la marchesa. Non mi aspetto le scuse
di chi sputtana i miei concittadini, mi accontenterei che chiudesse la bocca e
pensasse che senza la Lombardia tornerebbe alla mezzadria e al latifondo.
Feltri difende il Nord, nuovo titolo discutibile di Libero:
arriva l'ironico commento di Di Mare. Vittorio Feltri,
giornalista e Direttore di Libero, ha pubblicato un altro editoriale che prende
di mira i Meridionali. Redazione areanapoli.it il 9 giugno 2020. Renato Farina,
giornalista, ha scritto un articolo su Libero dal titolo: "Tutti odiano la
Lombardia, nessuno odia il Mezzogiorno". Farina scrive che “bisognerebbe
aggiungere un comma alle leggi che tutelano dalle discriminazioni razziali,
religiose, sessuali. Andrebbe dedicato alla lotta contro la lombardofobia”. Cita
Giuseppe Verdi e annuncia l’organizzazione di un Lombard-Pride. Per l’occasione
Ferruccio de Bortoli potrebbe lanciare il suo movimento territoriale. Vittorio
Feltri, sempre su Libero, ha invece scritto: “Se nomini il Sud ti massacrano, se
insulti il Nord. Io contro il Mezzogiorno? Ho detto verità incontestabili. Sono
stato linciato quasi avessi offeso il popolo del Sud. Si è scatenata una bufera
contro la Lombardia accusata di aver commesso ogni nefandezza in occasione del
Covid, come il virus fosse stato realizzato da Fontana e i suoi collaboratori.
Senza la Lombardia chi oggi accusa tornerebbe alla mezzadria e al
latifondo”. Gino Di Mare, giornalista e fratello di Franco (ora Direttore di Rai
3), ha commentato in modo ironico su Facebook: "I titoli di Libero andrebbero
protetti, tutelati, esposti. Secondo me una permanente al Thyssen-Bornemisza di
Madrid avrebbe il suo perché. Almeno facciamo ridere anche agli spagnoli".
VITTORIO FELTRI per Libero Quotidiano il 12 giugno 2020. Illustre
Sergio Pinto, pubblichiamo volentieri la sua lettera garbata sperando dimostri
ai nostri lettori come stanno effettivamente le cose. Nessuno qui a Libero è
ostile ai terroni, termine scherzoso esattamente come lo è polentoni. Certi modi
di dire non devono assumere una connotazione dispregiativa, al contrario vengono
usati con affetto. Io sono stato recentemente criticato perché ho parlato delle
tribolazioni del Sud, abbandonato dalla politica e reso così incapace di
fronteggiare una arretratezza che risale a tempi lontani. Da oltre sessanta anni
i meridionalisti più provveduti si lamentano poiché il Mezzogiorno è male
amministrato dallo Stato Centrale, e hanno mille ragioni. Sono sempre mancati
investimenti tesi allo sviluppo del territorio, privo di infrastrutture, di
trasporti adeguati alle esigenze degli imprenditori che, di fatto, non sono
riusciti a sfondare sul piano economico lasciando la loro gente in una
situazione di subalternità rispetto al Nord. Negare tutto questo significa non
aver capito nulla delle problematiche che affliggono da secoli le regioni più
sfortunate d' Italia. Personalmente insisto da lustri: la rinascita delle due
Sicilie dipende dalla volontà degli uomini. I quali non devono favorire piogge
di denaro sulle zone depresse, quattrini che poi vengono raccattati dalla
malavita organizzata e destinati ad arricchire le famiglie mafiose. I soldi
pubblici vanno investiti in grandi opere che siano importanti ai fini di un
rilancio definitivo del Meridione, bisognoso di strade, ponti, aeroporti,
ferrovie, altrimenti esso non sarà mai in grado di competere con i connazionali
più vicini all' Europa. Quando affermo che molti napoletani sono inferiori ai
lombardi scopro l' acqua calda, nel senso che le possibilità dei vesuviani,
perseguitati dalla miseria, dalla camorra e da un caos cittadino
incontrollabile, sono evidentemente più modeste rispetto a quelle di cui
dispongono gli abitanti di Milano. Chi non riconosce che esiste un gap tra una
parte e l' altra dello stivale o è cieco o è sciocco. Non si tratta di
differenze antropologiche tra polentoni e terrori, tuttavia smentire che le due
categorie abbiano un reddito e un modus vivendi dissimili costituisce una
manifestazione di ottusità.
Da casanapoli.net il 12 giugno 2020. Il direttore di “Libero
Quotidiano“, Vittorio Feltri, torna ad attaccare Napoli e il Sud in generale,
per rispondere alle accuse rivolte contro la Lombardia. Vittorio Feltri torna a
parlare contro Napoli e il meridione d’Italia. Il direttore di Libero,
rispondendo alle accuse rivolte contro la Lombardia attacca Napoli e il sud a
testa bassa. Queste le sue parole: “Un pestaggio senza precedenti che colpisce
polentoni quasi fossero delinquenti oltre che untori indefessi. Il migliore dei
settentrionali è dipinto quale un bastardo intento solo a impestare i
connazionali e ad accumulare denaro, speculando su tutto, anche del virus. Ma le
offese sanguinose sparate sui lombardi non hanno suscitato polemiche: solo
approvazioni. Non c’è stata e non c’è anima che si indigni e invochi punizioni
nei confronti dei detrattori dei miei conterranei. Niente, neanche un sospiro.
Se io dico che i napoletani sono spettinati, vengo infilato nel tritacarne e
ridotto a polpetta. Se invece il Paese intero imputa ai lombardi di essere un
popolo di gentaglia arraffona, avida e senza dignità, tutto va bene madama la
marchesa. Non mi aspetto le scuse di chi sputtana i miei concittadini, mi
accontenterei che chiudesse la bocca e pensasse che senza la Lombardia
tornerebbe alla mezzadria e al latifondo“. Il direttore di Libero continua la
sua invettiva contro i Napoletani: “Ricordo quando il Governatore della
Campania, il simpaticissimo De Luca, aveva da poco dichiarato l’intenzione di
chiudere i confini della sua regione. Cosa saggia. Chiamato a commentarla, mi
chiesi se tale chiusura fosse solo in entrata o anche in uscita. Precisando
comunque che a me non importava trasferirmi a Napoli per lavoro, visto che non
avevo e non ho intenzione di fare il posteggiatore abusivo. Aggiunsi che il
capoluogo vesuviano è abitato anche da gente che non soffre di alcun complesso
di inferiorità, ma è inferiore. Il giudizio non era di tipo antropologico, dato
che perfino io so che Benedetto Croce non è nato a Cuneo e che Gabriele
D’Annunzio non è venuto al mondo a Sondrio. In discussione dunque non erano né
potevano essere le virtù intellettuali dei meridionali, bensì il loro livello
economico, sociale e civile. Chiunque sa che il Mezzogiorno soffre di
arretratezza in campo produttivo: il reddito dei suoi cittadini è la metà di
quello dei lombardi, è devastato dalla criminalità organizzata, è privo di
infrastrutture idonee a favorire lo sviluppo. Queste sono verità incontestabili.
Nonostante ciò sono stato linciato quasi avessi offeso il popolo del Sud, il
quale peraltro si lamenta proprio perché lo Stato non ha mai provveduto a
colmare certe lacune che lo rendono appunto inferiore (che non è una parolaccia)
al settentrione. È un fatto noto a chiunque conosca la realtà patria. Mi sono
preso valanghe di insulti”.
Libero e Feltri difendono la Lombardia e attaccano il Sud:
“Offese sanguinose sparate sui lombardi”. Da Chiara Di
Tommaso il 9 giugno 2020 su vesuviolive.it. Fa discutere il nuovo titolo di
apertura di ‘Libero’ e il relativo editoriale in prima pagina firmato da
Vittorio Feltri. Questa volta il giornale mette direttamente a confronto il Nord
e il Sud alimentando odio come si evince del titolo che recita: “Tutti odiano la
Lombardia, nessuno odia il Mezzogiorno”, con tanto di foto di Attilio Fontana.
Una difesa a spada tratta del governatore contro le accuse fatte da ‘Report’ e
da ‘Il fatto quotidiano’ sulla gestione della sanità lombarda: “Giù le mani da
Fontana”, “Attacco al potere economico”. Peccato che a parlare siano i dati e le
varie inchieste aperte contro Fontana per indagare sulla gestione
dell’emergenza. Ma per ‘Libero’ e Vittorio Feltri gli attacchi a Fontana vengono
esclusivamente dai ‘meridionali invidiosi’ della Lombardia. Guai a sottolineare
qualcosa che non va, subito arriva l’editoriale in difesa del Nord e contro il
Sud troppo permaloso: “Se nomini il Sud ti massacrano, se insulti il Nord…”.
Feltri ricorda una sua frase quella sull’inferiorità dei meridionali e la spiega
meglio, sottolineando come non sia solo economica. “Un paio di mesi orsono,
forse meno, ero ospite del programma televisivo «Fuori dal coro» condotto
dall’ottimo Mario Giordano. Alle sette di sera registrai una intervista su temi
di attualità. Il Governatore della Campania, il simpaticissimo De Luca, aveva da
poco dichiarato l’intenzione di chiudere i confini della sua regione. Cosa
saggia. Chiamato a commentarla, mi chiesi se tale chiusura fosse solo in entrata
o anche in uscita. Precisando comunque che a me non importava trasferirmi a
Napoli per lavoro, visto che non avevo e non ho intenzione di fare il
posteggiatore abusivo, aggiunsi che il capoluogo vesuviano è abitato anche da
gente che non soffre di alcun complesso di inferiorità, ma è inferiore. Il
giudizio non era di tipo antropologico, dato che perfino io so che Benedetto
Croce non è nato a Cuneo e che Gabriele D’Annunzio non è venuto al mondo a
Sondrio. In discussione dunque non erano né potevano essere le virtù
intellettuali dei meridionali, bensì il loro livello economico, sociale e
civile“. Ed ecco la sua difesa della Lombardia: “Contro questa regione pilota,
provenienti dal meridione, sono stati lanciati strali velenosi. Un pestaggio
senza precedenti che colpisce polentoni quasi fossero delinquenti oltre che
untori indefessi. Il migliore dei settentrionali è dipinto quale un bastardo
intento solo a impestare i connazionali e ad accumulare denaro, speculando su
tutto, anche del virus. Ma le offese sanguinose sparate sui lombardi non hanno
suscitato polemiche: solo approvazioni. Non c’è stata e non c’è anima che si
indigni e invochi punizioni nei confronti dei detrattori dei miei conterranei.
Niente, neanche un sospiro. Se io dico che i napoletani sono spettinati, vengo
infilato nel tritacarne e ridotto a polpetta, se invece il Paese intero imputa
ai lombardi di essere un popolo di gentaglia arraffona, avida e senza dignità,
tutto va bene madama la marchesa. Non mi aspetto le scuse di chi sputtana i miei
concittadini, mi accontenterei che chiudesse la bocca e pensasse che senza la
Lombardia tornerebbe alla mezzadria e al latifondo“. In democrazia vi è libertà
di parola ma un conto è raccontare i fatti, altro difendere l’indifendibile
accusando il Sud. Forse sono in tanti che dovrebbero chiudere la bocca.
Libero e il “Sud infettato”. Next
Quotidiano l'11 ottobre 2020. La prima pagina del quotidiano “Libero” di oggi,
nella solita difesa della Lombardia e della sua disastrosa gestione
dell’epidemia, regala un’altra delle sue chicche di razzismo: “Altro che
Lombardia, il Sud è infettato”, ci avvisa. E nell’occhiello si legge quasi una
nota di compiacimento quando scrive: “Il Covid dilaga nel Mezzogiorno”, per poi
scrivere nel sommario che “sono bastati pochi contagi per mandare la sanità da
Roma in giù in tilt”. Evidentemente il quotidiano diretto da Feltri (che
preferisce dedicarsi alla crociata contro i monopattini nel suo editoriale) e da
Pietro Senaldi, non dispone di calcolatrice. Basta andare, per esempio, ai dati
di ieri, per constatare che la Lombardia, da sola, contava 1140 su 5724 casi di
nuovi contagi (circa il del 20% di quelli registrati in tutta Italia). E il Sud
“infetto”? Sommando quelli di Abruzzo (94), Molise (28), Puglia (184), Campania
(664), Basilicata (42), Calabria (68) e Sicilia (285), il totale di nuovi casi
registrato ieri è stato di 1365 (225 in più della sola Lombardia che “Libero”
indica quasi come una eccellenza). Anche volendo fare un confronto con la
popolazione residente e l’incidenza su questa dei contagi (uno dei refrain a
difesa della Lombardia è di essere la regione più popolosa d’ Italia, con oltre
dieci milioni di abitanti), il titolo di “Libero” si rivela la solita bufala. A
fronte di quei dieci milioni, le regioni del Sud contano quasi il doppio dei
residenti lombardi. E’ vero che i contagi stanno aumentando soprattutto in
Campania, ma questo non vuol dire che “il Sud è infetto”. Ma tanto, si sa, a
lavare la testa agli asini di “Libero” ci si rimette solo acqua e sapone…
Il tempismo di Libero che dice che il sud è infettato, quando
la Lombardia supera i 1000 casi in 24 ore. La prima
pagina di Libero di oggi, alla luce dei dati Covid di ieri, non può che
risultare fuori luogo. Ilaria Roncone su Giornalettismo l'11/10/2020. “Il Covid
dilaga nel Mezzogiorno. Altro che Lombardia, il sud è infettato”: questo il
titolo da prima pagina dell’edizione di Libero oggi. Non mancano le
puntualizzazioni su quanto siano bastati “pochi contagi per mandare la sanità da
Roma in giù in tilt“. Che Libero non faccia titoli lusinghieri nei confronti del
sud Italia lo sappiamo da sempre, ma oggi possiamo sottolineare quanto
risulti ironica la prima pagina in virtù dei numeri coronavirus della giornata
di ieri in Lombardia, in Campania e nel sud in generale.
Dati coronavirus Lombardia: solo ieri 1.140 nuovi contagi.
Continua la crescita esponenziale dei nuovi contagi in Italia. Nella giornata di
ieri sono stati registrati 5.724 nuovi casi positivi di Covid con 133.084
tamponi effettuati e 29 morti. Una crescita generalizzata dei contagi, certo, ma
ieri la regione che ha pagato il prezzo più alto è stata proprio quella
Lombardia che Libero contrappone al sud: 1.140 nuovi positivi con Milano città
che ha fatto registrare oltre 300 nuovi casi.
Perché la prima pagina Libero sul sud infettato non ha senso.
Anche il sud è in salita per quanto riguarda i dati coronavirus, con la Campania
– in particolare – che vede il governatore De Luca iniziare a parlare della
possibilità di lockdown Campania qualora il rapporto tra nuovi contagi e guariti
dovesse diventare eccessivamente sbilanciato. I nuovi contagi in Campania ieri?
664, dato leggermente in calo rispetto ai giorni precedenti, seppure comunque
alto. Chiariamolo: i contagi salgono ovunque, nessuna regione risulta da un po’
di tempo ormai a contagi zero; la crescita della curva è visibile ovunque e in
ogni regione crea preoccupazione. Andando però a guardare ai numeri è evidente
come il paragone fatto da Libero tra il sud e la Lombardia non sia propriamente
corretto.
Campania in prima pagina su “Libero”: “La ruota gira. Canta
Napoli e si infetta, ora il lanciafiamme fa cilecca”.
Veronica Ronza il 9 ottobre 2020 su vesuviolive.it. Il quotidiano “Libero”,
negli ultimi giorni, ha posto particolare attenzione alla questione Covid in
Campania. Ormai è risaputo che la Regione è una delle più colpite in fatto di
Covid-19. Situazione che desta dispiacere ai più ma, probabilmente, non ai
giornalisti della testata in questione. Già Angelo Forgione, nella giornata di
ieri, ha utilizzato il suo account Facebook per evidenziare le parole poco
carine di Renato Farina, co-fondatore della testata insieme a Vittorio Feltri.
Il suo pezzo, infatti, ha come titolo “La Campania colpita dal virus adesso
ricorda la Lombardia” e come occhiello “La ruota gira”. Inoltre, si
legge: “Quando il Covid infuriava al Nord, molti al Sud infierirono su milanesi
e bergamaschi. Ora che l’emergenza tocca a loro, il Pirellone apre ai napoletani
l’ospedale in Fiera. Il gesto dei lombardi alla Prima Crociata anti-Covid è una
magnifica offerta di fraternità. La piccola vendetta lombarda è il far del bene.
A questo punto, dopo esserci presi la soddisfazione della memoria, pace.” A
rincarare la dose, la prima pagina del numero di oggi in cui sovrasta il
seguente titolo: “Canta Napoli e si infetta. Ora il lanciafiamme di De Luca fa
cilecca.” E ancora si descrive in maniera distorta ciò che sta accadendo,
infierendo ancor di più su una popolazione già provata: “Per le vie del
capoluogo campano la gente si accalca come se nulla fosse, le terapie intensive
della Regione si riempiono e lo ‘sceriffo’ è impotente.” Del resto, è parte
della linea editoriale del quotidiano “Libero” la critica al Sud, dunque non
poteva non essere rimarcato il peggioramento della situazione Covid in Campania.
Proprio nel pieno della pandemia, il direttore editoriale Vittorio Feltri,
nonostante l’emergenza che ha colpito e messo in ginocchio tutta l’Italia, si
impegnava ad accusare di inferiorità i meridionali nei salotti televisivi.
Quei pagliacci di Libero che deridono il Sud infetto.
Da thewam.net il 10 ottobre 2020. Un altro attacco gratuito da giornali del nord
al meridione. Dopo «De Luca uomo di merda, a fanculo i campani», scritto su
Affari Italiani, questa mattina Libero titola: «Il Covid dilaga al Sud. Altro
che Lombardia, il Sud è infetto». Con un tono dispregiativo e proprio il giorno
in cui la Lombardia fa il doppio dei contagi della Campania...
Il quotidiano Libero deve avere un problema patologico con il Sud
e i Meridionali. Articolisti e titolisti fanno a gara a chi è più becero,
alimentando spaccature in un Paese che è in bilico, travolto da una emergenza
sanitaria senza precedenti. Un po’ come il tipo di Affari Italiani che oltre a
definire De Luca “un uomo di merda” (vero giornalismo d’altri tempi…), si è
sentito in dovere di mandare “a fanculo” i campani. Una volta certe gente non
avrebbe avuto diritto di parola neppure al bancone di un bar. Ora scrive sui
giornali.
Il Sud è infetto, altro che la Lombardia. Ma torniamo a Libero,
la perla quotidiana è questa: «Il Covid dilaga nel Mezzogiorno. Altro che
Lombardia, il sud è infettato». Ora, che il Covid dilaga al Sud è vero,
purtroppo: ma perché questo paragone con la Lombardia, oltretutto proprio nel
giorno in cui proprio la Lombardia fa registrate 1.100 casi, ovvero 500 contagi
in più della Campania, che è seconda.
Una informazione che fa schifo. Come fosse una gara, una
competizione tra Regioni. Una specie di Giochi senza frontiere del coronavirus e
Libero il quotidiano di riferimento degli ultrà settentrionali. In tutta
franchezza: siamo schifati da questi atteggiamenti. Siamo schifati da questa
informazione. Siamo schifati da chi continua a contrapporre, in modo
anacronistico, il Nord contro il Sud. La presunta efficienza contro il presunto
fannullonismo para mafioso. Basta.
Solo per dire che la nostra sanità non è come quella lombarda.
Libero ha fatto quel titolo per poter dire, con esibita soddisfazione: «Sono
bastati pochi contagi per mandare in tilt la sanità da Roma in giù». E ribadire
come invece il sistema lombardo è sì stato messo in crisi in primavera, ma a
fronte di una vera emergenza. Embè, lo sappiamo, lo sanno tutti che la sanità
lombarda è più efficiente di quella al Sud. E allora? Si vince un premio, ci si
sollazza su un giornale a osservare le difficoltà meridionali nell’intima
speranza di assistere a una tragedia? Per fare cosa, dire a tutti che il “sud
piagnone” si è piegato davanti al Covid? Libero, così come il Giornale, non sono
nuovi a uscite di questo tipo. Il tiro al meridionale viene subito dopo il tiro
all’immigrato, ma sta guadagnando terreno. Evidentemente l’immigrato invasore
non interessa più.
Ancora una risposta a De Luca. Forse bruciano ancora, e dopo
mesi, quelle dichiarazioni di De Luca («al nord non hanno chiuso e ora contano i
morti»), o l’aver assistito impotenti al crollo di tante certezze, come
l’efficientismo settentrionale, messo in ginocchio da un microscopico virus, o
ancora fa male quel pezzo di El Pais sulla «fine del modello lombardo», proprio
a causa della risposta alla pandemia. A dire il vero capire le ragioni di tanta
beceraggine, di questa ignobile volgarità che imbratta i giornali, non ci
interessa per nulla. Restano lì, titolacci e pezzacci scritti per spaccare il
Paese, magari ci scappa anche una ospitata in un talk show di terza serie. Nel
frattempo l’Italia, tutta intera, soffre dello stesso male, della stessa
emergenza sanitaria e della stessa crisi economica. Solo qualche pagliaccio
dell’informazione può pensare ad altro.
Le fake news su Attilio Fontana di Travaglio e Report che
alimentano il clima d’odio. Tiziana Maiolo su Il
Riformista il 9 Giugno 2020. Per il pubblico ministero Alberto Nobili, che lo ha
interrogato venerdi scorso, è persona offesa. Per il Fatto quotidiano e la
trasmissione Report è una sorta di faccendiere in perenne conflitto
d’interessi. Per Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, non c’è
pace, da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. Marco Travaglio lo ha messo
nel mirino e ogni giorno ne chiede le dimissioni, se non è proprio possibile
l’arresto. E due giorni fa si è fatto dare in prestito dai suoi amici della
trasmissione scandalistica Report una finta notizia su un conflitto di interessi
nella speranza che qualche procuratore voglia aprire un fascicolo e indagare
Attilio Fontana. Speranza presto esaudita visto che secondo indiscrezioni
la Procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva, senza ipotesi di reato
né indagati. Contemporaneamente sono apparse sui muri di Milano scritte del tipo
“Fontana assassino” (rivendicata dai Carc, comitati di appoggio alla resistenza
comunista), oppure “Fontana assassino, Sala zerbino”, che viene attribuita a un
centro sociale di nome Zam. E il legale della Regione Jacopo Pensa ha anche
consegnato al pm Nobili un dossier di trenta pagine intitolato «Clima d’odio»,
tanto per chiarire di che cosa si tratti. Non proprio una situazione rilassante
per uno che da tre mesi sta affrontando la tragedia di malati e morti come mai
si era visto, e la marea montante di revanscismo che sale da Scidda e
Cariddi verso la Regione più popolosa, più progredita e più colpita d’Italia. Lo
scoop di Report è – si può dirlo? – una vera stupidaggine. E l’uso che ne viene
dato dal Fatto, cui è stata concessa in esclusiva graziosamente l’anticipazione,
anche per aumentare l’ascolto alla trasmissione di ieri sera, una vera porcata.
Soprattutto nei confronti di una persona unanimemente (anche dagli stessi
cronisti di Report, ci pare) ritenuta per bene. Lo “scandalo” si snoda tra il 16
aprile e il 20 maggio. Nei giorni in cui erano introvabili i presidi sanitari e
il governo aveva già fatto pasticci con le mascherine, l’Aria, la centrale
acquisti della Regione Lombardia, lancia un invito per la fornitura di camici
idrorepellenti e altri indumenti di presidio sanitario. E contemporaneamente
molte aziende lombarde iniziano a riconvertire le proprie attività per dare una
mano, per solidarietà. Chi si mette a cucire mascherine, chi produce camici e
cappellini. All’invito di Aria rispondono tre aziende, una delle quali
amministrata dal cognato di Fontana, Andrea Dini. La Centrale acquisti della
Regione emette fatture che nel giro di un mese vengono però stornate, perché la
società Dama Spa aveva chiarito dal primo momento di aver avuto intenzione, come
già altri come Giorgio Armani, di fare una donazione dei camici. Del resto la
stessa società Dama non era nuova a questo tipo di gesti, visto che aveva già
versato 60.000 euro al Fondo per le emergenze della Regione e aveva fatto
diverse donazioni agli ospedali della provincia di Varese. In ogni caso non un
euro dei cittadini è entrato nelle sua casse, anzi ne sono usciti parecchi. Ma
che cosa stuzzica la fantasia sospettosa di Travaglio? Il fatto che Fontana non
ne sapesse niente, prima di tutto (ah, ma allora è come Scajola!) e il lasso di
tempo trascorso tra l’invito di Aria e lo storno della fattura. La spiegazione è
stata data ed è molto banale, l’assenza del Ceo in quei giorni dall’azienda. In
ogni caso l’inchiesta di Report è stata avviata “dopo”, quindi quale è il
problema? È sempre il solito: manette manette! Un po’ di scandalismo. Un bel
soffiare su quel fuoco pericoloso che si sta sviluppando, tanto da far
preoccupare lo stesso Presidente Mattarella, soprattutto nelle regioni del sud,
nei confronti dei cittadini lombardi, tanto da far chiedere l’istituzione di una
sorta di apartheid della regione più produttiva d’Italia, considerata anche la
più contagiosa. Lo si è visto fin dall’articolo di Gad Lerner (che giustamente
si è poi guadagnato un passaggio al Fatto quotidiano) su Repubblica del 4 aprile
in cui accusava la Regione Lombardia di aver compiuto una strage al Pio Albergo
Trivulzio. Si è poi scoperto che le inchieste sulle Rsa sono 40 in
tutta Italia e che i dati dei contagi e delle morti nelle case di riposo degli
altri Paesi europei erano ben più elevati di quelli lombardi. Poi c’è stata la
vicenda del reparto terapia intensiva alla Fiera di Milano costruito con fondi
privati in quindici giorni nel momento dell’emergenza più tragica, irriso da
Travaglio perché, per fortuna, la situazione è poi migliorata e non c’è stato
bisogno di riempirlo. Poi la campagna per la mancata istituzione della zona
rossa nel bergamasco, quasi come se spettasse alle Regioni istituire posti di
blocco con carabinieri e polizia. Per fortuna è stata la stessa pm di Bergamo a
mettere i puntini sulle “i” dicendo che era compito del governo quella decisione
che purtroppo non fu presa. Ma, considerazioni politiche a parte ed errori fatti
un po’ da tutti di fronte a qualcosa di inedito e tragico come una gravissima
pandemia, il problema è che l’opera di sputtanamento in questo Paese sembra non
finire mai. Anche senza le intercettazioni, anche senza il trojan, resta il
fatto che nella sub-cultura grillino-travagliesca il sospetto continua a essere
l’anticamera della verità, un innocente è solo un colpevole che l’ha fatta
franca, un indagato è peggio di un condannato e un presidente di Regione “non
poteva non sapere”. Oggi tocca a Fontana. Ma domani? Ma quando arrivano i famosi
più puri che epurano i puri?
L'odio contro la Lombardia per attaccare il centrodestra.
Sinistra e Cinque Stelle montano una campagna contro i
lombardi. Dietro c'è un preciso disegno politico per attaccare la Regione
guidata dal centrodestra. Andrea Indini, Lunedì 08/06/2020 su Il Giornale. È un
odio violento, atavico, a lungo taciuto e in questi mesi, complice l'epidemia di
coronavirus che ha piegato il Nord Italia, esploso con una virulenza senza
precedenti. Un odio che ha investito in particolar modo i lombardi e la
Lombardia, non solo in quanto tali, ma per quello che rappresenta: da sempre
fortino del centrodestra e, negli ultimi anni, capitanata da governatori
leghisti. Nonostante i morti, che contiamo a migliaia, e nonostante la fatica a
combattere un nemico tanto piccolo quanto letale, la sinistra e i Cinque Stelle
si sono scagliati (senza alcun rispetto) per biechi fini politici. Se,
all'inizio, quando l'Italia si è ritrovata - con il fiato sospeso - nella morsa
della quarantena, i colpi bassi erano più radi, non appena è scattata la "fase
2" l'odio è esploso con un vigore senza precedenti, fino a immaginare cimiteri
pieni di morti con il centrodestra al governo. L'odio è iniziato in sordina.
Sembravano semplici scaramucce politiche. Come quando il 26 febbraio, meno di
una settimana dopo la scoperta del "paziente 1" a Codogno, il governatore
Attilio Fontana pubblica su Facebook un video in cui annuncia il contagio di una
collaboratrice. Il suo viso è coperto da una mascherina chirurgica, verde. In
quei giorni non se ne vedono tante in giro. È probabilmente il primo politico
italiano a indossarne una in pubblico. È un messaggio, certo. Un messaggio a
tutti i lombardi affinché prendano le precauzioni necessarie per evitare il più
possibile occasioni di contagio. "Da oggi qualcosa cambierà perchè pure io mi
atterrò a quelle che sono le disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità per
cui per due settimane vivrò in una sorta di auto quarantena - spiega - oggi ho
già passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo nei
prossimi giorni". Gli sono subito saltati tutti al collo. I primi ad attaccare
sono stati quelli del Partito democratico. Da Matteo Orfini, che arriva
addirittura a negare l'utilità di metterla in Aula alla Camera ("È un gesto
inutile e dannoso per il messaggio che diffonde"), a Maurizio Martina che lo
accusa addirittura di "alimentare il panico" e di "danneggiare i cittadini e il
Paese". I grillini (ovviamente) non sono da meno. "Sono immagini che non aiutano
perché spaventano ed espongono l'Italia al rischio di un isolamento economico
che non ha alcuna giustificazione", tuona Danilo Toninelli. "Il panico deve
essere assolutamente arginato, non alimentato in alcun modo - conclude - serve
una corretta informazione, che non faccia inutili allarmismi, un linguaggio
equilibrato e altrettanto deve valere per i gesti". Sin dai primi giorni il
Prirellone si trova in forte contrasto con Palazzo Chigi. In Regione Lombardia
si accorgono sin da subito che a Roma non stanno capendo la gravità della
situazione. E così, mentre i vari Nicola Zingaretti, Beppe Sala e Giorgio Gori
fanno campagne per tenere aperto, sono costretti a rimboccarsi le mani e fare da
soli. Non solo. Devono pure "parare" le apre critiche del premier Giuseppe
Conte, che prova ad addossare all'ospedale di Codogno le colpe del focolaio nel
Lodigiano, e ingaggiare un estenuante braccio di ferro sempre con la presidenza
del Consiglio per allargare al più presto la "zona rossa" alla Val Seriana e al
Bresciano, dove già il 2 marzo - dati alla mano - appare chiaro che la
situazione è ormai sfuggita di mano. Non ci riuscirà. La chiusura della regione
arriverà troppo tardi e Fontana & Co. dovranno pure sorbirsi le critiche per non
essersela fatta da soli, quando anche il procuratore facente funzione di
Bergamo, Maria Cristina Rota, ha messo in chiaro ai microfoni del Tg3 che tale
decisione spettava all'esecutivo. Se non è la polemica sulle "zone rosse"
mancate, sono le critiche al sistema sanitario regionale che fatica a reggere
l'urto del Covid-19. Il 15 aprile, in un articolo apparso su Le Monde, Roberto
Saviano non perde occasione per tirare in ballo "il territorio di Silvio
Berlusconi" e si erge sul piedistallo per impartire ai lombardi "la debolezza
insita nel credersi invincibili". A sinistra è un sentimento diffuso. Sono
molti, infatti, quelli che credono che il coronavirus abbia dato una lezione al
Pirellone e che soprattutto il centrodestra non sia stato all'altezza di
gestirlo. Per dimostrarlo vengono montati ad arte teoremi sulla gestione del
sistema sanitario, vengono scomodati (senza nemmeno leggere le ordinanze della
Regione che sono identiche, in tutto e per tutto, a quelle emanate da altri
governatori iscritti al Pd) gli anziani morti nelle Rsa, viene screditata la
costruzione dell'ospedale in Fiera (quando è stato il governo Conte a chiedere
alle Regioni di aumentare del 50 per cento il numero dei posti letto). Il 21
maggio, durante l'informativa del premier sulla "fase 2" alla Camera, si viene
quasi alle mani quando il grillino Riccardo Ricciardi se ne esce con
accuse senza precedenti (guarda il video). "Chiedono collaborazione alle
opposizioni e poi vengono qui a prendere per il culo sui morti? Ecco,
prendersela coi morti anche no", sbotta Giancarlo Giorgetti invitando il
ministro della Salute Roberto Speranza a tenere a bada i Cinque Stelle. "Tira
male, io ve lo dico, qui finisce male. Qualcuno deve metterli in riga, coi morti
che ci sono stati. Non si può chiedere collaborazione alle opposizioni e poi
venire in aula a provocarci sui morti". Il punto è che anche all'interno di
Liberi e Uguali, partito a cui è iscritto Speranza, la pensano allo stesso
modo. Qualche settimana più avanti Pierluigi Bersani se ne andrà in
televisione a dire che "se avesse governato questa gente qua (il centrodestra,
ndr) non sarebbero bastati i cimiteri". E non ci si deve, poi, stupire se ci
ritroviamo i muri di Milano lordati dagli antagonisti con la scritta choc
"Fontana assassino". Lo stesso slogan urlato dai sindacati scesi in piazza ai
primi di giugno. La campagna (mediatica) di denigrazione tocca probabilmente il
suo apice con il falso scoop di Report, poi ripreso dal Fatto Quotidiano, in cui
si fa passare una donazione di materiale sanitario per un conflitto di
interessi. Un "attacco politico vergognoso", come lo ha definito lo stesso
Fontana, che ora finirà in aula di tribunale. L'odio politico, però, si mischia
all'odio regionale. E così sono troppi quelli che stanno portando avanti una
vera e propria campagna contro i lombardi. Lo fa persino chi, come lo scrittore
Massimo Mantellini, dovrebbe preservare il Paese dalla violenza verbale. Conte
lo ha, infatti, voluto nella task force governativa (una delle tante) per
epurare il web dall'odio dilagante. Nei giorni scorsi se ne è uscito con un post
a dir poco delirante: "La dico piano: chiudiamo i lombardi in Lombardia. Almeno
per questa estate". Lo stesso che vorrebbero fare alcuni governatori di sinistra
per sminuire gli sforzi che dal 20 febbraio il Pirellone sta compiendo per
vincere la partita contro il coronavirus. Sicuramente Regione Lombardia, come
anche il governo, ha fatto errori. Li ha fatti perché si è trovata a dover
combattere una battaglia senza precedenti. Usarli, ingigantirli e distorcerli
per fini politici è una bieca campagna di disinformazione che non rende
giustizia a tutti quei morti che stiamo ancora piangendo.
Nicola Mirenzi per huffingtonpost.it l'8 giugno 2020. Il conto si
paga con la vergogna: “Ancora oggi mi sento un po’ appestato. Non esco da
Milano. Rimango a casa il più possibile. Ascolto racconti di amici che sono
andati fuori dalla Lombardia e sono stati accolti da battutine, insinuazioni,
cattiverie. Alcuni hanno dovuto subire anche un cartellone che diceva: “Torna a
casa tua”. Sono cose che mettono a disagio e feriscono le persone. Uno spirito
anti lombardo è emerso nel Paese. Come se vedere colpita questa Regione, sempre
definita un modello, anziché suscitare vicinanza, desse un piacere che i
tedeschi definiscono con una parola precisa: schadenfreude, gioia per le
disgrazie altrui. Non è più inaccettabile. Bisogna reagire. Dire basta”. Nato a
Milano nel 1953, Ferruccio De Bortoli – giornalista, saggista, per due volte
direttore del Corriere della Sera, di cui oggi è uno dei principali
editorialisti – non aveva mai considerato l’ipotesi che il luogo di nascita
riportato sulla sua carta d’identità potesse diventare un marchio, se non
d’infamia, almeno di diffidenza: “Il razzismo al contrario, cioè l’idea che ora
i cittadini italiani discriminati siano quelli del Nord, mentre prima erano
quelli del Sud, è un concetto che trovo esagerato. Io credo che si tratti più
precisamente di un pregiudizio radicato, che ha moventi sociali, politici,
economici. Come spesso accade con i pregiudizi, essi sono degli strumenti
straordinari per costruire alibi. Ti consentono di non guardare dentro casa tua.
Ti levano la fatica di misurare i risultati che hai raggiunto, confrontandoli
con quelli altrui. La Lombardia e Milano rappresentano l’Italia che ce la fa nel
mondo. Il Paese che riesce a competere nella globalizzazione. Puntare il dito
contro di esse, alleggerisce la coscienza di chi non è riuscito a fare
altrettanto. Gli consente di non guardarsi allo specchio, scaricando tutta la
responsabilità altrove”.
La Lombardia non ha sbagliato niente?
«Anche la Lombardia ha commesso
degli errori. Soprattutto, di comunicazione. La Giunta farebbe bene a
riconoscerli e spiegare perché li ha commessi. Io però – da lombardo – mi faccio
anche un’altra domanda. Mi chiedo: "Perché siamo diventati antipatici?"»
Ha una risposta?
«Credo che, a volte, siamo stati
troppo orgogliosi dei nostri primati, esaltando le nostre virtù fino a sfiorare
l’arroganza. Forse, abbiamo avuto anche un atteggiamento semi-colonialista,
proiettando un’immagine di noi stessi che chiedeva un adeguamento ai nostri
numeri. Senz’altro, abbiamo sbagliato qualcosa anche noi».
Però?
«Però la Lombardia è stata investita
dal contagio con una violenza inusitata. Si è trovata di fronte un nemico che
nessuno conosceva e, all’inizio, tutti abbiamo sottovalutato, incluso io. La
giustizia deve andare sino in fondo, perché i familiari delle vittime e il Paese
devono conoscere la verità. Non si può però accettare la criminalizzazione
preventiva che è stata fatta. Stiamo parlando di una terra che è stata
martoriata, con decine di migliaia di morti. Dobbiamo avere rispetto. Un conto è
capire cosa non ha funzionato. Un altro conto è alimentare processi sommari. Che
sono inaccettabili».
Da dove è venuta fuori questa pulsione?
«Le posizioni sbrigative e
sprezzanti contro Milano e la Lombardia nascondono un’invidia sociale nei
confronti di chi è stato sempre ritenuto migliore. Sta succedendo in Italia
qualcosa di simile a quello che accade in Spagna con la Catalogna ed è successo
in Gran Bretagna con Londra, ed è all’origine della Brexit: si detesta chi è più
ricco, chi è riuscito a cavarsela nel mondo, chi ha espresso al meglio le
proprie capacità».
Perché non scatta, invece, l’emulazione?
«Perché bisognerebbe partire dal
riconoscere le proprie mancanze, dandosi come obiettivo quello di colmarle.
L’Italia, invece, è un Paese di continui e incessanti dualismi. Quello tra Nord
e Sud è uno dei più longevi. Negli ultimi anni, il dislivello si è tradotto in
un risentimento del Sud verso il Nord. Infatti, già prima della pandemia, il
ministro Provenzano aveva detto che Milano non restituisce nulla. Ora, questo
rancore si è manifestato più platealmente».
Che cosa ci vede dentro?
«Un disprezzo dell’impresa, una
diffidenza nei confronti dell’industria, una rivincita della statalizzazione
contro il mercato. Sottilmente, il liberismo viene ritenuto responsabile di
quello che è successo. Non ci sono prove che sia così. Però lasciarlo intendere
serve a proporre un ritorno al ruolo dello Stato, il cui luogo d’elezione
naturale è Roma».
La sanità privata ha funzionato bene?
«Gli ospedali privati, in Lombardia,
si sono dati da fare, come si sono dati da fare tutti. La solidarietà con il
pubblico è scattata. Forse si può rimproverare un ritardo, ma non si può
attaccare il privato in quanto privato, il modello lombardo in quanto lombardo.
Dimenticando che ogni anno 165 mila persone vengono a curarsi qui da altre
Regioni. In Italia, la sanità di sette Regioni è stata commissariata. Abbiamo
visto malcostume, ruberie, cattive gestioni scaricate sulle spalle dei
contribuenti. E ora il problema italiano sarebbe la sanità lombarda?»
È un attacco politico?
«Il pregiudizio anti lombardo è
radicato in una parte della sinistra italiana. Politicamente, Milano è percepita
come la città di Craxi, di Berlusconi, di Bossi, ora di Salvini. È qualcosa di
estraneo, che la sinistra non è mai riuscita ad afferrare fino in fondo. Anche
Sala, che oggi è sindaco della città, è come se venisse da fuori, non facendo
parte della tradizione Pd».
Basta a fondare un preconcetto?
«C’è anche il fatto che la sinistra
non ha mai parlato la lingua delle imprese piccole e grandi che costituiscono
l’economia del Nord. Però, anziché interrogarsi sul perché, cercando di
rimediare, oggi imbocca la scorciatoia della diffidenza. Ma non si può
risollevare il Paese coltivando un sentimento anti industriale, sospettando chi
intraprende e produce. La Lombardia vale il 22% del Pil italiano. Ha 54 miliardi
di residuo fiscale, pur contando il 16% della popolazione nazionale. Come si fa
a non capire che senza Milano e la Lombardia l’Italia non si metterà mai in
piedi?»
Cosa propone?
«Una tregua. Sospendiamo le
polemiche. Rimettiamo insieme il Paese. Cerchiamo di comprendere cosa è
successo, non per colpire l’uno o l’altro, ma per riparare gli errori e farci
trovare pronti in autunno, se ce ne sarà bisogno. Nel frattempo, la giustizia
farà il suo dovere».
Quante probabilità ci sono che accada?
«Non le so calcolare. Quel che so –
e che mi addolora – è che ci stiamo lasciando andare alle piccinerie. Alla
volgarità di frasi come ‘Milano da bare’. Alla grettezza regionalistica. Tanti
piccoli noi contro voi. Ma veramente vogliamo tornare ai pregiudizi? Al milanese
bauscia, al ligure tirchio, al calabrese scansafatiche? C’è davvero qualcuno che
crede che si possa uscire dall’angolo così?»
Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera” il 9 giugno 2020.
«Io ho vissuto la vicenda Covid con un'angoscia personale grandissima.
Terribile. Quello che mi ha aiutato a non fermarmi, è stato proprio il cercare
tutte le soluzioni per uscirne. Immaginare una strada anche per le fasi di
ripartenza che abbiamo di fronte».
Attilio Fontana è nel suo ufficio, provato dopo mesi a ritmi
serrati. Ma quale lezione ha tratto da questa vicenda?
«Quello che mi porto dentro è stato il vedere centinaia di
persone che non si sono date tregua, con dedizione assoluta, per aiutare gli
altri».
Lei quali errori si imputa?
«Noi, ma credo quasi tutti, siamo stati colti di sorpresa da
un'emergenza bestiale, di errori ne abbiamo commessi fin che ne vuole. Però, a
marzo prendere decisioni era durissima. Per questo ora io sto studiando,
cercando di vedere in quello che è accaduto le indicazioni per fare meglio in
futuro».
Per esempio?
«Inutile che anticipi adesso. Sto per nominare un mio gruppo di
lavoro che entro la metà di agosto indicherà le cose da fare e quelle da
evitare, proprio sulla base di questi mesi. La competenza viene prima di tutto,
e la Lombardia, me lo lasci dire, sulle competenze è fortissima».
Ferruccio de Bortoli ha detto che prendersela con la Lombardia e
Milano, che riescono a competere nel mondo, «alleggerisce la coscienza di chi
non è riuscito a fare altrettanto».
«Guardi, io di Ferruccio de Bortoli ho la massima stima, e certo
non lo si può accusare di simpatie leghiste. Io penso che Milano e la Lombardia
sono e resteranno la locomotiva della Nazione, e a breve ricominceranno a tirare
con tutta la loro forza. Certo, se poi qualcuno cerca di usare la vicenda Covid
per fini politici, significa che non solo ha del tempo da perdere, ma che ha
anche l'animo dello sciacallo. Chi si gingilla con questa politichetta, ha
capito male il nostro Paese».
A proposito, quali i rapporti con il sindaco Beppe Sala? Anche
con lui avete avuto momenti complicati.
«Mi creda, la mia non è una risposta di stile. Ma devo dire che
io ho una grande stima di Sala. Certo, non sempre sono d'accordo con lui. Ma
quando c'è da collaborare, l'ho sempre fatto. Peraltro, la sinergia è
indispensabile, perché la Lombardia non può fare a meno di Milano e Milano non
può fare a meno della Lombardia».
Perdoni, presidente. Ma dell'ospedale nell'ex Fiera non è
pentito? Di fatto, ha ospitato pochissimi pazienti.
«Lei vuole scherzare... Anche quello è nato sotto una pressione
terribile, l'ho deciso quando un medico, con le lacrime agli occhi, mi ha detto
che non voleva più scegliere chi far vivere. Detto questo, di strutture simili
ne sono state create ovunque nel mondo, 19 nei soli Stati Uniti. Ma di queste,
13 non sono mai entrate in funzione. L'ospedale in Fiera è stato uno
straordinario regalo alla città da parte di più di 5.000 donatori nel momento
più drammatico della pandemia. Per costruirlo in tempi da record, grazie a
Fondazione Fiera Milano, non è stato speso un euro di soldi pubblici».
Ma adesso che ne fate?
«Lo teniamo pronto, sperando di non usarlo, per fronteggiare
un'eventuale seconda ondata. E dopo, nulla sarà disperso: con il coordinamento
del Policlinico entrerà nella rete ospedaliera lombarda. Un piano, le anticipo,
che prevede 1.446 posti letto di terapia intensiva e ulteriori 704 letti di
terapia semi intensiva, almeno metà dei quali devono poter essere
tempestivamente convertiti in intensivi. Come peraltro chiede il governo».
Presidente, dica la verità: la sanità lombarda è uscita molto
ammaccata da questa vicenda. O no?
«Di nuovo: non scherziamo. Qui viene gente a curarsi da tutto il
mondo. E c'è un perché: abbiamo strutture pubbliche formidabili che vanno
potenziate, sostenute, arricchite. E abbiamo un settore privato forte in grado
di consentire ai cittadini di scegliere. Mi chiedeva un mea culpa?
Probabilmente, negli ultimi anni abbiamo trascurato i medici di famiglia. Le
anticipo che a settembre lanceremo un importante piano d'azione a loro dedicato.
Sono il primo presidio sanitario delle nostre comunità e lo renderemo più
forte».
Il Tar ha appena bocciato l'acquisto dei test sierologici senza
procedure di evidenza pubblica della Diasorin dal San Matteo di Pavia.
«Guardi che però io non sono parte attiva in questa vicenda».
Molto criticata anche la decisione di ricoverare pazienti Covid
nelle Rsa, su cui è in corso anche un'indagine. Qui nessun mea culpa?
«I pazienti sono stati ospitati in 18 case di riposo su 709. Il
problema non viene da quello, ma dire il contrario è una finta verità facile da
smerciare. Del resto, il 17 aprile l'Iss ha proprio previsto che siano
realizzate unità Covid dentro le Rsa».
E poi c'è la vicenda dei camici forniti da un'azienda di cui è
socia sua moglie.
«A parte il fatto che mia moglie è socia al 10% e non controlla
nulla, vuole sapere la verità? In quei giorni la Regione ha chiesto camici e
mascherine da chiunque li avesse. Il punto è questo».
“Caccia al
milanese” la nuova moda dell’Estate 2020.
Francesco
Caroli su Il Riformista il 10 Giugno 2020. Caro Beppe Sala, altro che scuse.
Avevi proprio ragione e sì, ce ne dovremo ricordare. Ce ne dovremo ricordare
quando ci si dovrà giustificare di voler tornare a respirare l’aria della
propria terra. Ce ne dovremo ricordare quando si subiranno delle occhiate di
disappunto o di sospetto. Ce ne dovremo ricordare quando ci sentiremo estranei
non graditi lì dove siamo cresciuti, dove andiamo in vacanza da anni o
semplicemente dove ci sentiamo a casa. Qualche giorno fa il Presidente della
Regione Sardegna, il filo leghista (non è un ossimoro, ma il frutto di epoca
malata) Christian Solinas, parlava della necessità di un patentino immunitario
per i turisti milanesi e lombardi in arrivo sulla loro isola. Il sindaco di
Milano Beppe Sala commentò cosi «Alcuni presidenti di Regione dicono che per i
milanesi ci vuole una patente d’immunità? Io però, e parlo da cittadino più che
da primo cittadino, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una
vacanza, me ne ricorderò», salvo poi a distanza di poche ore scusarsi per questa
considerazione. Non troviamo ci sia niente di male nel ricordarsi i trattamenti
e le parole che si ricevono, soprattutto quando si è in difficoltà, sulle gambe,
feriti ed a dirle è chi amministra una terra meravigliosa legata in maniera
viscerale con i cittadini lombardi. Questo avveniva ormai alcune settimane fa.
Tutt’oggi navigando nel web e tra i social ma, purtroppo, anche durante
videochiamate o nelle prime nuove riunioni di famiglia e cene con gli amici di
sempre è immancabile il momento di battutine o peggio insinuazioni ed insulti
velati su lombardi, milanesi acquisiti e non. Sono momenti, attimi, emozioni e
parole che feriscono, che creano disagio, che crepano i primi sorrisi di molti
che per mesi sono stati lontani dai propri affetti, perché rispettosi ed attenti
alla salute degli altri oltre che della propria, e che solo ora rientrano nella
propria Regione o si concedono qualche giorno di svago. Eh sì, perché il
lockdown, dicono gli esperti, può avere pericolosi effetti sulla salute e
sull’equilibrio mentale di molti, soprattutto di chi ha vissuto questa tragica
esperienza solo o distante dagli affetti più veri. E’ quindi tragico per queste
persone sentirsi ancora una volta soli in un oceano di pregiudizi, di
chiacchiere sparate ai quattro venti con la presunzione di saper leggere dei
dati. Ed eccoci ad un’altra annosa questione: i dati che dovrebbero raccontare
anche questa Fase 3. Dati che letti superficialmente racconterebbero ai più una
tragedia ancora in atto in Lombardia. Dati che non tengono conto degli ormai
pochissimi accessi in Pronto Soccorso in Lombardia, come nel resto d’Italia.
Dati che non tengono conto che le terapie che ci stanno facendo uscire da questa
crisi sono state sviluppate col lavoro sul campo svolto nella trincea degli
Ospedali lombardi, invasi per primi da un nemico spietato. Dati che a volte
nascondono il volto più umano di questa tragedia, dei suoi morti, dei lavoratori
che non sanno quando e se potranno ripartire, dei cittadini italiani da sempre
fieri della propria cultura dell’accoglienza. Nessuno ma proprio nessuno può
permettersi oggi di dire ad un giovane studente, manager, poliziotto o
infermiere o chicchessia di non poter ambire a sorridere, magari vicino alla sua
famiglia in Puglia o in Campania, di non poter desiderare di respirare la
libertà tanto desiderata di una birra con gli amici, di non poter restare
incantato davanti al proprio mare, spesso capace di ricaricare le batterie come
poche cose al mondo per chi ci è nato. Eppure questa “caccia all’untore” è di
moda oggi. “Come se vedere colpita questa Città, sempre definita un modello,
anziché suscitare vicinanza, desse un piacere che i tedeschi definiscono con una
parola precisa: schadenfreude, gioia per le disgrazie altrui. Non è più
inaccettabile. Bisogna reagire. Dire basta” si è espresso cosi, e non poteva
fare di meglio a nostro avviso, anche Ferruccio De Bortoli – in un intervista
recente all’ Huffingtonpost. “Come spesso accade con i pregiudizi, essi sono
degli strumenti straordinari per costruire alibi. Ti consentono di non guardare
dentro casa tua. Ti levano la fatica di misurare i risultati che hai raggiunto,
confrontandoli con quelli altrui. La Lombardia e Milano rappresentano l’Italia
che ce la fa nel mondo. Il Paese che riesce a competere nella globalizzazione.
Puntare il dito contro di esse, alleggerisce la coscienza di chi non è riuscito
a fare altrettanto. Gli consente di non guardarsi allo specchio, scaricando
tutta la responsabilità altrove”. E’ ovvio che anche la Lombardia ha commesso
degli errori. Senz’altro, abbiamo sbagliato qualcosa anche noi. Ma la Lombardia
è stata investita per prima dalla più grande emergenza sanitaria del
dopoguerra e si è trovata di fronte un nemico che nessuno conosceva e che in
moltissimi avevano sottovalutato. Va sicuramente capito cosa non ha funzionato.
Ma alimentare oggi processi sommari, spesso basati su paure infondate o dettate
da fake news, è inaccettabile. Sono inaccettabili le posizioni sprezzanti contro
Milano sia che nascano da un’invidia sociale nei confronti di chi è da sempre
considerato la locomotiva italiana, sia che nascano da timori sanitari o di
ingestibilità di un’eventuale seconda ondata. Non possiamo accettare che succeda
in Italia qualcosa di simile a quello che accade in Spagna con la Catalogna ed è
successo in Gran Bretagna con Londra, all’origine della Brexit: si detesta chi è
più ricco, chi è riuscito a cavarsela nel mondo, chi ha espresso al meglio le
proprie capacità. Non si può soprattutto permettere che a vincere sia la paura
dell’altro, propria di un’ignoranza gretta e meschina, magari avvallata dalla
convinzione di avere una propria insulsa verità in tasca senza mai essere
riusciti a guardare un problema da più punti di vista, imparando e migliorando
sé stessi. In questi giorni l’Italia e gli italiani hanno il dovere morale di
rialzarsi, di migliorare sé stessi, di progettare un futuro che ci veda
protagonisti di un nuovo Rinascimento. Ed il dito in questi casi va puntato lì
dove si vuole arrivare, verso l’alto e non verso l’altro. L’invidia e il rancore
troppo spesso invece rappresentano ormai il puzzo che sovrasta il profumo del
genio, delle competenze e dello spirito che da sempre hanno contraddistinto
l’Italia tutta, Paese che oggi, invece, si nasconde dietro i propri alibi o in
uno scaricabarile verso colpe reali o meno di altri. Svilenti emozioni che
bloccano la ripartenza. Parlando di sanità, non va dimenticato che ogni anno 165
mila persone vengono a curarsi qui da altre Regioni. Non va dimenticato che la
sanità di sette Regioni è stata commissariata. Abbiamo visto malcostume,
ruberie, cattive gestioni scaricate sulle spalle dei contribuenti. E ora il
problema italiano sarebbe la sanità lombarda? Ma davvero c’è chi pensa che si
può risollevare il Paese coltivando un sentimento anti industriale, sospettando
chi intraprende e produce. La Lombardia vale il 22% del Pil italiano. Ha 54
miliardi di residuo fiscale, pur contando il 16% della popolazione
nazionale. Come si fa a non capire che senza Milano e la Lombardia l’Italia non
si rialzerà mai in piedi, più forte di prima? Uniti e coesi per ripartire. Umani
e consapevoli per riabbracciarsi. Capaci ed illuminati per sognare. Insieme e
non più da “semplici” Italiani, ma da Europei. Questa riflessione è stata
scritta a 4 mani con Francesco Scarcia, Ingegnere spaziale e già Presidente di
Erasmus Student Network del Politecnico di Milano.
Renato
Farina: "La Camorra è il cancro d'Italia ma tutti infangano la Lombardia".
Libero Quotidiano l'11 giugno 2020. E il cancro d'Italia sarebbe
la Lombardia? Da cui difendersi con filtri e passaporti sanitari, intimando
minacce ai lombardi e a chi li rappresenta? Questi sguazzano nella camorra fino
alle ginocchia, e invece di bonificare la loro palude che inquina il mondo, si
permettono di tirar sassi alla Madonnina? Ieri a Napoli è stata per l'appunto
sgominata una rete di camorra, 59 persone sono state arrestate. Le accuse:
associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e
turbata libertà degli incanti. In pratica erano i padroni di un comune, Sant'
Antimo. Ci sono di mezzo anche attentati dinamitardi. Il clan Puca si era
comprato un sacco di voti. Ma la lista prediletta perse ugualmente. Dopo di che,
invece di aspettare cinque anni, si proposero di costringere i vincitori a
dimettersi con i modi tipici di queste brave persone: il fuoco. Ci sono di mezzo
anche politici - i fratelli Cesaro, di cui uno senatore di Forza Italia - ed
esponenti delle forze dell'ordine - due carabinieri sarebbero stati a libro paga
dei clan.
PESTE MORALE.
Ovvio: le misure sono "cautelari", preventive cioè. Siamo noiosi, togliamo
pathos alla faccenda, ma bisogna ridirlo: per stabilire la colpevolezza dei
soggetti non basta un mandato di cattura, e vale la presunzione d'innocenza, non
c'è eccezione a questa regola. Registriamo la notizia, e con risalto, perché ci
sembra parecchio simbolica dello stato della nazione e di dove siano i bubboni e
dove abiti la radice purulenta della nostra peste morale: in Campania, al Sud.
Questa retata sarà certo trascurata. L'abitudine ci ha indotti a ritenere la
criminalità organizzata un tratto folkloristico e persino cinematograficamente
trendy, uno starnuto endemico. Che sarà mai. In fondo è tutto fatturato: vuoi
per la malavita, vuoi per chi narrandola la trasforma in mito. Senza risalto
mediatico era stato pure il blitz natalizio ordinato da Nicola Gratteri contro
la 'ndrangheta, con 330 carcerazioni in Calabria e dovunque. Anche in Lombardia,
ovvio: non sono scemi i mafiosi, investono dove il business gira, e, grazie a
comunità di migranti per la grande maggioranza perbene, ci si può mescolare
inserendosi nel tessuto economico sano, inquinandolo. A proposito. Tutti zitti
sulla volontà dei colleghi di azzerare Gratteri, come risulta dalle
intercettazioni di Palamara, dove il procuratore di Catanzaro era gratificato da
titoli come «folle, persona da fermare»: per molto meno se lo avesse detto un
qualsiasi politico di centro destra all'indirizzo di un qualunque magistrato
antimafia sarebbe stato impalato. Torniamo al Nord. Il giornale unico nazionale
- tivù + stampa + social - insiste. Ancora ieri ha infilato nella sua macina di
carne umana la Lombardia. È questa regione, con i suoi dieci milioni e passa di
abitanti, e i suoi 16.300 morti da Covid la cui catasta non ha meritato la
visita del capo dello Stato, a essere ancora sotto attacco. Non bisogna essere
ingenui. L'attacco mediatico e politico, seguito subito da quello giudiziario
(fascicolo senza ipotesi di reato e senza nomi di indagati, ma fa brodo anche la
zampa della gallina) ad Attilio Fontana, è sì contro un singolo, maoisticamente
però serve a educare tutti i lombardi. Avvocato integerrimo e capace, è da mesi
assaltato, vivisezionato, appeso con Wanted sulle prime pagine perché è il
governatore di questo strano mondo superiore (in latitudine, reddito, sanità,
amministrazione pubblica, produttività, occupazione) che l'idiozia italica
dominante, nel momento della sua debolezza nella catastrofe da virus, vuole
sottomettere al neo-statalismo giallorosso. La Lombardia come modello economico,
morale e politico era (ed è) un'alternativa radicale allo status quo.
CORTINA DI
FERRO. Oplà. Moralmente essa è stata con manovra a tenaglia stritolata come
fosse il cancro del Paese. La donazione da parte di un'azienda di attrezzi
sanitari è diventata il pretesto inverosimile per provare a trasformare l'oro in
sterco. Ed ecco la nostra idea. La Lombardia vi fa così schifo? Fatecela, una
bella cortina di ferro intorno. Isolateci sul serio. Anzi, giacché è un'idea del
governatore della Campania, Vincenzo De Luca, eseguite il suo proposito che
aveva manifestato come una minaccia per non indurre i lombardi untori in
tentazione, mica che cerchino di andare ad Ischia o a Pozzuoli trasferendovi il
virus. De Luca è troppo simpatico per essere criticato. Feltri lo ripete sempre.
D'accordo. Assecondiamolo. Un bel muro per difendere il festoso popolo campano
dall'infezione nordista, dovuta - come ha scritto seriamente Angelo Forgione,
autore immortale di "Napoli, capitale morale" - al vizio del lavoro esagerato.
Questa è stata l'idea dell'ex sindaco di Salerno (Pd). Separare i campani dal
contagio dei lombardi. Non è che gli è mancata la volontà politica, crediamo, di
imitare l'amato Xi Jinping e innalzare la Grande Muraglia di tipo cinese. Ma
dove trovava i muratori napoletani disponibili a tirarlo su, con 'sto virus e
'sto caldo? Per costruirlo avrebbe dovuto attingere ai carpentieri e
pavimentisti delle valli bergamasche. Tranquillo, Enzino, vengono e pure gratis.
Insieme alle maestranze friulane che hanno rimesso a posto il Friuli in tre anni
dopo che era stato raso al suolo, ci mettono un mesetto. Importante però è anche
fissare la reciprocità del provvedimento. I lombardi e il Sud non vengono da
voi, ma per favore potete badare ai vostri terroni? Non è un linguaggio nostro,
ma una citazione. È di Luigi De Magistris, che fu il primo a evocare il
passaggio dal confinamento al muro. L'idea, O' Sindaco partenopeo la buttò sulla
faccia dell'omologo milanese Beppe Sala, in un dialogo animato da forte
solidarietà verso le sofferenze dei lombardi: «Se fosse stata Napoli e non
Milano epicentro della pandemia, alzavate il muro sparando ai terroni!». Oh come
godeva De Magistris a trattare i milanesi come razzisti, che voglia di tirar su
una parete di cemento armato per fargliela ai lombardi e blindarli in un
lazzaretto come contrappasso. Fatelo, dài. Ma per favore, potete bloccare "le
batterie di rapinatori" che salgono da Napoli a Milano, Varese, Segrate per
rapine volanti e poi ritornano giù a tarantellarsi il bottino? Trascrivo da un
ritaglio del settembre scorso: «"Ha appena parcheggiato una persona con un
orologio interessante al polso". Bastava un avvistamento comunicato via
cellulare per mobilitare la banda di rapinatori in trasferta, a Milano dal
Napoletano. I sei componenti puntavano ai Rolex». L'ultimo caso ieri. Hanno
arrestato sette napoletani, specialisti di rapine in trasferta. Si erano fermati
a Bologna stavolta, perché - come dice De Luca - Milano è pericolosa. Bisogna
dire però che i sette portavano correttamente, da tradizione, la mascherina. E
dunque De Luca può risparmiare sul lanciafiamme.
Dagospia il 9 giugno 2020. “POTRESTE SMETTERE DI MANTENERCI E
DUNQUE DI STARNAZZARE?” LETTERA DI OTTAVIO CAPPELLANI A DAGOSPIA. Riceviamo e
pubblichiamo: Caro Dago, da siculo, al contrario di Sallusti, ti ringrazio per
la "confezione" alla lamentazione (molto napoletana, in verità) di Vittorio
Feltri sui poveri lumbard. Da siculo, vorrei notificare a Sallusti che l'idea
migliana del federalismo, e anche del federalismo fiscale, era bello e buono e
santo e probabilmente avrebbe salvato la Sicilia e tutto il Meridione. L'idea è
stata abbandonata proprio da Salvini, al quale, evidentemente, essere re di
polentonia non gli bastava. Lo capisco, è un territorio rozzo e barbaro, senza
alcuna raffinatezza, dove esibite il portafoglio in pubblico. E infatti la Lega
si è precipitata sull'assessorato alla Cultura, ai Beni Culturali e all'Identità
Siciliana. Cosa che manco Lercio. Potreste smettere di mantenerci e dunque di
starnazzare? grazie Ottavio Cappellani
Dagospia il 9 giugno 2020. ''TE LO SPIEGO IO PERCHÉ
STARNAZZIAMO''. Riceviamo e pubblichiamo: Caro Dago, Da consumatore compulsivo
di Dagospia (lettore è riduttivo), mi è saltata all’occhio la confezione con cui
avete presentato l’editoriale odierno di Vittorio Feltri sulla Lombardia
sbertucciata. “Quanto starnazzano i lombardi”, vi chiedete, anzi affermate (in
realtà molto poco, se penso alla compostezza calvinista delle famiglie
bergamasche, tutte con almeno un lutto causa pandemia in casa). “È bastato
metterli due mesi nel ruolo di untori/discriminati per assistere a una reazione
furibonda, De Bortoli in testa”, aggiungete, e se è “furibonda” la sobria e
analitica difesa debortoliana di questa landa non esattamente irrilevante ai
fini del Pil italico, mi chiedo con che aggettivazione descrivereste la
fissazione monomaniacale di chi, Fatto Quotidiano in testa, da mesi sbatte la
mia regione in prima pagina come una cricca di malavitosi e assassini. Ma il
punto non è nemmeno questo. La notarella che vorrei sottoporvi, dalla periferia
polentona dell’impero, riguarda quello che c’è sotto il nostro “starnazzamento”.
Nientemeno che 54 miliardi di euro. La cifra, raccolta con le tasse dei suoi
abitanti, che la Lombardia ogni anno vede volatilizzarsi, risucchiata
dall’idrovora dello Stato centrale. I tecnici lo chiamano “residuo fiscale”, a
noi bauscia poveri di spirito pare una rapina che non ha pari nel mondo civile
(la Baviera ha impostato un braccio di ferro con Berlino per 3 miliardi di
residuo, la Catalogna è in stato di rivolta permanente contro Madrid per circa
10 miliardi). Allora, lo starnazzare, perdipiù in meneghino gutturale, può
senz’altro essere volgare. Capirete però che a noi pare assai peggio mantenere
da decenni il Paese senza fiatare, e alla prima difficoltà essere presi a calci
in bocca dai mantenuti.
Cordialmente, Giovanni Sallusti
DAGO-RISPOSTA. Caro Giovanni Sallusti, scomodare il “residuo
fiscale” della Lombardia per giustificare la stizzita reazione di alcuni
lombardi è un argomento un po’ grossier. Dire di “mantenere da decenni il Paese
senza fiatare” è un’affermazione degna del “Dogui” Nicheli e del suo “lavoro,
guadagno, pago, pretendo”. Per la serie: noi cacciamo i dane’ e voi non dovete
rompere le palle. E neanche criticare. La Lombardia contribuisce in proporzione
alla sua ricchezza, più di altre regioni. E’ vero. Ma se la redistribuzione
avviene con la progressività delle imposte sulle persone fisiche, con cui si
finanziano i servizi, è chiaro che i trasferimenti non vanno a zonzo da un
territorio a un altro, ma dai più “ricchi” ai più “poveri”. Non è un dettaglio:
è un principio che s’aggancia ad almeno tre o quattro articoli della
Costituzione. E se è vero che i lumbard trascinano l’Italia è pur vero che
ricevono dal resto del Paese - e dallo Stato centrale idrovora - più di quanto
siano disposti a riconoscere: dall’Expo (fu il governo Prodi a proporre Milano)
al sostegno per i giochi Milano-Cortina 2026, ad esempio. Fino alla forza
lavoro, spesso molto qualificata, in arrivo dal resto d’Italia. Se una regione
diventa fulcro e locomotiva di un Paese non è solo per la laboriosità dei
“bauscia poveri di spirito” (a proposito: quanti non lombardi lavorano e pagano
le tasse da quelle parti?): è il sistema-Paese che contribuisce a rendere una
città o una regione un magnete che poi, come denunciava il ministro Provenzano,
finisce per risucchiare tutto (investimenti, eventi, lavoratori). Sentirsi
vittima di un “pestaggio senza precedenti” (Feltri dixit) e assistere alla
diffusione di uno “spirito anti lombardo” (De Bortoli dixit) sembra la reazione
un po’ fregnona dei primi della classe bacchettati dalla maestra. Di quelli che
per diritto divino e quattrino non possono essere mai biasimati. Ma poi, di
preciso, di cosa stiamo parlando? Quando scrivi di “essere presi a calci in
bocca dai mantenuti” a cosa ti riferisci? Alle critiche (opinabili ma legittime)
al governatore Fontana e al suo assessore Gallera da parte dei giornalisti? Alle
inchieste (legittime) sulla sanità lombarda? A qualche battuta da social sugli
untorelli? Questo presunto sentimento anti lombardo da cosa è avvalorato? Dal
divieto di sbarco (poi revocato) ai turisti a Ischia? Siamo seri. De Bortoli ha
parlato di “pregiudizi radicati” contro i lombardi. E i meridionali allora cosa
dovrebbero dire? Ancora oggi qualche “bauscia povero di spirito” non affitta
casa a chi viene dal Sud. “L’unità morale” degli italiani vale solo quando
s’avanza qualche critica tra l’Adda e il Ticino? Lo stesso De Bortoli è
costretto ad ammettere che i lombardi hanno esaltato le loro virtù “fino a
sfiorare l’arroganza” con “un atteggiamento semi-colonialista”. E chi semina
vento, raccoglie pernacchie. Ps: la “rapina” dei 54 miliardi di euro di residuo
fiscale che lo Stato centrale ciuccia alla Lombardia è molto pubblicizzata sopra
la linea del Po. Lo è meno l’altra rapina: quella che vede la Lombardia in testa
alla classifica delle regioni dove l’evasione fiscale è più alta. Ma è meglio
non parlarne, dovesse adombrarsi qualcuno sotto la Madunina.
Dagospia il 10
giugno 2020. Riceviamo e pubblichiamo da Giovanni Sallusti: Caro Dago, Vi
importuno per la seconda volta in due giorni dall’Estremo Nord (ho casa a Como,
nemmeno a Milano, quindi immagino di aggiungere all’assodato “starnazzamento”
lombardo una sgradevole sfumatura di uggiosità lacustre) per felicitarmi della
notizia. Sono stato scavalcato, quanto a spirito “federalista”, dal siculo
Cappellani, con tanto di citazione del comasco Miglio. Il che del resto sta
nella storia della splendida isola, anch’essa vittima del centralismo italico,
seppur vittima di altro genere. Lì infatti sono schiavi sotto
l’assistenzialismo, qui siamo schiavi sotto la rapina fiscale. Per cui faccio
mie le parole ipernordiste di Cappellani, che davvero non avrei potuto scrivere
meglio: se ne esce solo se noi lombardi “smetteremo di mantenervi” e dunque di
“starnazzare”. I 54 miliardi del residuo fiscale, da domani, restano sopra il
Po. E no, caro Dago, qui vengo alla vostra risposta, non è un argomento
“grossier”. Sono 5500 euro a lombardo, e vi assicuro che nel post-Covid fanno la
differenza tra la vita e la morte professionale per molti artigiani brianzoli,
per molti negozianti bresciani, per molti casciavit milanesi, altro che ironia
sul “Dogui” Nicheli (che poi è pur sempre qualcuno che ha il dannato vizio di
creare posti di lavoro). Che non si stia palesando poi nel dibattito uno
“spirito anti-lombardo”, di fronte a programmi tivù che da mesi attaccano la
Lombardia (uno su tutti, il “Piazzapulita” del mangiatore compulsivo di
involtini cinesi Formigli), testate nazionali che da mesi attaccano la Lombardia
(una su tutte, il Fatto del capoufficio stampa di Palazzo Chigi Travaglio),
scrittori o presunti tali come Massimo Mantellini, che dimostrano la propria
appartenenza alla task force governativa contro l’odio online blaterando la
proposta d’odio offline di “chiudere i lombardi in Lombardia”, è tesi che dei
brillanti frequentatori dell’attualità come voi non possono certo sostenere.
Quanto all’evasione fiscale, cito la Nota di aggiornamento al Def 2019 del
governo giallorosso, non esattamente una velina filopadana, quando si va ad
analizzare la “distribuzione territoriale dell’incidenza dell’Economia Non
Osservata”. Ebbene, essa in Calabria è al 20,9% del valore aggiunto complessivo,
in Campania al 20%, in Sicilia e Puglia al 19%. In Lombardia è al 10,8%. Ecco,
lo dico col maggior tatto possibile, ho la leggerissima sensazione che
l’evasione abbia più a che fare con i traffici criminali di Don Carmelo,
piuttosto che con i Rolex del Dogui. Cordialmente, Giovanni Sallusti.
Dagospia il 10
giugno 2020. Riceviamo e pubblichiamo: La replica della replica della replica
non meriterebbe una replica. Epperò cvd (come volevasi dimostrare) Sallusti si
rotola beato nello stagno di chi, oramai è evidente, gode nel mantenerci per
potere starnazzare: siamo ai limiti dello stalking secondo la legislazione di
Paperopoli. E ci volete mollare o no? Non una parola ha speso il Sallusti per
richiamare all'ordine padano e federalista il centralississimissimo Salvini. In
ultimo le mie non sono parole ipernordiste perché (quack) il federalismo (quack)
non l'ha inventato la Lombardia (quack quack sberequeck). Proprio non ce la
fate, appena aprite bocca partono i cani da riporto. Saluti e baci cordiali, ma
davvero, non manteneteci più, come se avessimo accettato. Ottavio Cappellani
Lettera di Pino Aprile a Dagospia l'11 giugno 2020. Caro Dago, è
un fenomeno culturale interessante l'incapacità, persino di alcuni dei migliori
esponenti della classe dirigente lombarda (quindi, per non offendere i Ferruccio
de Bortoli, non c'entra la robaccia da rivista del Ku Klux Klan dei Feltri
Vittorio e consimili; o la schifezza televisiva da bar sport leghista dei Del
Debbio e consimili) di capire perché l'opinione pubblica nazionale stia
rivedendo, alla luce dei disastri e degli scandali della gestione dell'epidemia
di covid-19, lo stereotipo del Nord efficiente, “locomotiva” e onesto (pare ci
credano davvero, nonostante retate da decine e centinaia di arresti per l'Expo,
l'interminabile sequenza di appalti truccati e carcerati eccellenti della Sanità
“migliore d'Italia” e delle “grandi opere”). Per essere più precisi, il Nord si
riduce alla Lombardia, per il declino del Piemonte, finito in fondo alla
classifica (ingrata Italia, lamenta Aldo Cazzullo, mentre al Sud, dopo 159 anni,
non hanno ancora finito di contare i morti e i deportati, per i quali essere
grati) e l'imbarazzante paragone, per i lombardi, con il Veneto che, pur
investito dalla stessa bufera epidemica, ne è uscito molto prima e molto meglio.
Ne scrivo, tra l’altro, in un mio libro uscito appena ieri l’altro: Il male del
Nord, il mio Terroni dieci anni dopo, e ai tempi della pandemia. “Locomotiva” è
la citazione della quota lombarda del prodotto nazionale lordo. Ma si omette di
citare quanto di quello si deve a investimenti pubblici concentrati lì a
produrre superfluo, sottraendo il necessario a due terzi del Paese (Sud e aree
interne), condannate al rango di terre non-europee, per servizi e
infrastrutture, e incolpate delle della privazione di diritti di cui sono
vittime); “locomotiva” che si è venduta tutto, dai gioielli (grandi società,
grattacieli, fabbriche, maison dell'italian style) ai giocattoli (le squadre di
calcio), e mantiene il suo livello di vita grazie ai trasferimenti di risorse
pubbliche destinate al Sud e dirottate al Nord: almeno 61-62 miliardi all'anno,
stando a quanto documenta l'ente statale dei Conti Pubblici Territoriali
(significa rubare al Sud circa dieci ponti sullo Stretto di Messina all'anno); e
che in 15 anni, 2000-2015, è stata capace di “trainare” il Paese, unico nel
continente, a una crescita di zero-zero virgola, mentre le medie del resto
d'Europa vanno dal 18 al 38 per cento (zona euro-zona non euro). Interessante
pure il modo in cui la classe dirigente lombarda mira a banalizzare
(trasformandola ancora una volta in una colpa terrona) la sua caduta dal podio
di “regione che fa grande l'Italia nel mondo” (ovvero di regione che l'Italia fa
grande nel mondo, dotandola di risorse e servizi che nega alle altre): il
disconoscimento della primazia lombarda (“Prima il Nord” o “prima i bianchi”, la
pretesa è la stessa: razzista) sarebbe un malanimo dei meridionali che
coglierebbero la situazione di debolezza della regione devastata dal virus, per
manifestare la loro “invidia per i primi della classe“ (aridaje!) e mancanza di
solidarietà. È un modo subdolo per non riconoscere il proprio fallimento, tale
già da un bel po', ma nascosto dietro l'illusione ottica dei soldi che girano,
perché requisiti al resto del Paese. È stato il Los Angeles Time a parlare di
“tempesta perfetta: il disastro del virus in Lombardia è una lezione per il
mondo” e quegli errori commessi “saranno studiati per anni”; è stato lo spagnolo
El Pais a scrivere: “il virus inverte i ruoli storici del Nord e del Sud
d'Italia”, a proposito della più efficiente risposta meridionale al morbo; sono
state le tv anglosassoni a documentare l'eccellenza degli ospedali di Napoli; è
stato il quotidiano francese Le Monde a dedicare un inserto di quattro pagine,
con il titolo: “Lombardia: autopsia di un disastro”. Cosa c'entrano i terroni?
Sono stati i tedeschi, gli austriaci, i greci e quasi tutti gli altri Paesi
europei a escludere l'Italia dai loro flussi turistici, per via della Lombardia
e del Nord-Ovest ancora troppo infestati dal virus; è stato il presidente della
Liguria, Giovanni Toti, a protestare per l'esodo incontrollato di lombardi a
rischio morbo nelle seconde case liguri; sono stati imprenditori turistici della
Versilia a dire che i lombardi non li vogliono, per non rischiare di
compromettere la stagione già danneggiata; è stato il presidente della Regione
Toscana, Enrico Rossi, a dire che se al posto della Lombardia ci fosse stata una
regione del Sud, l'avrebbero tenuta blindata e commissariata. E quanto a
solidarietà, migliaia di infermieri e medici meridionali si sono offerti
volontari per aiutare la Lombardia e i malati gravi lombardi sono stati ospitati
e guariti negli ospedali del Sud, mentre il Veneto non ha offerto un operatore
sanitario, né un posto letto di terapia intensiva, pur avendone il 60 per cento
vuoti. Che c'entrano i terroni? C'entrano, perché “anche” i meridionali hanno
criticato la disastrosa gestione lombarda dell'epidemia. E i giornali del Nord,
i politici del Nord, la classe dirigente e tanti intellettuali del Nord (quoque
tu, Ferrucce!) tacciono su tutto il resto e riducono la figuraccia alla presunta
“invidia” dei meridionali per chi è più bravo di loro (sì? Vogliamo parlare
dell'ospedale-covid costruito a Napoli con 7 milioni in 30 ore “e 45 secondi”,
72 posti letto, e della sceneggiata di quello della Fiera di Milano, costato da
21 milioni a forse il doppio, inaugurato finito dopo due settimane, ma finito
dopo altre due, per tre posti letto, poi faticosamente portati a una dozzina,
forse 20?). Ancora una volta, la Lombardia (e il Nord in generale) trasforma una
propria debolezza in colpa dei terroni: se fallisce come “locomotiva” è per la
palla al piede, il Sud, che dice di “mantenere” (“residuo fiscale”: quoque tu,
Ferrucce!), mentre gli sottrae decine di miliardi all'anno; se si rivela un
disastro nella gestione l'epidemia, colpa dei terroni è mostrarsi più efficienti
(lo scrivono in tutto il mondo, meno che i giornali del Nord, in Italia), per
“invidia dei primi della classe” (un modo per rimettersi in testa, quando ci si
scopre ultimi, dopo il Veneto, il Sud e e tutti gli altri). Ora, a parte che,
fosse pur vero, il malanimo terrone, sarebbe ampiamente giustificato quale
ritorsione per decenni di insulti, discriminazioni, razzismo padano contro i
meridionali. E che la classe dirigente del Nord, specie lombarda, ha aizzato,
tollerato, minimizzato e di fatto condiviso, tanto che uno dei giornali più
rappresentativi dello spirito padano, fallita la razzistissima Padania, è il
portavoce del Feltri-pensiero (parola grossa), quanto di più anti-meridionale ci
sia (“sono inferiori”). La fine di un popolo si misura con un
sentimento-termometro: la vergogna, il guardiano delle norme della convivenza.
Sparita quella, c'è solo una indistinta massa umana che non riconosce ad altri
la stessa dignità, gli stessi diritti, lo stesso rispetto. I Feltri, i capi
partito con condanna per razzismo che fa curriculum sono la prova di questa
dissoluzione delle basi di convivenza. Interventi pur più sfumati nella sostanza
e civili nella forma, quale quello di de Bortoli, a me paiono persino più
rivelatori, perché mostrano che i veleni di quel sentire sono entrati nel
dialogo e nei temi dell'area moderata; quindi sono “culturalmente” dominanti,
rappresentativi di una comune, diffusa convinzione. Il che spiega quel misto di
sorpresa e sconcerto, persino contenuta irritazione (o spudorata, vedi Feltri:
«Senza di noi farete una brutta fine, meritata») di chi vede violato un dogma,
la certezza fondante della propria identità: siamo noi, i migliori per
autodefinizione, a decidere la classifica e a porre tutti gli altri in
quell'ordine “naturale delle cose” che va da “Prima il Nord” a “terroni di
merda” (i più costumati, invece: «Non sono razzista, figurati. La mia cameriera
è di Molfetta, ho un operaio di Trapani, il mio compagno di bocce è napoletano.
Brava gente, ma non sono come noi»). Stupisce il loro risentito stupore dinanzi
a critiche più che motivate (che non accettano, perché non abituati a esser
giudicati, ma a giudicare) e che vengono declassate a invidia per il primo della
classe; invidia per la Sua Eccellenza la Sanità lombarda, patrona dei privati
allevati a dismisura con soldi pubblici (e alla prova del virus letteralmente
franata, al contrario di quelle veneta, emiliana, meridionale). Quel risentito
stupore denuncia la natura del rapporto squilibrato: se noi vi insultiamo, è
espressione di un sentimento popolare e diffuso di insofferenza per le vostre
colpe; se voi osate discutere la nostra primazia, persino quando tutto il mondo
e il resto d'Italia la contestano, la cosa ci risulta intollerabile, una sorta
di aggressione. Il Nord ha paura, perché il Sud non accetta più la condizione di
sudditanza: si mette alla pari! Si incrina la base del sistema di potere
coloniale su cui si regge l'economia del Nord, dall'Unità (trasferimento
selvaggio di risorse da Sud a Nord) a oggi (trasferimento selvaggio di risorse
da Sud a Nord): una economia che genera una politica, su cui fiorisce una
cultura. Se prima questo avveniva in forme sfumate, non immediatamente
riconoscibili, oggi, con la consapevolezza sempre più diffusa, a Sud, di come
stanno davvero le cose e con la fine, nell'euro, del controllo della propria
moneta, senza l'elasticità della svalutazione, il gioco si è fatto scoperto: il
razzismo si mostra senza sfumature e il sistema si è arroccato. Yanis
Varoufakis, in “Adulti nella stanza”, narra la domanda che gli fece l'allora
segretario di Stato degli Stati Uniti, Larry Summers, quando il docente greco fu
eletto al Parlamento, poi ministro alle Finanze nel momento più buio del suo
Paese: «Ci sono due specie di politici, quelli che “giocano dentro” e quelli che
“giocano fuori”. Tu come giochi?». Giocare dentro vuol dire essere garantiti ma
complici; giocare fuori sono liberi, ma inascoltati. Quando il blocco di potere
padano si sentiva forte, poteva permettersi il lusso di avere Pasolini a fargli
il controcanto sulla prima pagina del Corriere della sera; oggi non si legge un
economista, uno storico fuori dal coro “noi locomotiva, voi terroni mantenuti”
(i Viesti, i Sales, i Daniele, eccetera, tutti esclusi) e se il ministro Peppe
Provenzano dice una coraggiosa banalità («Milano prende e non restituisce») si
alzano le barricate giornalistiche e non si spiega la verità di quella frase; i
documenti truccati per rubare risorse al Sud si possono leggere in alcuni libri,
rimbalzati su qualche giornale al Sud, vedere a Report, ma non sporcano le
“macchine del consenso” del potere padano. Le colpe degli intellettuali del
consenso (alcuni per ignoranza, in buona fede; altri, sapendo, per convenienza e
viltà), sono di portata storica in questa miserabile stagione di allevamento di
una classe dirigente razzista. Tale lettura suona troppo terrona, di parte,
esagerata, ai sostenitori di quel sistema? Basterebbero le analisi e i documenti
dello Svimez, dell'Eurispes), volendo capire. È la chiusura al dubbio e alla
possibilità di riconoscere sbagliato quel che si crede di sapere la ragione
prima della mancata conoscenza reciproca degli italiani, del pregiudizio, del
razzismo, inutilmente denunciato da oltre un secolo, da Ciccotti e Gramsci a
oggi. Una chiusura troppo spesso sospetta: non conviene, si campa male “fuori”.
Ma, alla fine, anche il virus, come è stato detto, può essere il pettine che
mostra i nodi. Il risentito stupore alla pretesa terrona della parità, anche di
giudizio dei fatti, disorienta il “prima il Nord”, il lombardo presunto
“trainante” incapace di accettare equiparazione ai presunti “trainati”. Se dallo
stupore e dalla stizza per la lesa maestà derivasse anche un interrogarsi su se
stessi (parlo per quelli in buona fede, e de Bortoli lo considero tale), forse
si farebbe in tempo a diventare un popolo. Altrimenti, la frattura già
conclamata diverrà insanabile. O equità, o secessione. “Prima io” è razzismo; e
quel tempo è finito: se non alla pari, meglio da soli. La lente impietosa del
coronavirus ha fotografato con brutale evidenza l’Italia com’è: non è un Paese,
non c’è. Se ne può stupire solo chi in tutti questi anni, per interessi
privatissimi ben più che per miopia, non ha voluto vedere. Ma le gigantesche
falle che la pandemia e la crisi economica hanno reso palesi, frutto velenoso di
mali remoti e recenti, ci hanno messo di fronte anche a un’antica, virulenta
verità: ciò che si fa agli altri, si fa a se stessi. Ora, mentre vanno in scena
grandi generosità e incalliti egoismi, siamo al punto di non ritorno. Se
l’Italia non sarà in grado di ripartire da Sud, se si tenteranno di imporre
nuovamente i fallimentari modelli del passato, allora si spezzerà
definitivamente. Se non sarà finalmente equa e unita, allora non sarà proprio
più niente. PINO APRILE giornalista e scrittore, è autore di saggi di
straordinario successo, tradotti in diversi paesi. Terroni, uscito nel 2010 e
diventato un caso editoriale da mezzo milione di copie, e i successivi lavori,
tra cui Giù al Sud e Carnefici, hanno fatto di lui il giornalista
“meridionalista” più seguito d’Italia, al Sud come al Nord. A New York è stato
proclamato “Uomo dell’Anno” dall’Italian Language Inter-Cultural Alliance.
CORRUZIONE, LOMBARDIA È DA RECORD.
sinistraxmilano.org il 7 ottobre 2019. L’articolo di ieri su Avvenire rilancia
l’allarme di Transparency International Italia sulla corruzione italiana. Record
Lombardo, Milano e Brescia su tutti. Da leggere. Luca Bonzanni. Grandi mazzette
e micro-corruzione. È la quotidianità del malaffare che s’intreccia con la
pubblica amministrazione attraverso matrici diverse, chiaramente criminali o
mimetizzate negli interstizi di imprenditoria e politica. La Lombardia, centro
economico e di potere dell’intero Paese, resta giocoforza terra di collusione e
connivenze: l’ultimo campanello d’allarme arriva da Transparency International,
ong impegnata nel campo della legalità, che ha mappato censendo le notizie
apparse sui media il fenomeno in Italia, individuando nella Lombardia la regione
più interessata da condanne, inchieste e arresti per corruzione o malversazione
nella sfera pubblica. Sono stati 66 gli episodi individuati in regione nei primi
mesi del 2019: nella classifica del Belpaese, il podio è completato dalla
Sicilia (59 casi) e dalla Campania (52), col Lazio al quarto posto (46). Un
dato, quello del primo semestre di quest’anno, tendenzialmente in linea con i
dati registrati sull’intero 2018: negli scorsi dodici mesi, Transparency aveva
censito in Lombardia un totale di 125 casi di corruzione e reati affini; a
spiccare, le 36 “voci” di Brescia e le 33 di Milano. Scorrendo nel dettaglio i
fatti elencati da gennaio a giugno 2019, 23 sono localizzati a Milano e
provincia. Maggio è stato il mese mediaticamente più caldo: prima l’inchiesta
“Mensa dei poveri” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del
capoluogo lombardo, con un centinaio di indagati e una quarantina di misure
cautelai (tra cui l’arresto del consigliere comunale di Milano Pietro Tatarella
e i domiciliari per il consigliere regionale Fabio Altitonante, entrambi di
Forza Italia) a scoperchiare un presunto sistema di appalti pilotati,
finanziamenti illeciti ai partiti, persino i tentacoli della ‘ndrangheta sullo
sfondo; poi la vicenda di Legnano, con accuse di corruzione elettorale e nomine
pilotate che portarono ai domiciliari il sindaco Gianbattista Fratus (Lega) e
l’assessora alle opere pubbliche Chiara Lazzarini e in carcere il vicesindaco
Maurizio Cozzi. Sono invece 24, tra condanne e inchieste in corso, i casi
censiti in sei mesi nel Bresciano, altro centro nevralgico della corruzione,
soprattutto quella “micro”. «Non ci stupiscono i tre settori più critici si
legge nel report semestrale di Transparency International, con considerazioni
sulla situazione nazionale che trovano riflessi anche nello scenario lombardo -:
pubblica amministrazione, sanità e politica. Quello che colpisce di più è il
fatto che proprio questi tre settori, così cruciali nella vita di tutti noi, da
soli rappresentino quasi i due terzi dei casi riportati dai media. E addirittura
un caso su tre è relativo ad appalti pubblici. Questo dimostra nuovamente quanto
alto sia il rischio di corruzione in un settore tanto delicato come quello dei
lavori pubblici. La tipologia di reato contestato vede la corruzione come la più
diffusa con il 40% dei casi, ma non possiamo dimenticare tutti i reati affini
come peculato, abuso d’ufficio e turbativa d’asta».
Milano vs
Resto d’Italia: è il Sud che ruba al Nord o avviene il contrario? Francesco
Bruno il 13 Novembre 2019 sueconopoly.ilsole24ore.com. Le parole su Milano
del ministro Giuseppe Provenzano sono state un po’ strumentalizzate, come sempre
accade quando si solleticano i vari campanilismi che interessano il nostro
Paese. Lo stesso ministro ha poi corretto il tiro in un post su Facebook,
scritto a mente fredda. Ma se la polemica è abbastanza stantia, la questione
sottesa non è irrilevante. Essa potrebbe interessare diversi tipi di dualismi,
come quello tra metropoli e provincia ad esempio. Ma nel caso italiano i divari
più significativi restano quelli regionali o per macroaree. Milano è sicuramente
in forte ascesa come città, ma è anche il centro di un sistema industriale
avanzato e inserito nelle catene globali del valore. Piuttosto che soffermarsi
sul ruolo -limitato- che una singola città può avere a livello nazionale, se non
quello di fungere da esempio come correttamente scritto da Massimo Famularo,
l’occasione appare propizia per riflettere sui divari infranazionali, tra le
principali fonti di polemiche interne nel dibattito mediatico e politico. Perché
in fin dei conti, da 158 anni, si finisce nel solito vicolo cieco: è il Sud che
ruba al Nord o avviene il contrario? La domanda riguarda due principali temi.
usati dalle opposte fazioni. Da un lato il Nord che reclama lo “scippo” di
risorse economiche, dall’altro il Mezzogiorno che lamenta il drenaggio di
capitale umano. Entrambe le tesi sono suffragate dai dati, ma presentano alcune
distorsioni da un punto di vista del rapporto causa-effetto. Partiamo dal primo
punto. Per provare ad elaborare alcune riflessioni, possiamo utilizzare la
recente pubblicazione della Banca d’Italia sulle economie regionali. Iniziamo
con le istanze del Settentrione. Veniamo da anni in cui alcune regioni del Nord,
Veneto in particolare, seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna, chiedono nuove
forme di autonomia differenziata. A prescindere dal merito della riforma
(in aggiornamento e già trattato spesso su Econopoly), la movimentazione
politica muoveva dalla retorica sul cosiddetto residuo fiscale (stima, a livello
locale, di un ipotetico saldo fra le spese e le entrate del bilancio pubblico).
Nel citato rapporto si legge a tal proposito che «(…) nel 2017 (ultimo anno per
il quale è possibile effettuare la ricostruzione) il bilancio pubblico avrebbe
erogato risorse nette pari all’incirca al 3,6 per cento del PIL nazionale alle
regioni meridionali, contro un prelievo netto pari al 5,6 per cento in quelle
del Centro Nord (corrispondenti a circa il 16 e il 7 per cento del PIL delle
rispettive macroaree e a 2.900 e 2.400 euro in termini pro capite)». Se andiamo
a vedere le tabelle, in percentuale al PIL nazionale, la Lombardia è nettamente
la regione con il residuo fiscale più alto.
Quindi, è vero
che la Lombardia ad esempio -e in particolare il suo capoluogo- dà tanto al
resto del Paese, ma occorre chiarire due un aspetto fondamentale, che
rappresenta un equivoco nella battaglia politica degli autonomisti. La forma
di redistribuzione principale del nostro sistema è la progressività delle
imposte sulle persone fisiche, con la quale si finanziano poi i vari servizi
dello stato sociale. I trasferimenti, pertanto, non viaggiano da un territorio a
un altro, ma dai “ricchi” ai “poveri” per capirci. Il fatto che sia più abituale
che il ricco abiti a Nord piuttosto che a Sud, rappresenta un dato che non muta
il principio costituzionale di base, che garantisce alcuni diritti a prescindere
dalla residenza. Se così non fosse, finiremmo nel paradosso di una Milano che
potrebbe rivendicare il residuo fiscale positivo nei confronti del resto della
Lombardia. Si tratta di un principio insuperabile, a meno di secessione.
Chiarito quanto sopra, passiamo alle tipiche istanze meridionali, che -in tema
di risorse- lamentano una spesa pubblica pro capite, corrente e in conto
capitale, inferiore a quella del Nord. Secondo il rapporto di cui sopra, «In
termini pro capite tale spesa è valutabile in circa 10.600 euro per un cittadino
residente nelle regioni meridionali, a fronte di 12.000 euro per un residente al
Centro Nord». Ma come precisa lo studio la differenza è dovuta principalmente
alla componente pensionistica, sebbene restino carenze sul lato dei livelli
essenziali delle prestazioni. Anche per le spese in conto capitale il Sud appare
sfavorito a livello pro capite, ma in misura minore.
Da qui si
potrebbe evincere la figura di un Nord ladrone? La Storia d’Italia suggerisce di
no. Semplicemente perché non è tutto riconducibile ad una questione di quantum,
ma anche di qualità della spesa pubblica. Inebriati dalle varie teorie sul
famigerato moltiplicatore, sono in molti (non solo al Sud naturalmente) ad
immaginare virtù miracolose della spesa stessa, salvo poi scontrarsi con una
realtà differente. I risultati sono sotto i nostri occhi, ma non vogliamo levare
le fette di prosciutto. La Banca d’Italia ci dà un suggerimento sul perché
innanzitutto il miracolo non avvenga. Inoltre, il Mezzogiorno ha un rapporto
ancor più controverso con la spesa pubblica, perché la stessa è molto alta se
rapportata al PIL dell’area. Questo ha inevitabilmente prodotto forme
di assuefazione, spesso sfociate in richieste di assistenzialismo. Ma nonostante
questo ci si ostina a ritenere l’intervento dall’alto come possibile panacea,
dimenticandosi che la spesa viene poi sistematicamente dirottata al sostegno dei
redditi piuttosto che ad investimenti produttivi. Con una torta sempre più
piccola da dividere. Ciò non significa che il sistema di finanziamento degli
enti locali non debba essere corretto nelle sue distorsioni ed inefficienze,
ma appare del tutto utopistico sovrastimare gli effetti sullo sviluppo derivanti
da un’eventuale aumento delle risorse pubbliche a disposizione. In definitiva
sul punto delle risorse economiche, entrambi gli schieramenti appaiono vittime
di alcune informazioni fuorvianti e di illusioni di lunga data. A livello di
effetti però, le illusioni sono più pericolose per il Mezzogiorno, che sembra
non voler imparare le lezioni che la sua storia gli impartisce. In merito alla
seconda questione, relativa all’emigrazione ed al drenaggio di capitale umano,
mi scuso per l’autocitazione, ma posso aggiungere ben poco rispetto a
quanto scritto qualche mese fa su questi pixel. Oltre a riflettere amaramente
su come questo Paese faccia così fatica a comprendere le ragioni dei ragazzi che
emigrano dal Mezzogiorno al Centro-Nord o dall’Italia all’estero, mi unisco alla
provocazione di Massimo Famularo rivolta al Ministro. Si chiede perché Milano
non formi classe dirigente come un tempo, ma il Ministro farebbe bene a
guardarsi intorno, anche all’interno dell’Esecutivo di cui fa parte. Vede
meritocrazia intorno a sé? Nella politica? O nei principali incarichi a nomina
pubblica? Forse è per questo che le menti migliori scelgono un’altra via, che ad
alcuni potrà apparire egoistica nei confronti del Paese, ma che spesso altro non
è che una normale e sana ambizione di raggiungere traguardi che siano in linea
con gli sforzi e le fatiche di una vita. E su questo non deve riflettere solo
Milano, che sembra peraltro aver capito il trend imposto dai nostri tempi, ma il
resto d’Italia.
Lo stato
spende più al Nord o al Sud?
Da ilpost.it venerdì 20 dicembre 2019. Dipende molto da come si conta la spesa
pubblica, ma se si tiene conto di tutto-tutto gli abitanti del Sud ricevono meno
degli altri. Il divario crescente tra Nord e Sud del paese è tornato ancora una
volta di attualità, negli ultimi anni, grazie al dibattito sulla maggiore
autonomia chiesta da alcune regioni del Nord Italia. Uno dei motivi che spesso
motivano questa richiesta è l’idea che le regioni più ricche vedano una parte
significativa delle risorse pubbliche – che contribuiscono in gran parte a
creare – impiegate per finanziare una spesa pubblica inefficiente, improduttiva
e clientelare nel resto del paese. Di recente però lo SVIMEZ, il centro di
ricerca pubblico sullo sviluppo del Sud Italia, ha ricordato che quando si
include nel conteggio ogni voce, il Nord riceve una percentuale della spesa
pubblica molto superiore al Sud: circa 4 mila euro a persona in più. È un dato
che non è molto conosciuto dai non addetti ai lavori, anche perché di recente il
dibattito sul divario Nord-Sud si è concentrato sulla questione del residuo
fiscale, ossia quante tasse raccolte in una regione rimangono effettivamente sul
territorio e quante invece vengono redistribuite nel resto del paese. Com’è
facile immaginare, le regioni del Nord sono quelle con il residuo fiscale più
alto: principalmente per il fatto che hanno un PIL maggiore e abitanti più
ricchi, quindi pagano più tasse delle regioni meno sviluppate e con abitanti
meno ricchi (e, spesso, più disoccupati e indigenti). Ridurre o addirittura
eliminare il divario fiscale è l’obiettivo rivendicato da molti dei sostenitori
dell’autonomia. Accanto alla questione del residuo fiscale, cioè di quanto i
territori pagano in tasse in proporzione a quanto ricevono, è importante
osservare anche quanto ricevono in assoluto. In altre parole, al di là di chi
paga di più (sappiamo che la risposta è il Nord), è interessante sapere anche
chi riceve di più. A questo proposito, negli ultimi tempi sono circolati molto i
dati della Ragioneria generale dello Stato sulla “spesa statale generalizzata”
(furono pubblicati per esempio dall’ex ministra leghista per gli Affari
regionali Erika Stefani). Secondo questi dati le regioni del Nord – Lombardia e
Veneto in testa – sono quelle che ricevono meno risorse: ogni anno un lombardo
riceve circa 2.700 euro di spesa statale regionalizzata, un veneto 2.900, mentre
un abitante del Lazio ne riceve ben 5.700. Come ha ricordato però lo SVIMEZ lo
scorso aprile – e poi, di nuovo, in un’audizione parlamentare pochi giorni fa –
i dati della Ragioneria generale dello Stato sono parziali. È la stessa
Ragioneria, infatti, a spiegare che su circa 590 miliardi di euro l’anno di
pagamenti effettuati dallo Stato, ne considera “regionalizzabili” – cioè
ripartibili a livello regionale – circa 270. Da questo conto mancano alcune voci
molto importanti, per esempio la spesa previdenziale e per assistenza sociale:
quindi pensioni, politiche sociali e per la famiglia, che da sole costituiscono
quasi il 70 per cento della spesa che la Ragioneria considera “non
regionalizzabile”. Il conto della Ragioneria, infine, tiene conto solo dei
pagamenti dello Stato centrale, quindi non considera le risorse proprie
impegnate nella sanità dalle regioni, per esempio, né quelle spese dalle società
controllate pubbliche che forniscono servizi molto importanti per la qualità
della vita dei cittadini, per esempio i trasporti locali e la raccolta dei
rifiuti. Per avere un quadro più completo di quanta spesa pubblica
effettivamente raggiunga ogni regione, i ricercatori dello SVIMEZ sostengono che
sia meglio utilizzare dati diversi da quelli parziali della Ragioneria: quelli
raccolti dal sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT), che fa parte
dell’Agenzia per la coesione territoriale. A differenza dei dati della
Ragioneria, quelli del CPT includono tutti i flussi finanziari, compresi quelli
previdenziali e quelli del cosiddetto “settore pubblico allargato” (che include
per esempio società di diritto privato ma a controllo pubblico). Tenendo conto
anche di questi dati, la classifica di chi riceve più spesa pubblica cambia. Se
per la Ragioneria, infatti, il Sud e i suoi abitanti ricevono circa 3.800 euro
di spesa pubblica pro capite ogni anno, mentre al Centro-Nord la cifra scende al
3.375, guardando i dati del CPT sul totale della pubblica amministrazione
(comprensivo anche di regioni, enti locali ed enti previdenziali) il Centro-Nord
passa in vantaggio con una spesa pro capite di 13.400 euro contro i 10.900 del
Sud. Se nel conto si include anche il settore pubblico allargato (quindi ENI,
Ferrovie dello Stato, società municipalizzate, ecc.) il divario arriva a quasi 4
mila euro a persona, con una spesa pubblica pro capite al Centro-Nord pari a 17
mila euro e al Sud pari a 13.300. Andando a vedere le singole regioni, emerge
che la regione che riceve nel complesso la maggior quantità di spesa pubblica
pro capite è la Valle d’Aosta, con 25 mila euro annuali. Tra le regioni non a
statuto speciale riceve più spesa pubblica il Lazio, con 22 mila euro, seguita
dalla Liguria, con 18 mila. La regione dove invece si spende meno è la Campania,
con 12 mila euro: meno della metà della regione che riceve di più.
Storie di
“Gallo” e “Paglietta”, il Nord vuole farsi Stato Dal trucco della spesa storica
alle mani sulla cassa centrale fino allo “scippo” delle tasse.
Roberto
Napoletano il 2 luglio 2019 su Il Quotidiano del Sud. C’è qualcosa di veramente
misterioso che gonfia il petto per gli strilli dei Governatori padani. Fingono
di avere qualche numerino sconosciuto ai più, ma ancora prima alle regole
generali della contabilità e degli Stati unitari o federali, per non parlare
della decenza, che li fa reclamare senza rossore la “restituzione” di non si
capisce che per sanare l’ingiustizia perpetrata da non si capisce chi. Hanno la
pancia piena di una abbuffata di decine e decine di miliardi l’anno (61, per la
precisione) indebitamente sottratti alle donne e agli uomini del Mezzogiorno per
trasferirli in mille rivoli assistenziali nei portafogli dei loro
cittadini-elettori e si permettono di pretendere, oltre ogni limite, di avere
restituito ciò che loro dovrebbero restituire con gli interessi e la recita di
una cinquantina di rosari se non vogliono perdere la speranza che qualcuno possa
pensare di assolverli un giorno dai loro peccati.
SCOPRI I
CONTENUTI SULLO SCIPPO PERPETRATO AL SUD. La banda del buco del Grande Partito
del Nord, di cui loro fanno oggi autorevolmente parte, ha inventato il gioco
delle tre carte di Pontida e Varese, che ha fatto fare la figura dei
principianti a quelli di Forcella. Di che si tratta? Con destrezza lumbard, nel
silenzio complice di tutti, hanno buttato nel cestino le due carte – livelli
essenziali di prestazione e fabbisogni standard – che sono imposte dalla
Costituzione e perfino dalle regole federali dell’ex ministro leghista
Calderoli, ma danno il giusto ai meno ricchi e per questo (solo per questo) non
sono stati mai dolosamente determinati. Sul tavolo resta solo la terza carta che
è la moneta dei ricchi e, cioè, la spesa storica perché li fa stravincere e ne
arma le mani predoni dentro la cassa pubblica. Ogni anno i lamentosi signorotti
della politica del Nord vanno al bancomat dello Stato e inseriscono la moneta
telematica che ha il cambio della refurtiva incorporato. Ogni anno assumono
sempre più gente, buttano soldi qua e là, aumentano la spesa storica e, poi, il
bancomat paga in contanti per ogni loro desiderio. Ignorano i “Governatori” che
in uno Stato unitario o federale esiste un atto costitutivo che tiene insieme
diritti e doveri tra cittadini e Stato e che questo patto nulla ha a che vedere
con il genetico e generico diritto del mitizzato territorio del Nord. Anche se
si accondiscendesse a questi inammissibili (e penosi) conti territoriali di dare
e avere in salsa leghista, mai emergerebbe una quantificazione legittima di
pretese ma un obbligo costituzionale cogente di restituzione di tutto ciò che è
stato fino a oggi egoisticamente rubato dal Nord al Sud attingendo alla spesa
pubblica, ignorando i diritti di cittadinanza di molti. Tutto ciò, principi,
metodo, numeri (veri) non quelli loro (mai esibiti) e, tanto meno, quelli falsi
raccontati dalla portavoce-Pinocchio in Parlamento, la ministra Erika Stefani, i
Governatori fanno finita di non sapere, di non vedere, di non sentire,
confermando che c’è del metodo nella follia. Questo metodo fa cadere la maschera
e rivela il loro vero obiettivo: farsi Stato.
STORIA DI
“GALLO” E “PAGLIETTA”. A Napoli, questo agitato strombazzare è argutamente
assimilato alla mattutina performance del “gallo ‘ncoppa ‘a munnezza” che, a
pieni polmoni, come un brontolone di provincia, ripete il suo antelucano verboso
rituale. Sempre a Napoli, l’insistenza fastidiosa di certi comportamenti, per
cui la questione delle quote latte è un problema di Stato e la Regione Emilia
Romagna si ritaglia il ruolo di concorso esterno in autonomia differenziata,
l’inevitabile, supplementare, carico di quotidiane litanie sull’autonomia
“virtuosa” configura un mestiere ben noto, quello del “paglietta”. Personaggio
retorico e inconcludente ma pericoloso se – come accade nelle pianure del Nord –
governa milioni di ricchi, male informati, decadenti fedeli. Per evitare
equivoci, nella settimana che si propone (auspicabilmente e verosimilmente solo
a parole) di definire una proposta di autonomia differenziata e di presentarla
all’approvazione del Consiglio dei ministri, vogliamo riepilogare alcuni punti
fermi e alcuni punti interrogativi che il nostro lavoro di inchiesta
giornalistica ha messo a fuoco in questi mesi. Ci rivolgeremo di volta in volta
al “gallo” o al “paglietta” di turno avendo, però, la consapevolezza di
sottolineare che questi bizzarri elementi comportamentali emergono solo quando
si parla di autonomia e di cassa pubblica a testimonianza che si tocca un nervo
scoperto. In più circostanze, e intendo qui ribadirlo, abbiamo parlato della
buona amministrazione dei territori del Nord (non tutti e non sempre,
ovviamente) e dei loro Governatori, nonché della forza del tessuto civile. Il
punto da noi posto nell’interesse del Nord quasi prima che del Sud, è quella di
una più equa distribuzione delle poche risorse pubbliche perché si smetta di
pensare che tutti i soldi pubblici nazionali per fare investimenti siano
proprietà delle regioni ricche e alle regioni povere restino solo i fondi
comunitari come un Paese terzo a cui, poi, puntualmente si sottraggono i
cofinanziamenti nazionali per soddisfare l’ultima corporazione di turno nordista
tipo quote latte e dintorni. Per fortuna, non siamo più soli, e siamo certi che
l’operazione-verità avviata da questo giornale avrà nell’indagine conoscitiva
proposta dalla presidente della Commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco,
una sede competente e attenta. Sottoponiamo, di seguito, alcuni elementi di
valutazione.
STORIA DEI 61
MILIARDI E DINTORNI.
a) I dati dei
conti pubblici territoriali più aggiornati misurano algebricamente la spesa del
settore pubblico allargato e sono inequivoci. Sono gli unici completamente
veritieri (qualcuno informi la ministra Stefani) perché riguardano
amministrazioni centrali, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Inps,
Anas, Ferrovie, e così via. Il conto è presto fatto: a una popolazione del Sud
pari al 34,3% corrisponde il 28,3% della spesa pubblica, al 65,7% della
popolazione del Centro-Nord arriva il 71,7%. Balla il 6% che viene indebitamente
sottratto al Sud povero e regalato al Nord ricco. Sono 61 miliardi l’anno, avete
capito bene. C’è qualcuno disposto a chiedere al “gallo” o al “paglietta”
nordisti, alla loro prima egoistica lamentazione general generica, di mettere
mano al portafoglio e di cominciare a restituire quanto di ciò arbitrariamente
sottratto da almeno dieci anni in qua?
b) Come è
stato possibile tutto ciò? Lo abbiamo già detto, hanno fatto il gioco delle tre
carte e continuano senza un minimo di decenza a ben guardarsi dal definire i Lep
e i fabbisogni, concepiscono di aggredire anche la cassa delle amministrazioni
centrali dove la Costituzione e le regole generali di uno Stato unitario vengono
rispettate. C’è qualche motivo, governatore Zaia, governatore Fontana e, in
concorso esterno, governatore Bonaccini perché a dieci anni dalla legge
Calderoli non solo non si varano i parametri per rispettare i diritti di
cittadinanza dalle Alpi a Pantelleria, ma addirittura non trovate il tempo
neppure per costituire un Fondo di perequazione tra Regioni come, almeno
formalmente, hanno fatto i Comuni? Di che cosa avete paura? Volete togliere alle
Regioni del Sud indebitamente penalizzate lo strumento giuridico per agire e
chiedervene conto nelle sedi giudiziarie competenti? Il “gallo” e il “paglietta”
hanno nulla da dire, in proposito, tra un’ingiustificata lamentazione e l’altra?
c) Siete a
conoscenza che nella sua classica definizione di federalismo fiscale di stampo
cooperativo, J.M. Buchanan esplicitò negli anni 50 il criterio di equità
orizzontale che ritroviamo nello spirito della riforma del titolo V sintetizzato
dal motto: si trattano in modo uguale gli uguali. In base a questo principio
FEDERALE “un individuo dovrebbe avere la garanzia che dovunque egli desideri
risiedere nella nazione, il trattamento fiscale complessivo che egli riceverà
sarà approssimativamente lo stesso”. Ho parlato un linguaggio difficile? Allora
mi spiego meglio: che giudizio avrebbe, governatore Zaia, di una persona con un
reddito X che paga regolarmente le sue tasse e vorrebbe che lo Stato si
impegnasse a investire il gettito delle sue tasse per rifare per la terza volta
la villa comunale (attualmente in ottimo stato) su cui si affaccia la sua
abitazione mentre le strade comunali continuano ad essere piene di buche, il
pronto soccorso dell’ospedale perde pezzi, e così via? Ci pensi un attimo è
quello che state chiedendo di fare voi trattenendo una cassa che nessuno è
neppure in grado di determinare e che anche voi avete difficoltà a mettere nero
su bianco in documenti da presentare nelle sedi competenti? Che cosa ve lo
impedisce? Perché non lo fate?
d) Per evitare
equivoci la base del patto sociale nel quale si riconosce una comunità, sia che
si organizzi in modo federale che unitario, non consente simili giochetti, non
sa che cosa sia il presunto diritto alla restituzione del cosiddetto residuo
fiscale che nessuno sa e potrà mai davvero sapere che cosa esattamente sia. In
una comunità di eguali dove il trattamento fiscale deve essere
approssimativamente lo stesso e dove i principi di solidarietà sono fondanti,
questo oggetto misterioso di cui si narra nelle vallate del Nord non ha neppure
diritto di asilo. Diverso è il caso di uno Stato Confederale che collega
comunità diverse e dove il principio di equità orizzontale vale all’interno
delle singole comunità e non per individui di comunità diverse, modello al quale
di fatto aspira il sedicente regionalismo a geometria variabile che intende
realizzare il regime di autonomia rafforzata. Si tratta di questo? Sì, allora
ditelo: volete farvi Stato? Tutto si può fare, ma bisogna dirlo e non bastano di
certo referendum consultivi e le compiacenze del mite Gentiloni, premier pro
tempore, per fare sparire l’Italia senza nemmeno chiedere ai cittadini italiani
di esprimersi tutti nell’urna. Qualcuno, tra una lamentazione e l’altra, del
“gallo” o della “paglietta” di turno, potrà spiegare questi elementari
ragionamenti?
e) Siete al
corrente che la Ragioneria dello Stato in un documento a uso interno ha fatto
presente che se non sanate i difetti costituivi di questo federalismo
all’italiana, il federalismo dei ricchi, il volume di criticità mette a rischio
l’intero impianto in vigore? Non quello che follemente sognate?
f) Qualcuno vi
ha informato che 65 Comuni del Sud si sono rivolti al TAR del Lazio perché
ricevono zero euro spaccato per asili nido e altra spesa sociale garantita dai
diritti di cittadinanza e che la presidenza del TAR ha chiesto al ministero
dell’interno una “documentata relazione” relativa alla questione perché da
questo ministero dipende il fondo di perequazione tra Comuni? Qui almeno hanno
avuto la decenza di costituirlo.
g) Sapete che
cosa è successo, di saccheggio in saccheggio del Nord al Sud dalla cassa di
Stato, nella mappa dell’impiego pubblico? Che la capitale del posto fisso è
diventata il Nord Est che ha 4,9 dipendenti pubblici ogni mille, ultimo
censimento Istat, contro i 4,5 del Sud, isole comprese? Non vi sembra che dietro
questi numeri non c’è solo la fine di un luogo comune insopportabile ma anche
l’alterazione del corso sano di flussi pubblici che si traducono in
assistenzialismo al Nord (non ne ha bisogno) e tolgono risorse per gli
investimenti al Sud fino ad azzerarle? Ma dove ci condurranno mai logiche così
miopi e regressive?
h) Che cosa
dire del rapporto sulla finanza pubblica della Corte dei conti che segnala che
le Regioni del Nord hanno assunto dieci volte di più di quelle del Sud e che
gran parte del buco (copre tutto il bancomat della spesa storica) viene da tre
regioni a statuto ordinario del Nord, nell’ordine Piemonte, Liguria e, meno,
Toscana?
i) Come si fa
a parlare con tanta leggerezza di residuo fiscale di una regione piuttosto che
un’altra in uno stato unitario o federale che dir si voglia? Ma davvero volete
ripetere, anche su questo versante, la figuraccia fatta dalla ministra Stefani
sulla regionalizzazione della spesa pubblica? Volete anche voi sentirvi dire che
i numeri esposti sono fragili, indimostrabili, comparativamente lacunosi,
comunque senza diritto di cittadinanza in uno Stato federale? Come si fa a dire
che una tassa pagata in una determinata città è frutto del lavoro di quella
città mentre il reddito prodotto potrebbe essere (molto spesso è) il frutto del
lavoro di altri cittadini italiani svolto in altri territori? E poi, come li
calcolate? Che cosa rispondete al presidente della Svimez, Adriano Giannola, che
sostiene che dovete almeno scalare gli interessi che percepite sui titoli di
Stato perché “rappresentano una spesa erogata a titolo di servizio del debito
pubblico” che una prassi consolidata non computa anche se resta una delle poste
con un significativo impatto redistributivo?
QUEI NUMERI AL
LOTTO. Il ragionamento di Giannola è il seguente: vista la pretesa del diritto
alla restituzione in base a un presunto residuo fiscale che sottrarrebbe risorse
da un territorio per finanziare un altro territorio (aggiungo io come sarebbe
giusto, ma come qui non avviene perché l’abbuffata di spesa pubblica sottratta
dal Nord al Sud ammazza tutto) allora questo dato va integrato con l’imputazione
territorialmente corretta della spesa pubblica impiegata per corrispondere il
servizio del debito. Tanto più che (equivalenza ricardiana) il valore delle
imposte presenti e future necessarie a soddisfare il debito tende a coincidere
con l’ammontare degli interessi percepiti dai detentori del debito. Per questi,
insomma, gli interessi percepiti sono una forma di restituzione di imposte.
Secondo Giannola e tanti altri, quindi, anche in termini quantitativi questo
presunto residuo fiscale non avrebbe nulla da spartire con i numeri al lotto
dati al bar o sui giornali, mai in documenti ufficiali presentati oggi all’esame
del governo, ma si ridurrebbe a poco più di un terzo di quanto indebitamente
acquisito di anno in anno dalle Regioni del Nord con la spesa pubblica non
dovuta. Potremmo dire: di che cosa parliamo? Invece no, la nostra critica è
molto più radicale: questo numero (qualunque sia la sua dimensione) in uno stato
unitario o federale non può essere frutto di “appropriazione indebita” da parte
di chicchessia e minerebbe, tra l’altro, in modo clamoroso, unico al mondo, le
ragioni fondanti dello Stato e quelle altrettanto importanti (obbligate) di
perequazione fiscale. Senza di esse non esisterebbe lo Stato, siamo stati
chiari? Ma come vi permettete di dire li spendo io questi quattrini (molto molto
meno di quello che pensate voi) quando sono dell’intera comunità nazionale?
Certo che possono essere vostri – solo vostri se esistono. – Ma vi dovete
perlomeno fare uno Stato per i fatti vostri. Ovviamente non vi conviene, ma se
avete tanta voglia di consegnarvi mani e piedi a francesi, tedeschi, cinesi, che
farebbero di voi un solo boccone, accomodatevi. Perché ciò avvenga, ancorché
masochistico, dovreste almeno svestire i panni del “paglietta” e dire come
stanno le cose. Soprattutto, dovreste dire al “gallo” di cantare un’altra
canzone.
Roberto
Maroni: «Continuerò a difendere l’Autonomia, ma la spesa storica va superata».
L’ex ministro leghista: «Il Veneto ha chiesto 23 materie, la
Lombardia 20: siamo sicuri che servano tutte?» Claudio Marincola il 31 ottobre
2019 su Il Quotidiano del Sud. Conosce bene le regole del galleggiamento,
Roberto Maroni. Ex segretario federale della Lega Nord, ministro dell’Interno e
poi del Lavoro nei governi Berlusconi, governatore della Lombardia fino allo
scorso anno, finito in fuorigioco per una lunga vicenda giudiziaria. A 64 anni
il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia lo ha chiamato a far parte
della commissione che tratterò con le regioni la difficile partita
dell’autonomia differenziata.
Lei ha detto
di essere disposto a trattare anche con il diavolo se questo potrà servire alla
causa dell’autonomia. Ma chi è il diavolo, scusi?
«Era solo un
modo di dire».
Sembrava
riferito al ministro.
«Guardi,
conosco Boccia, ed è tutt’altro che un diavolo. Con quella espressione mi
riferivo a un episodio del passato. Quando Umberto Bossi mi disse, era il ’94,
di andare a trattare con Alleanza nazionale. Loro erano contrari al federalismo,
noi al presidenzialismo. Non se ne usciva. Alle elezioni si rischiava di andare
l’uno contro l’altro. Fisichella e Miglio, due professori, si incontrarono per
trovare un’intesa ma invano. Poi arrivò Pinuccio Tatarella, uscì dalla stanza e
disse ai giornalisti: “Trovato l’accordo”. E nacque il governo. Ecco, io penso
che se ci si mette intorno a un tavolo e si trova una soluzione, si riesce a
fare quello che al governo precedente non è riuscito. Una cosa utile a tutti. Al
Sud e al Nord. Per questo ho accettato l’offerta di Boccia».
Lei andrà a
trattare con le regioni. Ma come la mettiamo con i 61 miliardi l’anno di mancati
investimenti sottratti al Sud? Noi lo chiamiamo scippo. E cosa pensa sul 34%
degli investimenti che il governo destinerà al Mezzogiorno?
«So di cosa
parla, leggo il vostro giornale. Ma sullo scippo non sono d’accordo. O meglio,
dipende dai criteri».
Sono numeri
certificati dalla contabilità nazionale. E c’è un’indagine conoscitiva in
Parlamento.
«I criteri con
cui si fanno questi calcoli sono tutti discutibili. E comunque, anche ammettendo
lo scippo, e io non sono d’accordo, potremmo parlare del residuo fiscale, la
differenza tra quello che le regioni versano e le risorse che tornano indietro
ai territori».
Il residuo
fiscale dei territori non esiste, esiste solo quello individuale. Non lo diciamo
noi, lo dice la Ragioneria generale dello Stato…
«…la
interrompo. La verità vera è che alla modifica del Titolo V della Costituzione,
pensato per dare più autonomia alle regioni, non si è dato attuazione».
Obiezione. Al
governo ci siete stati anche voi.
«Certo,
verissimo. L’autonomia è una sorta di contenitore rimasto vuoto. E allora io
dico: mettiamoci intorno a un tavolo e discutiamo. Voi parlate di scippo? E
volete che tutto resti uguale e si continui così? Non conviene a nessuno,
vediamo come rimediare, troviamo una forma di win to win che vada bene anche
alle regioni. E anche al diavolo, se occorre. L’autonomia può essere una buona
soluzione per tutti».
Il Veneto
vuole il via libera su 23 materie, la Lombardia su 20. E poi c’è il nodo
dell’istruzione. Le pare facile trovare un’intesa?
«Aspetti. Il
confronto serve proprio a questo. Può servire a superare quello che voi chiamate
“scippo”. L’autonomia è prevista dalla Costituzione, gli articoli 116 e 119 non
hanno nulla di eversivo. Partiamo dunque dalla pre-intesa che io stesso, da
governatore della Lombardia, ho firmato il 28 febbraio del 2018 con l’allora
primo ministro Gentiloni, a Palazzo Chigi».
C’è un’Italia
che viaggia sull’Alta velocità in business class e un’altra dove tutte le rotaie
del Meridione non raggiungono quelle della sola Lombardia. Dove un malato su 5
non si cura perché non se lo può permettere. A lei questa Italia piace?
«No, non piace
neanche a me. Ma senza voler sostituire i governatori, perché non voglio parlare
per nome e per conto loro, posso dire che ci sono molte cose, per esempio a
proposito dell’articolo 117, che si possono rivedere. La disponibilità di Boccia
a parlarne c’è».
Esempio?
«Il Veneto
chiede 23 materie concorrenti. Ma servono proprio tutte, ci siamo chiesti? Sono
materie che ci interessano quelle sull’ordinamento delle Casse Rurali e delle
Casse di Risparmio che tra l’altro non esistono più? E che dire dell’ordinamento
sportivo? Siamo sicuri che ai territori gliene freghi qualcosa? Stesso dicasi
per la materia che regolamenta porti e aeroporti, visto che c’è l’Anac e un
eventuale devoluzione potrebbe anche essere vista con sospetto da compagnie
straniere che potrebbero investire. Anche per ciò che comporta le competenze in
materia di Grandi reti di trasporti e di navigazione. A prescindere che in
Lombardia non c’è il mare ma siamo sicuri che sia essenziale incartarsi su
questioni del genere? Ordinamento della comunicazione. Ma davvero c’interessa? E
il trasporto dell’energia perché non può rimanere nazionale? Capisco la
produzione, lì potremmo incassare le accise, ma il trasporto? Che se ne fa la
Lombardia?».
Lo scippo
nasce dal criterio della spesa storica. Per anni i servizi sono stati finanziati
alle regioni e ai comuni che già li avevano. Zero asili, zero mense scolastiche,
zero trasporti a tutti gli altri.
«La spesa
storica andava di pari passo con la definizione dei fabbisogni standard e dei
Lep. Era un calcolo transitorio. Di chi è la colpa se si è andati avanti così?
Non è certo della Lombardia, ma è dei governi. Poi c’è il discorso di chi le
risorse le sa utilizzare e chi no. Lo sa che restituiremo il 75% dei fondi
europei, decine di miliardi?».
Il Nord spesso
ha gestito quei fondi peggio del Sud.
«Purtroppo
esistono anche nel Nord zone di inefficienza. Abbiamo un nostro “Sud”. Voglio
raccontarle un episodio. Quando ero ministro mi presentarono una graduatoria: i
Comuni che facevano meglio la raccolta differenziata. Al quarto posto, dopo
alcune città del Nord, c’era Salerno. Non volevo crederci. Feci controllare,
pensavo a un errore, ma a un secondo controllo verificai che era tutto vero.
Allora andai a Salerno e volli conoscere di persona il sindaco. Era De Luca,
siamo rimasti amici».
Appunto.
Ammetterà che la favoletta di un Sud inefficiente e sprecone che non merita le
risorse perché non sa gestirle non regge più.
«Ci sono buone
pratiche anche al Sud, certo ne sono perfettamente consapevole. Ma se mi dice
che il Nord ha depredato il Sud glielo contesto».
E lo scippo,
dunque?
«Se mi
convincete che effettivamente c’è stato uno scippo sarò il primo ad ammetterlo.
In quanto al lavoro che farò in commissione non terrò la bandiera del Nord, non
ho accettato per questo. Terrò alta la bandiera dell’autonomia».
Il falso mito dello "scippo" di risorse del Nord a danno del
Sud: al Mezzogiorno la spesa pubblica pesa di più. a
cura di OSSERVATORIO CPI, Giampaolo Galli e Giulio Gottardo, Osservatorio sui
Conti Pubblici Italiani, su La Repubblica il 26 settembre 2020. Lo Stato spende
di più per i cittadini del Centro-Nord che per quelli del Mezzogiorno? Al netto
della spesa per interessi e di quella pensionistica - che lo Stato non può
decidere come allocare a livello territoriale - la risposta è negativa. Se poi
si tiene conto del diverso costo della vita, il Meridione sembra beneficiare di
un trattamento migliore rispetto al Centro-Nord. Di recente, il presidente
dell'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno (Svimez) ha
dichiarato che "il Nord ha sottratto al Sud 60 miliardi all'anno". Come è stata
ottenuta questa stima? Nell'analisi della Svimez vi sono una serie di
peculiarità che a nostro avviso distorcono notevolmente il risultato.
Innanzitutto, l'analisi è basata sui dati di spese ed entrate di fonte CPT
(Conti Pubblici Territoriali a cura dell'Agenzia della Coesione) la cui somma
per regioni è molto diversa dai totali nazionali ISTAT, un punto (di notevole
gravità) che è già stato messo in evidenza dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
Parlamentare di Bilancio. In secondo luogo, viene considerata la spesa della
cosiddetta P.A. allargata, ovvero l'insieme di società partecipate, enti locali
e amministrazioni centrali. Di conseguenza, in questi 60 miliardi sono incluse
le spese di società come Eni, Enel, Poste Italiane e Leonardo che sono quotate
in borsa e non operano in base a obiettivi di perequazione geografica, bensì di
profittabilità e che devono comunque cercare di soddisfare la domanda effettiva
per i beni e servizi prodotti. È quindi pressoché inevitabile che la spesa di
queste società sia maggiore nelle regioni più ricche, in cui la domanda è più
elevata e le opportunità d'affari sono tipicamente maggiori. Consegue che
considerare tutta la P.A. allargata è discutibile, in quanto include delle spese
il cui meccanismo di allocazione è fondamentalmente il mercato e non una
decisione politica. In terzo luogo, nel calcolo dei 60 miliardi "sottratti" al
Mezzogiorno, secondo Svimez, ci sono anche le pensioni, che rappresentano più di
250 miliardi all'anno di spesa pubblica. Tuttavia, lo Stato non ha alcun
controllo sulla loro allocazione regionale: dato che al Nord i lavoratori
(provenienti sia dal Nord che dal Sud) hanno versato più contributi, i
pensionati settentrionali hanno mediamente diritto a pensioni più alte, il che
fa inevitabilmente lievitare la spesa pubblica pro capite nelle loro Regioni.
Infine, la Svimez non tiene conto delle differenze molto rilevanti nel costo
della vita tra regioni.
La distribuzione regionale della spesa. Passando alla pars
costruens, per fare un'analisi solida della distribuzione regionale della spesa,
occorre fare riferimento all'aggregato della Pubblica Amministrazione (che a
livello nazionale è calcolato dall'ISTAT, in base ai criteri Eurostat), la cui
disaggregazione per regioni e macroaree è calcolata dalla Banca d'Italia.
Tav. 1: Spesa
pro capite della P.A.
|
Tav. 1: Spesa pro capite della P.A. |
|
|
Centro-Nord |
Mezzogiorno |
Gap |
|
SPESA NOMINALE PRO CAPITE (MEDIA 2014-2016, EURO) |
11850 |
10900 |
-950 |
|
SPESA NOMINALE PRO CAPITE SENZA PENSIONI (MEDIA
2014-2016, EURO) |
6800 |
7150 |
+350 |
|
SPESA PRO CAPITE SENZA PENSIONI A PARITÀ DI POTERE
D’ACQUISTO (MEDIA 2014-2016, EURO) |
6550 |
8500 |
+1950 |
Tutti i dati sono al netto degli interessi sul debito. Fonte:
elaborazione Osservatorio CPI su dati della Banca d’Italia e ISTAT. Se si
considera il dato grezzo dell'intera PA al netto degli interessi sul debito, con
riferimento alla media del periodo 2014-2016, il Mezzogiorno appare leggermente
svantaggiato nel senso che la spesa pro capite è pari 10.900 euro a fronte di
11.850 euro nel resto del paese, con un gap di 950 euro (Tavola 1, prima
colonna). Va detto subito che questo dato non è statisticamente significativo
perché, come si mostra più avanti, vi sono differenze significative fra regioni
a Statuto ordinario e a Statuto speciale, nonché fra regioni di diverse
dimensioni all'interno delle stesse macroaree. In ogni caso, moltiplicando
questo gap per la popolazione del Mezzogiorno (20,5 milioni) si ottiene la cifra
di 19,5 miliardi all'anno, che è rilevante, ma molto lontana dal dato citato
dalla Svimez. Tuttavia, se si sottraggono le pensioni, sulla cui allocazione
geografica il decisore politico non ha alcun controllo, la spesa pro capite di
tutta la P.A. nelle varie regioni rimane abbastanza eterogenea, ma la
"classifica" non sembra discriminare il Meridione rispetto al Centro-Nord; anzi
il gap si rovescia a favore del Mezzogiorno e diventa positivo (+350 euro pro
capite, Tavola 1, seconda colonna). L'altra correzione ai dati grezzi sulle
uscite della P.A. muove dalla considerazione che nel Mezzogiorno i prezzi sono
più bassi che al Centro-Nord; ogni euro di spesa in una regione del Sud ha
quindi un potere d'acquisto - e quindi un valore reale - maggiore rispetto al
resto del Paese. Per eseguire l'aggiustamento a Parità di Potere d'Acquisto (PPA)
della spesa, è stata utilizzata l'unica fonte ufficiale disponibile che è
rappresentata dalle soglie di povertà definite dall'ISTAT. La soglia di povertà
nel Mezzogiorno è inferiore del 20 percento circa rispetto al Centro e del 24
rispetto al Nord, rispecchiando una considerevole differenza nel costo della
vita. Quando si opera anche questa correzione, il gap diventa molto rilevante
(+1950 euro pro capite) e decisamente favorevole al Mezzogiorno (Tavola 1, terza
colonna). In valori assoluti, si tratta di una maggiore spesa "reale" nel
Mezzogiorno pari a quasi 40 miliardi. Anche per quanto riguarda le singole
Regioni, la spesa non pensionistica pro capite a Parità di Potere d'Acquisto non
sembra penalizzare il Mezzogiorno, ma piuttosto appare favorire le Regioni a
Statuto Speciale e quelle più piccole (Figura 1).
Il Mezzogiorno è discriminato? Per un'analisi più accurata
occorre tenere conto delle differenza di spesa determinata da fattori diversi da
quelli che sono oggetto di questa indagine, ossia la dimensione delle regioni
(dato che vi sono notevoli economie di scala) e il loro status costituzionale
(regioni a Statuto Ordinario e a Statuto Speciale). Per fare questo è necessario
effettuare una regressione multivariata, che consenta di cogliere separatamente
l'effetto della grandezza e dello status di ogni regione sulla spesa pro capite
della P.A., lasciando che l'appartenenza al Mezzogiorno spieghi le differenze
restanti. In altre parole, si individua la differenza nella spesa pro capite tra
una regione del Mezzogiorno e una del Centro-Nord a parità di popolazione e
status.
Tav. 2: la spesa della P.A. è più bassa al Mezzogiorno?
(regressioni)
|
Tav. 2: la spesa della P.A. è più bassa al Mezzogiorno?
(regressioni) |
|
|
(1) Variabile dipendente:
Spesa PA pro capite |
(2) Variabile dipendente:
Spesa PA pro capite
senza pensioni |
(3) Variabile dipendente:
Spesa PA pro capite
senza pensioni e PPA |
|
POPOLAZIONE (MILIONI) |
-402,5*** |
-341,7** |
-356,2*** |
|
|
(-3,63) |
(-2,78) |
(-3,07) |
|
STATUTO SPECIALE |
2160,9*** |
2398,9*** |
2094,7*** |
|
|
(3,54) |
(3,55) |
(3,28) |
|
MEZZOGIORNO |
-1560,1*** |
-393,7 |
1397,1** |
|
|
(-2,92) |
(-0,67) |
(2,50) |
|
COSTANTE |
13758,6***
(25,00) |
8421,9***
(13,82) |
8219,4***
(14,27) |
|
OSSERVAZIONI |
21 |
21 |
21 |
|
|
0,74 |
0,65 |
0,69 |
Statistiche tra parentesi. *** significativo al 99%, **
significativo al 95%, *significativo al 90%. I valori di popolazione e spesa pro
capite sono medie 2014-2016. Fonte: elaborazione Osservatorio CPI su dati della
Banca d’Italia e ISTAT. I risultati sono presentati nella Tavola 2. Come
anticipato, la spesa pro capite è minore nelle regioni grandi (350-400 euro pro
capite in meno per ogni milione di abitanti) e maggiore in quelle a Statuto
Speciale (oltre 2.000 euro pro capite in più). Al netto di questi fattori, se
non si escludono le pensioni dalla spesa della P.A., la differenza tra spesa pro
capite nel Mezzogiorno e al Centro-Nord è significativa e negativa: i cittadini
meridionali riceverebbero ciascuno circa 1.560 euro in meno (colonna (1)).
Tuttavia, se si escludono le pensioni da questo calcolo, la differenza tra Sud e
Centro-Nord non è più statisticamente significativa. In altre parole, il Sud non
è discriminato nella distribuzione geografica della spesa pubblica nominale non
pensionistica (colonna (2)). Infine, se si considera la spesa della P.A. a
Parità di Potere d'Acquisto (PPA), ovvero se si tiene conto delle differenze nei
prezzi, il Sud appare significativamente favorito, nell'ordine di quasi 1.400
euro pro capite (colonna (3)). Questo risultato dipende ovviamente dal fatto che
quasi tutti gli stipendi pagati dalla P.A. sono uguali tra regioni e rispecchia
quindi il loro maggior valore reale nel Mezzogiorno. In altre parole, tenendo
conto anche delle differenze nel costo della vita, il Mezzogiorno riceverebbe un
trattamento più generoso del resto dell'Italia. A livello aggregato, questa
maggiore spesa pro capite equivarrebbe a circa 28,6 miliardi all'anno.
Quante risorse redistribuisce lo Stato? La combinazione tra un
ampio divario in termini di PIL pro capite tra Centro-Nord e Meridione e una
spesa pubblica nominale pro capite più equilibrata tra le due macroaree, fa sì
che, anche includendo la spesa pensionistica e senza tenere conto delle
differenze di potere d'acquisto, il peso della P.A. sul PIL regionale sia
estremamente alto nel Mezzogiorno e più contenuto nel resto del Paese. Agli
estremi ci sono la Lombardia, in cui la spesa pubblica è poco più del 33
percento del prodotto regionale, e la Calabria, dove questo dato raggiunge l'80
percento, una cifra davvero elevata. Poiché il peso delle entrate della P.A. sui
PIL regionali è molto più omogeneo, l'esistenza di massicci trasferimenti (i
cosiddetti residui fiscali) tra regioni è inevitabile (Figura 2). La Banca
d'Italia calcola che nel periodo 2002-2016, i trasferimenti pubblici a favore
del Mezzogiorno sono oscillati fra il 15 e il 20% del Pil dell'area; rapportato
alla media del PIL 2014-2016, queste percentuali corrispondono a cifre annuali
tra 57 e 76 miliardi di euro. Le regioni che hanno sostenuto la quasi totalità
di quest'onere sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Lazio, il Veneto, il
Piemonte e la Toscana. Da parte della Svimez (e di molti meridionalisti) si
argomenta che quello dei residui fiscali è un falso problema perché il prelievo
riguarda gli individui, non i territori e perché i diritti di cittadinanza non
possono variare in base alla residenza. L'argomento è comprensibile e in parte
condivisibile. Occorre però tenere conto che in tutte le strutture federali è
prevista una qualche corrispondenza fra la capacità contributiva di una regione
e la sua spesa. Se si pensa che questa corrispondenza non possa o non debba
verificarsi, allora non si capisce che senso abbia dire che l'autonomia delle
Regioni prevista dalla Costituzione vada contemperata con i livelli essenziali
delle prestazioni; bisognerebbe dire chiaramente che non si ritiene auspicabile
alcuna forma di federalismo o tantomeno di autonomia differenziata. In ogni
caso, non sembra in alcun modo accettabile distribuire in ragione della
popolazione anche la spesa delle imprese partecipate che operano sul mercato,
nonché le pensioni che dipendono dai redditi percepiti nel passato. Quanto alla
questione delle Parità di Potere d'Acquisto, si può essere dell'opinione che gli
stipendi pubblici e forse anche quelli privati debbano essere gli stessi in
tutto il paese, ma non si può negare che un euro al Sud ha un potere d'acquisto
- e quindi un valore - maggiore che nel resto del Paese. Questo insieme di
fattori fanno sì che il Mezzogiorno d'Italia sia una della poche aree al mondo
in cui il livello dei consumi (privati più collettivi) è superiore al PIL:
sempre con riferimento al periodo 2014-2016, tale rapporto è pari a 1,025 nel
Mezzogiorno e a solo 0,746 nel resto d'Italia. In un'altra nota di prossima
pubblicazione, mostriamo che ciò è vero dagli anni cinquanta del secolo scorso
ed è la ragione principale per la quale la bilancia commerciale del Mezzogiorno
è costantemente in deficit, per cifre anch'esse tipicamente comprese fra il 15 e
il 20% del PIL.
Conclusione e problemi irrisolti. Alla luce di queste
considerazioni la dichiarazione del presidente della Svimez circa i 60 miliardi
"sottratti" ogni anno dal Nord al Sud - al netto dei gravi limiti dei dati
sottostanti - è vera soltanto se si considera l'intera P.A. allargata, senza
tenere conto che una larga parte delle sue spese non possono essere distribuite
diversamente sul territorio (partecipate e pensioni). Questa dichiarazione è
infatti ispirata ad un'interpretazione estremamente estensiva del principio
costituzionale di perequazione della spesa pubblica, in quanto sottintende che
la distribuzione geografica della spesa pro capite dovrebbe essere simile in
tutte le aree del paese, includendo nella valutazione anche le imprese
partecipate che operano con criteri di mercato e le pensioni che non possono che
dipendere dai redditi passati. In ogni caso, per quanto riguarda la spesa della
P.A. in senso stretto - e quindi la spesa che il decisore politico può decidere
dove allocare - già al netto delle pensioni il Meridione non appare
discriminato; se poi si corregge per il costo della vita sembrerebbe addirittura
favorito. Questo trattamento, equo nominalmente e vantaggioso a Parità di Potere
d'Acquisto si traduce in ingenti trasferimenti da parte delle amministrazioni
pubbliche dal Centro-Nord verso il Mezzogiorno. Questa considerazione è
puramente quantitativa e non è detto che "più sia meglio": come mostrano gli
indicatori della stessa Svimez, la qualità dei servizi pubblici al Sud è
generalmente peggiore; quindi l'assenza di discriminazione nell'ammontare di
risorse non esclude una carenza di servizi, anche essenziali, che pesa
negativamente sulle persone e sulle imprese di molte aree del Mezzogiorno.
Giampaolo Galli e Giulio Gottardo, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
L'operazione verità ritorna in Parlamento.
Claudio Marincola su Il Quotidiano del Sud il 30 ottobre 2020.
Nel Paese dei bugiardi i cani miagolano e i gatti abbaiano. Poi arriva qualcuno
che, come il Gelsomino del racconto di Gianni Rodari, inizia a dire pane al pane
e vino e al vino e la verità viene a galla. Una favola? No. La storia della
ripartizione delle risorse pubbliche tra il Nord ed il Sud e del modo in cui per
anni è stato perpetrato lo “scippo”. Una battaglia che questo giornale porta
avanti da sempre e che ora verrà affidata a livello istituzionale ad una sorta
di “sottocommissione” formata da Banca d’Italia, Istat e Upb (Ufficio
parlamentare di bilancio). Poi succede che grazie ad un articolo («Quei
privilegi differenziati che come la bussola indicano sempre il Nord», a firma
del professor Adriano Giannola, presidente della Svimez (Associazione per lo
sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), la questione finisca in Parlamento. E
che un’interrogazione firmata dal senatore pentastellato Vincenzo Presutto e da
altri 23 senatori M5S e la senatrice di Forza Italia Gabriella Giammarco,
finisca sul tavolo del ministro dell’Economia chiamato a rispondere circa
l’esistenza di una forte sperequazione tra Nord e Sud nell’allocazione della
spesa pubblica a tutto vantaggio del primo: “il ministro Roberto Gualtieri
chiarisca…”. Arriva in Parlamento. O meglio torna. La commissione bicamerale
d’inchiesta sul sistema bancario guidata dalla deputata Carla Ruocco aveva
infatti già avviato una indagine conoscitiva durata 6 mesi sui sistemi tributari
delle regioni convocando in audizione tra l’ altro anche il ministro per gli
affari regionali Francesco Boccia. Il primo passo dell’ operazione verità per
smascherare le storture che l’attuazione del federalismo fiscale nella
prospettiva dell’autonomia differenziata si trascina dietro.
LA CAMPAGNA PREVENTIVA CONTRO IL SUD: “EVITIAMO SPRECHI”. Il Nord
riceve annualmente 60 miliardi di euro più del Sud in termini di risorse
complessive. Il costo delle erogazioni pensionistiche non coperto dai versamenti
contributivi che va incluso nella valutazione della spesa pubblica attribuibile
ai diversi territori e non spalmato sulla fiscalità generale. «Il Nord – si
legge nell’interrogazione – riceve maggiori erogazioni per pensioni anticipate
(metodo contributivo) grazie ad una platea di individui che, essendo entrati
prima nel mondo del lavoro, godono della pensione per un numero maggiore di anni
e che in genere hanno pensioni di importo superiore rispetto alle pensioni di
vecchiaia». Va calcolato il complesso della spesa pubblica attivata da un
aggregato pubblico ampio, insieme delle amministrazioni centrali, delle
amministrazioni locali, degli enti previdenziali e delle società partecipate. Le
quali, di norma, attivano spese per importi maggiori al Nord rispetto al Sud.
Sarà un caso da qualche mese a questa parte – fatalmente in vista del Recovery
fund – è partita una campagna in direzione opposta e contraria. Prima il
professor Andrea Giovanardi su Il Foglio, poi Giampaolo Galli e Giulio Gottardo
(Osservatorio sui conti pubblici italiani) su Repubblica, hanno sostenuto che
l’operatore pubblico non può decidere come allocare a livello territoriale. Né
la spesa pensionistica (che dipende dai contributi versati), né le imprese
pubbliche (che dipendono dalle regole del mercato. Con il paradosso che, essendo
al Sud il costo della vita notevolmente inferiore rispetto al Nord, il
Mezzogiorno risulterebbe addirittura favorito (sig..). Fin qui il dibattito
sulla diversa allocazione delle risorse tra Nord e Sud. Con l’aggiunta di
qualche ulteriore intervento finalizzato a scoraggiare l’utilizzo dei fondi del
programma Next Generation Eu nel Mezzogiorno. Sud. in quanto – hanno sostenuto
di recente Francesco Drago e Lorenza Reichlin – nel Mezzogiorno non ci sarebbero
gli interlocutori adatti, i soggetti che «possano dare le gambe». Per cui
meglio, la conclusione meglio «evitare sprechi».
PRESUTTO: RISPETTARE ALMENO LA CLAUSOLA DEL 34%. Quanto tutto
questo chiacchiericcio scomposto si ricolleghi al tema dell’autonomia
differenziata, alla capacità fiscale di una regione e ai meccanismi perequativi
è di tutta evidenza. Vincenzo Presutto è il vicepresidente della Commissione
parlamentare bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale. Fa parte del
gruppo dirigente pentastellato con la qualifica di “facilitatore” in ambito
economico. Ma va da sé che l’interrogazione presentata ieri richiede una
risposta tutta politica. Chiede in che modo si vogliano utilizzare i 209 i
miliardi di euro che l’Unione europea ha concesso all’Italia. La quota più alta
in assoluto, di cui una parte consistente per rilanciare lo sviluppo delle aree
più arretrate. E chi è più arretrato del nostro Meridione, dove l’ultima serie
di grandi interventi risale agli anni ’50, gli anni in cui operava la Cassa del
Mezzogiorno? «L’Italia – ricorda Presutto – sarebbe chiamata per lo meno a
rispettare la clausola del 34 per cento, il che darebbe al Mezzogiorno la
disponibilità di 71 miliardi di euro, percentuale che allo stato dei fatti
risulta inadeguata a colmare il divario tra Nord e Sud. Per la prima volta
nascerà una sorta di sottocommissione. Un gruppo composto da un rappresentante
di Banca d’Italia, Istat e l’Ufficio parlamentare di bilancio per stabilire i
criteri e chiarire la discordanza tra le valutazioni della Svimez e quelle
dell’Osservatorio dei conti pubblici italiani e i dati di spese fonte CPT (conti
pubblici territoriali elaborati dall’Agenzia della coesione)». Da qui
l’opportunità di un confronto anche sul piano metodologico per un corretto
utilizzo dell’informazione statistica nella valutazione dei flussi territoriali
delle spese e delle entrate pubbliche. Si chiede di fare chiarezza sulla
ripartizione della spesa pubblica, fornire voci di spesa, valutare l’intervento
pubblico per far luce sul reale gap esistente, superando qualsiasi
contrapposizione di carattere accademico, e togliendo qualsiasi dubbio
interpretativo. Quello che noi abbiamo “operazione verità”.
Ennesimo
colpo al Sud: altri 70 milioni dirottati al Nord.
Fondi Ue,
Italia bocciata dalla Corte dei conti europea. Lia Romagno su Il Quotidiano del
Sud l'11 novembre 2020. Un nuovo “sgarbo” sembra profilarsi nei confronti del
Mezzogiorno a vantaggio del Nord, una sottrazione di risorse che vale 70
milioni. A segnalarlo è stato il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale
del dipartimento Sud di Forza Italia: «Per dare un nuovo colpo ai bilanci dei
territori del Sud mancava solo l’adozione dei nuovi criteri per la revisione
della metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni appartenenti alle Regioni a
statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti». L’obiettivo, si è
sostenuto, sarebbe costruire meglio i piani finanziari dei Comuni per lo
smaltimento dei rifiuti. Ma la sostanza, ha avvertito Russo, « è che è destinata
a incidere, a danno degli enti locali del Sud, sulla ripartizione del fondo di
solidarietà perequativo nazionale dei comuni. Il risultato è, infatti, che i
grandi centri del Nord saranno ulteriormente avvantaggiati. Questo governo
quando c’è da togliere al Meridione è rapido ed efficiente, quando, invece, c’è
da definire i fabbisogni standard sul fronte dei trasporti, degli asili o della
salute cincischia, rallenta o ritarda. Ci dicono che questa sperequazione
ulteriore valga poco in termini economici e la chiamano sterilizzazione. Per me
è un altro regalo al Nord che vale 70 milioni di euro tolti al Sud».
I FONDI
STRUTTURALI. Ieri, intanto, la Corte dei conti europea ha bacchettato l’Italia
per l’uso dei fondi strutturali. Il Paese è al penultimo posto in Europa per
l’utilizzo dei fondi strutturali europei nel 2019. Con il 30,7% di fondi spesi –
rispetto a una media europea del 40% – condivide la posizione di fanalino di
coda con la Croazia, che fa anche peggio arrivando solo al 30% e si aggiudica
l’ultimo posto nella classifica che vede in testa la Finlandia con il 66,2%,
seguita dall’Irlanda con il 60,6% e dal Lussemburgo con il 57%.
LA CLASSIFICA.
La “pagella” – che suona come l’ennesima reprimenda nei confronti del Paese in
merito alla sua capacità di spesa, alimentando le “perplessità” dei Paesi
frugali sulla reale possibilità di mettere a terra le risorse del Next
Generation Eu – compare nella relazione in cui la Corte europea paragona
l’assorbimento dei fondi del 2019 e del 2012, rappresentativi dei cicli di spesa
a valere sui bilanci settennali della Ue per il 2007-2013 e il 2014-2020. La
“giustificazione”, accompagnata dai numeri a sostegno dell’impegno per un
cambiamento di rotta, arriva dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in
un’audizione in commissione Politiche europee del Senato.
La dotazione
complessiva di tutti i Programmi dell’attuale ciclo vale oltre 53 miliardi, due
terzi dei quali sono destinati alle regioni del Sud, sia meno sviluppate sia in
transizione, ha ricordato il ministro. «I ritardi accumulati in partenza dal
ciclo di programmazione ne hanno reso complessa l’attuazione, ma negli ultimi
mesi abbiamo registrato importanti segnali di accelerazione – ha detto
Provenzano – Diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti, tutti i
Programmi operativi hanno raggiunto le soglie minime di spesa previste al 31
dicembre 2019».
LA
CONTESTAZIONE. I ritardi ci sono stati, quindi, ma il ministro contesta la
comparazione con il ciclo precedente adottata dalla Corte dei conti europei per
due motivi: innanzitutto, per «il ritardato avvio del ciclo 2014-20, a seguito
di un negoziato molto lungo, mentre lo sforzo delle Amministrazioni regionali e
centrali era ancora tutto indirizzato alla chiusura del ciclo precedente onde
evitare di perdere risorse. E poi la regola dell’N+3 che dilata di un ulteriore
anno i tempi di assorbimento rispetto al ciclo precedente (quando valeva
l’N+2)». Tuttavia, ha riconosciuto il ministro, «nonostante il raggiungimento
del target, la situazione di avanzamento della spesa a fine 2019 non era affatto
soddisfacente e si attestava a un dato tra i più bassi dell’intera Ue. In
particolare, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Centro Nord era pari,
rispettivamente a circa il 26% e il 32%». Il monitoraggio Igrue, aggiornato al
30 agosto, mostra «un apprezzabile miglioramento», destinato, secondo
Provenzano, a migliorare ulteriormente quando saranno «visibili» gli effetti
della riprogrammazione delle risorse nell’emergenza Covid 19 operata con le
Regioni per circa 11,5 miliardi. Da febbraio ad agosto, intanto, risulta una
crescita degli impegni dal 60,5% al 69,2 e dei pagamenti dal 31,7% al 39,2%
dell’intera spesa programmata, che vale 3 miliardi. I programmi procedono in
maniera disomogenea, alcuni sono particolarmente in ritardo, come i Por di
Calabria, Marche e Abruzzo in ambito Fers, o di Sicilia, Campania e Abruzzo per
il Fse. E i comunque riguardano anche le amministrazioni centrali. Per quanto
riguarda l’obiettivo di spesa di fine 2020, stimato in 12,1 miliardi di quota
Ue, «restano da certificare e richiedere rimborsi per circa 2 miliardi di
contributi comunitari», pertanto l’Italia, ha affermato il ministro, è «in linea
con gli impegni previsti».
IL CICLO
2021-2027. Intanto, per quanto riguarda il prossimo ciclo 2021-2027, ha detto
Provenzano, l’Italia è tra i pochi Paesi che vede aumentare la dotazione di
Fondi Ue di 6,8 miliardi. Inoltre, ha aggiunto, «a seguito di un lungo confronto
con il Mef abbiamo deciso» in legge di Bilancio 2021 «di aumentare l’impegno
finanziario di cofinanziamento nazionale dei programmi di uso dei fondi
strutturali Ue rispetto ai minimi fissati dalla Commissione, così riequilibrare
e aumentare il cofinanziamento anche nelle Regioni meno sviluppate e in quelle
in transizione. Questo ci porterà ad avere una dotazione di fondi strutturali,
tra cofinanziamento europeo e cofinanziamenti nazionali, di circa 80 miliardi di
euro. Se ci pensate, è un ammontare di aiuti superiore alla quota dei sussidi,
ad esempio, della Recovery and Resilience Facility». Quanto al Next Generation
Eu, il ministro ha ribadito la necessità che la clausola del 34% per il Sud sia
«applicata anche alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma –
ha sottolineato – come una quota minima».
TRASPORTI,
I FURBETTI DELLE REGIONI. Il virus sul bus porta i soldi al Nord.
Roberto
Napoletano il 14 ottobre 2020 su Il Quotidiano del Sud. I governatori della
terza camera dello Stato fanno finta che devono rispettare il tetto dell’80% e
chiedono una compensazione per il restante 20%, ma i pulmini viaggiano zeppi, le
persone sono strette come sardine. Per cui gli incassi saranno quelli di sempre,
ma a questi incassi vogliono aggiungere pure le compensazioni. Che federalismo è
quello che mette la cassa dei ricchi prima di ogni cosa e che ignora la
perequazione perfino in tempi di Pandemia? Governano i governatori. Sua Maestà,
Stefano Bonaccini, parla e si muove come uno specialissimo Presidente del Senato
delle Regioni di impronta monarchica. Nessuno gli ha dato questo mandato, ma lui
lo esercita e lo fa a modo suo. Prima i ricchi, poi i poveri. Volessimo
affrontare per una volta un tema serio: come mai gli investimenti in sanità sono
pari a 85 euro pro capite per ogni cittadino emiliano-romagnolo e a 16 euro pro
capite per ogni cittadino calabrese? Buon ultimi a certificare questi
numeri-verità sono arrivati i ricercatori del Crea di Tor Vergata che si sono
addirittura spinti a dire che sull’efficienza delle singole regioni pesa per il
40% la quantità di finanziamenti ricevuti. Chissà che cosa si inventeranno i
professorini in servizio permanente effettivo della squadra della diseguaglianza
per negare questa elementare evidenza! Sono arrivati al punto di mettere in
discussione la statistica nazionale pur di proteggere l’indifendibile.
Francamente impressiona. Per chi come questo giornale sottolinea dal primo
giorno di uscita la gravità della questione istituzionale meridionale per le
evidentissime incapacità della sua classe dirigente c’è proprio da sorridere nel
vedere come ci si affatica contro ogni regola e ogni logica a smontare quello
che non è smontabile. Vale a dire che, grazie al trucco della spesa storica, in
sanità scuola e trasporti si fanno figli e figliastri fino al punto che le
Regioni del Nord si azzannano perché lo Stato rifinanzi i servizi aggiuntivi di
pulmini e scuola-bus mentre il Sud questi bus navetta non li ha mai visti
nemmeno in cartolina. Scusate, una domanda: ma questa apertura delle scuole Sua
Maestà Bonaccini della Sinistra Padronale e i pari-dignitari Fontana e Zaia
della Destra a trazione leghista se la aspettavano o no? Sono stati presi in
contropiede, come mai? A queste linee aggiuntive, visto che loro i bus navetta
ce li hanno, non potevano pensarci prima? Ora Zaia vuole la didattica a
distanza, come facciamo con le aree interne del Nord e quasi tutto il Sud che la
banda ultra veloce se la possono solo sognare? Ma forse forse, siamo arrivati al
punto che non esiste più l’impresa globale o l’impresa nazionale, ma solo quella
regionale pagata dagli altri e, cioè, sovvenzionata dallo Stato? Che federalismo
è quello che mette la cassa dei ricchi prima di ogni cosa? Che ignora la
perequazione perfino in tempi di Pandemia. Che arriva addirittura a fare affari
sul Covid. Sui trasporti locali i controlli sono una finzione, non esistono, non
sono stati proprio previsti, probabilmente neppure potrebbero funzionare. I ras
regionali non li vogliono svuotare, i loro bus. Ovviamente non esiste il
biglietto nominativo, zero tracciabilità. Morale: fanno finta che devono
rispettare il tetto dell’ottanta per cento e chiedono una compensazione per il
restante 20%, ma i pulmini viaggiano zeppi, le persone sono strette come
sardine. Per cui gli incassi saranno quelli di sempre, ma a questi incassi
vogliono aggiungere le compensazioni negate a ristoratori e operatori turistici,
questi sì, davvero in brache di tela. Non sappiamo come fare a rinnovare la
cassa integrazione e, al di là degli annunci fuori misura e fuori luogo di chi
guida la politica economica italiana, la Grande Depressione avanza, e il nostro
problema è quello di soddisfare le pretese di lorsignori governatori! Gli stessi
che fanno le pulci al governo per qualunque tipo di provvedimento prenda ma non
hanno le carte in regola per rimproverare alcunché, e non hanno nemmeno la
dignità morale di ragionare in termini solidaristici. Quando la finiranno di
rivendicare le loro autonomie e le loro competenze sul territorio solo se devono
bussare a quattrini? Ci ha colpito che la Francia nel suo piano nazionale di
Recovery Fund ha assegnato la quota più rilevante (36 miliardi) alla coesione
sociale e territoriale, lo ha fatto per tabulas e senza grandi proclami. Questo
accade nella nazione della città-Stato per eccellenza. Presidente Conte, non c’è
più tempo per traccheggiare e fare compromessi con i mille cantastorie
dell’interesse predominante e del miope privilegio dei ricchi. Per noi il
Recovery Plan deve avere una sola declinazione: l’equità sociale e territoriale
e il superamento di una frammentazione decisionale che ha nella incapacità di
molti governatori meridionali e nell’arroganza di molti governatori del Nord la
causa prima del declino strutturale italiano.
Resta un mistero lo stato di soggezione dei governatori del
Sud nei confronti di quelli del Nord.
Roberto Napoletano su Il Quotidiano del Sud il 10 ottobre 2020.
Invece di elemosinare posti di terapia intensiva e qualche assunzione in più
nella sanità per fare fronte alla seconda ondata della pandemia, perché i Capi
delle Regioni del Sud non si rivolgono tutti insieme alla Corte Costituzionale
affinché cessi lo sconcio della spesa storica e si riconoscano finalmente gli
investimenti dovuti in sanità e scuola? Che cosa impedisce loro di chiedere
l’attuazione della legge Calderoli e vedere finalmente riconosciuti i diritti di
cittadinanza degli abitanti delle loro comunità? E che dire del ministro
Gualtieri che parla dell’economia italiana come di una specie di turbo che
umilia le grandi economie del mondo! Ma dove vive? Siamo allibiti. Viviamo i
giorni durissimi della seconda ondata della Pandemia. Il mondo è tornato a
tremare, noi non sappiamo che cosa ci aspetta in casa. Lo sceriffo De Luca ha
voluto più di tutti chiudere la Campania quando il Covid non c’era e rischia ora
di doverla richiudere perché ha terrorizzato di nuovo i suoi cittadini. Che si
sono rimessi tutti in fila a fare il tampone rischiando di moltiplicare i
contagi perché nulla è stato fatto in questi lunghissimi sei mesi per garantire
servizi celeri e rafforzare la medicina sul territorio. Ovviamente l’economia
della regione più importante del Mezzogiorno è stata chiusa, ma nessuno se ne
cura perché i professionisti dell’anti-Covid dispongono della vita umana e della
vita economica delle persone e i Capi delle Regioni sanno solo presentare il
conto allo Stato, pavoneggiarsi in tv da mattina a sera, insidiare Crozza come
imitatore professionale e, in genere, come showman. I ristoranti sono di nuovo
vuoti, il trasporto veloce e quello aereo sono in ginocchio. Il mondo
dell’intrattenimento ha fatto finta di ripartire, la scuola se la è cavata
meglio del previsto anche se soffre e le Italie pure nelle sofferenze sono
ovviamente due. Il pubblico impiego ha persone di valore che si sacrificano, ma
non ha gli strumenti digitali per fare da casa quello che faceva in ufficio e dà
il suo contributo silenzioso al lento spegnersi della piccola economia di
consumi. Tutti i dipendenti privati che sono in cassa integrazione sono
consapevoli che l’anno prossimo rischiano di rimanere a casa. Il quadro,
insomma, è nerissimo, ma non serio. Al punto che per unire farsa alla farsa
tocca di vedere un ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che a Porta a
Porta, sotto gli occhi sbigottiti di Bruno Vespa, parla dell’economia italiana
come di una specie di turbo che umilia le grandi economie del mondo. Scusatemi,
ma dove vive? E ancora: che cosa deve accadere per capire che il gallismo dei
Capi delle Regioni porta l’Italia alla rovina? È possibile continuare, anche ai
tempi del Covid, in questo circuito perverso di miopi egoismi che non è
nient’altro che l’Italia ridotta in venti staterelli? Ma quale dignità possono
avere davanti ai nostri occhi i Capi delle Regioni del Nord che si nascondono
dietro lo scudo della spesa storica per fare incetta di spesa pubblica sociale e
infrastrutturale e, ancora di più, i Capi delle Regioni del Sud che elemosinano
posti di terapia intensiva e qualche assunzione in più nella sanità ma si
guardano bene dal ricorrere alla Corte costituzionale per chiedere l’attuazione
della legge Calderoli e vedere finalmente riconosciuti i diritti di cittadinanza
degli abitanti delle loro comunità? In quali mani siamo finiti! Che cosa
impedisce ai Capi delle Regioni del Sud di rivolgersi tutti insieme alla Corte
costituzionale perché cessi lo sconcio della spesa storica e si riconoscano
finalmente gli investimenti dovuti in sanità e scuola? Possibile che neppure
l’occasione storica del nuovo piano Marshall europeo – le somme oggi in gioco
sono molto di più di quelle di allora – permetta di riequilibrare la spesa
sociale e di avviare la riunificazione infrastrutturale immateriale e materiale
delle due Italie? Per noi che in assoluta solitudine abbiamo condotto
l’operazione verità e denunciato la grande balla di un Sud che vive sulle spalle
del Nord, resta un mistero insondabile lo stato di soggezione dei governatori
del Sud nei confronti dei governatori del Nord. Non si tratta di dichiarare
guerra a nessuno, ma di rinunciare alla pratica poco dignitosa di presentarsi
sempre con il cappello in mano e di imboccare la via maestra che consente di
ristabilire la verità una volta per tutte. Nell’interesse dei ricchi come dei
poveri. Se non si passa da qui l’Italia tutta conoscerà la fase estrema del suo
lunghissimo declino e uscirà dal novero delle grandi economie industrializzate.
SUD, DOVE TUTTO CIO’ CHE FA LO STATO E’ MENO DELLA META’ DEL
NORD. Raffaele Vescera il 04.10.2020 su Il Movimento
24 agosto. La differenza di dotazione delle infrastrutture tra Nord e Sud è
semplicemente scandalosa, come si evince dalla seguente tabella:
Chilometri di autostrada ogni 100 kmq. Nel Nord-Ovest 3,3%. Nel
Sud l’1,7%.
Chilometri di ferrovia ogni 100 kmq. Nel Nord-Ovest del 7,2%. Al
Sud del 4,7%.
Alta velocità ferroviaria, nel Nord è del 9,6. Nel Sud del 1,4%.
Aeroporti: Tra Albenga e Trieste, ben 17, al Nord 1 x 50 km. Tra
Napoli e Bari solo 1, al Sud 1 x 300 km.
Porti: Porto franco a Trieste, inclusione del porto di Genova
nella nuova “via della seta”, con esclusione dei porti del Sud, Messina, Gioia
Tauro, Taranto etc. Ma questo è il meno, tra Bari e Napoli non esiste un solo
treno che colleghi le due maggiori città del Sud continentale, mentre da Bari a
Reggio Calabria occorrono ben 14 ore di treno per fare 450 km, a una velocità
media di 30 km l’ora. Il nordico ministro Delrio, nel precedente piano
ferroviario da 5 miliardi di euro ne ha destinati il 95% al Nord per 69 progetti
e 2 al Sud, promettendo di intervenire per migliorare la condizione della
ferrovia jonica, chiudendola però per 4 anni, il sospetto che voglia chiuderla
per sempre è legittimo. E sia, tutto ciò è parte della Questione meridionale,
mentre i media denunciano scandalizzati presunti sprechi al Sud, al Nord si
investe e si spreca per davvero, dall’inutile autostrada doppione Bre-Be-Mi,
alla pedemontana lombarda per la spesa di svariati miliardi di euro, fino al
vergognoso costo dell’alta velocità al Nord di 67 milioni di euro a km, la
stessa che in Francia è costata 10 e in Spagna 9. Alta velocità italiana che si
ferma a metà dello Stivale, fatta con i soldi stanziati per farla arrivare a
Lecce sulla dorsale adriatica a Palermo su quella tirrenica. Tutti ci chiediamo
come mai il Sud non si ribelli unito a fronte di tale vergogna, Antonio Gramsci
ne spiegò le ragioni nel suo “Il Risorgimento”, eccole, valide ancora oggi: “Il
programma di Giolitti e dei liberali democratici tendeva a creare nel Nord un
blocco “urbano” (di industriali e operai) che fosse la base di un sistema
protezionistico e rafforzasse l’economia e l’egemonia settentrionale. Il
Mezzogiorno era ridotto a un mercato di vendita semicoloniale, a una fonte di
risparmi e di imposte ed era tenuto “disciplinato” con due serie di misure:
misure poliziesche di repressione spietata di ogni movimento di massa con gli
eccidi periodici di contadini… Misure poliziesche-politiche con i favori
personali al ceto degli “intellettuali” o “paglietta”, sotto forma di impieghi
nelle pubbliche amministrazioni, di permesso di saccheggio impunito delle
amministrazioni locali…cioè di incorporamento “a titolo personale” degli
elementi più attivi meridionali nel personale dirigente statale, con particolari
privilegi giudiziari, burocratici etc. Così lo strato sociale che avrebbe potuto
organizzare l’endemico malcontento meridionale, diventava invece lo strumento
della politica settentrionale, un suo accessorio di polizia privata.” Che altro
aggiungere alle esaustive parole di Gramsci? Solo una, la mafia, mai combattuta
dallo Stato, in quanto anch’essa accessorio di polizia segreta utile alla
spoliazione del territorio meridionale e al successivo trasferimento di capitali
da investire al Nord.
LE DUE ITALIE ANCHE PER I TAMPONI. IL SUD SOTTO LA MEDIA
NAZIONALE. L’obiettivo dei 400mila al giorno è ancora
lontano e le procedure sono ancora lente e farraginose. Luca La Mantia su Il
Quotidiano del Sud il 10 ottobre 2020. Milioni di mascherine sfilano per strade
delle città italiane in ossequio all’ultimo Dpcm adottato per fronteggiare
l’emergenza coronavirus dopo quasi 10 settimane di ricrescita dei contagi
giornalieri. Ma sull’efficacia della protezione, indossata all’aperto, la
comunità scientifica si è più volte divisa. Lo stesso Andrea Crisanti – non
certo annoverabile nel partito dei negazionisti – ha recentemente spiegato a Sky
Tg24 che la stessa, da sola, non è sufficiente per risolvere il problema.
NUMERO MAGGIORE. Il microbiologo da mesi sostiene, infatti, che
l’unica vera arma contro il Covid19 sia estendere il numero di tamponi
effettuati fino a portarlo a quota 400mila ogni 24 ore. L’auspicio si scontra,
però, con la realtà quotidiana dei test realizzati, che fanno segnare un record
quando si avvicinano alle 130mila unità (come accaduto ieri). Un dato che, fra
l’altro, risente dei mezzi e dell’efficienza dei singoli sistemi sanitari
regionali, col risultato che il Paese – per quanto riguarda l’aggressione al
virus – si presenta più che mai a macchia di leopardo. La questione non è di
poco conto: aumentare la quantità di tamponi significa non solo intercettare per
tempo contagi e potenziali focolai ma anche valutare l’andamento e l’incidenza
dell’epidemia in termini statistici. A oggi gli unici dati “reali”, a parte i
decessi, sono quelli che derivano dalle ospedalizzazioni (4.473 secondo l’ultimo
bollettino) e – all’interno di queste – dalle terapie intensive (387). Va da sé
che questi numeri hanno un peso maggiore o minore nella valutazione della
gravità della pandemia in Italia a seconda della quantità di persone attualmente
positive. Le oltre 70mila registrate ieri sono, quasi certamente, solo una
frazione di un volume più ampio, i cui contorni possono essere definiti solo
allargando il campione di soggetti testati. Semplificando: se in Italia ci
fossero 10 ricoverati a fronte di 1000 positivi la situazione sarebbe meno grave
rispetto a un rapporto di 10 a 100.
IL REPORT E I RITARDI. Ma sul punto siamo ancora indietro, specie
in alcune zone del Paese. Lo dimostra l’ultimo istant report sul Covid19
realizzato dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari
(Altems) dell’Università cattolica del Sacro Cuore. A oggi, spiega lo studio, la
media nazionale di tamponi effettuati ogni mille abitanti è pari a 10,13. Fra le
regioni che superano questo valore non ce n’è nemmeno una del Mezzogiorno. In
testa troviamo il Veneto con 17,67; seguono Pa di Trento (17,55), Friuli Venezia
Giulia (16,07), Pa di Bolzano (14,64), Umbria (12,68), Toscana (12,5), Emilia
Romagna (12,27), Liguria (12,13) e Lazio (12,05). Se si eccettuano Lombardia
(appena sotto il coefficiente mediano con 10,12), Abruzzo, Piemonte Valle
d’Aosta e Marche, i valori sotto la media nazionale sono interamente appannaggio
di Sud e Isole. La peggiore è la Puglia (5,32), poi Calabria (5,54) e Sicilia
(6,39). La Campania, che sta facendo registrare continui boom di contagi, non fa
meglio (7,17). Le regioni dunque, sottolinea il documento allegato al report,
“continuano a differenziarsi in termini di strategia di ricerca del virus
attraverso i tamponi, anche se il trend nazionale è in aumento dalle scorse
settimane”. Sullo sfondo dell’andamento altalenante dei tamponi è la questione
dei costi. La stessa Altems ha calcolato che dal 24 febbraio ai primi di
settembre la spesa sostenuta dal Sistema sanitario per l’individuazione dei casi
di Covid è stata pari a oltre 300 milioni di euro. Ipotizzando una media di 35
euro per tampone – il prezzo in realtà varia di regione in regione – la stessa
Scuola ha calcolato quanto viene investito in ciascun distretto territoriale
nell’attività di ricerca del virus. In testa alla classifica questa volta
troviamo la Lombardia dove, nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre, sono
stati spesi circa 4 milioni e 500mila euro. Seguono il Veneto (poco meno di 3
milioni), il Lazio (più di 2 milioni e 500 mila) e l’Emilia Romagna (quasi 2
milioni e 400mila). In coda c’è la Valle d’Aosta – anche per una questione
legata all’esiguità della popolazione – ma subito dopo troviamo due regioni del
Sud: Molise (neanche 70mila euro) e Basilicata (poco più di 139mila e 500). Nel
panorama del Mezzogiorno la regione dove si è speso di più nello stesso periodo
è la Campania (oltre un milione e mezzo di euro). Un’inchiesta dell’associazione
Altroconsumo offre, invece, un quadro interessante sui cosiddetti “tamponi
volontari” eseguiti da persone che sospettano di essere entrate in contatto con
potenziali contagiati o accusano sintomi riconducibili al Covid. Per accorciare
i tempi di attesa del Ssn questi individui si rivolgono spesso a laboratori
privati, nei quali i costi risultano spesso elevati. L’indagine ha riguardato
154 strutture di questo tipo situate in sei regioni. In Lombardia il prezzo
richiesto può andare dai 70 ai 152 euro, in Veneto dai 65 ai 102. Dalla Campania
– unico territorio meridionale entrato nel campo d’analisi – non sono arrivati
dati utili allo studio per quanto riguarda i tamponi. Tuttavia per l’alternativo
test sierologico possono essere chiesti dai 25 ai 60 euro. Costi elevati un po’
ovunque quindi. Ma sull’efficienza delle strutture anche in questo caso emergono
importanti differenze fra Nord e Sud. “Più di tre volte su dieci l’appuntamento
è addirittura per il giorno stesso – afferma Altroconsumo -. Non mancano però le
eccezioni: in Campania e in Lazio, per esempio, nella prima metà di settembre
non era possibile eseguire il tampone privatamente”.
IL VERO TIMORE. I dati ancora bassi relativi all’attività di
testing preoccupano in vista dell’incipiente stagione delle influenze che
rischia di mandare in tilt il Ssn. «Abbiamo speso miliardi per il bonus bici e i
banchi, invece di investirli per creare un sistema sanitario di sorveglianza– si
è lamentato di recente Crisanti a Repubblica – a fine agosto ho presentato un
piano per quadruplicare i tamponi al governo che lo ha sottoposto al Cts. Poi
non ne ho saputo più nulla»
La sanità iniqua smascherata anche dal virus: per i pazienti
del Nord ci sono sempre più soldi. Complice il sistema
della “spesa storica” che lo penalizza, il Sud continua a ricevere risorse
insufficienti dallo Stato. Lia Romagno su Il Quotidiano del Sud il 10 ottobre
2020. I numeri del turismo sanitario dal Sud verso il Nord raccontano da anni la
“malattia” del sistema sanitario del Mezzogiorno con cui i suoi cittadini sono
costretti quotidianamente a fare i conti per assicurarsi le cure. La pandemia ha
mostrato all’intero Paese la gravità della situazione, certificando che il
diritto alla salute si declina su base territoriale. La prima ondata è stata
“contenuta” nel meridione, ma la seconda si annuncia molto più minacciosa, come
dimostra il boom dei contagi in Campania e il tasso di ospedalizzazione dei
pazienti Covid al Sud rispetto alla media. Mettendo alla prova un sistema già in
forte sofferenza. E che da anni è costretto a fare i conti con una dotazione di
risorse da parte dello Stato inferiore rispetto al resto del Paese, come
dimostra anche la ripartizione del Fondo sanitario nazionale di quest’anno.
I NUMERI DEL DIVARIO. Qualche numero: per un pugliese, ad
esempio, al termine del 2020 lo Stato spenderà complessivamente 1.826 euro pro
capite, contro i 1.918 riservati a un emiliano e i 1.877 a un veneto. Per ogni
lombardo, lo Stato destina 1.880 euro; per un campano, invece, 1.827. La
Calabria veste i panni della “Cenerentola”, con appena 1.800 euro per ogni suo
cittadino contro i 1.916 per ciascun friulano, i 1.935 di spesa pro capite del
Piemonte o i 1.917 della Toscana. Come accade ormai da oltre 15 anni, il Nord
continua a prendere più soldi per i suoi ospedali, complice il meccanismo della
spesa storica. Alla Puglia, 4,1 milioni di abitanti, dei 113,3 miliardi
complessivi del fondo sanitario 2020, sono stati riservati 7,49 miliardi;
l’Emilia Romagna (4,4 milioni di residenti) riceverà 8,44 miliardi: quasi un
miliardo in più nonostante una popolazione quasi identica. Prendendo in
considerazione il Veneto (4,9 milioni di abitanti) la sproporzione resta, visto
che la Regione di Zaia incassa 9,2 miliardi, quasi due in più rispetto alla
regione di Michele Emiliano. Il quadro della spesa pro capite fotografa
chiaramente le disparità: per la salute e le cure di un pugliese lo Stato
investe 1.826 euro, contro i 1.918 riservati ad un emiliano e 1.877 per un
veneto. La Campania, 5,8 milioni di residenti, avrà 10,6 miliardi: 1.827 euro
pro capite, mentre la Lombardia, che conta 10 milioni di residenti, riceve 18,8
miliardi – 1.880 euro per ogni sua cittadino – per la sua sanità che pur non ha
dato una bella prova di sé durante l’emergenza Coronavirus. La Calabria (quasi
due milioni di abitanti) ottiene nella ripartizione del fondo sanitario
nazionale da 113 miliardi solamente 3,6 miliardi: 1.800 euro per ogni cittadino.
Ancora: il Friuli Venezia Giulia, che conta 1,2 milioni di residenti, incassa
2,33 miliardi: 1.916 euro per ogni suo cittadino; il Piemonte, che pure negli
ultimi anni come ha certificato dalla Corte dei Conti, non ha brillato
nell’obiettivo di tenere sotto controllo la spesa sanitaria, incassa dallo Stato
8,33 miliardi per 4,35 milioni di abitanti: circa 1.935 euro per residente.
Infine, la Toscana, 3,73 milioni di abitanti e 7,1 miliardi: 1.917 euro pro
capite.
L’INCREMENTO. Negli ultimi 10 anni, poi, sempre le regioni del
Nord hanno registrato un incremento percentuale del Fondo sanitario nazionale
maggiore rispetto alle altre: tra il 2010 e il 2020, infatti, la quota della
Lombardia è cresciuta dell’11,4%, l’Emilia Romagna del 9,9%; 8,2% in più per la
Toscana. La Basilicata, al contrario, ha avuto un incremento percentuale molto
più modesto (+4,9%); l’Abruzzo del 6,7%; Calabria +5,7%; la Puglia e la Campania
di circa l’8,1%. Non solo: dal 2012 al 2017, nella ripartizione del Fondo
sanitario nazionale, sei regioni settentrinali hanno visto aumentare la loro
quota, mediamente, del 2,36%, mentre altrettante regioni del Sud, che erano già
penalizzate perché beneficiarie di fette più piccole della torta dal 2009 in
poi, hanno visto lievitare la loro parte solamente dell’1,75%, cioè oltre mezzo
punto percentuale in meno. Fatti i conti, quindi, dal 2012 al 2017, Liguria,
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato
poco meno di un miliardo in più (per la precisione 944 milioni) rispetto ad
Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e Calabria. E chi volesse
giustificare questo stato di cose con una migliore performance nella gestione
delle risorse da parte delle Regioni del Nord troverebbe una facile smentita nei
conti del settore sanitario che tra il 2018 e il 2019 registrano un
peggioramento del disavanzo del 10 per cento: dai 990 milioni di euro del 2018
si è infatti passati a poco meno di 1,1 miliardi di euro nell’esercizio appena
concluso.
LE RESPONSABILITÀ. Un peggioramento che, come ha certificato la
Corte dei conti nel Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, è da
ricondurre «in prevalenza alle Regioni non in Piano e a statuto ordinario, che
vedono ampliarsi il disavanzo dai 69,1 milioni del 2018 ai 165,5 del 2019». «“Un
risultato – si legge ancora nella relazione – dovuto soprattutto al Piemonte,
che quest’anno sembra chiudere l’esercizio con uno squilibrio di circa 79
milioni. Più limitati gli squilibri di Liguria, Toscana e Basilicata». Le
regioni in Piano, sostanzialmente quasi tutte quelle del Mezzogiorno, nel 2019
continuano a registrare un riassorbimento degli squilibri, mentre quelle a
statuto speciale segnano un incremento più contenuto (+6,6 per cento), pur
confermando il risultato fortemente negativo a cui fanno fronte immettendo
risorse aggiuntive. Le differenze tra le Regioni emergono anche dal numero del
personale impiegato nella sanità: la Campania conta 5,8 milioni di residenti e
può contare soltanto su 42mila operatori sanitari; in Puglia, dove si conta una
popolazione di 4,1 milioni di abitanti, i dipendenti a tempo indeterminato
impegnati negli ospedali supera di poco le 35mila unità, in Veneto (4,9 milioni)
quasi 58mila, in Toscana (3,7 milioni) sono quasi 49mila, in Piemonte (4,3
milioni) sono 53mila, in Emilia Romagna (4,4 milioni) sono invece oltre 57mila
mentre in Lombardia si arriva quasi alla soglia delle 100mila unità.
IL DIRITTO ALLA SALUTE NON È UGUALE PER TUTTI.
Anche in pandemia il Nord prende più soldi per gli ospedali.
Vincenzo Damiani su Il Quotidiano del Sud il 2 ottobre 2020. Le differenze si
fanno ancora più palesi se prendiamo la spesa pro capite dello Stato per ogni
cittadino. Il diritto alla salute è costituzionalmente garantito, ma lo Stato
italiano non spende la stessa cifra per la cura dei suoi cittadini. Per un
pugliese, ad esempio, al termine del 2020 spenderà complessivamente 1.826 euro,
contro i 1.918 riservati ad un emiliano e i 1.877 ad un veneto. È questa la
quota pro-capite che emerge dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale
dell’anno in corso. Per ogni lombardo, lo Stato destina 1.880 euro; per un
campano, invece, 1.827 euro. Ma peggio va ai calabresi, ai quale spetta appena
1.800 euro a testa, contro i 1.916 euro che “riceve” ogni friulano, i 1.935 euro
di spesa pro capite del Piemonte o i 1.917 euro della Toscana. Chi sperava in
una inversione di rotta almeno dopo una pandemia che ha stravolto le nostre vite
e i nostri sistemi sanitari resterà deluso. Il Nord continua a prendere più
soldi per i suoi ospedali, come accade ormai da oltre 15 anni. È un dato di
fatto certificato che le Regioni settentrionali continuano a ricevere maggiori
fondi, è lo scippo della spesa storia che prosegue. Alla Puglia, 4,1 milioni di
abitanti, dei 113,3 miliardi complessivi del fondo sanitario 2020, sono stati
riservati 7,49 miliardi; l’Emilia Romagna (4,4 milioni di residenti) riceverà
8,44 miliardi: quasi un miliardo in più nonostante una popolazione quasi
identica. Prendendo in considerazione il Veneto (4,9 milioni di abitanti) la
sproporzione resta, visto che la Regione di Zaia incassa 9,2 miliardi, quasi due
in più rispetto alla regione di Michele Emiliano. Le differenze si fanno ancora
più palesi se prendiamo la spesa pro capite dello Stato per ogni cittadino: per
la salute e le cure di un pugliese, lo Stato investe 1.826 euro, contro i 1.918
riservati ad un emiliano e 1.877 per un veneto. La Lombardia, che conta 10
milioni di residenti, riceve 18,8 miliardi per la sua sanità che non ha brillato
durante l’emergenza Coronavirus: fatti due calcoli, significa 1.880 euro per
ogni sua cittadino.
La Campania, 5,8 milioni di residenti, avrà 10,6 miliardi: 1.827
euro pro capite. La Calabria (quasi due milioni di abitanti) ottiene nella
ripartizione del fondo sanitario nazionale da 113 miliardi solamente 3,6
miliardi: 1.800 euro per ogni cittadino. Potremmo continuare: il Friuli Venezia
Giulia che conta 1,2 milioni di residenti, incassa 2,33 miliardi: 1.916 euro per
ogni suo cittadino. E ancora: il Piemonte, che pure negli ultimi anni come
certificato dalla Corte dei Conti, non ha brillato nell’obiettivo di tenere
sotto controllo la spesa sanitaria, incassa dallo Stato 8,33 miliardi per 4,35
milioni di abitanti: circa 1.935 euro per residente. Chiudiamo con la Toscana,
3,73 milioni di abitanti e 7,1 miliardi: 1.917 euro pro capite. Nel confronto
tra il 2010 e il 2020, l’incremento percentuale del Fondo sanitario nazionale
premia ancora il Nord: negli ultimi 10 anni la Lombardia ha visto aumentare la
propria fetta dell’11,4%, l’Emilia Romagna del 9,9%; 8,2% in più per la Toscana.
La Basilicata, invece, ha avuto un incremento percentuale molto più modesto
(+4,9%); l’Abruzzo del 6,7%; Calabria +5,7%; la Puglia e la Campania di circa
l’8,1%.
Non solo: dal 2012 al 2017, nella ripartizione del fondo
sanitario nazionale, sei regioni del Nord hanno visto aumentare la loro quota,
mediamente, del 2,36%; mentre altrettante regioni del Sud, già penalizzate
perché beneficiare di fette più piccole della torta dal 2009 in poi, hanno visto
lievitare la loro parte solo dell’1,75%, oltre mezzo punto percentuale in meno.
Significa che, dal 2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato poco meno di un miliardo in più
(per la precisione 944 milioni) rispetto ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata,
Campania e Calabria.
Si dirà, le Regioni del Nord ricevono più soldi perché le
spendono meglio. Falso mito. Tra il 2018 e il 2019, in Italia si è registrato un
peggioramento del disavanzo nei conti del settore sanitario del 10 per cento:
dai 990 milioni del 2018 si è passati a poco meno di 1,1 miliardi nell’esercizio
appena concluso. Un peggioramento – certifica la Corte dei Conti nel Rapporto
2020 sul coordinamento della finanza pubblica – da ricondurre “in prevalenza
alle regioni non in Piano e a statuto ordinario, che vedono ampliarsi il
disavanzo dai 69,1 milioni del 2018 ai 165,5 del 2019”. I giudici contabili
stanno parlando proprio delle Regioni del Nord, lo chiariscono in un passaggio
successivo: “Un risultato – si legge nella relazione – dovuto soprattutto al
Piemonte, che quest’anno sembra chiudere l’esercizio con uno squilibrio di circa
79 milioni. Più limitati gli squilibri di Liguria, Toscana e Basilicata”.
Le regioni a statuto speciale segnano un incremento più contenuto
(+6,6 per cento), pur confermando il risultato fortemente negativo a cui fanno
fronte immettendo risorse aggiuntive. Le regioni in Piano, cioè sostanzialmente
quasi tutti quelle del Mezzogiorno, nel 2019 continuano a registrare un
riassorbimento degli squilibri. Le differenze sono palesi anche sul numero di
dipendenti a disposizione: in Puglia, dove si conta una popolazione di 4,1
milioni di abitanti, il personale sanitario a tempo indeterminato impegnato
negli ospedali supera di poco le 35mila unità; in Emilia Romagna (4,4 milioni) i
dipendenti sono invece oltre 57mila, in Veneto (4,9 milioni) quasi 58mila, in
Toscana (3,7 milioni) sono quasi 49mila, in Piemonte (4,3 milioni) sono 53mila,
non parliamo della Lombardia dove si sfiora le 100mila unità. La Campania, che
fa 5,8 milioni di residenti, può contare soltanto su 42mila operatori sanitari.
L'Altravoce dell'Italia. Le due Italie. SUDISMI - Direbbero
perfino che la terra è piatta pur di non ammettere i miliardi sottratti al Sud.
Pietro Massimo Busetta l'1 ottobre 2020 su Il
Quotidiano del Sud. Ieri audizione in Commissione Federalismo fiscale del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia. La sua
relazione si può riassumere nella determinazione di calcolare i livelli
essenziali di prestazione prima di procedere a qualunque allargamento delle
autonomie differenziate. Oltre che aspettare, prima di operare, l’equiparazione
infrastrutturale. Buone notizie quindi, perché se un marziano venisse dallo
spazio si renderebbe immediatamente conto che i Paesi sono due: per
infrastrutturazione, per servizi scolastici, per Università , per occupazione,
per servizi sociali. Si contestano i dati del furto, ormai diffusi in tutto il
Paese, perché vi sono i fondi del Recovery Plan, una quantità più rilevante dati
dall’Unione proprio perché il Paese ha questi territori arretrati, che devono
essere distribuiti. Ma c’è un ladro che si aggira nel Paese. Ormai è
riconosciuto anche dallo stesso protagonista che è reo confesso. Prova a
difendersi dicendo che si è vero che ha rubato, ma non quanto qualcuno direbbe,
che ha rubato meno, ma è confesso. Parliamo dei 60 miliardi che ogni anno
verrebbero sottratti al Sud se nascere a Reggio Calabria fosse indifferente
rispetto a nascere a Reggio Emilia. Se invece passasse il principio che ognuno
si trattiene il reddito che produce questo furto non ci sarebbe. Ma in quel caso
i brianzoli, i bergamaschi o i comaschi dovrebbero stare attenti. In quel caso,
anche la ricca Cortina potrebbe sostenere che i suoi studenti hanno diritto ad
essere presi in auto la mattina da un autista privato, perché il loro reddito
prodotto lo consente e pazienza se nei borghi montani si dovrebbero chiudere
alcune scuole. La Svimez ed il nostro quotidiano, sulla base dei dati dei conti
territoriali, rilevano che se si calcola quanto viene speso al Sud ed al Centro
Nord si rileva una differenza di 60 miliardi sottratti al Mezzogiorno e dati in
sovrappiù all’altra parte del Paese. Il calcolo viene fatto sulla base della
spesa procapite effettuata includendo aziende tipo Ferrovie dello stato, Anas,
Fincantieri, Poste italiane. Quello che viene chiamato settore pubblico
allargato. Ovviamente le potenti lobbies nordiste, che vedono in tale
affermazione un rischio per una distribuzione dei fondi, che non li veda
prevalere come sempre è accaduto, si mobilitano. Soprattutto dopo un’intervista
al presidente della Svimez, Adriano Giannola, che contestava lo scippo e
individuava una qualche possibilità che ci fosse un criterio di riequilibrio.
Apriti cielo, parte all’attacco un professore ordinario di diritto tributario a
Trento, Andrea Giovanardi, e poi arrivano le truppe pesanti. Il laboratorio
diretto da Carlo Cottarelli con un articolo firmato da Gianpaolo Galli, già
direttore del centro studi Confindustria per anni e poi deputato al Parlamento
per il PD. Quale il tema? Per riassumerlo vero è che vi sono queste differenze
ma il calcolo è errato per tre motivi. D’altra parte se i numeri li torturi
prima o poi ti diranno quello che vuoi far dire loro. È lì tabelle, grafici, per
dimostrare che la terra è piatta, che l’uomo non è mai andato sulla luna, che i
vaccini non hanno effetti e che le due torri gemelle sono state abbattute dal
Pentagono. Le contestazioni: la prima che l’ammontare delle pensioni non deve
essere inserito perché esse sono state pagate dai contribuiti dei lavoratori. Ed
il fatto che per anni molta parte delle pensioni sia stata pagata con la
fiscalità generale, considerato che il sistema è stato prima solo retributivo ed
adesso misto? Non conta nulla, non incide in questo calcolo per gli illustri
ricercatori. Il secondo tema riguarda la contestazione sull’inserimento di
società come le Ferrovie dello stato o dell’Anas o delle Poste. Il tema è che
queste ed altre sono società che seguono le regole del mercato e quindi
investono laddove il mercato esiste. Giustamente quindi non si fa il ponte sullo
stretto di Messina che servirebbe a trasportare quattro ceste di arance, che
possono tranquillamente viaggiare con i ferry boat! Ma la dimensione di
piattaforma logistica del Mediterraneo del Paese ed il collegamento tramite
Augusta a Suez? Irrilevante! Non pervenuta. Lo sviluppo di un territorio grande
più di un terzo del Paese che viene lasciato nel sottosviluppo, con 100.000
persone che ogni anno emigrano con un danno di 20 miliardi, più di quanti poi ne
arrivano con i fondi strutturali con tutte le difficoltà di spese che esse
comportano? Non è rilevante. Terzo ed ultimo elemento: in ogni caso il costo
della vita al Sud è più basso. Quindi se diamo 50 milioni per costruire la linea
di alta velocità con essi al Nord si possono costruire un chilometro mentre al
Sud se ne costruiscono due? E se hanno un reddito pro capite che è un terzo di
quello brianzolo? In realtà a parità di potere d’acquisto una famiglia
napoletana riesce con un solo reddito per famiglia, pari a un terzo di quello
del Nord, a mantenere molte più persone, considerato che il valore dell’euro
duosicilie è molto più pesante dell’euro brianzolo. Siamo alla arrampicata sugli
specchi. Dispiace che tali ragionamenti vengano condotti da coloro che sono
conosciuti come ricercatori attenti. Ma si sa “ a guerra è guerra e quando
viene, viene per tutti”. Adesso Boccia mette un punto fermo sulla necessità,
prima di procedere, che tutti abbiano i Lep, e per recuperarli di utilizzare i
fondi del Recovery Plan. Ma siamo ancora alle prime scaramucce. Ne vedremo delle
belle.
SUDISMI -
L’operazione verità che nessuno vuole vedere: neanche i governatori del Sud che
reggono il gioco di Bonaccini.
Pietro Massimo Busetta su Il Quotidiano del Sud il 20 ottobre 2020. SI SONO
scatenati. Articoli, video su YouTube, interventi, comparsate in televisione per
dimostrare che è tutto falso. Parlo del dibattito in corso sullo “scippo” che
ogni anno si consuma nei confronti del Sud. Tutto falso! Gli asili nido? A
Reggio Calabria non li vogliono. Le ferrovie? I meridionali preferiscono
utilizzare i bus o andare a piedi. E poi il mantra che ormai è diventato virale:
«La realtà è che hanno avuto un mare di soldi che giacciono, non spesi. E quando
li utilizzano servono a foraggiare la criminalità organizzata. Se il Nord non
avesse il peso morto del Sud volerebbe e sarebbe comparabile alla Baviera. La
colpa è loro, perché se avessero una classe dirigente non sarebbero nelle
condizioni in cui sono».
MILLE PERCHÉ.
A parte la considerazione che se è vero che la mancanza di classe dirigente,
quella che ha come obiettivo il bene comune, e anzi la presenza di una classe
dominante estrattiva, che pensa ai propri clientes, è un problema fondamentale,
è altrettanto vero che la soluzione non può essere quella di affermare che se ci
fosse non ci sarebbe il problema, perché è come dire che se lo zoppo non fosse
zoppo potrebbe vincere le Olimpiadi. Bisogna invece fornirgli delle protesi per
farlo correre. Ma la domanda che ci si pone è perché il Nord ha paura
dell’operazione verità e perché invece i governatori del Sud non ne fanno un
cavallo di battaglia per chiedere, se non il risarcimento (cosa estremamente
complicata e inattuabile, considerata la cifra che si aggira, a seconda di come
si vogliono fare i calcoli, da 300 a 600 miliardi) una diversa aggiudicazione
delle risorse, e invece continuano a tollerare che, grazie alla Conferenza delle
Regioni, si continui con la spesa storica? Perché di fronte a un ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri, che afferma in maniera tranquilla che il ponte
sullo stretto di Messina, quello che dovrebbe permettere all’alta velocità
ferroviaria di arrivare fino in Sicilia e quindi collegare Suez e Hong Kong al
nostro Paese, non si farà per i prossimi cinque anni, non ci sono reazioni
serie? Perché si consente alla ministra Paola De Micheli di contrabbandare
un’alta velocità/capacità farlocca, come se i meridionali avessero l’anello al
naso e non capissero che quando si parla di alta velocità a 160 chilometri orari
ci stanno prendendo in giro?
IL RISCHIO UE.
Lo strano è che non si vedono nemmeno posizioni avvertite e progressiste nel
Nord, che accettino quello che è evidente a chiunque guardi la realtà italiana
senza pregiudizi. Come fa la Ue, che prima con Le Maitre, minaccia di togliere
le risorse all’Italia se continua a spenderle in maniera sostitutiva delle
risorse ordinarie e ora con il Recovery plan destina all’Italia una cifra
maggiore, proprio perché le condizioni del Sud sono precarie. «Se non verrà
mantenuto un adeguato livello d’investimenti pubblici nel Mezzogiorno, l’Italia
rischia un taglio dei fondi strutturali». È l’allarme della Commissione Ue, che
ha inviato una lettera al governo «indicando le cifre più che preoccupanti sugli
investimenti al Sud, che sono in calo e non rispettano i livelli previsti per
non violare la regola Ue dell’addizionalità».
IL TAVOLO DEL
GIOCO. È per la paura di perdere finanziamenti, e quindi di dover rinunciare
all’ennesima corsia su una qualche autostrada del Nord o di dover diminuire gli
scuola bus per darne qualcuno anche a Canicattì? Possibile che tutta la classe
colta, vera classe dirigente del Paese, si trinceri dietro l’arrampicata sugli
specchi di Andrea Giovanardi, che arriva a sostenere che «livelli essenziali non
vuol dire uniformi» e che quindi è corretto che in parti diverse del Paese i
cittadini abbiano alcuni servizi di serie A e altri di serie B, nella scuola ,
nella sanità, nel traporto. Oppure che Giampaolo Galli e Giulio Gottardo, andati
in avanscoperta, e poi il candido Carlo Cottarelli affermino che lo scippo c’è
ma anzi no, e le pensioni non vanno calcolate e che le ferrovie se investono a
Milano mica li possiamo obbligare a investire a Napoli e che poi vivere a
Palermo costa meno che vivere a Brescia o a Bergamo. Come mai non si accetta,
come fece persino Calderoli, che i livelli essenziali di prestazioni sono un
must irrinunciabile per tutto il Paese? E Confindustria e i sindacati? Nessuno
che si strappi le vesti e dica che le risorse del Next Generation Ue vanno
investite prevalentemente al Sud perché è lì che servono. Altro che il 34 %,
minimo sindacale. Perché questa difesa dell’indifendibile, perché continuare a
dire come il lupo che l’acqua può anche sporcarla chi sta in basso al ruscello?
E dall’altra parte, se una “Operazione verità” è stata fatta come mai gli
Emiliano, presidente di una regione di 4 milioni di abitanti, i De Luca che ne
ha 6 milioni e i Musumeci con 5 milioni, che da soli rappresentano un quarto del
Paese, di fronte a un’ingiustizia così palese, invece di continuare a fare la
corte a un Bonaccini che fa il gioco delle tre carte, nel quale alla fine vince
sempre il banco, ciò il triangolo emiliano- veneto -lombardo, non fanno saltare
il tavolo del gioco?
IL SILENZIO
TOMBALE. Il Vangelo dice che se non parleranno le persone per gridare la verità,
parleranno le pietre. Ma qui la sensazione è che non parli nessuno e che ciò che
doveva essere dirompente rispetto al sistema, e cioè che anche un euro venisse
sottratto al Sud per darlo al Nord, sia stato assimilato come un veleno
inevitabile, che continua a distruggere un corpo malato. E che in realtà il
Mezzogiorno non sia più capace neanche di indignarsi. E invece di sbandierare i
dati dello scippo si continuino a chiedere piccole mancette e non pretendere
quello che ci tocca e ci è dovuto come cittadini di questa Italia.
Spesa statale, la beffa del Mezzogiorno: 499 miliardi in meno
in 20 anni. Marco Esposito Lunedì 27 Luglio 2020 su Il
Mattino.it. Recuperare i divari Nord-Sud. L'impegno, vecchio come il mondo
verrebbe da dire, ha preso sfumature meno vaghe da quando, complice la crisi
della pandemia, l'Italia è diventata primo beneficiario in Europa delle risorse
del Recovery fund. Ci sono soldi veri da spendere in modo oculato e il
Mezzogiorno è senza dubbio l'area italiana a maggiore potenziale di crescita,
così come è stata trent'anni fa la Germania Est per i tedeschi. Però il Sud, si
afferma spesso e talvolta anche tra i meridionali, è una pentola bucata, un
pozzo senza fondo che assorbe risorse a vuoto, un territorio che ha goduto per
decenni di leggi di favore con i risultati mediocri che sono sotto gli occhi di
tutti.
Due false informazioni, due fake news si direbbe oggi. Entrambe
dimostrabilmente false. La prima utilizzando i valori ufficiali dei Conti
pubblici territoriali. La seconda elencando le norme scritte in favore del
Mezzogiorno - tante, questo è vero - ma rimaste inattuate. Sui soldi è presto
detto. Il Sud non è affatto una terra inondata di risorse spese male. Sia
chiaro: di soldi spesi male ce ne sono stati in passato e ve ne sono ancora, al
Sud non diversamente che al Nord, come dimostrano le inchieste giudiziarie e le
condanne. Ma sulla quantità di risorse siamo ben lontani dall'equità. Tuttavia
sui numeri si fa non poca confusione, per cui è l'occasione di fare chiarezza. A
inizio 2020 il Rapporto annuale dell'Eurispes, in particolare, ha calcolato in
840 miliardi la somma di spesa pubblica che il Sud avrebbe dovuto ricevere dal
2000 al 2017 se ci fosse stato perfetto equilibrio territoriale in base agli
abitanti. Una denuncia forte (e documentata) che però ha ricevuto l'accusa di
essere una bufala da parte dei cacciatori di fake news di Pagella Politica. Come
stanno in realtà le cose? La base dati è unica e si chiama Conti pubblici
territoriali e in effetti se si confronta la spesa media procapite per i
cittadini del Centronord e quelli del Mezzogiorno il divario è molto forte, di
quasi 4mila euro. Per l'esattezza, in base ai valori più aggiornati e relativi
al 2018, 16.612 euro al Centronord e 12.706 nel Mezzogiorno con una media di
15.282. Quindi se tutti fossimo trattati in modo matematicamente uguale, il
cittadino meridionale dovrebbe salire a 15.282 euro, cioè beneficiare di una
spesa pubblica di oltre 2.500 euro superiore. E visto che i meridionali sono più
di 20 milioni, il totale sottratto al principio d'equità in un solo anno fa
circa 50 miliardi, ovvero gli 840 miliardi per l'intera serie storica calcolati
da Eurispes fino al 2017. Ma è giusto - ci si deve chiedere per onestà
intellettuale - che tutta la spesa pubblica sia ripartita con equità
territoriale? C'è una voce importante, peraltro la principale nel bilancio
statale, nella quale il conteggio è strettamente individuale: la pensione. Se
due fratelli gemelli hanno vite professionali diverse - uno fa carriera e
diventa docente universitario e l'altro fa l'insegnante alle medie - ci
aspettiamo che abbiano stipendi diversi e troviamo del tutto naturale che
prendano pensioni diverse. Ecco, al Centronord grazie a un'economia più florida
ci sono più persone che iniziano a lavorare prima e che hanno redditi elevati,
per cui visto che i soldi attirano soldi, le pensioni sono di solito più
generose. Lo Stato, in tale caso, fa da cassa comune tramite l'Inps e limita la
solidarietà all'erogazione delle pensioni minime e di quelle sociali. La spesa
per le pensioni da sola giustifica la metà del divario Nord-Sud e va depurata
dal conteggio.
Cosa dicono i numeri netti? Li trovate in pagina. Intanto sono
aggiornati rispetto a quelli Eurispes e arrivano al 2018. E poi sono ripuliti
sia della spesa previdenziale, sia della cassa integrazione, la quale anch'essa
va soprattutto al Nord perché per restare senza lavoro devi prima averne uno,
sia degli interessi sul debito che dipendono dai risparmi (ovviamente superiori
al Nord). Il risultato è forse meno roboante ma è tecnicamente inattaccabile:
anche pulendo i valori delle spese inevitabili, in tutti gli anni considerati lo
Stato spende mediamente più al Centronord che nel Mezzogiorno e l'importo perso
dai meridionali rispetto alla media va da un minimo di 11 miliardi nel 2000 (il
primo anno della serie storica) a un massimo di 34 miliardi nel 2008. La somma
dei diciannove anni (2000-2018) porta a 499 miliardi, con una media di 26
miliardi all'anno di minore spesa pubblica per servizi sociali, sanità,
trasporto, scuola, investimenti. Se si entra nel dettaglio delle tipologie di
spesa, il Mezzogiorno cade nella voce acquisti di beni e servizi. Quando c'è da
pagare stipendi pubblici, infatti, lo Stato si comporta in modo equanime. C'è
una sola (vistosa) eccezione: la sanità, settore nel quale il Mezzogiorno è
trattato decisamente peggio. Ma in generale, per enti locali, scuola, sicurezza,
giustizia le spese per il personale al Sud sono in linea con la media e talvolta
superiori. A frenare il Mezzogiorno è l'acquisto di beni e servizi per far
funzionare la macchina pubblica: i dipendenti pubblici meridionali sono poco
produttivi perché operano in strutture meno dotate.
Ma perché ciò è accaduto nonostante le tante norme di favore?
Questo è l'altro corno del problema. Carlo Azeglio Ciampi, da ministro del
Tesoro del governo Prodi, a partire dal 1996 ha colto l'importanza di una spesa
pubblica concentrata nel Mezzogiorno e, proprio per capire come spende la
macchina statale, Ciampi volle un sistema specifico di contabilità, diventato
poi i Conti pubblici territoriali. Più volte si è provato a rendere cogenti le
regole di equità. Per esempio nella finanziaria 2005 e poi nella finanziaria
2007 si è stabilito (una volta al comma 17, la seconda al comma 873) che le
imprese pubbliche devono spendere almeno il 30% degli investimenti ordinari nel
Mezzogiorno. Ma la legge è rimasta inapplicata perché la principale società
pubblica per investimenti, le Ferrovie dello Stato, in quegli anni era impegnata
nella realizzazione dell'alta velocità ferroviaria, come noto realizzata quasi
tutta al Centronord. Infatti le Fs nel 2005 investirono al Sud appena il 15%,
compresi gli interventi straordinari, mentre nel 2007 la quota fu del 20%. Ma
ovviamente non ci fu alcuna sanzione perché l'azienda di stato non fece altro
che rispettare i contratti di programma. Non andò molto meglio nel 2009. Roberto
Calderoli preparò un sistema di decreti di attuazione del federalismo fiscale
ben congegnato e che rispettava il principio d'equità. In particolare per
superare di divari di infrastrutture tra Sud e Nord era prevista una
ricognizione dell'esistente, che però non è neppure partita. Clamoroso, infine,
il ritardo nella definizione dei Lep, sigla che sta per «livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale» (Costituzione, articolo 117). Tocca
al Parlamento fissare l'asticella dei diritti, ma dal 2001 non è mai stato fatto
con il risultato paradossale che quando nel 2014 si è dovuto determinare il
fabbisogno standard di un determinato territorio (operazione effettuata per i
Comuni) si è deciso che in assenza del servizio non c'era il fabbisogno. Fino
all'assurdo degli asili nido zero, corretto solo (e parzialmente) a partire dal
2020. Il 2020 dovrebbe essere anche il primo anno di attuazione della cosiddetta
«legge del 34%» ovvero la norma che impone di destinare il 34% degli
investimento ordinari al Mezzogiorno, sulla base del banale principio che al Sud
vive il 34% degli italiani. La legge c'è dal 2017 ma nonostante la sua ovvietà,
è rimasta inapplicata con i ministri del Sud Claudio De Vincenti e poi Barbara
Lezzi. Ora ci sta provando Peppe Provenzano. Ma perché è così difficile
applicare persino le regole ovvie? Semplice. Perché è più facile (e per nulla
costoso) convincere i meridionali che se le cose non vanno è colpa di una
mediocre classe dirigente (che anche c'è, sia chiaro) piuttosto che impegnarsi a
far funzionare le cose per davvero, come se fossimo tutti tedeschi, anche ad
Est. Pardon, tutti italiani, anche al Sud.
Il rischio povertà al Sud e le politiche coloniali dello Stato
italiano. Michele Di Pace il 27.09.2020 su Il
Movimento 24 agosto. Di Roberto Cantoni – Referente M24A-ET Spagna. Uno spettro
di aggira per l’Europa: lo spettro della povertà. A guardare meglio, in realtà,
non si aggira per tutta l’Europa, ma soltanto per alcune sue aree ben
specifiche: segnatamente, il Sud Italia. La notizia è assurta agli onori – o
meglio, ai disonori - di cronaca in luglio, in seguito alla pubblicazione del
Rapporto 2020 dell’Eurostat. Da tale rapporto risulta che, nella poco onorevole
classifica delle zone UE col maggior tasso di popolazione a rischio di povertà,
la Campania occupa il gradino più alto del podio, con un 41,4%, seguita dalla
Sicilia (40,7%) e, in ottava posizione, dalla Calabria (32,7%). Aggiungendo al
rischio-povertà anche il dato sul rischio di esclusione sociale, la Campania
arrivava al 53,6%, mentre la Sicilia al 51,6%). Cioè, oltre metà della
popolazione delle due regioni. Come spiega il rapporto, “Il numero o la quota di
persone a rischio di povertà o di esclusione sociale combina tre criteri
distinti che coprono le persone che si trovano in almeno una delle seguenti
situazioni:
- a rischio di povertà - persone con un reddito disponibile
mediano equivalente (dopo i trasferimenti sociali) al di sotto della soglia di
rischio di povertà;
- persone che soffrono di gravi privazioni materiali - persone
che non possono permettersi almeno quattro su nove oggetti materiali considerati
desiderabili (o addirittura necessari) dalla maggior parte delle persone per
avere una qualità di vita adeguata;
- persone che vivono in una famiglia a bassissima intensità di
lavoro, dove gli adulti in età lavorativa non hanno lavorato più del 20% del
loro potenziale totale nei 12 mesi precedenti.”
Questo dato va considerato insieme a quello sulla disoccupazione
di lungo-termine, endemica delle nostre zone, tutte caratterizzate da
percentuali superiori al 50%. Tuttavia, se si vanno a scorporare i dati sulle
fasce d’età, si vede che la disoccupazione giovanile è una vera e propria piaga
nel Meridione, con tutte le regioni con tassi superiori al 25%, cioè un giovane
su quattro (al di sopra dell’Umbria, soltanto il Piemonte è nelle stesse
condizioni in Italia). Altro dato interessante riguarda le famiglie a bassissima
intensità di lavoro: la Sicilia, per dirne una, ha una percentuale quasi otto
volte maggiore della provincia di Bolzano. E, almeno in teoria, sarebbero parte
dello stesso paese. Idem per il PIL pro-capite, con tutte le regioni del Sud
caratterizzate da PIL di oltre il 25% al di sotto della media europea (con la
parziale eccezione dell’Abruzzo, tra il 10 e il 25%). In tutte le regioni del
Nord, al contrario, il PIL pro-capite è pari o superiore alla media europea. E
ancora: tra il 2008 e il 2018, una delle regioni con la maggior crescita del
numero di lavoratori nel settore scientifico-tecnologico è stata la Lombardia
(+300.000 unità), mentre la Calabria è stata una delle otto regioni europee in
cui i lavoratori in questi settori sono diminuiti. Ora, l’Unione Europea è
piuttosto prodiga di fondi per le regioni in condizioni socioeconomiche
disagiate, e ha una politica di coesione territoriale ben definita, che porta
avanti con serietà. È evidente, quindi, che il problema è più a valle: al
livello nazionale. Certo, c’è da dire che, se il Sud fosse uno stato a sé,
avrebbe diritto, oltre ai fondi strutturali che ricevono tutti i paesi membri,
anche al Fondo di coesione, che finanzia progetti nei paesi in cui il reddito
nazionale lordo (RNL) pro-capite è inferiore al 90% della media dell’UE. Il
paradosso è che il contributo del Centro-Nord al RNL rende l’Italia un pese
relativamente agiato, almeno per le statistiche. È come la storia dei polli di
Trilussa: quella secondo cui, se una persona ha due polli e un’altra nessuno,
per la statistica hanno un pollo a testa, e quindi stanno relativamente bene. La
media nazionale finisce per sfavorire il Sud, che invece, secondo la maggior
parte dei parametri socioeconomici, è in condizioni simili a Bulgaria, Romania e
repubbliche baltiche. Al livello europeo, purtroppo, fino a poco fa si è dato
per scontato che il governo italiano si adoperasse nella funzione di
ridistribuzione dei fondi nazionali, nel senso di favorire la perequazione. Ciò
non avviene, e se ne sono accorti recentemente anche a Bruxelles, (qui un
intervento del referente per la Lombardia di M24A-ET Massimo Mastruzzo in
proposito) dove la Commissione ha minacciato l’Italia di tagli ai fondi
strutturali in mancanza di un intervento massiccio al Sud, usando però la spesa
pubblica nazionale, e non i fondi europei, che – ha ricordato la Commissione –
sono aggregativi, non sostitutivi di quelli nazionali. Ricordiamo, tra l’altro,
che l’Eurispes nel suo rapporto 2020 ha certificato la sottrazione al Sud di 840
miliardi di euro in 17 anni. 840 miliardi di euro: cioè oltre 49 miliardi di
euro all’anno. Soldi che sono andati indebitamente al Centro-Nord. C’è quindi un
problema spaventoso di gestione della spesa pubblica: ed è un problema che
genera i dati illustrati nel rapporto della Commissione Europea. Il Sud è
trattato dal governo nazionale come un territorio coloniale, sotto qualunque
punto di vista. I paralleli con le colonie africane di Francia e Regno Unito del
XX secolo sono illuminanti e calzanti. Dobbiamo, da meridionali, prenderne
coscienza e agire di conseguenza, decolonizzandoci prima mentalmente e poi
economicamente. Occorre agire nei confronti dello Stato italiano facendo perno
sull’unico parametro cui è sensibile: i fondi europei. Per farlo, abbiamo però
bisogno dell’aiuto di un organismo che abbia più potere coercitivo dell’Italia:
l’Unione Europea. Forse chiedere ai meridionali di vedere la Commissione europea
come un’istituzione amica è eccessivo, ma sicuramente, pur con tutte le sue
tare, lo è di più del governo italiano degli ultimi decenni. Per questo motivo
credo che, come Movimento, dovremmo fare pressione perché la Commissione passi
dalle parole ai fatti nei suoi procedimenti contro lo Stato italiano,
obbligandolo a capovolgere la politica coloniale seguita finora, e a restituire
al Sud almeno il maltolto degli ultimi 17 anni. Finché ciò non avverrà, potranno
continuare a eleggere presidenti della repubblica meridionali, ma la sostanza
della nostra subalternità socioeconomica non cambierà. Il reddito disponibile
delle famiglie è determinato sommando tutti i redditi monetari (a prescindere
dalla fonte da cui siano percepiti, compresi i redditi da lavoro, gli
investimenti e le prestazioni sociali) di ciascun componente della famiglia ai
redditi percepiti a livello di famiglia e detraendo le imposte e i contributi
sociali versati.
ECONOMIA, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. CHI SI RIVEDE, LA
POLITICA RISCOPRE LA QUESTIONE MERIDIONALE. STAI A VEDERE CHE E’ PER MERITO DI
QUEI QUATTRO URLATORI MERIDIONALISTI? Raffaele
Vescera l'01.10.2020 su Il Movimento 24 agosto. Dopo decenni di negazionismo, di
autofustigazione nel ripetere che “è tutta colpa dei meridionali”, i politici
del Sud scoprono l’acqua calda e riconoscono che esiste una Questione
meridionale, data da uno Stato che nega ai cittadini del Sud i diritti
elementari. Lavoro, infrastrutture, salute, istruzione, tutto in meno al Sud,
nella misura di 61 miliardi l’anno di investimenti, dovuti al Mezzogiorno e
“trasferiti” al Nord, come se niente fudesse, nel silenzio generale dei partiti
e dei media, saldamente detenuti nelle mani del Partito Unico del Nord. Non che
i politici meridionali riconoscano la totalità del furto, se così fosse
dovrebbero stracciarsi le vesti per i tanti anni di ignavia nel migliore dei
casi, di vergognoso collaborazionismo nel peggiore, praticato in cambio di
privilegi economici e giudiziari. Tuttavia dal negazionismo sono passati a
un’ammissione, timida nella maggioranza dei casi, decisa in pochi altri. E’
così che, mettendo da parte l’antimeridionale lega e suoi alleati, dopo le
parole del leader M5s Di Maio che negava l’esistenza della Questione meridionale
in nome di un movimento non territoriale ma nazionale, sono sempre di più le
voci di parlamentari pentastellati che ne riconoscono l’esistenza. Così la
portavoce del M5s Conny Giordano scrive che “Il Recovery Fund è un'opportunità
storica per il Sud. Grazie ai soldi del Recovery Fund abbiamo l'occasione
storica per colmare il gap tra Nord e Sud d'Italia. Abbiamo fatto passare in
Commissione un parere che concede la priorità allo sviluppo strutturale del
Mezzogiorno d'Italia. Dobbiamo individuare tutti i criteri che assicurino un
maggiore afflusso di risorse nei territori storicamente svantaggiati.”
Benissimo, meglio avrebbe fatto ad aggiungere che i fondi europei non devono
essere sostitutivi ma aggiuntivi a quelli dello Stato negati al Sud, secondo
logica e volontà della stessa Commissione europea, se si vuole sanare il
vergognoso squilibrio Nord-Sud, frutto di 160 anni di trattamento coloniale del
Mezzogiorno. Ed è così che i parlamentari meridionali del Pd, nelle commissioni
congiunte trasporti e ambiente della Camera, scrivono che “Il ritardo economico
del Mezzogiorno è inaccettabile e ingiustificabile perché non consente a un
terzo della popolazione italiana di godere appieno di diritti, opportunità e
prospettive che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini. Ed è oltremodo
ingiustificabile perché le ricchezze culturali, ambientali, di capacità
produttive inespresse presenti nel Mezzogiorno possono e devono essere
utilizzate per il rilancio dell'economia dell'intero Paese”. E così aggiungono:
“per affrontare il tema del gap infrastrutturale Nord – Sud, con proposte
operative, devono essere previste già nei prossimi finanziamenti nazionali ed
europei, dal Recovery Fund ai contratti Rfi e Mit. Tra queste, innanzitutto
l’alta Velocità al Sud, da Salerno a Reggio Calabria e poi fino a Palermo con
l'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, realizzando una
infrastruttura che ponga fine all'isolamento della rete dei trasporti siciliani
da quella del resto del Paese. Oggi abbiamo registrato un fatto molto positivo
avendo ottenuto sull'impostazione del nostro testo, la condivisione di tutti i
gruppi parlamentari, di maggioranza e opposizione”. Bene, ignorano totalmente
l’alta velocità ferroviaria dell’asse adriatico, da Bologna a Lecce, ma
riconoscono la necessità dell’Alta velocità tirrenica da Salerno a Reggio e poi
fino a Palermo, con “attraversamento stabile” dello Stretto, dicono, ma senza
avere il coraggio di nominare la parola “ponte”, un struttura già progettata e
immediatamente fattibile. Di grazia, diteci come superare lo Stretto? In
antesignano traghetto, ambientalista bicicletta o fantascientifico tunnel?
Vediamo chi la spara più grossa dopo la ministra De Micheli. Che i parlamentari
del Sud comincino a prendere coscienza, sino a formare un intergruppo
meridionale è un dato positivo, tuttavia non possiamo ignorare la forza
sovrastante del Partito Unico del Nord che ricorre ad ogni mezzo per contrastare
l’equità territoriale nella distribuzione delle risorse, nazionali ed europee,
sino a fare il gioco delle tre carte, come fanno certi stracotti economisti alla
Cottarelli, i quali arrivano a sostenere che il Sud ha avuto fin troppo
dall’Italia? Ah, sì, signori miei, e i 110 miliardi dell’Alta velocità
ferroviaria, di cui 50 miliardi destinati per fare le ferrovie Av al Sud, chi li
ha mangiati se non il Nord che si è preso tutto, distribuendo in tangenti buona
parte dei soldi? E le strade statali, gli ospedali, le scuole, i tribunali e
altre opere mancanti al Sud forse non spettava allo Stato farle? E’ per questa
ragione che occorre una forza politica “decisamente” meridionalista, che pur
riconoscendo il diritto all’equità per tutto il territorio nazionale, ove essa
sia negata come in alcune zone interne, si batta per cancellare la più grande
ingiustizia italiana, la disparità Nord-Sud. Intanto possiamo ascrivere alle
nostre “urla nel deserto” l’iniziale presa di coscienza dei politici
meridionali. Noi del Movimento 24 Agosto per l’Equità territoriale non ci
fermeremo, continueremo a urlare la verità. A partire dal 6 ottobre in Piazza
Monte Citorio a Roma, per poi arrivare a Bruxelles. Dopotutto, “basta sollevare
un pugno di sabbia nel deserto, per modificarlo”, dice il filosofo. Noi di pugni
ne abbiamo molti da sollevare.
Provenzano contro chi nega lo scippo al Sud: i numeri parlano
da soli e la matematica non è un’opinione. La
relazione del ministro: «Al Mezzogiorno spetta almeno il 34% delle risorse del
Recovery Fund». Lia Romagno il 29 settembre su Il Quotidiano del Sud. Le
«ricostruzioni» che negano lo squilibrio nella ripartizione della spesa pubblica
a beneficio del Nord, e la ventennale penalizzazione del Mezzogiorno, «difettano
di matematica», mettono in dubbio «dati ufficiali», mentre la «vecchia teoria
dei residui fiscali», poi, «è da rigettare alla radice». Ma soprattutto,
conducono a un errore strategico, perché è indubbio che «ogni 10 euro investiti
al Sud, 4 tornano al Centro Nord in termini di attivazione di domanda di beni e
servizi». Con quattro passaggi della sua relazione sulle priorità per
il Recovery Plan davanti alle commissioni riunite del Senato, Giuseppe
Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ha liquidato
l’analisi dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Quattro punti di un discorso ben più articolato che
ha smontato quello che nelle sintesi giornalistiche è diventato il “falso mito”,
la favola della sottrazione di risorse al Sud, mettendo in discussione
l’indagine della Svimez elaborata sulla base dei Conti pubblici territoriali
curata dall’Agenzia per la Coesione territoriale. «I dati sono ufficiali – ha
affermato Provenzano – ci raccontano di uno squilibrio, di uno svantaggio,
soprattutto nella spesa pro capite per investimenti tra le aree che va colmato».
«Soprattutto in giorni in cui vedo nuove ricostruzioni dei giornali che negano
addirittura lo squilibrio e la penalizzazione che nel corso di questi anni le
regioni meridionali hanno invece subito nella spesa in conto capitale» il
ministro ha ribadito che «che c’è un gap che dobbiamo colmare anche in termini
di investimenti». Secondo il ministro, «queste ricostruzioni, non solo difettano
di una visione politica capace di capire quanto investire nelle aree meno
sviluppate sia essenziale a liberare un potenziale di sviluppo anche nel resto
del del paese, ma difettano proprio di matematica e il tentativo di rispolverare
la vecchia teoria dei residui fiscali è da rigettare alla radice, perché questo
concetto se applicato ai territori è del tutto discutibile anche sul piano
scientifico, e comunque riduce il rapporto Nord e Sud, e tra le aree del Paese,
a una contabilità misera di cui dovremmo fare a meno». Mentre la storia del
nostro Paese, confortata dall’analisi economica, ha evidenziato, mostra
l’interdipendenza tra le diverse aree del Paese, sia sul piano economico e
commerciale: «La Banca di Italia, ma anche la Svimez, ha ricordato come un
investimento nelle aree meno sviluppate è capace di attivare reddito e lavoro in
misura maggiore per tutto il Paese. Sappiamo che per ogni 10 euro investiti al
Sud 4 tornano al Centro Nord in termini di attivazione di domanda di beni e
servizi». Intanto, il Sud entro la fine dell’anno rischia di perdere 600-800mila
posti di lavoro. La fiscalità di vantaggio, con la riduzione strutturale del
cuneo fiscale del 30% per le imprese private del Sud – su cui, ha riferito il
ministro, è in corso «un negoziato molto difficile con la Commissione europea» –
ha proprio lo scopo di scongiurare la «voragine occupazionale» e rilanciare gli
investimenti. L’occasione per ripartire arriva dall’Europa, che proprio il
risanamento delle fratture territoriali, ha messo al centro della strategia per
il rilancio e superare la crisi con più sviluppo ed equità. Ora, tra Recovery
Fund e fondi europei, le risorse aggiuntive attivabili sia per il Paese sia per
il Mezzogiorno «raggiungono quote mai realizzate», ha spiegato il ministro:
oltre ai «65, quasi 70 miliardi di aiuti», «avremo complessivamente una quota di
43 miliardi di fondi strutturali europei per il ciclo 2021-2027», cui vanno
aggiunti il cofinanziamento nazionale e regionale che dovrebbe attivare una
quota di risorse per i programmi operativi nazionali e regionali pari a 80
miliardi. «Queste risorse riguardano in particolare, per i fondi strutturali,
soprattutto le aree meno sviluppate: di questi 80 miliardi circa 52 miliardi
sarebbero destinati, secondo il riparto attuale, al Mezzogiorno», ha aggiunto
Provenzano, sottolineando, poi che «per il ciclo di programmazione 2021-2027,
considerando almeno anche il 34% della parte di aiuti del Recovery Fund, avremo
circa un punto e mezzo di Pil all’anno di investimenti maggiori aggiuntivi nel
Mezzogiorno». Almeno il 34% perché, ha ribadito, ci sono settori, «come quello
per il completamento dell’alta velocità di rete, in cui i fabbisogni di
investimento sono anche maggiori». Ora la sfida, ha detto il ministro sta nel
definire obiettivi e fabbisogni di investimento ben precisi, puntare su uno
sviluppo che garantisca i «diritti di cittadinanza», non disperdere le risorse
in un progetto sponda in cui infilare tutti i progetti finora irrealizzati. E
recuperare il deficit di credibilità che ha reso «difficile rispondere alle
obiezioni dei Paesi frugali, non del tutto infondate, sulla nostra capacità di
messa a terra degli investimenti. Ora – ha concluso Provenzano – abbiamo
un’opportunità storica».
Federalismo fiscale, nel dibattito politico assume il ruolo
delle bomboniere nella credenza. Della “storia
incredibile e vera dell’attuazione perversa" si occupa con garbo e dovizia di
dettagli il giornalista Marco Esposito nel suo libro Zero al Sud. Alessandro
Cannavale il 21 Settembre 2020 su Basilicata 24. Nel dibattito politico degli
ultimi anni, il federalismo fiscale assume il ruolo delle bomboniere di famiglia
nella credenza. Nessuno – quasi – osa metterne in discussione la presenza. Della
“storia incredibile e vera dell’attuazione perversa del federalismo fiscale”,
come promette il sottotitolo in prima pagina, si occupa con garbo e dovizia di
dettagli il giornalista Marco Esposito, responsabile Economia del “Mattino”. La
riforma del Titolo V della Costituzione (2001) ha, come noto, rivisto la
ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, fondandosi su tre
articoli decisivi (117, 119 e 120). Il carburante del dibattito politico che ha
sospinto i partiti – da destra a sinistra – a dare ascolto alle sirene del
federalismo, attuando quella riforma così sostanziale del testo costituzionale,
è stato offerto dalla crescente demonizzazione dell’intervento pubblico,
unitamente al crescente “disegno leghista di concentrare le risorse disponibili
sui propri territori di elezione, premiando in primo luogo i propri cittadini; e
quindi riducendo gli interventi nel Mezzogiorno”. Esposito affronta il nodo
delle cosiddette narrazioni, come quella sul “residuo fiscale”, a più riprese
affrontata dal Presidente di Svimez, Adriano Giannola, o quella sugli “sprechi
del Sud”. Per fugare i dubbi, Esposito ricorda quanto sia falso che la spesa
pubblica sia omogenea sul territorio nazionale, visto che, citando i Conti
pubblici territoriali del 2015, pubblicati nel 2017, “la spesa pubblica
complessiva pro capite in Italia era di 15.801 euro nel Centronord e di 12.222
euro nel Mezzogiorno”. Lo Stato, lo sanno tutti ormai (si spera), spende al Sud
meno del 30% delle risorse, a fronte di una popolazione del 34.4%. Dove ha
condotto l’applicazione del federalismo fiscale, dalle sue origini ai giorni
nostri? Di questo parla “Zero al Sud”. Lo fa combattendo da un lato la
deficitaria informazione su un tema tanto delicato come la ripartizione
nazionale delle risorse per i servizi fruiti dai cittadini italiani, dall’altro
la marea di luoghi comuni che sono diffusi tra i meridionali stessi, inficiando
ogni nascente possibilità di iniziativa concreta. Se al lettore, temi come il
federalismo e la sua attuazione possano sembrare da addetti ai lavori, il saggio
di Esposito, edito da Rubbettino, mette in campo una secca e urgente smentita.
Dal modo in cui il federalismo si è andato attuando, sono scaturiti livelli
discutibili dei servizi essenziali per tutti i cittadini italiani. Di cosa
parliamo? Di cose che ci sono più vicine di quanto crediamo: degli asili nido,
ad esempio, ma anche degli altri servizi, che sono tutt’altro che astratte
elucubrazioni. Stiamo parlando della qualità delle nostre vite di cittadini, sui
nostri territori. Il libro ricapitola quasi venti anni dell’intricato percorso
federalista, passando per la cruciale approvazione della Legge 42/09, che aveva
ribadito la necessità di stabilire i Livelli Essenziali delle Prestazioni e i
cosiddetti “obiettivi di servizio”, per le amministrazioni locali. Quella Legge
fu firmata da Berlusconi, Tremonti, Bossi e dal Ministro per i rapporti con le
Regioni di allora, Raffaele Fitto. Il fondo di perequazione, stabilito
dall’articolo 13 di quella legge, si trovò di fronte al limite della “neutralità
finanziaria per il bilancio dello stato”, cioè “dalla presente legge […] non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Quindi,
quel testo sanciva che le risorse aggiuntive per i comuni in stato di bisogno di
perequazione finanziaria dovessero e potessero giungere solo dai comuni più
abbienti, in modo orizzontale e non più verticale. Minando l’attuabilità della
perequazione stessa. Cosa scaturì da tutto questo? Ne parla con dovizia di
dettagli Marco Esposito, narrando le discussioni delle varie commissioni
parlamentari di cui l’epilogo fu il seguente: “Si considerò essenziale e quindi
meritevole solo l’asilo nido dove c’era e superfluo, se non inutile, dove non
c’era”. Se hai è giusto che tu mantenga il tuo status; se non hai, invece,
peccato per te. Con amarezza, il testo ci ricorda che fu debole la risposta e la
partecipazione dei parlamentari meridionali, nei vari contesti in cui si
discussero questi temi, come si sforza di documentare Esposito, nelle pagine di
“Zero al Sud”. Come chiarisce l’autore, “in cinque anni di lavori, nei verbali
della Bicamerale risultava solo una manciata di interventi di parlamentari
dell’Italia meridionale, perlopiù concentrati nel primo mese di lavori della
Bicamerale, dicembre 2013”. Forse ora, dopo queste brevi battute, emerge chiaro
a cosa faccia riferimento il titolo, Zero al Sud: in Italia, l’attuazione del
federalismo fiscale andava sancendo la consuetudine secondo cui “per riconoscere
i livelli alti in alcuni territori bisognava mantenere bassi quelli nei
territori più in difficoltà”. L’assenza della definizione dei Livelli Essenziali
delle Prestazioni (o LEP) conduce l’Italia a distorsioni che Esposito a buon
diritto definisce gravissime, “come considerare “fabbisogno standard” la vacanza
estiva per i ragazzi delle scuole in cui il servizio sia attuato, come a
Bologna, e di giudicare inutile la mensa scolastica là dove il servizio era
inesistente, come a Reggio Calabria”. Nel 2017 entrava infine in funzione
quello che Esposito battezza “federalismo fiscale disuguale”, capace di
moltiplicare persino gli “zeri”, per molti comuni, dagli asili nido
all’istruzione, ai servizi sociali, al trasporto locale. Nel libro, è riportata
una tabella che merita qualche attenta considerazione da parte di tutti gli
italiani che credano nella Costituzione. Qualche auspicabile riflessione in più,
da parte dei meridionali. Essa infatti sancisce che l’attribuzione delle risorse
tra Nordest e Sudovest, ad esempio – sia che si ricorra al fabbisogno standard
che alla spesa storica – sia in rapporti pari a 80 a 45 e 86 a 32,
rispettivamente; tanto, pur con tutta la gravità del divario Nord- Sud che
persiste da sempre. Ecco perché è stata davvero importante la recente presa di
posizione dell’Unione Europea sulle modalità in cui verranno distribuite le
risorse comunitarie che giungeranno nel nostro Paese. Alla luce di queste
premesse, risultano più dolorose le parole del presidente di Svimez, Adriano
Giannola, secondo cui “Il Sud potrebbe recriminare per l’eccessivo danno subìto
a causa delle scelte del Nord: sono stati sottratti 60 miliardi ogni anno da 10
anni”. Sono fioccati tentativi di smentita e il dibattito sui media è aperto.
Conoscere le premesse di questo dibattito diventa più facile, leggendo il libro
di Marco Esposito.
Ospite di Bruno Vespa nel programma “Porta a Porta”, il
Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è detto pronto ad un
stretta nelle misure anti-Covid. Domingo Palma il 29 settembre 2020 su
zerottonove.it. Allarme e preoccupazione ma anche rigore e fermezza. Questo è
quanto emerge dalle parole del Presidente della Regione Vincenzo De Luca ospite
di Bruno Vespa nel programma televisivo “Porta a Porta”. Il neo-riconfermato
Governatore si è espresso sulla situazione Covid-19 in Regione. “Sono molto
allarmato – ha dichiarato De Luca – credo che dobbiamo aprire gli occhi e dire
con chiarezza ai cittadini che siamo già nella seconda ondata dell’epidemia.
Ricordo che la Campania è la Regione che ha la più alta densità abitativa
d’Italia e il 60% dei positivi oggi sono nelle Asl Napoli 1 e 2 e a Caserta cioè
quelle a maggiore congestione abitativa“. “Se vogliamo convivere con il virus
per altri 10 mesi, quando avremo disponibilità del vaccino se ci va bene, il
controllo del territorio dev’essere rigoroso e capillare. Io rilevo che da 2-3
mesi le Forze dell’Ordine da questo punto di vista sono scomparse, non trovo più
una pattuglia dedicata al lavoro di controllo anti Covid. Se pensiamo di
convivere con il Covid in queste condizioni per altri 10 mesi dobbiamo dire
chiaramente agli italiani che tra un mese dobbiamo chiudere tutto. La Campania
viene depredata ogni anno di 300 milioni di euro, perché nel riparto del fondo
sanitario nazionale si applica solo un criterio, quello dell’età anagrafica, e
siamo la popolazione più giovane. Ma c’è un secondo criterio che andava
applicato, che era quello della deprivazione sociale, cioè il livello di
reddito, la disoccupazione. Siamo usciti da 10 anni di commissariamento della
sanità facendo un miracolo e scontando il fatto che in 10 anni di
commissariamento abbiamo perduto 13.500 dipendenti della sanità. Sfido chiunque
a gestire un sistema sanitario in queste condizioni“.
Recovery Fund, De Luca: «Se ci danno 300 milioni l’anno va
bene». Da supersud.it il 29 settembre 2020.
“Sul recovery fund discuteremo con amicizia e troveremo una soluzione,
l’importante e’ che ci diano 300 milioni l’anno poi siamo d’accordo su tutto”.
Lo ha detto con un sorriso il governatore della Campania Vincenzo De Luca a
Porta a Porta dove era ospite insieme al collega veneto Luca Zaia. I due hanno
discusso anche della ripresa del dibattito sull’autonomia differenziata: “Mi
piace – ha detto De Luca – chiarendo dei presupposti come la difesa senza
equivoci dell’unita’ nazionale, il rispetto dell’articolo 119 della Costituzione
che prescrive una norma perequativa tra regioni con maggiore base fiscale e
regioni che ne hanno meno. E poi l’assunzione piena dell’obbligo costituzionale
di riequilbrio tra nord e sud. Noi abbiamo chiesto di avere maggiore autonomia a
partire dal superamento della spesa storica, bisogna fare operazione verita’ per
sapere quante risorse vanno al sud e quante al nord, perche’ con la spesa
storica il sud molto penalizzato a partire dalla sanita’, in cui la Campania nel
fondo sanitario riceve meno di tutte le altre Regioni e viene depredata di
trecento milioni di euro l’anno”. Sulla sanita’, De Luca ha sottolineato che
“abbiamo raddoppiato i livelli essenziali di assistenza facendo un risanamento
finanziario, ma scontiamo la perdita di 13.500 dipendenti nel settore. Quindi se
ci sono elementi di sprechi e clientela li spazziamo via ma siamo prointi ad
affrontare sfida efficienza nei confronti di chiunque”.
Ma come può il Sud fidarsi del Nord dopo tutti i soprusi che
ha subito? Pietro Masimo Musetta il 30 settembre 2020
su Il Quotidiano del Sud. Se vai in montagna in cordata ti devi fidare
ciecamente di chi sta sopra di te. Se pensi che in un qualunque momento chi sta
sopra può tagliarti la corda e farti precipitare allora devi evitare di andare.
Purtroppo il Sud si è reso conto in molte occasioni che del Nord non ci si può
fidare. Ma non solo della Lega che per molti anni ha fatto del “ dai al terrone”
il mantra su cui impostare la propria politica. Ma anche delle uscite dei Sala e
dei Gori in sintonia con i Bonaccini con lo slogan facciamo ripartire la
locomotiva. In un accordo, nella conferenza delle regioni, che piuttosto che
politico è diventato territoriale, con Lombardia e Veneto, per emarginare e
contenere le esigenze del Sud. Il tema si ripropone da parecchi anni ed ha
riguardato tutti i settori. Dalle banche meridionali, che sono state massacrate,
come nel caso del Banco di Napoli, le cui cosiddette sofferenze hanno portato
all’azzeramento del valore del Banco di Napoli e quindi all’eliminazione del
patrimonio della Fondazione che lo possedeva. Tranne poi scoprire che le
sofferenze erano garantite e sono state recuperate quasi integralmente. Ma il
tema ha riguardato tutto il sistema bancario meridionale dalla Cassa di
Risparmio Vittorio Emanuele al Banco di Sicilia che invece di essere salvato
andava a salvare la Banca di Roma. Anche nell’Università il discorso continua ad
essere analogo per cui i criteri stabiliti sono tali per cui gli atenei del Sud
stanno sempre più diventando dei super licei, mentre la ricerca e i soldi per
farla vanno tutti agli atenei del Nord, per dei parametri tutti da rivedere.
Perché tale approccio penalizzante avvenga è necessario qualcuno che
operativamente agisca ma anche che vi sia un clima favorevole al quale pensano i
media, monopolio del Nord sia nel settore della carta stampata che in quello
televisivo. E che rappresentano interessi molto precisi e che danno lo spazio
che serve al momento opportuno ai centri di ricerca e studi che fanno uscire dai
numeri quello che vogliono. Per cui si dimostra che il Sud ha avuto un mare di
soldi che non si capisce dove sono finiti, evidentemente, si sottintende, rubati
dai malavitosi meridionali. Considerato che opere pubbliche non se ne vedono, si
parli di alta velocità ferroviaria o di autostrade o di cantieri navali o di
porti. Se ne è accorta che il gioco è truccato anche l’Unione europea, che non
riesce a vedere gli effetti che si aspettava dall’utilizzo dei fondi
strutturali. E che ha svelato l’arcano. Non hanno avuto effetti adeguati poiché
hanno sostituito in parte le risorse ordinarie per cui era naturale che non
avessero effetti perché non sono stati aggiuntivi ma sostitutivi. Le conseguenze
di tale scippo si sono già viste politicamente con la nascita del movimento
cinque stelle al grido dei meridionali “o mi sviluppi o mi mantieni” . E dopo la
delusione lo sbandamento e la ricerca di movimenti autonomisti o separatisti. Ma
se ne é accorta anche la destra che adesso comincia a cavalcare il progetto Sud,
per cui i più accesi fautori del ponte sullo stretto di Messina diventano Matteo
Salvini, Giorgia Meloni e Forza Italia. Non solo la vera classe dirigente del
Paese, come invece è accaduto in Germania, non capisce che senza mettere a
regime il Mezzogiorno il nostro Paese non sarà capace di recuperare il divario
rispetto alle altre grandi economie europee, ma tenta in tutti i modi di
accaparrarsi tutte le risorse, rischiando rivolgimenti sociali che potrebbero
portare a sconvolgimenti non prevedibili. Nell’assenza e spesso con la
complicità di sindacati e imprese. Per cui diventano nemici da abbattere coloro
come la Svimez, che analizzano i dati dimostrando quello che è visibile a
chiunque abbia voglia di vedere. Abituati ad un Mezzogiorno non reattivo ci si
stupisce della contestazione dell’autonomia differenziata, ma anche alla pretesa
incredibile di avere una parte considerevole del recovery plan. Abituati a
considerare il Sud colonia perfetta per allocarci gli hot spot per i migranti,
per le produzioni inquinanti, che continuano a restare in attività dietro il
ricatto o la salute o il lavoro, o per seppellire rifiuti tossici, non riescono
a capire le inattese reazioni di una società civile, che superando le
rappresentanze elette, sempre molto prone alle dinamiche dei partiti di
appartenenza, comincia a far capire alla gente che si è discriminati rispetto
alla spesa pubblica. L’approccio che il Nord ha nei confronti del Sud si è visto
in modo plastico, quando si è fatto in modo che gli studenti ed i lavoratori
emigrati scappassero dal Nord, in modo da alleggerire le terapie intensive,
senza pensare che il trasferimento di un numeroso gruppo di meridionali ,
studenti e lavoratori, nelle località di origine avrebbe trasportato con essi
anche il virus, come puntualmente è avvenuto. c. Capisco che è difficile passare
dall’abitudine di fare l’asso pigliatutto a condividere le risorse, ma prima il
Nord si abitua e meglio è per tutto il Paese. L’alternativa farebbe male a
tutti.
ISTRUZIONE, SANITÀ, AMBIENTE E TERRITORIO. MA COME SI FA A
PARLARE DI PARITÀ NORD-SUD. Non c’è bisogno neanche
dei Lep per fare semplici elaborazioni. Fabrizio Galimberti il 29 settembre su
Il Quotidiano del Sud. L’insistenza di questo giornale sulla maladistribuzione
delle risorse pubbliche fra Mezzogiorno e resto del Paese ha cominciato a
percolare nella coscienza nazionale. La "questione meridionale" non è più solo
argomento di ponderosi saggi e pacati (non sempre) dibattiti; si è vestita di
cifre, di miliardi, di addizioni e sottrazioni, e così facendo ha toccato il
portafoglio, cioè a dire un nervo scoperto. Ecco che la "cifra magica" al centro
del dibattito – i circa 60 miliardi di euro all’anno ‘sottratti’ al Sud –
cominciano, come era da prevedere, a innescare accese contestazioni.
Naturalmente, sia i proponenti della saldezza di quella cifra che i denigratori
portano ognuno acqua al proprio mulino, con diverse giustificazioni e
definizioni della spesa pubblica da ripartire fra le regioni italiane: aggiungi
questo, togli quest’altro, tieni conto del costo della vita, ridefinisci il
perimetro e i parametri della spesa… Confermando, insomma, l’antica battuta,
secondo cui se si torturano i dati abbastanza a lungo gli si può far confessare
qualsiasi cosa…Un recente studio dell’Osservatorio CPI (Conti Pubblici Italiani)
ha contestato i famosi "60 miliardi", cominciando col dire che «Innanzitutto,
l’analisi è basata sui dati di spese ed entrate di fonte CPT (Conti Pubblici
Territoriali a cura dell’Agenzia della Coesione) la cui somma per regioni è
molto diversa dai totali nazionali ISTAT, un punto (di notevole gravità) che è
già stato messo in evidenza dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Parlamentare di
Bilancio». Salvo poi, nella riga seguente, a dire che la ragione della
differenza sta nel fatto che i CPT considerano il Settore Pubblico Allargato
(SPA), che include, oltre alle Amministrazioni pubbliche (PA) di cui ai calcoli
dell’Istat, anche le aziende pubbliche, dalle grandi alle piccole
(municipalizzate). Quindi il fatto che la somma per regioni di fonte CPT è molto
diversa dai totali nazionali ISTAT non è un punto di ‘notevole gravità’, ma il
semplice risultato di un diverso universo di riferimento. A proposito, chi si
voglia prendere in carico un’analisi delle differenze fra i conti PA e i conti
CPT, può rivolgersi al sito della Agenzia per la Coesione Territoriale, dove è
possibile scaricare l’intera banca dati dei conti e una ponderosa guida
metodologica.
Non si può accusare l’Agenzia di mancare di trasparenza…E in
effetti, nelle Conclusioni, lo studio dell’Osservatorio CPI conclude – appunto –
che la cifra dei 60 miliardi ‘sottratti’ ogni anno dal Nord al Sud «è vera
soltanto se si considera l’intera P.A. allargata». Ma…, e qui veniamo alla
sostanza delle controdeduzioni: quella cifra non tiene «conto che una larga
parte delle sue spese non possono essere distribuite diversamente sul territorio
(partecipate e pensioni)». Cominciamo dalle partecipate (cioè le imprese
pubbliche). Dai tempi della famosa ‘Programmazione’ di Giorgio Ruffolo, alle
imprese pubbliche sono stati assegnati compiti di redistribuzione territoriale
degli investimenti e della presenza in loco, nell’ospedale da campo di questi
tempi e di questo Paese. Compiti ribaditi anche recentemente da norme e leggi
che assegnano alle grandi imprese pubbliche percentuali di spesa per gli
investimenti nel Mezzogiorno. Ma l’Osservatorio afferma che «considerare tutta
la P.A. allargata è discutibile, in quanto include delle spese il cui meccanismo
di allocazione è fondamentalmente il mercato e non una decisione politica». Non
si capisce allora perché queste imprese si portino appresso l’aggettivo
‘pubbliche’. Poi, per quanto riguarda le municipalizzate, queste forniscono
servizi pubblici, anche se sono fuori dal perimetro della PA, ed è quindi
legittimo includerle nei conti SPA. Veniamo alle pensioni. L’inclusione delle
pensioni nella spesa per Regioni – si dice – non ha senso dato che lo Stato non
può usare le pensioni a scopo redistributivo: queste dipendono dai contributi
versati (beh, in parte – come ha argomentato Giuliano Cazzola, una buona parte
delle pensioni pagate viene dalla fiscalità generale e non dai contributi
versati – col sudore della fronte – da imprese e lavoratori). C’è del vero in
questo argomento, ma l’argomento è a doppio taglio. Ci sono più pensioni pagate
al Nord perché in passato ci sono stati (e ci sono ancora) maggiori salari e più
occupazione al Nord. Ma più occupazione e più salari dipendono dal fatto che lo
Stato, malgrado la famosa "coesione territoriale" sia sempre stata presente nei
programmi di tutti i Governi, non ha fatto abbastanza per ridurre la piaga del
dualismo Nord-Sud. L’inclusione delle pensioni nella ripartizione territoriale
della spesa si giustifica come un eco di questo fallimento, un triste testimone
della minorità da sempre assegnata allo sviluppo del Mezzogiorno, che soffre da
sempre di una inadeguata dotazione infrastrutturale. Per quanto riguarda la
spesa per interessi (che è compresa nei conti CPT), la sua inclusione non altera
sostanzialmente i calcoli. Uno studio della Banca d’Italia sulla distribuzione
territoriale della ricchezza finanziaria (costituita in gran parte dai titoli
pubblici) suggerisce che la quota del Mezzogiorno sul totale è all’incirca
eguale alla quota degli abitanti sul totale Italia. Veniamo, infine, alla
questione del livello dei prezzi. Secondo l’Osservatorio, il fatto di ignorare
il più basso costo della vita al Sud «si traduce in ingenti trasferimenti da
parte delle amministrazioni pubbliche dal Centro-Nord verso il Mezzogiorno».
Ora, questo più basso costo della vita (che la Banca d’Italia ha quantificato in
circa il 10%, tenendo conto dei fitti effettivi) vuol dire che lo stipendio di
un dipendente pubblico – che, a parità di mansioni, è ovviamente identico in
tutte le zone del Paese – "vale" di più nel Mezzogiorno. Qui si innestano
sottili questioni di metodo e di concetto. Ora che abbiamo imparato a
distinguere fra Pil e benessere, è legittimo dire che un dato stipendio ‘vale’
di più, se altri elementi del benessere – qualità dei servizi pubblici,
sicurezza, mobilità… – scarseggiano? E in ogni caso, il livello dei prezzi di
cui si parla è quello del costo della vita. Ma la spesa non è fatta solo di
stipendi: è fatta anche di investimenti, di acquisti di beni e servizi (il costo
di una macchina per la risonanza magnetica o di una uniforme per un poliziotto è
davvero più basso al Sud?). Non abbiamo i dati per una "parità di potere di
acquisto" per tutte le sfaccettature della spesa pubblica. Ci sono molte pesanti
evidenze della minorità del Mezzogiorno nella distribuzione territoriale della
spesa; evidenze che potrebbero essere quantificate se il Governo procedesse
davvero al calcolo dei "Livelli essenziali di prestazioni" (Lep) previsti dalla
legge 42/2009, e mai messi in opera. Ma non c’è bisogno dei Lep per fare
semplici elaborazioni, già più volte presentate su questo giornale, sulla spesa
pubblica per abitante in tema di istruzione, sanità, ambiente e territorio…Cifre
su cui pensioni o interessi o imprese pubbliche non incidono significativamente,
ma che danno la misura di quanto il Sud sia stato penalizzato da molti anni a
questa parte.
TUTTI I NUMERI DELLO SCIPPO AL SUD CHE AFFOSSANO IL FUTURO DEL
PAESE. Dopo le “Operazioni verità”, il “Manifesto per
l’Italia” e l’appello per gli Stati generali dell’economia la battaglia condotta
del nostro giornale continua. Claudio Marincola il 13 giugno 2020 su Il
Quotidiano del Sud. «L’unica battaglia che si è persa in partenza è quella che
non si è mai combattuta». A qualcuno sembrerà esagerato scomodare addirittura il
comandante Che Guevara per raccontare le campagne di questo giornale. Se diciamo
però che aprire l’involucro delle mistificazioni e rovesciare le tante falsità
spacciate per verità non è stato facile, credeteci. Per troppo tempo al Sud sono
state sottratte risorse, investimenti produttivi, spesa pubblica. Un artificio
contabile, un gioco da prestigiatori e, oplà, i conti tornavano. Una foresta
pietrificata di pregiudizi, decenni di affabulazioni da smascherare.
OPERAZIONE VERITÀ SCIPPO SMASCHERATO. Sul Mezzogiorno, per anni,
la fabbrica all’ingrosso della manipolazione ha prodotto fake. Numeri
contraffatti diffusi come granitiche certezze. Presunti vizi antropologici
diventati luoghi comuni, caricature geografiche. Siamo partiti dai numeri. Dai
61,5 miliardi l’anno. Con il trapano della Spesa storica lo Stato ha continuato
a regalare al Nord, finanziando ogni genere di assistenzialismo. Abbiamo
raccontato, cifre alla mano, come la Regione Piemonte spenda per i suoi servizi
generale cinque volte più della Campania pur avendo un milione e mezzo di
abitanti in meno. Da sola più di quanto sommano insieme Campania, Puglia e
Calabria. Da queste colonne s’è sollevata, in britannica solitudine, la campagna
fatta propria da questo governo e inserita nella legge di bilancio: l’iniqua
distribuzione che ha privato il Sud di risorse destinando quote ben inferiori
alla soglia del 34%, la quota di popolazione residente. Scippo raccontato frame
dopo frame, come in un film. Titolo: “Operazione verità”. La banca del buco che
ha scavato sottotraccia per anni – abbiamo scritto – nelle pieghe del bilancio
italiano. Risultato: al Nord 735, 4 miliardi, il 71,7% della spesa pubblica
totale totale, al Sud solo 290,9 miliardi. Uno scarto rispetto alla quota dovuta
del 6%, pari, appunto, a 61,5 miliardi. Che vuole dire meno mense, meno servizi
pubblici, asili zero o quasi, etc., etc.
IL MANIFESTO PER L’ITALIA E LA LETTERA DI CONTE. La lotta per
ridurre le disuguaglianze vale al Nord come al Sud. Questo concetto, valido
anche in Europa, lo abbiamo chiaro, ed è con questo spirito che nel settembre
2019 è stato sottoscritto il Manifesto per l’Italia (LEGGI), uno stimolo per
politici, sindacalisti, ricercatori, studenti per far ripartire il Paese. Senza
tuttavia mai perdere di vista la bussola: il Mezzogiorno, area geografica dal
perimetro ben delimitato, il luogo in cui si è perpetrato un “delitto
all’italiana” gettando le basi culturali ed economiche della mancata crescita
nazionale. A rimetterci è stato infatti l’intero Paese, se è vero come è vero
che già prima del Covid-19 Nord e Sud d’Italia erano gli unici territori europei
a non aver raggiunto i livelli pre-crisi del 2008. Per l’esattezza: il nostro
Meridione 10 punti sotto. Il 12 settembre la lettera del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte: «Caro direttore, accolgo con favore la dichiarazione
di intenti del Manifesto, serve una fase nuova, ho condiviso con von der Leyen i
contenuti dell’agenda riformatrice…». La favola di un Sud pigro e sprecone –
generata da una classe dirigente inadeguata e corrotta – ha fatto da carburante
per alimentare la macchina dello scippo perfetto. Ed ecco in che modo gli aiuti
di Stato sono finiti in larga parte alla locomotiva d’Italia, la Lombardia che
ora riesce a malapena a trainare se stessa. Dalla metà del 2017 la regione del
presidente Fontana – un governatore che a volte sfiora forme di masochismo e si
fa male da solo – ha incassato ben 3,5 miliardi di euro contro i 600 milioni
della Campania. “Aiutini” di Stato andati anche a Veneto (1,5); Piemonte (1,3);
Emilia-Romagna (1,3); Lazio (1,1); Toscana (1,0); Trentino-Alto Adige (1,0).
LE MANI DEL NORD SUI FONDI EUROPEI. Sono i numeri di un’Italia
rovesciata. Con il Mezzogiorno che invece di aumentare la spesa degli
investimenti pubblici la vedeva ridurre dello 0,5% rispetto all’anno precedente
(Fonte Cresme). Il rischio di uno scenario da deriva greca, un Sud dove il
reddito pro-capite è la metà o quasi del Nord, un sistema Paese che non tira
più, il fantasma della Troika che avanza. Appena due mesi prima che si scoprisse
la diffusione del virus a Cologno una nostra inchiesta sui carrozzoni suonava
profetica: Il 42 per cento delle risorse sanitarie incassate dalle Regioni del
Nord, il 20 per cento dalle regioni del Centro e il 23 per cento da quelle del
Sud. Dati della Corte dei conti, diffusi in tempo non sospetti, in cui si diceva
tra l’altro che la quota di riparto del fondo sanitario nazionale era cresciuta
in Lombardia del 1.07 per cento contro lo 0,75 per cento della Calabria, lo 0,42
per cento della Basilicata e lo 0,45 per cento del Molise. In pieno lockdown c’è
stato anche chi, qualche tecnico del Mef, ha pensato di sfruttare la catastrofe
del contagio per dare alla Lombardia i finanziamenti dei fondi europei destinati
al Sud. La catastrofe della catastrofe. Una “rapina di Stato” in tempo di pace.
RI-FATE PRESTO IL DECRETO ILLIQUIDITÀ. Con il protagonismo dei
governatori si è scoperto l’inganno dell’autonomia differenziata. La sanità
pubblica svuotata, i presidi territoriali dismessi, i vantaggi concessi al
privato. I viaggi della speranza dei cittadini del Mezzogiorno per gonfiare le
tasche dei privati. Il modello-Formigoni che stiamo ancora pagando a caro
prezzo. In questo clima è partita la campagna “Ri-fate presto”. Un conto alla
rovescia contro la burocrazia e contro “l’esproprio” del decreto di lancio.
L’assurdo di uno Stato che invece di risarcire il danno arrecato ne approfitta
per entrare nel capitale sociale delle aziende con Invitalia e Cdp. L’assenza di
una cabina di regia, le responsabilità del ministro del Tesoro, Roberto
Gualtieri. Il fallimento del decreto “illiquidità”, l’incapacità di fornire
prestiti agli italiani e alle imprese in difficoltà. Il “tappo” delle banche
ammesso ancora ieri da Bankitalia, la rabbia degli italiani e di quanti saranno
costretti ad abbassare la saracinesca. Il ruolo della Commissione bicamerale
d’inchiesta sul sistema bancario presieduta dalla deputata Carla Ruocco. Il caso
limite degli “appestati”, i tanti italiani finiti per avventura o per disgrazia
nella famigerata Centrale rischi della Banca d’Italia, Condannati “a morte”
magari solo per una rata scaduta.
L’APPELLO PER GLI STATI GENERALI. Difficile in questi giorni
liberarsi dall’impaccio del reale e sognare una ripartenza di slancio. La crisi
da Covid ha messo a dura prova le difese immunitarie di un Paese già in
sofferenza. La liquidità che arriva con il contagocce, le aziende che chiudono,
il terrore di una seconda ondata, le nuove stime negative della Federal Reserve.
Da qui l’urgenza di abbattere le burocrazie ministeriali e bancarie e dotarsi di
un piano strategico di lungo respiro. È partito da queste considerazioni
l’appello lanciato dal Quotidiano del Sud per la convocazione degli Stati
generali dell’economia, l’esigenza di gestire in modo ottimale ed efficiente il
fiume di denaro che arriverà dall’Unione europea. Un appello raccolto dal
premier Conte, osteggiato da falchi, gufi e altri volatili in libera uscita, da
gabbia o da voliera. E la battaglia continua.
EQUITÀ: UNA SCELTA ETICO-POLITICA A VANTAGGIO (NON SOLO) DEL
MERIDIONE. Raffaele Vescera il 12.06.2020 su Movimento
24 agosto. Di Roberto Cantoni. Il meridionalismo fa più bene o male alle istanze
meridionaliste? La domanda può sembrare senza senso, ma la riflessione nasce da
una critica spesso formulata da parte di pensatori e pensatrici di sinistra a
movimenti come il nostro che, seppur teso all’equità territoriale in tutto il
territorio italiano, nasce come geograficamente ancorato a una realtà
macroregionale ben precisa. Semplificando all’osso, per i pensatori di sinistra
di estrazione marxista, la cosiddetta politica “della singola questione”, cioè
quella che si concentra su un tema in particolare – sia questo inerente al
genere (movimenti femministi), all’etnia (movimenti antirazzisti), al territorio
(movimenti regionalisti), all’ecologia (movimenti ambientalisti), alla
sessualità (movimenti anti-omofobia) – fa perdere di vista la lotta principale,
che è quella di classe, che vede opposti gli interessi del capitale a quelli dei
lavoratori, di qualunque etnia, provenienza e genere siano. Le altre lotte
possono essere sussunte in quella di classe. Quella della politica della singola
questione è una miopia, continuano i critici, che non fa che indebolire la
classe degli sfruttati, dividendoli in sottoclassi antagoniste che potrebbero
invece associarsi per combattere gli interessi del capitale. E mentre la
sinistra si frammenta sulle singole questioni, scindendosi fino all’inverosimile
(celebre la satira di Guzzanti-Bertinotti sulla “viralità” della nuova
sinistra), la destra, che per sua natura è meno pluralista e più monolitica, se
non si consolida, almeno non si frammenta, e di conseguenza risulta
percettivamente più coesa, più convincente, e, in breve, vince le elezioni in
mezzo mondo. Che poi è la tendenza generale degli ultimi anni. È la tesi, per
esempio, del geografo marxista statunitense David Harvey. La domanda che Harvey
ci potrebbe porre è quindi: e se calcando la mano sul meridionalismo ci
perdessimo dei possibili alleati politici? Alleati che potremmo trovare, per
esempio, in movimenti e partiti cui sta a cuore, come a noi, la questione
dell’equità territoriale, ma che non ne fanno il principale cavallo di battaglia
della loro linea politica? Non è, insomma, che concentrarsi sugli sfruttati del
Meridione ci tagli fuori dalla possibilità di ricevere il sostegno degli
sfruttati di altri territori? Non è una tesi nuova. Gramsci sosteneva, per
esempio, che fosse possibile un’alleanza tra contadini nel Sud e operai del
Nord, in nome di una società socialista. Ma erano gli anni Venti del secolo
scorso. Cent’anni dopo, possiamo dire che quest’alleanza non si è verificata: in
parte è stata una conseguenza della strategia di quella che Eugenio Scalfari e
Giuseppe Turani negli anni ’70 chiamarono ‘razza padrona’: mettere gli sfruttati
gli uni contro gli altri. In parte, è stato perché le premesse su cui si basava
l’idea gramsciana in questo caso erano deboli. Troppo lontani gli interessi
immediati di contadini e operai, troppo diverse le loro mentalità (anche se va
riconosciuto che il figlio del contadino meridionale emigrava diventando operaio
al Nord, quindi i confini tra i due gruppi non sono così netti come si potrebbe
credere). Contadini meridionali troppo conservatori, quindi. Ironico, sei si
pensa che il brigantaggio, stroncato dall’esercito piemontese, nacque proprio
come lotta di classe. Ma quelle velleità di lotta erano state appunto annullate
nel post-Conquista, o erano confluite in altre istanze rivendicative, non di
classe ma di potere, ben radicate localmente. L’occasione persa di una possibile
alleanza contadini-operai, e la presa d’atto del conservatorismo politico della
classe agricola meridionale, portarono gradualmente la sinistra meridionale a
distaccarsi dai suoi sfruttati, e ad assumere la narrativa operaista
settentrionale come dominante. La rivoluzione si sarebbe fatta a partire dalle
fabbriche, non dalle campagne. Questa narrativa si è poi espansa nei decenni,
includendo pian piano istanze anticolonialiste, antisessiste e, a volte, anche
antispeciste (o ecosistemiche). Ma, con buona pace di Gramsci, Salvemini e
compagnia, quello della subalternità politica del Sud è rimasto un tabù, a
sinistra, e lo è tuttora. In alcuni ambienti della sinistra massimalista
meridionale riesce più accettabile battersi per le lotte basche, palestinesi e
curde, che per la fine della subalternità del Sud al Centro-Nord o, per citare
Nicola Zitara, del colonialismo interno italiano. Ma torniamo al punto: si perde
o si guadagna, in termini strategici, puntando su una politica che abbia come
cardine il Meridione? Dipende da come si struttura il discorso politico. Finita
l’epoca dell’utopia gramsciana, occorre ricordare due punti: il primo sono i
tantissimi meridionali che vivono al Centro-Nord; il secondo è che l’iniquità
territoriale c’è anche in quelle zone. Se il Sud è la periferia d’Italia,
laddove il Nord ne è il centro, il Nord rurale è la periferia del Nord centrale.
Di conseguenza, le nostre rivendicazioni devono essere inclusive, e avere un
obiettivo di ampia portata, il più universale possibile. È una scelta
etico-politica, che il nostro movimento ha compiuto puntando sull’equità
territoriale come obiettivo primario, e coniugando così gli interessi del Sud,
territorio che subisce una forte iniquità territoriale, con quelli di altre zone
del territorio italiano. “Ovunque qualcuno sia discriminato, lì c'è lavoro per
M24A-ET. Non è una questione geografica, ma pratica (e morale)”, riporta la
pagina di presentazione del Movimento. Il posizionamento è chiaro. La questione
non è più, quindi, soltanto quella del Meridione, ma si tratta di una
rivendicazione più ampia, potenzialmente in grado di coinvolgere anche realtà
non meridionali. Una rivendicazione che però non può e non deve prescindere
dalla storia politica del territorio italiano.
RAZZISMO CONTRO IL SUD E DIRITTI NEGATI.
Raffaele Vescera il 06.06.2020 di Roberto Oliveri del Castillo,
su Movimento 24 agosto. Il senso del 2 giugno, tra razzismo strisciante e
diritti negati. Le celebrazioni della Festa della Repubblica cadono quest’anno
in un momento molto delicato. Fuori dalla retorica, esse coincidono con il
termine della mobilità tra regioni bloccata dal marzo scorso per l’emergenza
Covid19, e nel pieno delle polemiche innescate dalle dichiarazioni del sindaco
di Milano Sala, ed altri politici del Nord, in risposta alle richieste
provenienti da alcuni presidenti di regione del Sud, che chiedevano controlli e
attestazioni di negatività al Covid19 per consentire gli ingressi ai turisti
provenienti da nord. A questa richiesta, che appare di puro buon senso, il
sindaco Sala ha risposto con un minaccioso “Ce ne ricorderemo” (“Patente di
immunità chiesta ai milanesi? Ce ne ricorderemo”, Corriere della Sera, 27 maggio
2020). In tema di ricordi, anche noi ne abbiamo qualcuno. Ad esempio ci
ricordiamo ancora come furono trattate Napoli e Bari all’epoca del colera, per
una epidemia che fece a Napoli 24 morti e poco più di 200 ricoverati nel 1973.
Ebbene, si scatenò una vera e propria psicosi, incrementata e fomentata dagli
articoli dei maggiori quotidiani dell’epoca. L’assessore regionale alla Sanità
della Lombardia, diramò una nota in cui raccomandava a chiunque provenisse da
“zone infette” di presentarsi agli uffici sanitari comunali per controlli; a
Sanremo, una famiglia di napoletani fu rifiutata dall’albergatore perché gli
ospiti presenti (pare tedeschi, milanesi e torinesi) non erano disposti a
condividere l’albergo con i malcapitati napoletani; l’incontro di calcio
Genoa-Napoli di Coppa Italia fu vietato per evitare l’arrivo in Liguria di
tifosi napoletani al seguito della squadra, “per evitare pericoli di diffusione
del colera”; la Lega Calcio dispose l’inversione del campo, ma di giocare a
Napoli si rifiutarono i giocatori del Genoa, per gli stessi pericoli di
infezione; per gli stessi motivi i giocatori del Verona si rifiutarono di
scendere a giocare a Bari, dove si registrava un altro piccolo focolaio
infettivo. “Rifiuti giusti”, dirà il Corriere della Sera del 16 settembre 1973.
Nonostante i numeri veramente esigui dell’epidemia di colera, subito isolata e
sconfitta grazie al lavoro di quella che già all’epoca era una eccellenza
nazionale come l’Ospedale Monaldi, il blocco subito da Napoli si protrasse per
diversi mesi. Non si registrarono, tuttavia, commenti indignati, strali contro
il razzismo più o meno strisciante, invocazioni contro sentimenti antinapoletani
o altro. Invece in questi mesi abbiamo perso il conto di quanto
giornalismo-straccio abbia scaricato sul Sud ogni genere di invettiva, quasi
come se il Covid19 al Nord l’avesse portato qualche napoletano o qualche
calabrese. Come non ricordare ad esempio la domanda posta da Barbara Palombelli
(Stasera Italia del 20 marzo 2020): “Il 90% dei morti è nelle regioni del nord.
Cosa può esserci di diverso? persone più ligie, che vanno tutte a lavorare?”.
Quindi a noi ci avrebbero salvato disoccupazione e nullafacenza. O ancora,
sempre in risposta alle perplessità avanzate dal presidente della regione
Campania De Luca ed alla prospettiva di chiudere la Campania agli arrivi da nord
in caso di contagio ancora in atto, alla trasmissione di Rete4 “Fuori dal
coro”, Vittorio Feltri rivolto a Mario Giordano, che gli chiedeva se pensava di
andare in Campania, “Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare cosa? I
posteggiatori abusivi?” per poi aggiungere: “I meridionali sono inferiori”.
Innumerevoli poi i servizi giornalistici finalizzati a scoprire violazioni delle
indicazioni antiassembramento a Napoli, con la giornalista RAI Serena Bortone
(Agorà 15 aprile 2020) che chiede all’inviata milanese (ma a proposito, la RAI
non ha una sede a Napoli? perché inviare una giornalista milanese? a spese di
chi? misteri…) “tu che hai uno sguardo nordico sul nostro amato sud, puoi dirci
se Napoli è vuota o no?”. L’inviata risponde “siamo qui da mezz’ora e fin’ora
cera un passaggio di auto abbastanza forte nonostante sia una zona pedonale”.
Ebbene, la scaltra giornalista era al limite tra una zona carrabile e la zona
pedonale del Vomero (via Scarlatti), e comunque le immagini ritraevano durante
tutto il servizio giusto un paio di vetture. Ma il massimo lo raggiunge dopo
pochi secondi, quando è costretta a dire “Niente, non siamo fortunati, in questo
momento non c’è nessuno, ma fino a pochi minuti fa c’era un passaggio di auto
intenso”. Certo, ci crediamo. Ma il pregiudizio antinapoletano può colpire
involontariamente chiunque, anche una giornalista napoletana come Myrta Merlino,
che a “L’aria che tira” su La7, dirà sull’ospedale Cotugno, “Per me è
incredibile, non ci aspettavamo mai che l’eccellenza arrivasse da Napoli. La
storia del Cotugno napoletano ci ha tutti sorpresi”, costringendola poi alle
scuse per le successive polemiche. Il servizio parlava del fatto che per tutto
il periodo dell’epidemia nell’ospedale napoletano attrezzato per il Covid19, non
si era registrato alcun contagio tra il personale medico e paramedico, come
rimarcato da testate straniere (SkyNews UK). Qualche riflessione su questo tipo
di giornalismo scandalistico e discriminatorio, e sull’atteggiamento di certa
politica, ai limiti del razzismo, va pur fatta. E la riflessione va fatta
partire, a mio avviso da lontano, dai primi anni ’90 del secolo scorso, grosso
modo con l’esplosione del “leghismo”, quando nel dibattito politico fanno
irruzione concetti di critica smodata a presunte politiche assistenzialiste
alle regioni del Sud, con le risorse del ricco Nord produttivo, invalse
soprattutto dagli anni ’50 del secolo scorso fino agli anni ‘90. Su tali
argomenti il “leghismo” ha costruito le sue fortune politiche sin dalla nascita,
al grido di “Roma ladrona”, “Sud parassita”, “indipendenza del Nord” e così via,
quasi che tutti i mali dell’Italia che produce fossero sintetizzati nella parola
“Sud”, e che l’unica soluzione fosse staccarsene, o meglio minacciare il
distacco per ottenere vantaggi di tipo politico ed economico. Ma in fondo, i
fatti sono realmente come vengono esposti da questa facile vulgata di provincia?
Esiste sul serio questo Sud improduttivo che consuma le risorse del Nord? O
invece, scavando un po' nel passato e nel presente, troviamo che è vero il
contrario, ovvero che storicamente il Nord ha ampiamente saccheggiato le
risorse del Sud, le sue energie migliori, ed ha continuato per decenni a
destinare percentuali minime di bilancio alle infrastrutture del Sud a vantaggio
del Nord, più omogeneo alla nuova classe dirigente sabauda? Ed a tutt’oggi,
continua o meno, con la complicità delle organizzazioni criminali e di una
classe politica meridionale collusa e corrotta, ad utilizzare il nostro
Meridione come una colonia d’oltremare, una terra da riempire di spazzatura
spesso pericolosa come una enorme discarica, per traffici illegali, o con
industrie obsolete ed inquinanti come l’ex Ilva, lasciandoci in una costante
situazione di sudditanza? E infine, quello che sta accadendo intorno al calcio,
con cori razzisti e discriminatori in molti stadi del centronord sempre contro
Napoli e i napoletani, visti come simbolo di “Sud”, di “diversità”, di “minorità
socioculturale”, con agguati organizzati da centinaia di teppisti contro una
carovana di tifosi napoletani con famiglie al seguito, è ancora qualificabile
come follie di pochi facinorosi, oppure è ormai reale sintomo di una società
malata di razzismo e di odio discriminatorio nei confronti del “diverso”, di
colui che appartiene ad altra collocazione geografica, il meridionale per
antonomasia? Le cronache di questi mesi sono l’ennesima riprova che
probabilmente la malattia non può essere confinata al mondo del calcio, ed ha
invece contaminato ed eroso le radici stesse della nostra convivenza civile,
come dimostrano le polemiche dei mesi dell’emergenza Covid19. Proviamo allora a
riflettere su quanto questo razzismo strisciante, carsico, che esplode e viene
in emersione ciclicamente in occasione di incontri di calcio (dove le tifoserie
avversarie si coalizzano addirittura insultandone una terza estranea, o
organizzando addirittura agguati armati nei confronti di famiglie inermi che si
recano allo stadio) come in occasione di emergenze nazionali, quanto sia
profondo, e quanto radicato nella nostra società, poiché quanto più queste
radici affondano nella storia, tanto più sarà difficile estirparlo e bruciarlo
come si conviene ad una gramigna che soffoca la pianta buona. Volendo affrontare
la questione con qualche base attendibile dal punto di vista storico, si dovrà
quindi mettere necessariamente in discussione qualche certezza storica, in
realtà priva di fondamento, e rimettere al contempo in discussione quanto la
vulgata risorgimentale ha sapientemente instillato in 150 anni di celebrazioni
di una unità nazionale densa di retorica ma a ben vedere priva di fondamento.
Una unità nazionale che,a fare attenzione, appare essere stata imposta dalla
dinastia sabauda – contro la volontà dello stesso Cavour - per propri scopi di
potere e arricchimento personale, con il ricorso alla forza, a due popoli quello
del nord e quello del sud, che non avevano alcuna intenzione di essere uniti, e
con il ricorso ad un vero e proprio genocidio della popolazione meridionale
gestito dalle sfere militari piemontesi, col beneplacito del Re Vittorio
Emanuele II e del Conte di Cavour, dal famigerato gen. Enrico Cialdini e i suoi
sottoposti. Ma ciò che non molti sanno, soprattutto perchè in questi 150 anni
sapientemente censurato ed espunto dai libri di storia ed emerso solo in saggi
storici di autori non di regime, sono i giudizi e le affermazioni di stampo
razzista, spesso provenienti da riconosciuti “padri della Patria”, che
costituiscono l’antecedente culturale diretto delle attuali vergognose cronache
a margine di molte partite di calcio. Il primo ad esprimersi in termini
inequivocabilmente razzisti sull’unione tra nord Italia e stati del Sud fu
Massimo D’Azeglio, che in un lettera privata scrisse: “La fusione con i
Napoletani mi fa paura; è come mettersi a letto con un vaiuoloso” (cit. da
Giordano Bruno Guerri, Il sangue del sud – antistoria del Risorgimento e del
Brigantaggio, Mondadori). Ma D’Azeglio è solo uno degli esempi di eroi del
Risorgimento che in privato dimostrava di detestare i meridionali e in un certo
senso svela quali logiche e quali inconfessabili motivi hanno portato i
piemontesi all’annessione del Regno di Napoli. Cavour e Farini, suo ministro
degli interni nel 1860, avevano fitte corrispondenze dove il secondo scriveva al
primo: “Che paesi sono mai questi, il Molise e la Terra di Lavoro (che all’epoca
comprendeva le province di Caserta e Frosinone, ndr.). Che barbarie! Altro che
Italia! Questa è Affrica: i beduini, a confronto di questi caffoni, sono fior di
virtù civile”. Anche nei resoconti giornalistici il Sud viene considerato una
terra da annettere e civilizzare piuttosto che una regione che entrava alla pari
in un nuovo stato, sicuramente più simile ad una colonia d’oltremare che ad un
territorio di pari dignità. E l’emblema di questa presunta arretratezza ed
inciviltà risiedeva nella vecchia capitale, vista come una terra caratterizzata
da “incapacità, corruzione, inerzia, abitata da un popolo ignorante, ozioso,
instabile” come scrive un parlamentare impegnato, come Costantino Nigra, nella
campagna contro il brigantaggio, e addirittura un parlamentare di sinistra come
Aurelio Saffi, deputato di un collegio lucano, definì il Sud “un lascito della
barbarie alla civiltà del XIX secolo”. Il famoso luogotenente di Garibaldi, Nino
Bixio, scriverà al Generale: “ (il Sud) è un paese che bisognerebbe distruggere
o almeno spopolare e mandare in Africa a farsi civile”. Il presidente del
Consiglio unitario dopo Cavour, Bettino Ricasoli, definì Napoli, fino a pochi
mesi prima una delle prime e più brillanti capitali d’Europa, “una cloaca
massima dove tutti gli uomini più onesti sono destinati a perire”. E i pochi
meridionali che facevano parte dei primi governi unitari non furono da meno
quanto a pregiudizio antiborbonico e antimeridionale, essendo ormai di cultura
piemontese e schierati con lo stato sabaudo dal quale traevano vantaggi politici
e benefici economici come l’economista napoletano Scialoja e l’abbruzzese
Spaventa, ed avendo ormai da anni reciso i legami con le terre d’origine. La
realtà è che la spedizione dei Mille e tutto il clima politico e sociale
precedente lo sbarco di Marsala, aveva creato l’attesa di una svolta epocale e
un alba di nuovi diritti, soprattutto nelle classi meno abbienti; i contadini,
da sempre sfruttati dal regime baronale, credevano che con Garibaldi finalmente
si sarebbe affrontato il tema della distribuzione delle terre, da sempre
respinto dai grandi latifondisti. E tuttavia, nei momenti critici come in caso
di carestie, la ricchezza del regno borbonico e la sua vocazione paternalistica
consentiva interventi a sostegno delle popolazioni con distribuzioni di farina e
pane, cosa che invece non si verificò più con i nuovi regnanti. Inoltre, le
promesse di terre fatte da Garibaldi furono subito smentite dai Savoia, che
cercarono il consenso dei vecchi ceti nobiliari e della nuova borghesia
imprenditoriale sempre a scapito dei contadini. Ciò determinò l’emarginazione
del vecchio Generale che di fatto si ritirò a Caprera dopo l’incontro diTeano
proprio per il naufragare degli ideali unitari e nel vedere la guerra al
brigantaggio condotta con criteri cruenti e colonialistici. Su quella che si
avviava a diventare una vera e propria guerra civile il vecchio Generale
ravvisava “una questione sociale, che non si poteva risolvere col ferro e col
fuoco, di cui erano responsabili il Governo e la borghesia, e che in gran parte
dovuta allo scioglimento dell’esercito borbonico senza che lo stesso fosse
assorbito nel nuovo esercito nazionale”(cfr. E.Perino, Vita di G. Garibaldi,
1882, p.796). Già nel 1861, quando i focolai di rivolta erano diffusi in tutto
il territorio dell’ex Regno di Napoli, Cavour nominò luogotenente generale per
le zone annesse il principe Eugenio di Carignano, al quale veniva affidato il
compito di normalizzare la situazione dell’ordine pubblico nelle zone del Sud,
con una lettera dal tenore inequivoco: “Il Paese e il Parlamento reclamano a
gran voce che si adotti un sistema di rigore e di fermezza che si imponga alla
razza volubile e corrotta del Regno di Napoli”. Non c’è da meravigliarsi, se
queste erano le disposizione governative, se la guerra al brigantaggio assunse
accenti da vera e propria crociata quando morto Cavour, e salito al potere
Ricasoli, di idee ancora più estreme, il compito di sovrintendere all’ordine
pubblico fu dato al famigerato generale Enrico Cialdini. A costui non solo si
deve la distruzione,con l’uccisione deliberata di gran parte dei suoi abitanti,
compresi donne vecchi e bambini, dei due paesi simbolo di quella che a tutti gli
effetti può essere chiamata “la guerra civile risorgimentale”, ovvero
Pontelandolfo e Casalduni, ma si devono anche le cifre delle sue attività solo
nelle province napoletane: circa 9.000 fucilazioni, oltre 7.000 prigionieri, 6
paesi distrutti, oltre 13.000 prigionieri deportati, 1.400 paesi posti in stato
d’assedio. Non sono numeri da lotta alla criminalità, ma numeri da guerra civile
nei confronti di popolazioni colonizzate malvolentieri e tutt’altro che aderenti
con liberi plebisciti (per lo più taroccati) ad un nuovo stato unitario su basi
paritarie. Tra il luglio e l’agosto 1861 Abruzzo, Molise, Sannio, Ciociaria,
rappresentano i luoghi più sconvolti da insorgenza, ribellioni, massacri di
massa. Solo a Napoli, e solo nel mese di Luglio 1861, il gen. Cialdini aveva
fatto fucilare quasi 600 oppositori, oltre a centinaia di incarcerazioni
sommarie. Tra questi i briganti veri e propri erano una minima parte, per il
resto vi erano soggetti che per la storiografia ufficiale viene ascritta al
brigantaggio, mentre per la versione borbonica erano semplici oppositori del
regime sabaudo e pubblici critici della monarchia piemontese. Tra gli arrestati
figura addirittura il Cardinale Sisto Riario Sforza e il suo vicario, lasciati
in carcere qualche giorno e poi portati in nave a Genova. La ribellione armata
in quei giorni montava, Castellammare era tornata sotto il controllo borbonico,
e la stessa Napoli era in procinto di essere assediata da truppe legittimiste
borboniche. Cialdini chiese aiuto (di nuovo, dopo quanto era avvenuto durante lo
sbarco di Marsala, evidentemente secondo precisi accordi presi da Cavour) al
commodoro inglese che era di stanza in zona, e ben 400 soldati inglesi sbarcati
dalla nave da guerra Exmouth (a proposito, ma che ci facevano nel porto di
Napoli?) aiutarono i piemontesi a respingere gli assalti. Poco dopo altre sette
navi britanniche giunsero con compiti di supporto e se necessario, di intervento
armato, ovvero bombardare gli insorti. In quei giorni Pontelandolfo era tornata
sotto controllo borbonico con l’intero paese che aveva festeggiato il ritorno
delle insegne di Francesco II. Cialdini fece muovere le truppe del generale de
Sonnaz da Campobasso, tra queste un drappello di una quarantina di soldati agli
ordini del tenente Cesare Augusto Bracci che doveva restare nei dintorni di
Pontelandolfo, in attesa dei rinforzi, senza addentrarsi nell’abitato, affatto
sicuro. Invece l’incauto Bracci entrò nel paese e fu circondato da una folla di
contadini armati. Decise così di fare rotta verso Casalduni, ma la strada era
controllata da reparti dell’esercito borbonico sbandati, agli ordini del
sergente Angelo Pica, detto “Picuozzo”, lo scontro fu inevitabile e i piemontesi
(l’esercito si sarebbe potuto chiamare italiano solo se fossero stati
implementati i reparti borbonici, ma non essendovi soldati napoletani,
l’esercito continuava in sostanza ad essere quello piemontese) ebbero la peggio,
alcuni soldati savoiardi morirono, e gli altri furono disarmati efatti
prigionieri. Condotti a Casalduni, il sergente Pica voleva liberarli dopo
averli interrogati, trovandoli non colpevoli delle precedenti razzie nella zona,
ma la folla ne decretò la fucilazione come rappresaglia per le violenze commesse
dai soldati piemontesi in quei mesi nella zona, quando le soldataglie
razziavano, uccidevano, violentavano civili inermi nel tentativo di avere
notizie e informazioni sulle bande di briganti della zona, che tali erano le
modalità della raccolta di informazioni in questa vera e propria guerra civile.
La rappresaglia decisa da Cialdini fu quella che si percepisce tra le pagine non
dei manuali di storia, che non ne parlano, ma nelle pagine di saggistica
specifica, di siti internet alternativi (tutti citati da G.B.GUERRI, Il sangue
del Sud, cit.) e non censurate dalla retorica di Stato. I due paesi furono
distrutti ed incendiati di li il 14 agosto 1861 con tutti i loro abitanti
(Pontelandolfo ne contava 5.000, Casalduni 3000: oggi sono ridotti a meno della
metà). Le cronache ufficiali parlano di circa 160 morti. Quelle ufficiose di
almeno 900 morti ed un numero imprecisato di dispersi, tanto che il deputato
milanese Giuseppe Ferrari in Parlamento si espresse così rivolto a Cavour, dopo
aver fatto un viaggio nei due paesi distrutti, rievocando l’orrore visto
direttamente a Casalduni: “A destra e a sinistra le mura erano vuote e annerite,
dalle finestre vedevasi il cielo. Qua e là incontravasi un mucchio di sassi
crollati…edifici puntellati minacciavano di cadere a ogni istante…”, e a poche
anime che ancora vagavano come fantasmi si vedeva in faccia l’orrore vissuto
delle razzie dei piemontesi che depredavano le case prima di incendiare e
uccidere al grido di “Piastre! Piastre!” mentre cercavano gioielli e preziosi,
addirittura strappandoli di dosso alle donne prima di violentare ed uccidere.
“Di fronte ad un uditorio dal quale provenivano anche risate e sghignazzi,
Ferrari concluse: “Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel
sangue, non so come esprimermi” (cfr. “ Il sangue del sud”, G.B. Guerri, cit. ,
pag. 150, 151). A fronte di dati difficilmente discutibili date le stesse
cronache di soldati piemontesi (basta leggere i resoconti dell’eccidio redatti
da Carlo Mangolfo, un bersagliere di Sondrio citato da Giordano Bruno GUERRI nel
suo ultimo saggio citato sopra) ci sono ancora ricostruzioni di storici filo-
piemontesi tese a minimizzare i fatti e gli eventi di quell’agosto di sangue del
1861, per lo più prive di fondamento storiografico o basate su letture di
parte, oltre che infarcite di luoghi comuni giustificazionisti con la “lotta al
brigantaggio”, in cui “bisogna tenere conto del contesto” e “dell’uccisione di
41 soldati del Regio Esercito” (cfr. “Il doppio massacro di Pontelandolfo”,
Sergio Boschiero, in Storia in rete del 12.6.2018, pag. 62 e ss., o ancora
“Borbonia felix…o infelix?”, altro articolo folcloristico e irridente, Pierluigi
Romeo di Colloredo, ivi, pag. 18 e ss.). In questa pseudo saggistica
filo-piemontese , dove si giustifica tutto, si mette quasi in burla il Regno
delle Due Sicilie, si legittima l’operato di Cialdini e Negri (il comandante sul
campo che si occupò della rappresaglia verso i due paesi), dove si afferma che
“le violenze c’erano da entrambe le parti”, e che c’era la legalità da una parte
e i terribili briganti dall’altra, (con ciò da una parte negando la realtà di
una vera e propria guerra civile che infiammò il decennio tra il 1860 e e il
1870, e dall’altra legittimando il concetto di rappresaglia nei confronti di
inermi popolazioni civili, che costituisce a tutti gli effetti un crimine
contro l’umanità come hanno dimostrato i processi instaurati solo 80 anni dopo
contro i nazisti (Fosse Ardeatine, Marzabotto, etc.), stranamente si tace un
aspetto. Ma alla fin fine, perché? Perché queste trame diplomatiche, questi
accordi internazionali tra Regno sabaudo, Francia, Inghilterra, questa ansia di
procedere alla unificazione delle terre italiane, questi movimenti di truppe
senza bandiera e senza uniforme, quando le popolazioni che si volevano unificare
erano così arretrate, barbare, povere, incolte, e piene di difetti, tali da
essere più africane che italiane? Per gli ideali di unità, di Patria, di
italianità? o non c’erano dietro ben definiti interessi economici che
condividevano I Savoia con Francia e Inghilterra, magari paludati e occultati da
grandi ideali patriottici? Ci sarebbe materia per un'altra ben più lunga
riflessione, che non è il caso di infliggere al paziente lettore di queste note.
Sta di fatto che spesso i più biechi interessi economici vengono veicolati nella
popolazione con ben più allettanti principi e ideali, basti pensare alla
dottrina Wilson e all’autodeterminazione dei popoli, che se da una parte si
poneva come argine al totalitarismo, dall’altra consentiva la rivendicazione di
autonomie anche violente per il crogiulo di popoli costituito dall’Europa
soprattutto nell’Est, o in tempi più recenti ai processi di integrazione europea
basata solo su criteri di matrice economica. Ebbene, forse la risposta sta, come
sempre, nelle analisi economiche piuttosto che negli ideali dei patrioti.
Citando uno studio di Francesco Saverio Nitti, non certo uno studioso
“neoborbonico” contemporaneo, G.B. GUERRI riporta dati economici inequivocabili.
Nel 1860 la riserva aurea del Regno di Sardegna ammontava a 27 milioni di lire,
il Granducato di Toscana aveva da parte 85, 2 milioni di lire, Romagna Marche ed
Umbria 55,2, mentre le riserve auree del regno delle Due Sicilie ammontavano
alla astronomica cifra di 445, 2 milioni. Ecco spiegato, forse, il motivo di
tanto fervente ardore ideale nel Re sabaudo, e perché invece uomini politici più
avveduti come lo stesso Cavour, a fronte delle differenze sociali e culturali,
auspicavano invece soluzioni federaliste, purtroppo non considerate né da
Vittorio Emanuele II per ingordigia, né da Francesco II per incapacità e miopia
politica, non volendosi inimicare il Papa. L’annessione si rivelò, quindi, un
grande affare per il Piemonte, e mentre da una parte il Sud era letteralmente
depredato delle sue ricchezze, delle sue riserve auree, delle sue fabbriche
all’avanguardia tecnologica, dall’altra parte lo stesso Sud era ridotto a
colonia di smistamento dei prodotti industriali del nord Italia, ed in più,
oltre ai danni, la beffa delle cronache folkloristiche sulla presunta
inferiorità civile e morale dei meridionali, quasi a giustificare il sacco che
stava avvenendo. Se oltre a questo aggiungiamo che la spesa per le terre nell’ex
regno di Napoli raggiungeva percentuali minime di bilancio rispetto a quanto era
speso al Nord, con la complicità di una classe dirigente meridionale
parassitaria, collusa e cialtrona, ben descritta da Tomasi di Lampedusa ne “Il
Gattopardo”, il quadro di insieme di quella che già allora era definita “la
questione meridionale” appare completo. Ce n’è abbastanza per cominciare a
rivendicare, magari proprio per il 14 agosto, la data per il ricordo delle
vittime del genocidio della gente meridionale che si opponeva all’invasore
piemontese e che tradì tutti gli ideali di svolta sociale e di rivendicazioni
libertarie che venivano evocate in quel periodo, procedendo ad una annessione
colonialistica basata sul saccheggio e sul sangue dei vinti. E sarebbe l’ora che
le sonnacchiose e inerti classi politiche meridionali trovassero un minimo di
coraggio ed orgoglio identitario per far finalmente riscrivere una pagina di
storia negletta e soffocata da una retorica di regime ormai insopportabile e
appestata dal tanfo mefitico della menzogna. Con ciò non si vuol certo difendere
un regime reazionario, autoritario e sanguinoso come quello borbonico sotto il
Re Ferdinando II, o dire che tutto era perfetto nel Regno delle Due Sicilie
come fosse una Città del Sole, (come vuol fare apparire in modo poco storico e
molto folkloristico l’articolo “Borbonia felix o …infelix?” lo storico
Pierluigi Romeo di Colloredo sulle tesi neoborboniche, in Storia in rete, cit.,
pag. 18 e ss.). Si vuol solo dire che gli ideali di libertà, riforme economiche,
diritti civili, utilizzati nella propaganda filo-sabauda e che tanti convinse a
sposare la causa “unionista” si è rivelato un autentico specchietto per le
allodole, e la dimostrazione di ciò si ebbe con la saldatura tra la classe
dirigente piemontese e le classi abbienti soprattutto siciliane, a danno dei
ceti contadini e produttivi del Sud, e ancora di più, sotto il profilo militare,
con la battaglia d’Aspromonte tra piemontesi e garibaldini, dove Garibaldi fu
bloccato nel proposito di spingersi fino a Roma, e arrestato per impedirgli
altri colpi di mano. “Loro hanno creduto”, si potrebbe dire parafrasando il
famoso romanzo di Anna Banti, a proposito dei patrioti meridionali che tra il
1848 e il 1860 pensavano di instaurare un regime di riforme e di libertà al Sud
grazie ai Savoia, mentre invece consentirono ad un regime autoritario di
sostituirsi ad un altro, come si vede anche nel bel film di Mario Martone.
Quindi non tanto deprecare un’unità che, come si è visto, in realtà si voleva
solo per interessi economici, ma deprecare e stigmatizzare il modo attraverso
il quale si è giunti a tale unità, a colpi di cannone e di stragi piuttosto che
di riforme sociali e diritti civili, che consentissero di rendere omogenei due
territori e due popoli tanto diversi per storia, cultura, costumi, lingua.
Partendo da tale consapevolezza, non è escluso che possa ripartire con maggiore
serietà anche una più incisiva battaglia per debellare il razzismo negli stadi
italiani, esemplificato dai cori discriminatori e razzisti, sospendendo le
partite e chiudendo settori di stadi allorquando queste vergogne avvengano. Gli
anni tra le due guerre mondiali e dal secondo dopoguerra ad oggi, con spese in
bilancio caratterizzate sempre da fondi destinati in gran parte al centro nord,
ed al sud erogati con criteri emergenziali e di stampo assistenzialistico, che
hanno finito per ingrassare criminalità organizzata e ceto amministrativo
parassitario meridionale, costruendo generazioni di politici di respiro
strettamente localistico, è fenomeno tutt’ora particolarmente evidente con
l’assenza di interventi strutturali seri e credibili per la vita delle comunità
locali (le vicende kafkiane del Palagiustizia di Bari, atteso da 20 anni, o
dell’ILVA di Taranto, per restare in Puglia, sono emblematiche del
gattopardismo nostrano e connotano da decenni la vita pubblica meridionale).
In tutto questo, non c’è risvolto della vita quotidiana nel quale questo odioso
cripto-razzismo non faccia a volte biecamente capolino, come in occasione della
vicenda della annunciata nascita di un distaccamento della Scuola Superiore
Normale di Pisa a Napoli, d’intesa con l’Università Federico II. Il progetto,
dopo aver avuto tutti gli assensi dei due Atenei coinvolti e del competente
Ministero, è stata fatta naufragare dal sindaco leghista di Pisa, insorto
all’idea che Pisa e Napoli potessero unirsi in un progetto formativo di alta
qualità. Le dichiarazioni rese alla stampa sanno tanto della frase di Massimo
D’Azeglio sui napoletani, e costituiscono una brutta pagina per l’autonomia
dell’Università: “Non ci sarà nessuna Normale al Sud. La scuola d’eccellenza è e
resta pisana e rimane nella nostra città. Abbiamo fatto una battaglia per Pisa e
la dimostrazione che quando le amministrazioni locali insieme ai deputati eletti
lavorano per il territorio i risultati arrivano”. Il sindaco leghista di Pisa,
Conti, può andare fiero di sé. Pisa è salva, anche se non si sa da cosa. Forse
questo oscuro funzionario di partito non sa, tutto chiuso nell’angusto spazio di
piazza dei Miracoli, che l’Università di Napoli, primo Ateneo laico d’Italia,
vanta ben più blasonate join-venture, come quella con la californiana Apple, che
da quest’anno ha aperto con il Politecnico partenopeo la Apple Developer Academy
per 400 sviluppatori, e forse nemmeno sa che la Scuola Superiore Normale a
Napoli si farà lo stesso, anche senza il connubio con il rinomato Istituto
pisano. Si chiamerà Scuola Superiore Normale Meridionale e siamo certi che darà
nuova linfa alle energie intellettuali del nostro Sud in un’ottica nazionale ed
internazionale, e potrebbe costituire l’occasione, anche grazie alle vicende
politiche contingenti (che hanno portato l’ex rettore della Federico II Gaetano
Manfredi a diventare ministro per la ricerca scientifica e l’università) a
rimettere al centro del dibattito gli Atenei meridionali, troppo spesso
bistrattati ed ignorati dai media anche nei tratti di eccellenza che pure ci
sono. Una rivalutazione che passa anche per maggiori flussi di finanziamenti e
una maggiore, si spera, attenzione alla qualità dell’insegnamento ed alla
qualità dei docenti, magari cominciando a sospendere gli indagati per gravi
reati (“Bari, docente universitario accusato di violenza sessuale resta in
servizio”, Giuliano Foschini, la Repubblica, 25 maggio 2019). Quindi, in
definitiva, se deve avere un senso la festa del 2 giugno, questo senso non può
che partire dal recupero effettivo dell’art. 3 della Costituzione, e della
necessaria effettiva parità tra tutti i cittadini, a prescindere dal territorio
dello Stato a cui appartengono; parità di diritti e di prestazioni essenziali,
che potrà essere assicurata solo quando l’accesso alla sanità, alla scuola, alla
giustizia, all’università, al credito, all’attività d’impresa non sarà più
negato ad interi territori, costretti alla migrazione al nord o all’estero per
accedere a quelle prestazioni. Fino a che tali diritti e prestazioni essenziali
saranno precluse a larga parte del sud, finchè politica e media continueranno a
praticare il discredito del sud come mezzo di persuasione di massa, non ci
saranno molti motivi per festeggiare la festa della Repubblica. Fino a quel
momento, l’ unica distinzione tra le forze antagoniste nella società non sara’
tra destra e sinistra, o tra cattolici e laici, o tra moderati ed estremisti.
L’unica distinzione sara’quella che già nel 1946 (Cristo si è fermato ad Eboli,
L’orologio) aveva intuito un intellettuale del calibro di Carlo Levi, ovvero
tra Luigini e Contadini, con tali termini intendendo i primi gli appartenenti
al ceto degli sfruttatori, di quelli che si approfittano dei deboli, di quelli
che impediscono agli altri pari diritti e pari dignità, qualunque sia la
funzione in concreto svolta e a qualunque latitudine appartengano, e i secondi
gli sfruttati, anch’essi trasversali al tempo ed allo spazio, destinatari di una
patria minore e senza l’accesso ai diritti fondamentali come alle prestazioni
essenziali (per una approfondita analisi del dibattito, e sull’autonomia
differenziata, cfr. M. Esposito, Zero al sud, Rubbettino). Quando la politica,
finalmente equa, non porrà più le premesse per il mantenimento di due società
distinte all’interno della stessa nazione e dello stesso popolo e la Storia,
finalmente con la S maiuscola, verrà scritta rispettando gli accadimenti reali e
non paludati dalla retorica monarchica prima e fascista poi, solo allora l’art.
3 della Costituzione potrà dirsi applicato nella sua integrità senza
discriminazioni territoriali all’interno dell’unica Repubblica Italiana, frutto
della resistenza al nazifascismo; allora e solo allora il 2 giugno finalmente
avrà la dignità che gli spetta di diritto.
·
La Questione
Settentrionale.
Scusate
l’errore: ai Comuni del Sud i fabbisogni vanno incrementati del 67% La
controllata del Mef ridefinisce i criteri.
Vuol dire 650 milioni in più per la spesa sociale e in gran parte a favore dei
Comuni meridionali: Cancellato dopo anni l’obbrobrio di “zero servizi”. Claudio
Marincola su Il Quotidiano del Sud il 27 ottobre 2020. C’è voluta una lunga
campagna di smascheramento per sgretolare omissioni, manipolazioni, pregiudizi
bilaterali. Ma ora è scritto nero su bianco. E ad ammetterlo sono gli stessi che
per anni si sono rifugiati dietro tecnicismi e vertiginose negazioni: i
fabbisogni standard dei comuni delle regioni del Sud dovranno crescere del 67 %.
Lo ha stabilito la Commissione tecnica del Sose, (Soluzioni per il sistema
economico, società controllata dal ministero dell’Economia per l’88% e per le
restanti quote dalla Banca d’Italia). La decisione avrà due effetti immediati:
rovescerà i criteri adottati finora nelle valutazioni delle funzioni e dei
servizi forniti dagli enti territoriali di prossimità, cioè i Comuni e al tempo
stesso determinerà la ripartizione del fondo di solidarietà 2021 per i comuni
delle regioni a statuto ordinario. Tradotto vuol dire 650 milioni in più per la
spesa sociale e in gran parte a favore dei comuni del Sud. Ma anche i comuni
delle regioni del centro vedranno un incremento del 12 %, mentre i comuni delle
regioni del Nord/ovest un decremento del 1,6% e i comuni delle regioni del
Nord-Est un decremento dei fabbisogni del 6%. Viene dunque rovesciato quel
principio che se un territorio non offre un servizio vuol dire che non serve. Un
criterio a lungo utilizzato per negare al Mezzogiorno le risorse necessarie a
garantire il cosiddetto minimo sindacale.
NASCE L’INDICE
COVID DI AGGRAVIO SANITARIO. Una svolta epocale? In un certo senso sì. Se non
fosse che già altre volte agli annunci sono seguite docce gelate o entrate a
gamba tesa. Uno studio, sempre del Sose, ha messo a fuoco “l’indice di aggravio
sanitario” determinato dalla pandemia. Un complesso rapporto che prende in
considerazione vari parametri, ospedalizzati, posti letto, numero medi di casi
di contagio, con una lunga serie di variabili. L’obiettivo finale è quantificare
l’impatto che la prima ondata ha avuto sul tessuto sociale e sul reddito di
aziende, persone fisiche, dipendenti in relazione alle spese dei comuni
italiani. A livello nazionale la riduzione media è del 18,69%. Pe rle aziende è
del 5,43%. Dati parziali e già da rivedere purtroppo in seguito alla seconda
ondata. È un fatto però che la Commissione Tecnica abbia approvato u nuovi
fabbisogni e che verranno utilizzati per determinare il Fondo di solidarietà
comunale per l’anno 2021. Per anni, in attesa dei Lep, ci si è nascosti dietro
calcoli “sballati”. La determinazione dei fabbisogni standard nasce per misurare
le necessità degli enti locali a garantire servizi adeguati ai cittadini. Il
confronto tra fabbisogni standard e capacità fiscale serve poi a commisurare
l’entità delle perequazione. Peccato che non è andata cosi. Con il meccanismo
della spesa storica – come più volte denunciato da questo giornale – si è
finanziato solo l’esistente. Se in un Comune – per fare l’esempio più noto –
l’asilo c’era allora vuol dire che era essenziale e dunque meritevole di
finanziamento. E se non c’era? Pazienza. Zero finanziamenti. Un obbrobrio
storico. Uno scippo in palese violazione di qualsiasi principio costituzionale.
UNIFORMARE I
SERVIZI SUL TERRITORIO NAZIONALE. Da cosa nasce il ricalcolo? I nuovi fabbisogni
prevedono l’adozione di nuove metodologie in particolare per le funzioni sociale
e ambiente e territorio. Ciò comporta variazioni soprattutto per la funzione
sociale dove vi è stato un vero e proprio stravolgimento rispetto alle stime
precedenti. Per la Sose – una Spa finita in questi giorni nell’occhio del
ciclone per i presunti incarichi d’oro, collaborazioni da 247 mila euro l’anno a
un pensionato co.co.co e per le acrobazie dell’ad Vincenzo Atella, un docente
dell’università Tor Vergata, che si sarebbe auto-nominato direttore generale –
si tratta di una vera e propria inversione di tendenza. I filo conduttore che ha
guidato le scelte della commissione per la funzione sociale è stato quello di
prevedere una uniformazione del livello dei servizi, in tutto il territorio
delle regioni a statuto ordinario. In alcuni punti il report della Ctfs sembra
scoprire l’acqua calda. Ad esempio, quando, in base all’analisi dei dati desunti
dal questionario e dai differenti livelli di spesa per il Settore sociale,
riconosce le sostanziali differenze nell’erogazione dei servizi lungo l’intero
territorio nazionale. In molti comuni l’intensità i – ma meglio sarebbe dire
l’inesistenza dei servizi – è così bassa da apparire del tutto inadeguata a
quanto richiesto per la tutela dei diritti civili e sociali. Ciò ha spinto la
CTFS a definire “regole di normalizzazione” prendendo come riferimento “il
livello di servizi e i costi delle realtà più virtuose”. Per rendere più
credibili e robusti i risultati, si è per la prima volta innovato il meccanismo
metodologico scegliendo non più una sola provincia come riferimento ensì un
gruppo di province “benchmark” ritenute particolarmente efficienti per aver
offerto nel triennio di analisi un livello di servizi superiore alla media
nazionale a fronte di una spesa inferiore alla media.
RISARCIMENTO
TARDIVO. Queste scelte hanno determinato l’incremento delle risorse necessarie
per poter garantire i fabbisogni standard dei comuni per poter erogare i servizi
relativi alla funzione sociale, risorse che sono state stimate in un maggior
fabbisogno, a regime, di circa 650 milioni di euro in più rispetto alla spesa
storica di riferimento della funzione sociale. L’individuazione di un livello
uniforme del servizio, individuando dei gruppi di comuni benchmark di
riferimento (aggregati per provincia) ha determinato una forte variazione dei
fabbisogni standard. In alcuni comuni del Sud l’assegnazione del fabbisogno
raddoppia la spesa storica. Un risarcimento tardivo (meglio tardi che mai).
Sud e Nord,
questione di fondi.
Giuseppe Coco
su Il Corriere della Sera il 9/10/2020. La correlazione empirica tra crescita di
un paese e evoluzione del sistema della finanza evidente. Ma gli economisti si
dividono sulla sua interpretazione. Alcuni ritengono che il principale nesso di
causalità vada dalla finanza alla crescita, altri nella prevalenza del nesso
opposto. La finanza evoluta sarebbe il prodotto della crescita più che la sua
conseguenza. In realtà esistono entrambi i nessi causali e certamente la finanza
importante come precondizione per la crescita. In uno Stato unitario come il
nostro quindi la fornitura di opportunità di finanziamento anche a imprenditori
delle aree più svantaggiate deve essere un obiettivo di politica economica.
Purtroppo questo obiettivo stato spesso travisato. In effetti esso non significa
che il sistema bancario debba rispettare una qualche distribuzione territoriale
del credito, e nemmeno che tutti i progetti di investimento debbano essere
finanziati ovviamente. Significa che bisogna solo creare le migliori condizioni
di finanziamento per gli imprenditori compatibili con la solidità degli
intermediari. Ci sono una serie di ragioni per cui un mercato senza correzioni
probabilmente non assicura questa condizioni nel Mezzogiorno. L’assenza di
grandi banche meridionali rende più difficile l’accesso al credito (si veda la
letteratura sulla distanza funzionale tra testa e sportelli delle banche di
Zazzaro e Ferri per es.). In anni più recenti il credito bancario peraltro
diventa sempre meno importante per finanziare lo sviluppo. Le restrizioni e i
requisiti prudenziali sempre più stringenti sul credito rischioso assieme alla
normativa antiusura, restringe i margini di manovra delle banche nel finanziare
imprese innovative necessariamente più rischiose. La nuova finanza passa
attraverso intermediari più evoluti. Si tratta dei fondi di private equity. La
forma tipica di questi investimenti l’acquisizione di quote di capitale di
rischio delle imprese. Un tipico fondo di private equity identifica imprese ad
alto potenziale di crescita in settori fortemente innovativi (o che applicano
tecnologie innovative in settori tradizionali) e ne finanzia la partenza o lo
sviluppo, anche intervenendo nel governo dell’impresa. Trattandosi di una forma
di investimento rischiosa e costosa in termini di acquisizione di informazione,
consulenza e monitoraggio dell’impresa, anche per le professionalità evolute che
richiede, riservata a imprese che possono dare rendimenti molto elevati. Ma
queste sono anche le imprese che in maniera crescente faranno la differenza per
la crescita dei territori. Fino al 2018 la quasi totalità degli intermediari
di private equity era collocata al Nord. Anno su anno i finanziamenti a imprese
meridionali si attestavano sul 2/3% del totale. Nel 2018, per iniziativa
dell’allora ministro De Vincenti entrato in attività il cd Fondo Imprese Sud.
Finanziato con fondi del FSC, questo fondo poteva finanziare solo la crescita di
imprese con testa e sede nel Mezzogiorno, col vincolo di dover investire con
soci privati. La successiva Finanziaria ne modificava la destinazione di fondi
(dalla crescita d’impresa al finanziamento di startup innovative) e lo spostava
sotto il cappello del Fondo Nazionale Innovazione presso Cassa Depositi e
Prestiti. Purtroppo la transizione societaria da Invitalia ha comportato un
ritardo di più di un anno nell’utilizzo dei finanziamenti, ma questo fondo oggi
finalmente sta investendo velocemente le sue risorse su imprese innovative e
brillanti, contribuendo a creare le condizioni per una imprenditoria di successo
al Sud. Contemporaneamente il ministro per il Sud ha opportunamente reinserito
nell’ultima Finanziaria una norma che rifinanzia il Fondo Imprese Sud con le
caratteristiche e la vocazione originaria riaffidandolo con modalità identiche
ad Invitalia. Il Fondo sarebbe in fase di partenza e colmerebbe un vuoto
importante che potrebbe creare un tessuto di medie imprese utili a passare la
tempesta anche a imprese minori nei territori di riferimento. Nel complesso la
politica, o almeno la parte pi intelligente, stata sensibile a una esigenza di
finanza evoluta per il Mezzogiorno. Si tenga presente che per le risorse
riservate al Sud nel Fondo Nazionale Innovazione, sono al momento il 15% del
totale. importante che il resto delle risorse non venga pensato come riservato
al Nord. Alla stessa maniera importante che questa finanza non venga utilizzata
per esigenze di ciclo politico. La progettazione dei fondi e la loro
organizzazione fortunatamente al momento una garanzia che entrambe queste
esigenze siano soddisfatte.
Ecco la lobby che gonfia le casse della triade.
Claudio Marincola su Il Quotidiano del Sud il 25 settembre 2020.
E’ la Terza Camera della Repubblica. Gestisce le risorse, ha voce in capitolo su
tutto, anche su materie che sarebbero di esclusiva competenza dello Stato. Un
oggetto misterioso che da 37 anni vive e convive all’ombra del potere e
costituisce essa stessa una sorta di contropotere. La sede nazionale è in via
della Stamperia, al centro di Roma. Palazzo Chigi è a poche centinaia di metri
ma le porte comunicanti non mancano. Quando nacque, ufficialmente nel 1983, in
pochi la presero sul serio e forse nessuno, neanche i fondatori, avrebbe
immaginato il peso che poi avrebbe avuto in seguito. L’ultima formulazione
conosciuta, riveduta e corretta, è “Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano”. E adesso, che l’avete
scoperta, immaginateli, i presidenti, notabili di ieri e di oggi, immolati alla
causa del federalismo, nella Sala delle riunioni. Un antico palazzo
rinascimentale edificato da un cardinale. Tra affreschi, stucchi e antiche
colonne si decidono i destini delle nostre regioni, la quantità di asili nido,
i ticket, il costo dei biglietti dell’autobus. Destini che da tempo si ripetono
con le stesse modalità e sempre nella stessa direzione. A chi tanto e chi
niente, seguendo criteri imprescindibili e, casualmente, sempre a tutto
vantaggio della triade: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, con incursioni
toscane e piemontesi. In realtà, quando i fondatori si riunirono scelsero
Pomezia, cittadina poco nota dell’hinterland romano. Più Centrosud che Centro.
Più periferia che Roma. Era il 15 gennaio del 1981, quando alla stregua di
carbonari, in una zona commerciale semi-disabitata e scarsamente illuminata, i
presidenti delle regioni italiane si incontrarono all’Hotel Selene. Non
pensavano certo che quella loro creatura sarebbe diventata un giorno l’appendice
misconosciuta del Parlamento. Tutt’al più immaginarono di dar vita ad una
conferenza consultiva, un organismo che avrebbe coordinato e semplificato i
rapporti tra enti e governo.
IL VERBALE DEL 1981 “MAI CONTRO LA REPUBBLICA”. Nel verbale della
prima riunione, poco meno di un documento storico, un pezzo raro, custodito
dallo Svimez come una reliquia, l’allora presidente della Regione Liguria, il
giurista Giovanni Persico, iscritto al Partito repubblicano e scomparso a 90
anni 5 anni fa, volle fare una premessa: «È importante prevedere una
organizzazione unificata, uffici e strutture, per la documentazione e la
ricerca che curi i rapporti tecnici con gli uffici amministrativi: ma la somma
delle Regioni che è la Repubblica non può contrapporsi alla stessa Repubblica».
Parole che oggi suonano come visionarie. Si pensi al gigantesco contenzioso con
lo Stato, un’idrovora che si nutre di ricorsi e di burocrazia e paralizza sia
enti che ministeri. E si pensi al confronto/scontro quotidiano tra i
governatori e il governo durante l’assedio della pandemia. Per evitare che la
Conferenza diventasse un palcoscenico si propose che la presidenza avesse un
unico potere: convocare le assemblee e decidere l’ordine del giorno. La
definitiva istituzione, arrivata due anni dopo, nel 1983, ne ribadì lo spirito
cooperativo. Una conferenza come organo di raccordo per favorire il principio
della leale collaborazione e favorire la concertazione. Non certo quello che poi
sarebbe diventata, il centro decisionale della parte più sviluppato del Paese
con una più o meno rigida separazione di funzioni. D’allora, dicevamo, molto è
cambiato. La spinta regionalista non si è tradotta in una Camera delle Regioni.
Il referendum del 4 dicembre 2016, che avrebbe dato vita al Senato delle
regioni, fu bocciato. Cosi che a seguito della modifica del Titolo V della
Costituzione sono cambiati gli assetti tra i diversi livelli di governo, la
riforma è rimasta a metà e la Conferenza è stata riconosciuta a tutti gli
effetti anche dalla Corte costituzionale. «I criteri con i quali vengono
distribuite le risorse però non sono cambiati – punta il dito il professor
Adriano Giannola, presidente della Svimez – i fondi della sanità, ad esempio,
continuano ad essere ripartiti in base all’età della popolazione. Cosi che la
Campania, una delle regioni più povere e più giovani d’Europa, continua a
ricevere meno risorse. E questo discorso vale in genere per tutto il
Mezzogiorno». Non è l’unica anomalia. «Se quel referendum voluto da Matteo Renzi
avesse avuto un esito diverso, per il Sud la fregatura ci sarebbe stata
comunque. In pochi rilevarono, e tra questi Massimo D’Alema che ne parlò una
volta e poi basta, che i senatori sarebbero stati rappresentati in base alla
popolazione. E dunque avremmo avuto anche allora più lombardi, piemontesi e
veneti che calabresi o pugliesi».
LO STRAPOTERE DELLA TRIADE E GLI EQUILIBRI DI SALVINI. La
Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal ministro degli Affari regionali,
Francesco Boccia (Pd) si occupa impropriamente della ripartizione dei fondi per
la sanità, fondi che costituiscono il 75% del bilancio delle regioni e la cui
competenza generale resta a carico dello Stato. Gestisce le materie di
attribuzione per ciascuna regione. Fatalmente economia, lavoro e sanità
finiscono sempre agli stessi, cioè nell’orbita della triade. Ciononostante, non
più tardi di ieri, il capo leghista Matteo Salvini, ha chiesto «nuovi equilibri
nella Conferenza Stato-Regioni». il governatore veneto Luca Zaia, un minuto dopo
ha rivendicato l’autonomia. Sarà un caso ma nella nuova segreteria del Carroccio
è riapparsa come d’incanto l’ex ministro degli Affari regionali, Erika Stefani,
la stessa che durante il suo mandato spacciò il Mezzogiorno come il paradiso
dell’assistenzialismo prendendo per buoni solo i numeri della Ragioneria
centrale dello Stato (il 22,5% del totale) e tralasciando quelli della spesa
regionalizzata del settore pubblico (il 77,5%). Un’esperta nel gioco delle tre
carte, insomma. L’assalto alla diligenza è pronto. La Lega vuole tornare al
vecchio amore: autonomia e secessione. L’ultima casamatta è la Conferenza
Stato-Regioni, destinata ad assumere sempre più rilevanza dopo la vittoria del
Sì al referendum che ha tagliato la rappresentanza parlamentare. Per il gioco
dei pesi e contrappesi crescerà invece il ruolo ipertrofico dei Super
governatori. Forse qualcuno dovrebbe ricordare che le varie competenze degli
enti regionali – politiche finanziarie, erogazione dei servizi pubblici;
promozione di accordi di programma; processi di ricostruzione; consulenze
socioassistenziali e gestione delle risorse Tpl – dovrebbero confluire in un
solo obiettivo: la riduzione del disagio sociale: la creazione posti di lavoro,
la lotta alla disuguaglianza e la perequazione infrastrutturale, (art.22 della
legge Calderoli). Temi ormai scomparsi dall’ordine del giorno della Conferenza.
Con buona pace del ministro Boccia.
POVERI AL SUD E SPRECONI AL NORD. I
soldi del Recovery Fund li mette l’Europa ma l’interlocutore non può essere la
Conferenza Stato-Regioni. Roberto Napoletano su Il Quotidiano del Sud il 23
settembre 2020. La Regione Piemonte spende per i suoi servizi generali cinque
volte di più della Regione Campania che è così bene amministrata da avere il
primato europeo del rischio povertà. La Regione Emilia Romagna ha la stessa
popolazione della Puglia ma spende il doppio per i suoi servizi generali. Serve
una interlocuzione politica e tecnica centrale di livello e vanno messi in riga
i capetti delle regioni del Nord e del Sud. MA DAVVERO credete che il futuro di
questo Paese possa essere nelle mani di chi ha amministrato una regione che ha
conseguito il primato europeo del rischio di povertà? Se più di uno su due dei
cittadini della Campania è a rischio povertà vuol dire che questo territorio sta
messo peggio delle aree più svantaggiate di Grecia, Romania, Bulgaria, Spagna!
Vi rendete conto di che cosa stiamo dicendo? Dove sono finiti i 7,5 miliardi
l’anno del reddito di cittadinanza e i proclami del super ministro degli Esteri
grillino, Luigi di Maio, di abolizione della povertà? Ma vi rendete conto che la
Regione Piemonte spende per i suoi servizi generali cinque volte di più della
Regione Campania che è ridotta così e addirittura spende da sola di più di
quanto spendono tutte insieme le Regioni Campania, Puglia e Calabria? Vi rendete
conto che la Regione Emilia-Romagna dell’efficientissimo Bonaccini ha la stessa
popolazione della Puglia ma spende esattamente il doppio per suoi servizi
generali? Vogliamo parlare poi dei miliardi al vento bruciati dai carrozzoni
burocratici e dallo stuolo di municipalizzate, società in house e appendici
clientelari varie delle Regioni Lombardia e Emilia-Romagna? Lasciando per un
momento da parte la vergogna di una spesa sociale e infrastrutturale che toglie
indebitamente sviluppo al Sud e regala assistenzialismo al Nord, la spesa pro
capite per scuola e sanità oscilla della metà da un capo all’altro del Paese, ma
davvero davvero pensate che si possa affidare nelle mani dei “capi bastone”
regionali del più grande sprechificio nazionale il futuro del Paese e la
gestione del Recovery Fund? L’Europa si è rifatta viva ieri per chiedere ai
singoli Paesi che cosa metteranno nelle loro leggi di bilancio. Per chiedere di
fare bene i conti, quelli delle spese e quelli delle entrate, tenendo a mente le
previsioni del Recovery Fund. Siamo al monitoraggio sistemico giorno per giorno.
Questo impone all’Italia, più che altrove, di attrezzarsi con una interlocuzione
politica e tecnica centrale di livello, concludente, che esprime la visione
strategica del Paese e gli obiettivi operativi con il massimo della concretezza.
I soldi li mette l’Europa e l’interlocutore dell’Europa non può più essere, come
è stato di fatto fino a oggi, la Conferenza Stato-Regioni. A fare le riunioni, a
definire il programma 2021/2027 ci vanno loro. Ognuno per conto suo. Ognuno
facendo male per conto suo. I risultati raggiunti fino ad ora sono così scadenti
che dovrebbero escluderci a priori. Il punto è che se chiedi alla De Micheli che
cosa è il programma 21/27 c’è il rischio concreto che ti risponda che è un ambo.
Il punto è che in Italia, nella sede della Conferenza Stato-Regioni in via della
Stamperia a Roma, passa tutto, si definisce o si bollina tutto. Si decide la
spesa pubblica territoriale in tutte le sue voci, qui non altrove c’è la
governance reale di quanto si dà e a chi per scuola, ospedali, treni, mobilità.
Sempre qui si contrattano le leggi di bilancio e gli obiettivi della Nadef. Qui
si fa e si disfa tutto e ciò è inaccettabile perché fino a oggi questi poteri
anomali e il modo in cui sono gestiti hanno prodotto la peggiore crescita
europea in termini quantitativi e qualitativi perché non solo siamo gli ultimi
ma anche i più diseguali. No, noi non crediamo in un Paese che vende il sogno
della abolizione della povertà attraverso sussidi assistenziali e che affida il
suo futuro nelle mani di capetti esigenti di baracconi clientelari che ragionano
come se il loro territorio sia uno Stato, non un pezzo di una nazione. I
governatori degli Stati americani tassano e spendono loro, hanno la
responsabilità diretta del bilancio. Questi spendono solo e non hanno nessuna
responsabilità diretta. Soprattutto i capi delle cosiddette regioni ricche
spendono alla grande e scavano nel bilancio di tutti per soddisfare le loro
clientele mettendole sul conto di chi ha meno. Se non si spezza questa spirale
perversa tutta l’Italia diventerà Sud e il mondo avrà trovato la sua capitale
mondiale della povertà. Mettiamoli al loro posto i presidenti delle regioni, si
occupino dei loro territori e la smettano di saccheggiare il bilancio pubblico
per soddisfare le mille clientele delle mille liste che hanno sostenuto i capi
dei potentati regionali. Questa è la prova decisiva del governo Conte. L’Italia
deve uscire dal suo federalismo ingiusto e deve recuperare un’idea unitaria di
Paese con un piano di opere materiali e immateriali definito e gestito dal
centro con una sola priorità. La riunificazione infrastrutturale del Paese e
almeno il 50% delle risorse europee attribuite al Mezzogiorno. Questo serve
all’Italia prima ancora che al Mezzogiorno. Questa dopo venti anni di
distrazione è l’unica possibilità che ha il Paese di tornare a misurarsi con i
suoi problemi reali.
Regioni, spese senza più freni. E la sprecopoli abita al Nord.
La sola macchina burocratica piemontese, con i suoi
911 milioni l’anno, costa più di quelle di Calabria, Puglia e Campania messe
insieme. Nord al top anche per le partecipate in perdita. Vincenzo Damiani su Il
Quotidiano del Sud il 24 settembre 2020. La macchina burocratica e istituzionale
della Regione Piemonte è tra le più costose d’Italia, i numeri sono praticamente
da record: 911 milioni all’anno per stipendi di consiglieri e dipendenti,
gestione immobili, segreteria generale, servizi generali, per citare alcune
delle principali voci di spesa. Certo, Lombardia (742 milioni), Emilia Romagna
(528 milioni) e Veneto (482 milioni) non sono da meno, ma considerando anche la
popolazione di ogni regione il Piemonte ha una spesa superiore.
LE SPESE. Se poi questi numeri, estratti dai bilanci di
previsione 2019-2021 di ciascun ente, vengono paragonati a quelle delle Regioni
del Sud, il divario diventa imbarazzante: la Puglia, ad esempio, per i “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” spende 256 milioni, la Campania 207
milioni, la Calabria poco più, 302 milioni. Sommando i costi dei tre Enti
meridionali la cifra che scaturisce (765 milioni) è di gran lunga inferiore a
quella del solo Piemonte, di poco più alta rispetto a quella della Lombardia.
L’Emilia Romagna ha la stessa popolazione della Puglia ma spende il doppio. In
Italia, complessivamente, solamente gli stipendi dei consiglieri, assessori e
presidenti delle Regioni costano alle casse pubbliche circa 800 milioni di euro
e rappresenta una delle voci più onerose per i bilanci, terza dopo il costo del
personale (2,8 miliardi) e le generali “spese per servizi” (1,3 miliardi), ed
esclusi i trasferimenti. Andando a spulciare i bilanci delle singole Regioni
arriva la conferma di un costo eccessivo dei carrozzoni chiamati Regioni. Un
problema che riguarda tutta l’Italia, ma è il Nord a spendere di più per il
funzionamento della macchina burocratica. Entrando più nel dettaglio, per il
funzionamento degli “organi istituzionali” c’è un buon divario: 75 milioni il
costo messo in bilancio dalla Lombardia, 70 milioni dal Piemonte, 52 milioni,
invece, dalla Puglia, 60,8 dal Veneto e 66 dalla Campania.
IL CASO PIEMONTE. Insomma, i dati dei bilanci parlano da soli. I
numeri della Regione Piemonte, poi, sono impressionanti. La bellezza di 70
milioni è stata spesa nel 2019 per il funzionamento degli organi istituzionali.
Se mettiamo insieme tutte le voci che vanno a completare la cosiddetta “Missione
1” superiamo gli oltre 911 milioni. Insomma, vicini al miliardo di euro soltanto
per garantire quotidianamente i servizi istituzionali (70 milioni), i lavori
della segreteria generale, la gestione delle risorse umane, gli altri servizi
generali, quelli informativi – altra spesa enorme, 65 milioni – e infine la
gestione dei beni demaniali.
IL PIANETA PARTECIPATE. Il Nord è anche la terra delle società
partecipate inutili e spendaccione: il record spetta alla Lombardia, dove le
società accumulano debiti per 26,5 miliardi. Sul podio salgono altre due regioni
del Nord, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna: rispettivamente: 12,71 e 8,89
miliardi. Una legge statale, la Madia, ha provato a mettere ordine nel settore e
a ridurre i costi, obbligando le Regioni a dismettere le partecipazioni o le
società stesse che producono solo passivi. Eppure, nonostante i record negativi
delle partecipate del Nord, il trend sembra proprio non cambiare. Basti pensare
che, come evidenzia la Corte dei conti, nel 2018 «solamente in riferimento alle
società a partecipazione maggioritaria della Regione Toscana il risultato
economico complessivo risulta negativo per circa 7 milioni di euro. Rispetto
all’esercizio 2017, quando la perdita di pertinenza regionale si assestava su
3,6milioni di euro, si rileva, quindi, un peggioramento». Insomma, anziché
migliorare queste società continuano a produrre maggiori perdite. E a chi prova
a spiegare questi continui passivi nei bilanci con una congiuntura economica
sfavorevole, la Corte dei conti replica così: «In molti settori, (termale,
creditizio e fieristico), la crisi assume un carattere strutturale e non
congiunturale». Società nate per produrre debiti.
LA CLASSIFICA. In tutta Italia sono 7.090, di cui attive 5.766, e
danno lavoro a 327.807 persone, ma producono più debiti (104 miliardi) che
crediti (53 miliardi). Si occupano di attività diverse (rifiuti, trasporti,
acqua) e, soprattutto, gestiscono un fiume di danaro, con risultati spesso non
lusinghieri, soprattutto al Nord. Lo dicono i numeri: le prime 12 società in
profondo rosso sono quasi tutte al Nord, più precisamente 10 al Nord e 2 al
Centro, nessuna al Sud. Insomma, le partecipate del Nord realizzano più debiti
di quelle del Sud (Campania e Sicilia con 3,87 e 3,24 miliardi sono quelle con
più “copponi”) e danno anche più lavoro: nei 962 organismi della Lombardia sono
impiegati 59.924 dipendenti, in Emilia Romagna 557 enti danno occupazione a
30.342 persone, in Veneto sono 29.296 gli impiegati; di contro, in Campania i
dipendenti sono 16.805, in Puglia 10.199, in Calabria 4.391, in Basilicata 668,
solo la Sicilia (Regione, però, a statuto speciale) si avvicina ai numeri delle
Regioni del Nord con 23.512 dipendenti. La Lombardia è la regione con più
società partecipate: 962, quasi il 17% del totale. E stacca non di poco l’Emilia
Romagna, seconda con 557 enti.
IL PAESE
ARLECCHINO CHE SI NUTRE DI FAKE.
Chi lavora per
consegnare l'Italia a un destino greco. Roberto Napoletano su Il Quotidiano del
Sud l'8 ottobre 2020. Questo giornale ne ha fatto una bandiera dal suo primo
giorno di uscita. Nessuno potrà mai convincerci che i diritti di cittadinanza
sono garantiti quando se nasci a Reggio Calabria ricevi 19 euro di spesa
pubblica per gli asili nido, se vieni al mondo a Altamura, nella Murgia
pugliese, di euro “addirittura” te ne toccano zero mentre appena esci dalla
culla in Brianza hai la fortuna di trovare ai tuoi piedi un assegno di tremila
euro. Abbiamo denunciato questa vergogna italiana e gli amministratori
coraggiosi di alcuni Comuni del Sud si sono rivolti al Tar del Lazio e hanno
avuto ragione. La risposta del Governo “all’ordinanza istruttoria” dei giudici
amministrativi è stata quella di mettersi subito in regola. Oggi i 3.300 bambini
di Altamura non ricevono più zero euro per gli asili nido, ma 688 mila euro. La
strada della parificazione dei diritti è ancora lunga, ma il primo passo è stato
compiuto e lo rivendichiamo come un risultato di questo giornale. Tutto ciò è
stato possibile perché i Comuni non sono usciti dalla trappola della spesa
storica che privilegia i ricchi ai danni dei poveri, ma almeno il Fondo di
perequazione previsto dalla legge Calderoli sul federalismo fiscale lo hanno
fatto. Nella Conferenza Stato-Regioni, la “terza Camera” dello Stato, i galli
delle Regioni del Nord e del Sud alzano tutti la cresta e trattano lo Stato
italiano come la gallina che deve fare ogni giorno l’uovo dei loro desideri,
quindi non uno ma venti, si rifiutano ostinatamente di varare anche i Fondi di
perequazione sociale e infrastrutturale. Siamo alla vergogna delle vergogne. Non
si tratta di chiedere risarcimenti ma di attuare l’ineludibile operazione verità
e sulla base di questa costruire il Progetto Paese che si identifica con la
riunificazione delle due Italie. Credetemi: non possiamo andare avanti con il
miope egoismo dei Governatori della Sinistra Padronale tosco-emiliana in
combutta con quelli della Destra a trazione leghista lombardo-veneta e lo
sceriffo campano che prima ha chiuso la sua regione per tutelare la sicurezza
senza che il Covid vi fosse e che ora che il Covid c’è davvero ha spaventato
così tanto i suoi concittadini che le file per fare il tampone rischiano di
trasformarsi in un grande focolaio a cielo aperto. Liberiamo il Paese da questi
gendarmi che vanno peraltro ognuno per i fatti suoi.
Oggi apriamo
il giornale con un’esclusiva di Giuliano Cazzola che documenta, dati alla mano
della relazione annuale della Corte dei Conti, il pesantissimo effetto
redistributivo che ha la spesa previdenziale perché le pensioni più pregiate
sono, come è noto, al Nord e perché permane il “premio” del calcolo retributivo
per quote importanti di ogni storia lavorativa. Ora sappiamo che con quota 100
paghi 673 euro di contributi e ricevi 2033 euro. La più grande fake che si può
commettere parlando di spesa pubblica territoriale è togliere il peso di questo
smaccato privilegio dal computo. Non importa se lo si fa per servilismo nei
confronti di chi si permette di liquidare la questione sostenendo che le
pensioni si pagano con i contributi (questa sì che è una fake) e, quindi, vanno
dove c’è più lavoro ben retribuito o se lo si fa per guadagnarsi patenti di
neutralità dicendo il falso. Ovviamente dopo avere detto che sono “falsi” i dati
dei Conti Pubblici Territoriali si può dire che sono “falsi” anche quelli della
Corte dei Conti. Così, però, non si costruisce il dialogo tra Nord e Sud che noi
vogliamo per capire come stanno davvero le cose e fare ripartire l’Italia più
coesa e finalmente riunificata, ma si lavora per consegnare il Paese tutto a un
destino greco. Nessun interesse e nessuna forma di narcisismo possono consentire
di sporcare l’operazione verità.
Pensioni,
paghi 673 euro e ne incassi 2033: il calcolo retributivo che arricchisce il
Nord.
Giuliano Cazzola su Il Quotidiano del Sud il 9 ottobre 2020. È
incomprensibile l’interesse suscitato dall’annuncio di Giuseppe Conte al
Festival dell’economia di Trento: il governo non ha intenzione di prorogare
quota 100 dopo la scadenza del 31 dicembre 2021. Non c’è proprio nulla di nuovo.
Quota 100 è una misura voluta fin dall’inizio a carattere sperimentale e
derogatorio per un triennio, che avrebbe dovuto fare da ponte con un intervento
più organico.
QUOTA 100.
Sarebbe, tuttavia, il caso di spiegare all’opinione pubblica che “quota 100’’
non ha mancato soltanto l’obiettivo di sostituire gli anziani in uscita con
l’assunzione di giovani (come ormai è riconosciuto da tutti gli osservatori), ma
non ha convinto neppure i destinatari di questo provvedimento (va ricordato,
però, che quanti maturano i requisiti previsti entro la fine del 2021 si portano
appresso la possibilità di esercitare successivamente il diritto al
pensionamento anticipato) il cui numero, nel 2019, è risultato inferiore alle
previsioni (confermate per il 50% nel pubblico impiego; solo per il 15% nel
settore privato). La questione della spesa pensionistica è entrata di prepotenza
(per il suo rilievo) anche nel dibattito sulla ripartizione della spesa tra Nord
e Sud, dopo la “denuncia’’ della sottrazione di 60 miliardi alle regioni
meridionali. Alcuni economisti – pur ammettendo ciò che è risaputo e cioè che le
pensioni più pregiate (in particolare quelle di anzianità) sono erogate al Nord
a ex lavoratori maschi – hanno sostenuto che è sbagliato includere la spesa
pensionistica nel computo, perché i trattamenti di cui si tratta sono coperti
dai contributi. Sul Quotidiano del Sud abbiamo dimostrato che questo sinallagma
pensioni/contributi non esiste neppure al Nord, perché i trattamenti corrisposti
alle generazioni del baby boom (quelle che sono andate in quiescenza negli
ultimi anni e che ci andranno in quelli prossimi) hanno fruito del “premio’’
garantito dal calcolo retributivo per quote importanti della loro storia
lavorativa.
LA CORTE DEI
CONTI. La Corte dei conti – si vedano i grafici di questa pagina – ha dimostrato
che l’introduzione di quota 100 (notoriamente più diffusa nelle regioni
settentrionali e tra i lavoratori maschi: si calcola una donna ogni sei uomini)
ha amplificato (mettendo a confronto il pannello A con quello contrassegnato B)
il divario tra la pensione erogata e i contributi versati. Ovviamente tale
divario si amplia lungo tutto il periodo in cui la prestazione viene percepita,
incluso il conteggio della reversibilità ai superstiti. Sempre la Corte dei
Conti, infatti, ha messo in campo anche dei numeri. Considerando 100 euro di
retribuzione pensionabile in regime retributivo, corrispondenti a un trattamento
di 62 euro, e tenendo conto di una speranza di vita di 25 anni, il lavoratore in
ipotesi (con 62 anni e 38 di contributi) beneficerà di trattamenti complessivi
pari a 1.550 euro nel 2044 quando cesserà la pensione diretta; il superstite
beneficerà poi, sotto forma di pensione indiretta, per ulteriori 13 anni di 37
euro di assegno annuo con il che i benefici pensionistici complessivi
dell’assicurato in questione assommeranno a 2.033 euro. A fronte di ciò il
grafico mostra che a fine 2018 i contributi sociali cumulativamente versati tra
il 1981 e il 2011, cioè quelli validi per la sola quota retributiva di cui ci si
sta qui occupando, erano pari a 673 euro.
L’ALLARME.
Intanto è scoppiato l’allarme: «Le previsioni della spesa pensionistica
continuano a scontare il sensibile aumento del numero di soggetti che accedono
al pensionamento anticipato, con “Quota 100” e le altre opzioni. Secondo la
previsione a legislazione vigente, una crescita della spesa per pensioni più
contenuta rispetto a quella dell’economia contribuirà a far scendere il rapporto
tra tale spesa e Pil, dal 17,1% del 2020 al 16,2% nel 2023. Cionondimeno, la
spesa per pensioni a legislazione vigente nel 2023 risulterà più alta di 0,8
punti percentuali in rapporto al Pil in confronto al 2019». Così è scritto nel
Nadef. Insomma, le politiche previdenziali del Conte 1 presentano la nota spese
al Conte 2. Qualche sindacalista è arrivato a sostenere che il governo si è
sbagliato (sic!) a fornire il dato all’Unione europea, dimenticando che le
statistiche si fanno sulla base di indicatori concordati e comuni.
L’EQUIVOCO. È
la solita mania di equivocare tra le spese previdenziali e quelle assistenziali,
in nome di una separazione tra i due comparti che è già stata compiuta nel 1984
e perfezionata nel 1998, prima dell’ingresso nel club dell’euro. Ne deriva che
la spesa pensionistica è una sola e che è finanziata attraverso i contributi e i
trasferimenti. Pretendere di ‘‘sterilizzare’’ quanto è posto a carico del fisco
perché l’ammontare dei contributi non basta a coprire il costo del sistema, più
che una partita di giro costituirebbe un falso in bilancio, in stile greco.
Tutto ciò premesso, la questione si sposta sul come uscire dal regime delle
deroghe sperimentali alle regole della riforma Fornero, perché, senza adeguate
modifiche, esse tornerebbero in vigore “più gagliarde’’ di prima, con lo
“scherzo da prete’’ di uno “scalone’’ (da 62 a 67 anni) per quei soggetti che
non avessero i requisiti per il pensionamento ordinario di anzianità. A
risolvere il problema sono in azione le confederazioni sindacali in un clima di
“cordiale intesa’’ con il ministro Nunzia Catalfo. Perché “uscire in avanti’’
quando è più facile e confortevole farlo “all’indietro’’?
SINDACATI IN
ERRORE. In soldoni, la proposta di Cgil, Cisl e Uil “supera’’ la riforma
Fornero, riportando il sistema pensionistico alla belle époque del secolo
scorso. Si andrebbe in quiescenza con almeno 62 anni di età (e 20 di anzianità
contributiva) oppure con 41 anni di versamenti a qualunque età (evitiamo di
elencare la gamma di ulteriori sconti che sarebbero previsti come contribuzione
figurativa per la maternità, i lavori usuranti e disagiati e quant’altro). I
dirigenti sindacali non sono degli sprovveduti, tanto che accompagnano queste
loro proposte con un ragionamento, fondato sul piano tecnico, ma sbagliato su
quello politico. Nelle future pensioni – affermano – sarà crescente la quota da
calcolare col metodo contributivo. In tali casi il relativo montante verrà
moltiplicato per un coefficiente ragguagliato all’età, in applicazione del quale
sarà incentivato il posticipo e disincentivato l’anticipo. Ma è proprio questo
l’errore; perché non ha senso, al cospetto degli scenari demografici attesi e
del ritardo delle nuove generazioni nell’ingresso nel mercato del lavoro,
premiare la durata della pensione (anticipandone la decorrenza) a scapito
dell’adeguatezza del trattamento. I sindacati – anche se chiedono una pensione
di garanzia per i giovani (è singolare volerli tutelare da pensionati, visto che
non riescono a farlo da lavoratori) – rimangono prigionieri della condizione dei
baby boomers (maschi e settentrionali): i soli che possono continuare a trarre
beneficio da siffatti requisiti.
A riposo in anticipo e sistemi premiali: le pensioni
“regalate” abitano al Nord. Su 12 miliardi spesi per i
trattamenti di anzianità la parte sostenuta dalla collettività è in media
intorno al 28%. Giuliano Cazzola il 18 settembre 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Nel dibattito aperto sull’allocazione delle risorse che il governo ha
“prenotato" in conto Recovery Fund si è aperta una certa dialettica tra le
priorità territoriali dei progetti e degli interventi. L’argomento non è affatto
secondario, perché se è vero che il “motore’’ dell’economia sta nelle regioni
del Nord (per questo motivo deve continuare a funzionare nel migliore dei modi
possibili nell’interesse di tutto il Paese) è altrettanto vero che il salto di
qualità che l’Italia deve compiere, grazie alle risorse rese disponibili da
parte della Ue, riguarda un impegno per un effettivo riequilibrio e per una
maggiore coesione territoriale.
IL DIVARIO. Nel dibattito è stata chiamata in causa la spesa
pensionistica previdenziale e assistenziale. Alcuni economisti hanno
riconosciuto che la quota maggiore della spesa per le pensioni è erogata al
Nord, anche in rapporto al netto prevalere dei trattamenti di anzianità
sostenuti da robuste e continuative storie contributive che consentono alle
generazioni del baby boom di andare in quiescenza intorno ai 60-61 anni con
prestazioni che, mediamente, sono di importo doppio rispetto a quello riservato
alla vecchiaia. Ovviamente non c’è nessun inganno: l’assetto del sistema
pensionistico non è che la fotografia del mercato del lavoro, non di quello
attuale, ma di quello di ieri. E quindi quanti hanno fruito – sia pure con
fatica, sottoponendosi allo sradicamento dell’immigrazione interna, iniziando
precocemente l’attività lavorativa, sopportando condizioni di lavoro assai
critiche e integrazione sociale complicata (“Non si affitta ai meridionali!’’) –
si trovano a vivere una quiescenza più serena (ma non troppo) sul piano
economico, avendo davanti a sé un’attesa di vita in aumento, come mai prima
nella storia dell’umanità. I “nordisti’’ non negano il divario previdenziale con
un Sud in cui prevalgono le prestazioni assistenziali (a carico della fiscalità
generale e quindi dei contribuenti che pagano le imposte), ma rivendicano di
trovarsi in questa situazione in conseguenza dei maggiori contributi versati. E
pertanto di non avvalersi di alcun “privilegio’’.
LO SBILANCIAMENTO. E’ un ragionamento che fila, ma ci sono degli
aspetti che è utile chiarire. Coloro che si sono guadagnati il diritto di
usufruire del “pezzo pregiato’’ del sistema pensionistico, hanno potuto
avvantaggiarsi pure del suo risvolto “premiale’’. Mi spiego meglio avvalendomi
della tabella pubblicata in basso, relativa ai flussi del primo semestre 2020 in
confronto con quelli del 2019. Come si può vedere il numero maggiore di pensioni
erogate ha nel proprio montante contributivo una quota importante sottoposta al
calcolo retributivo. Fino al 1° gennaio 2012, poi, la stragrande maggioranza
delle pensioni era liquidata in regime retributivo. Ma è vero che le pensioni di
anzianità – tesoretto dei lavoratori maschi del Nord – sono coperte dalla
contribuzione anche quando sono calcolate secondo il metodo retributivo o misto?
Uno studio di Fabrizio e Stefano Patriarca ha dimostrato che i veri protagonisti
dello “sbilanciamento” tra pensioni contributive e retributive sono i
trattamenti di anzianità, ovvero proprio quelli che vengono difesi e riproposti,
magari sotto altre forme, a ogni piè sospinto. Considerando, come nello studio,
le pensioni di anzianità maturate (in media a 58,5 anni di età) da 486mila
lavoratori dipendenti privati tra il 2008 e il 2012, per un importo medio di
quasi 2mila euro lordi mensili, la spesa per questa platea è stata di 12
miliardi di euro. La parte non giustificata da contributi versati è in media
pari al 28% e si concentra prevalentemente (in quota del 37% dei pensionati)
nelle fasce con più di 2.500 euro mensili, che accumulano il 63% dello
squilibrio totale.
IMPORTI INGIUSTIFICATI. Lo studio, pertanto, calcola che sui 12
miliardi di spesa circa 3,5 miliardi siano “non giustificati” dai versamenti
contributivi. Lo squilibrio diminuisce nel caso di pensionamento di vecchiaia
(al 15% medio) per effetto della più ridotta attesa di vita. Aggiungendo anche
le pensioni di anzianità (2008-2012) dei dipendenti pubblici, (il cui squilibrio
tra calcolo contributivo e retributivo è valutato in 2,5 miliardi) la parte “non
giustificata” sale nell’insieme a 6 miliardi. Il bello, però, deve ancora
venire. Più aumenta l’importo dell’assegno (oltre 44mila euro l’anno) più si
riduce la parte “non giustificata”, perché sul valore dell’assegno opera la
rimodulazione al ribasso dei trattamenti più alti fino a ridursi al 5% per
pensioni intorno ai 12mila euro lordi mensili. Il grafico in alto evidenzia
questo stato di fatto.
Quei privilegi differenziati che come la bussola indicano
sempre il Nord. Adriano Giannola il 18 settembre 2020
su Il Quotidiano del Sud. Una nota vagamente “tecnica” penso sia lo strumento
migliore per illustrare uno degli aspetti del tema della perequazione che l’
operazione verità ha portato alla luce del sole in tutta la sua macroscopica
urgenza grazie al contributo di documentazione dei Conti Pubblici
Territoriali. L’ evidenza dei mitici 60 e passa miliardi all’anno per il periodo
2000-2018 è un dato da analizzare con il massimo scrupolo perché è solo a
valle di analisi accurate che si possono proporre le necessarie e rapide
correzioni e, soprattutto, individuare un percorso operativo che consenta
di ripristinare il rispetto della legge e della Costituzione. Si tratta, in
parole povere, di liquidare il tradizionale metodo fin qui in uso del
rinvio a messianiche attese (LEP, fabbisogni standard in regime di costi
standard prevista dalla Costituzione e dalla legge 42/2009 sui quali va fatta
finalmente una sintesi). Il Paese non può continuare in queste sceneggiate
rituali della commissione Stato-Regioni che, al motto ad impossibilia
nemo tenetur , legittima la “provvisoria” spesa storica rivelatasi un
formidabile, inerziale meccanismo di sistematiche sperequazioni
territoriali. Se non si comprende che tutto ciò fa molto male non solo al Sud
ma – alla lunga- anche alle nostre locomotive in ultradecennale affanno e si
continua a equivocare su presunte richieste di risarcimenti, magari per
contanti, senza voler capire che il “risarcimento” a vantaggio dell’ intero
Paese è quello di ristabilire regole certe: quelle scritte e approvate dal
Parlamento in applicazione della Costituzione. Proprio in omaggio a questo
spirito è più che legittima la pretesa di verificare se e quanto corretto sia
misurare la sperequazione sulla base di un nesso logico “indiziario” fondato
su una ragionevole aspettativa di coerenza tra quota della spesa e quota
della popolazione nei diversi territori. Una ipotesi di lavoro che impone,
dunque, una più che mai scrupolosa verifica. È perciò benvenuto ogni
serio contributo in merito. Non pare rispondere a questo auspicio il
problematico argomentare del prof. Giovanardi recentemente apparso sul Foglio
che elenca ben sei motivi per definire una “favola” la contabilità dei dati
dei CPT ritenendo così di delegittimare l’ operazione verità. L’esposizione
dei sei errori non fa onore alla scienza del valido scienziato nella
misura in cui propone considerazioni di buon senso strumentalmente adattate
alla bisogna, senza quantificazioni di sorta, neanche indiziarie. Né incanta
l’ insistere sul le itmotif del “diritto alla restituzione” esplicitamente
accampato sui mitici residui fiscali per i quali – se non se ne è ancora
reso conto – alla inconsistenza giuridica si accompagna la crescente
inconsistenza quantitativa. In una recente – più conciliante – occasione il
prof. giustifica il diritto alla restituzione sostenendo che la sua più
sincera disponibilità ad “aiutare il Mezzogiorno” si scontra con il fatto che
il Sud non cresce, anzi (in linea con una certa econometria à la carte)
“muore di aiuti e di vana filantropia”. L’unico serio motivo “tecnico”
addotto per argomentare criticamente non certo per porre in dubbio la
contabilità dei 60 miliardi concerne la spesa per la previdenza che, a suo
dire, andrebbe totalmente esclusa dal novero della spesa pubblica. Davvero
curiosa l’ultratempestiva sollecita adesione di Marco Esposito a questa
tesi, “… perché è le pensioni sono una forma di reddito differito e lo Stato non
può decidere a chi pagarle indipendentemente dai contributi versati”…
aggiungendo che “… scomputare la previdenza dimezza la cifra …. che diventa 30
e non 60 miliardi” . Non che 30 miliardi all’anno siano pochi, ma è un fatto che
risulta incomprensibile con quali criteri si possa fare questo calcolo e come si
possa abbandonare l’unica cifra certa che sono i 60 miliardi certificati da CPT
e sui quali gli argomenti sociologici fin qui addotti che non hanno nessuna
forza documentale. Il tema del come, quanto e se la previdenza sia rilevante
o no nell’ operazione verità e come vada contabilizzata è certo serio e la
versione del prof. Accolta da Esposito merita considerazione anche perché
altri ben attrezzati tecnici informati dei fatti non sono per nulla inclini a
sottoscriverla. Una prima considerazione è che le pensioni sono liquidate
attingendo al serbatoio delle contribuzioni dei futuri pensionati oltre che
dallo stock esistente dei contributi versati (e in via di liquidazione) da
quelli che via, via sono entrati nel mondo dei pensionati. Il fatto di attingere
ai contributi versati non significa che quella previdenziale non sia da
computare come spesa pubblica ma, semmai, di considerare con cura il meccanismo
per il quale chi eroga le pensioni attinge alle disponibilità correnti
(diciamo prende a prestito dai futuri pensionati oltre ad usare i contributi
versati in via di esaurimento dei pensionati). Si tratta del metodo “a
ripartizione” per il quale pago oggi prelevando dallo stock cumulato e in via
di accumulazione per corrispondere le pensioni a soggetti che non alimentano
più lo stock. La prima osservazione è che nel 2017 (Sesto Rapporto 2019) il
saldo tra pagamenti ed incassi contributivi vede un deficit per le pensioni di
68 miliardi a tutto titolo da considerare spesa pubblica, perché posti a
carico della fiscalità generale. Cioè il “fondo” si è rivelato insufficiente.
Ma un altro motivo fa sì che è più che legittimo considerare spesa pubblica
una parte significativa delle pensioni pagate anche se non eccedono il
monte contributi. Si dimentica infatti di prendere in considerazione quella
quota di prestazione che in passato e ancor oggi corrisponde alla “rendita”
della quale fruiscono i percettori di pensioni (sia di anzianità che di
vecchiaia) definite nel loro ammontare con il metodo retributivo e non con
quello contributivo. Il che assicura il godimento (si fa per dire) di una
pensione superiore a quella che sarebbe erogata facendo meramente riferimento ai
contributi versati. Attualmente questo aspetto è assolutamente prevalente e
rilevante per quello che riguarda lo stock di pensionati e tale si conferma
nonostante la modifica introdotta dalla “riforma Dini” (1995) e poi nel
2012 del governo Monti che traghetteranno solo dopo il 2036 a un sistema
contributivo integrale. Il prof Giovanardi lo sa o no? Dubito che non ne sia
perfettamente consapevole. Giuliano Cazzola che al tema ha dedicato profonde
analisi si chiede se ” le pensioni di anzianità – tesoretto dei lavoratori
maschi del Nord – sono coperte dalla contribuzione anche quando sono calcolate
secondo il metodo retributivo o misto” e rinvia a uno studio di Fabrizio e
Stefano Patriarca per concludere che “i veri protagonisti dello
«sbilanciamento» tra pensioni contributive e retributive sono i trattamenti di
anzianità… proprio quelli che vengono difesi e riproposti, magari sotto altre
forme, ad ogni piè sospinto”. Nel quadriennio 2008-2012 risulta che quota
non giustificata da contributi versati le pensioni di anzianità “… maturate
(in media a 58,5 anni) da 486mila lavoratori dipendenti privati è in media
pari al 28% su 12 miliardi di spesa”.
I percettori di pensione che hanno un introito superiore al
teorico flusso “garantito” dai contributi versati sono per questa quota
eccedente opzionalmente a carico della fiscalità generale. Dunque lo Stato,
fino al limite della capienza ” prende a prestito ” quanto necessario senza
pagare interessi dai futuri pensionati (fino a capienza del fondo contributi)
per erogare le prestazioni da corrispondere ai pensionati inclusi ve di
quel’ ammontare in eccesso che non hanno contribuito a determinare. Tutto ciò
coinvolge le pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia con una distinzione
da sottolineare e che per molteplici ragioni ha un chiaro significato: quelle
di anzianità sono corrisposte a una platea “più giovane” (il sopra citato
“tesoretto dei lavoratori maschi del Nord”) che quindi godrà più a lungo un
più ricco bonus che eccede il calcolo contributivo. Questa platea, grazie alle
condizioni del mercato del lavoro di riferimento ha iniziato il percorso e
quindi maturato in tempi più rapidi i requisiti conseguendo pensioni più
elevate sia per la continuità che per la rapida entrata nel mercato del lavoro.
Ben diverso ma sempre a carico della fiscalità generale è il privilegio
riservato alle pensioni di vecchiaia (dove comunque il Nord prevale
nettamente sul Sud) considerevolmente meno ricche riferibili a una platea
relativamente più anziana proprio in conseguenza delle maggiori difficoltà di
realizzare un percorso contributivo legato alle problematiche
caratteristiche del “loro” mercato del lavoro. Ovvio che la “anzianità”
premia il Centro-Nord con, di conseguenza, una sistematica differente
incidenza sulla fiscalità generale riconducibile al “bonus” di cui sopra ed
ai diversi tempi di fruizione. Ovvio che il metodo retributivo svanirà all’
orizzonte (in virtù delle riforma del 1995 e poi del 2012) più rapidamente nel
caso della vecchiaia, più lentamente per la più giovane platea dei percettori
di quelle di anzianità che, in aggiunta, gode di ammontati decisamente più
elevati (e quindi più onerose per la fiscalità generale visto che il
retributivo commisura la pensione alle ultime retribuzioni che – specie nel
caso dell’ anzianità – è ben diverso e più elevato dalle retribuzioni di
ingresso). Una avvertenza è d’obbligo. L’ impatto della previdenza nel
determinare squilibri ha una valenza del tutto particolare perché inscindibile
dalle specifiche condizioni del mercato del lavoro, a loro volta
condizionate dalla dinamica dell’economia. In questo caso quindi le
distorsioni e i connessi rilievi sugli aspetti redistributivi non
evidenziano certo una “negazione di diritti di cittadinanza” come avviene
esplicitamente nel caso dei diritti alla mobilità, salute e formazione che,
nell’esperienza del nostro sbilenco federalismo, sono frutto della non
applicazione di regole che esistono. Nella previdenza, al contrario, gli
squilibri nascono proprio dall’applicazione precisa e puntuale di regole,
riforme, che si calano sui territori con il loro carico implicito di vantaggi
e svantaggi. Evidentemente lo sviluppo dei territori è segnato dalle
condizioni sia all’ingresso che all’ uscita dei mercati del lavoro locali,
non fosse altro perché da esse dipenderà la facilità di accedere o meno a
una pensione e se essa sarà di anzianità o di vecchiaia. Nell’esperienza
italiana occorre ovviamente fare mente locale sulla pessima evoluzione di
performance di un Paese che, fino a che era su un sentiero significativo di
crescita, poteva scaricare sulla fiscalità generale il finanziamento di
“privilegi” differenziati. Oggi, a valle di oltre venti annidi stagnazione e
crisi le differenze previdenziali a carico della fiscalità generale
rappresentano un’ oggettiva sottrazione di risorse proprio rispetto
all’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei territori, a fare infrastrutture
per connettere il Paese e recuperare la leadership nel Mediterraneo, ridurre le
disuguaglianze e far crescere la coesione. Guarda caso proprio gli obiettivi
ai quali con durezza ci richiama l’ Europa.
ANDREA BASSI per Il Messaggero il 9 settembre 2020. Il dossier,
per lungo tempo, era stato insabbiato. Ora il progetto dell'Autonomia
differenziata chiesta dalle Regioni del Nord, è tornato nell'agenda del governo
e a ottobre, dopo le elezioni regionali, potrebbe essere presentato in
Parlamento. Nonostante i tentativi di correzione rispetto a quella che era stata
ribattezzata «la secessione dei ricchi», resta alto il rischio che le regioni
con maggiori risorse possano lasciare ancora più indietro quelle che già oggi
sono in affanno, ossia le Regioni del Sud. Il ministro degli Affari Regionali,
Francesco Boccia, ha messo a punto una nuova bozza della legge quadro dentro la
quale dovrebbero muoversi le intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.
Nell'ultima versione del testo, si torna a parlare per il finanziamento delle
funzioni che dovrebbero essere trasferite di «compartecipazione al gettito
erariale maturato nel territorio regionale». Cosa significa? Che lo Stato
cederebbe un pezzo dell'Iva o dell'Irpef per pagare il costo delle funzioni
trasferite dallo Stato centrale alla Regione. Il costo delle funzioni, questa
volta, verrebbe stabilito attraverso il meccanismo dei fabbisogni standard e non
più sulla base del costo storico, come prevedevano le intese dell'era
giallo-verde. Ma resta il fatto che se anno dopo anno, il costo del servizio
resta immutato e il gettito fiscale aumenta, quel surplus rimarrebbe nelle casse
della Regione e non andrebbe più in quelle dello Stato centrale. Che il punto
sia estremamente delicato lo dimostra anche la «clausola di salvaguardia»
inserita nella bozza della legge quadro. In sostanza, dice questa clausola, se
sul fronte dei conti pubblici le cose vanno male per lo Stato, allora si potrà
chiedere alle Regioni che hanno ottenuto l'autonomia di partecipare al
risanamento. Un principio di equità che nemmeno dovrebbe essere messo in
discussione e che, invece, viene affidato a una disposizione di rango primario e
a patto che le stesse misure vengano contestualmente imposte a tutte le altre
regioni a statuto ordinario. Grande assente della proposta del governo, invece,
è ancora una volta Roma, di nuovo dimenticata. L'autonomia regionale avviene per
«sottrazione» di risorse alla Capitale, senza che il governo, ancora una volta,
si preoccupi del destino della città. Il decentramento di funzioni
amministrative, oggi svolte dai ministeri romani, avrà inevitabilmente un
impatto, sul quale al momento all'interno del governo non c'è nessuna
riflessione o discussione. L'altro tema sul quale si era molto dibattuto, è il
ruolo del Parlamento nell'emendare le intese tra governo e Regioni. Nel
precedente tentativo del governo giallo-verde, le intese erano state blindate,
il Parlamento avrebbe potuto approvare o rigettare gli accordi ma senza poterli
modificare. Le cose, in realtà, cambiano poco anche con la nuova legge quadro.
Il Parlamento potrà pronunciarsi sulle pre-intese tra governo e Regioni. Avrà 60
giorni per fare delle osservazioni che potranno o meno essere recepite. Passato
questo termine, governo e Regioni potranno firmare gli accordi che, a quel
punto, potranno essere approvati o rigettati dal Parlamento. Alcuni passi avanti
rispetto al passato sono comunque stati fatti. Il principale riguarda la
circostanza che le funzioni non potranno essere trasferite fino a quando non
saranno pronti i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. Asili, trasporti,
mense, insomma, devono avere un analogo livello su tutto il territorio
nazionale. È un passo avanti decisivo rispetto alla vecchia impostazione in cui
di Lep non si parlava affatto. Nei tre articoli della bozza, poi, è prevista
anche la nascita di un fondo di perequazione infrastrutturale. Entro il 30
giugno del 2021, dovrebbe essere fatta una rilevazione del deficit
infrastrutturale nelle Regioni meridionali. Poi entro sei mesi andrebbero
presentati dei progetti per colmare questo deficit, da finanziare destinando una
percentuale (che nella bozza della legge quadro non è ancora indicata) delle
risorse statali per le infrastrutture. È ovvio che la valenza di questa norma
(che potrebbe essere spostata direttamente in legge di bilancio), dipenderà
proprio da quella percentuale. Che dovrà superare il minimo sindacale del 34%.
Rispunta la secessione dei ricchi. Ma ora i paletti sono
invalicabili. Torna l’autonomia differenziata con la
strana alleanza fra sinistra emiliana e leghisti lombardo-veneti. Pietro Massimo
Busetta il 10 settembre 2020 su Il Quotidiano del Sud. Tornano le problematiche
accantonate con il lockdown. Tra queste l’autonomia differenziata è già al
centro del dibattito. Forti della pressione delle regioni, in una strana
mescolanza tra quelle di sinistra come l’Emilia Romagna e quelle leghiste come
la Lombardia ed il Veneto. Ma ormai è abbastanza assodato che vi sia un accordo
tacito tra la sinistra emiliana con le punte di Milano e Bergamo e la gestione
leghista di Lombardia e Veneto, a cui presto si aggiungeranno le altre regioni
del Nord. Il tema di fondo riguarda l’esigenza e la volontà da parte delle
regioni ricche di tenersi il loro surplus fiscale. Come fossero degli Stati
autonomi vogliono utilizzare le risorse che producono, in maniera da poter
consentire ai propri concittadini degli standard di welfare, che lo Stato non
potrebbe consentire se dovesse trovare le risorse per tutti. Asili nido ?
Scuolabus? Sanità ? Scuola? Perché non dare servizi sempre più completi se la
Regione ha un surplus fiscale che lo consentirebbe? Dopo anni di propaganda
leghista su un Sud sprecone e parassita che aspira ad un reddito senza lavoro,
ritornare indietro ai concetti di solidarietà e di diritti di cittadinanza
uguali per tutti non ë complicato ma impossibile. E quindi Francesco Boccia non
potrà che riprendere il vecchio progetto e cercare di renderlo più equo
possibile, avendo chiaro però che la pressione delle forze politiche, con poche
eccezioni, anche all’interno del PD, é verso una regola: ognuno si tiene le
risorse che produce. Quella che é stata definita la secessione dei ricchi,
quella che é stata contestata con dati inequivocabili di risorse pro capite
assolutamente sperequate tra una parte e l’altra del Paese, alla fine avrà una
sua legittimazione normativa, visto che ad oggi la distribuzione delle risorse
ha aspetti di incostituzionalità. Già se vi saranno i correttivi relativi ai
livelli essenziali di prestazioni, i cosiddetti Lep, e se la riforma non andrà
avanti fino a quando tali livelli, come peraltro era previsto, non saranno
calcolati, se ciò avverrà sarà un gran risultato. Suona strano che tutto questo
possa avvenire malgrado la presa di coscienza di molte regioni meridionali, ed
il dibattito ampio che ha coinvolto enti di ricerca, come la Svimez, tanti
ricercatori e molte delle università meridionali, che hanno concluso che
l’autonomia differenziata in realtà porta a tanti staterelli. E malgrado che
l’esperienza Covid abbia mostrato l’esigenza di una linea di comando unica,
visto i danni che le decisioni di singole Regioni hanno portato al bene comune,
con decisioni su distanziamenti, mezzi pubblici, chiusura di Universitá che
hanno avuto ripercussioni su le altre regioni estremamente rilevanti. Peraltro
si vuole portare l’accordo in Parlamento in una forma blindata, che non consenta
molte modifiche perché é chiaro a molti che se si apre un dibattito e più
parlamentari del Sud, in genere disattenti e concentrati sulle loro esigenze
spicciole, realizzano gli effetti di una tale riforma potrebbe avvenire che si
blocchi tutto. Anche se la forza di “moral suasion” ed il potere dei partiti non
é da sottovalutare. Se dovesse passare diventerebbe normale ciò per cui si é
gridati allo scandalo e cioè che alcuni servizi siano differenziati per aree,
per cui le realtà più ricche li avrebbero di un livello diverso e superiore
rispetto a quelle più marginali e periferiche. L’effetto sarà quello di alcuni
comuni del Trentino che hanno i marciapiedi di marmo ed altri comuni del Sud che
non hanno nemmeno i marciapiedi in cemento. Ma al di là degli effetti rispetto
alle popolazioni delle singole regioni, alcune delle quali saranno molto
soddisfatte ed altre invece molto meno, è evidente rispetto gli effetti che
produrrà una tale normativa rispetto al sistema Paese. Le regioni del Sud
avranno un processo di sviluppo più lento, cosa che inciderà sull’evoluzione dei
territori in termini socio culturali. Per cui per esempio meno investimenti
nella scuola porteranno il permanere della dispersione scolastica, una qualità
più scadente dei territori e delle città ad un più difficile sviluppo turistico.
In generale il processo di messa a regime di un terzo del territorio e della
popolazione del Paese sarà più lento con conseguenze sullo sviluppo turistico,
già molto contenuto, e di quello manifatturiero perché é evidente che una realtà
con servizi meno efficienti avrà più difficoltà ad attrarre investimenti
dall’esterno dell’area. Insomma tutto il contrario di quello che ha fatto la
ricca Germania con la ex DDR, per la quale ha previsto un prelievo fiscale
apposito per accelerare lo sviluppo di quelle aree, cosa che ormai é quasi
avvenuta, e che ha portato la Germania a primeggiare in Europa e nel Mondo. Sono
scelte: ogni Paese fa le sue. Noi possiamo continuare ad utilizzare il Sud come
area per le produzioni inquinanti, non valorizzare la piattaforma logistica del
Mediterraneo, non investendo adeguatamente nelle infrastrutture ferroviarie di
alta capacità e velocità, magari privilegiando in tal modo Genova o Trieste , ma
prevalentemente Rotterdam ed Aversa. Possiamo diventare terzi o quarti per
presenze turistiche, superate da Spagna e Francia, pur avendo Pompei ed
Ercolano, due vulcani attivi, Stromboli ed Etna, i parchi archeologici più belli
del Mediterraneo come Paestum, Selinunte ed Agrigento, i bronzi di Riace in una
città sporchissima; possiamo fare tutto questo ma dobbiamo pure sapere che il
problema non sarà di Reggio Calabria o Agrigento, ma che quello che perde in
presenze turistiche il Mezzogiorno lo perde il Paese, che presto sarà costretto
a intervenire con il numero chiuso a Venezia e Firenze. Mentre le realtà
bulimiche del lodigiano, del bresciano o del bergamasco soffriranno sempre di
più per un inquinamento dovuto ad una concentrazione di manifatturiero che alla
popolazione potrà portare poco. Perché al massimo in una famiglia potranno
lavorare marito moglie e i figli, ma se serviranno altri occupati si dovranno
far venire dal Sud, dalla Polonia o dalla Romania se non dalla lontana Cina.
Sembra una logica facile da comprendere ed invece il nostro Paese, in una
visione campanilistica e provinciale, non riesce ancora ad avere chiaro che se
non cresce lo stivale esso si tira dietro tutti. E che l’ipotesi di staccarsi e
lasciare alcuni territori annegare non é praticabile, perché le reazioni,
strutturate o alla Masaniello, costringeranno il Paese a fare i conti con un
disagio diffuso ed amplificato da una mobilità che sbatte in faccia le
differenze tra i marciapiedi di marmo e la mancanza di essi.
Il Nord smascherato dai numeri certificati nega al Sud gli
stessi diritti di cittadinanza. Provate a spiegare
perché un bambino nato a Reggio Calabria debba avere meno servizi, meno
tutele, meno possibilità di un coetaneo nato a Reggio Emilia. Pietro Massimo
Busetta il 9 settembre 2020 su Il Quotidiano del Sud. Sessanta miliardi in meno
al Sud, ogni anno. Questo l’importo che viene sottratto ai cittadini
italiani/meridionali con la spesa storica. Questo il dato che va assolutamente
contestato da parte delle lobbies degli interessi della sinistra tosco emiliana
con le propaggini dei comuni di Milano e Bergamo e della destra leghista
lombardo veneta. I centri studi, gli studiosi, gli accademici, la commissione
appositamente costituita da Zaia, avranno modo di analizzare la cifra e la
logica di tale impostazione. Malgrado lo stato della sanità, della scuola, delle
infrastrutture stradali e ferroviarie, conseguenza anche del minore importo
destinato di risorse nazionali, bisogna a tutti i costi dimostrare che tale
evidenza è falsa, che in realtà il Mezzogiorno è stato invece sovra assistito,
che le risorse sono state non abbondanti, ma assolutamente enormi e che il Sud è
solo un enorme pozzo, che assorbe ed inghiotte fondi che il generoso Nord
concede. Che in realtà è solo una palla al piede di quell’Italia operosa e
lavoratrice, che ha sempre dato e che ora è stanca di continuare a farlo. Anche
se i dati sono quelli della Corte dei Conti, dell’Istat e non di un centro studi
periferico, bisogna trovare il modo di contestarli. Povero agnello che sporca
l’acqua del lupo, che sta in alto. E che vorrebbe dimostrare che normalmente
l’acqua scende verso il basso. Troppo comoda è stata la possibilità di avere una
colonia, che per tanti anni è servita da mercato di consumo, che ha dato risorse
formate quando servivano, la cui dimensione demografica può essere giocata sui
tavoli internazionali per poter dire che siamo un grande Paese, con 60 milioni
di abitanti, e che quindi è giusto dare l’Expo internazionale a Milano, le
Olimpiadi invernali a Cortina/Milano, l’agenzia del farmaco persa ma richiesta
da Milano, il tribunale dei brevetti a Milano e l’agenzia dell’innovazione a
Torino. La forza di fuoco dei quotidiani, dei media, dei ricercatori asserviti,
delle istituzioni nazionali silenti rispetto a tali problematiche, dei dati medi
che nascondono i due Paesi è talmente ampia che non sarà certo il Quotidiano del
Sud a svegliare coscienze e politici. Anche se ormai il gruppo di chi vuole
vederci chiaro diventa un po’ più ampio ed alcuni, prima silenti e distratti,
cominciano a svegliarsi, la reazione sarà tale da andare avanti ancora per
qualche anno. In attesa che le pietre, che finora sono state zitte, parlino. Con
lo stato delle ferrovie, della scuola, della sanità al Sud, con lo spopolamento
dei territori, con un mercato di consumo sempre più contenuto. Ma sopratutto con
una sempre maggiore marginalità di un Paese, che non valorizza la sua posizione
di piattaforma logistica del Mediterraneo, che perde i grandi traffici marittimi
a favore di Rotterdam ed Anversa, che perde il primato per presenze turistiche
in Europa, che non riesce a crescere ai ritmi degli altri partner europei, che
continua a non capire che mettere a regime un terzo del territorio non è un
favore che viene fatto ai “cafoni” meridionali ma una strada obbligata per tutto
il Paese. Per contestare le evidenze che negli ultimi mesi sono diventate le
basi per qualunque discorso sul Sud bisogna negare che vi siamo gli stessi
diritti di cittadinanza. Ed affermare che ognuno debba gestire le risorse che
produce. Se la base di partenza diventa questa non vi è alcuna sottrazione di
risorse. È infatti noto che ogni anno risorse prodotte nel Nord del Paese
vengono destinate al Sud. Che il saldo è certamente tale per cui l’affermazione
che il Sud sia assistito è corretta. Un ragionamento che sarebbe valido se fatto
tra Stati diversi, che diventa pretestuoso se fatto tra Regioni e che metterebbe
in discussione i principi fondanti della Costituzione. In particolare l’articolo
tre che al primo comma stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza, di lingua,
di condizioni personali e sociali. Accettato il principio che le risorse vengono
utilizzate da chi produce dovremmo dare servizi migliori alle aree ricche delle
città, che hanno un reddito pro capite più elevato a scapito delle periferie
dove, normalmente abitano i più poveri. È quello che si è fatto con il
Mezzogiorno negli ultimi anni e che si voleva statuire con la richiesta di
autonomie differenziate, fatte approvare con dei referendum ai lombardi ed ai
veneti con il mantra “non vogliamo più mantenere il Sud”. Il principio se
attuato prevederebbe che malgrado i doveri di ogni cittadino sia come
contribuente che rispetto alla sicurezza del Paese siano uguali, in realtà poi
abbia diritti diversi se nato a Reggio Emilia rispetto a Reggio Calabria, per
cui in un caso ha diritto agli asili nido ed ai scuolabus gratuiti, nell’altro
invece no. In realtà se confrontiamo i diritti degli svedesi e degli italiani
rispetto allo Stato sociale ci accorgiamo che in Svezia essi sono molto più ampi
che in Italia. Il concetto era di fare in modo che si ripetesse tale situazione
in Italia, per esempio tra Emilia Romagna e Sicilia. Se ai “cafoni” meridionali
avessimo chiesto perché andavano a combattere sul Carso ed a difendere aree che
parlavano dialetti diversi la risposta sarebbe stata “vado a difendere i confini
del mio Paese”. Aree che avevano un clima diverso dal suo di origine ma che
avevano la stessa bandiera e lo stesso inno. Se adesso si vuole mettere in
discussione l’Unità nazionale lo si può fare. La Cecoslovacchia si è divisa in
due parti. La ricca Repubblica Ceca e la povera Slovacchia, entrambi
appartenenti all’Unione, vanno avanti con incremento di reddito che vedono la
già povera Slovacchia avere tassi di crescita più elevati. Mentre la Germania in
una visione ampia ha deciso la riunificazione tra le due parti, diventando la
potenza economica industriale più importante dell’Europa, assistendo per decenni
l’ex DDR, in una visione di rafforzamento del Paese che ha dato già oggi i suoi
risultati. Le strade possono essere diverse, ma nessuno pensi di comportarsi
come se i Paesi fossero due e poi giocarsi sui tavoli internazionali una
dimensione demografica importante. Lo ha fatto fino adesso il Nord, ma il treno
ha fischiato, ed anche l’Europa ci ricorda che così non si può andare avanti.
CE L'HANNO FATTA: SIAMO ULTIMI IN EUROPA. Tutti i disastri
della Conferenza Stato-Regioni: ecco perchè va abolita.
Roberto Napoletano l'11 agosto 2020 su Il Quotidiano del Sud. Con
una politica miope la governance lombardo-emiliana ha fatto in modo che Sud e
Nord dell’Italia siano i due unici territori europei a non avere raggiunto i
livelli pre-crisi del 2007-2008 e che il Pil pro-capite dell’Italia sia sotto la
media europea. I “NOCCHIERI intraprendenti” lombardo-emiliani hanno portato a
sbattere la nave italiana sugli scogli con una forza d’urto che non ha pari in
Europa superando perfino la Grecia. Sono stati venti anni di mare sempre più
tempestoso, i nocchieri hanno sbagliato tutto con sempre maggiore convinzione,
cercavano approdi sicuri solo per loro e i loro cari, facevano la morale agli
altri e continuavano a riempire le stive di ogni genere di vettovaglia e
mercanzia che sottraevano agli altri a cui facevano la morale.
Non hanno deposto l’arroganza, vogliono continuare come pazzi a
farci sbattere, si rifiutano di prendere atto dei disastri che hanno prodotto,
non intendono cambiare la rotta. Anzi. Hanno ripreso a fare soffiare il vento
del Nord. Puntano senza neppure capirlo all’eutanasia dell’Italia facendo del
Nord il nuovo Sud dell’Europa e del Sud un’area di sottosviluppo del mondo.
Siamo sinceri: abbiamo paura. Avere azzerato gli investimenti pubblici
produttivi nel Mezzogiorno per “regalare” 600 miliardi (molta assistenza) al
Nord negli ultimi dieci anni, ha fatto dell’Italia un Paese con un reddito pro
capite nazionale che è precipitato sotto la media europea e dove un terzo della
popolazione a sua volta ha un reddito pari alla metà degli altri due terzi. A
furia di estrarre dal bilancio pubblico italiano sottraendo alle aree deboli le
risorse necessarie per fare infrastrutture di sviluppo e distribuendole alle
aree forti per aumentare la rendita sanitaria privata e mille privilegi
assistenziali-clientelari, ci si ritrova con il Piemonte sotto la media europea,
Marche e Umbria già Sud da quel dì, Toscana due punti sopra, Friuli Venezia
Giulia e tutto il Nord lì lì sull’orlo del burrone per raggiungere il Piemonte
sotto la soglia fatidica, il Sud d’Italia fuori dall’Europa a livelli da
continente africano. Questa politica miope dell’irresponsabilità appartiene alla
Sinistra Padronale tosco-emiliana e alla Destra leghista lombardo-veneta che
hanno da sempre saldamente nelle loro mani congiunte il controllo della
Conferenza Stato-Regioni e, suo tramite, la governance reale della spesa
pubblica. Questa politica miope ha fatto in modo che Sud e Nord dell’Italia sono
i due unici territori europei a non avere raggiunto i livelli pre-crisi del
2007/2008 ma anche quelli che hanno perso cumulati quasi 4 punti di Pil dal 2001
a oggi (3,9% per la precisione), si collocano addirittura del 6,18% sotto la
media europea e si avviano a conseguire la peggiore performance in Europa
nell’anno della Grande Depressione mondiale da Covid “umiliando” perfino la
Grecia. Di fronte a questo scempio, bisogna avere almeno il coraggio di dire le
cose come stanno. La Conferenza Stato-Regioni va abolita. Il luogo decisionale
dell’iniquità più miope che abbia mai conosciuto un Paese occidentale va
eliminato ad horas senza riguardi. La perequazione dei diritti di cittadinanza
per la spesa sociale (scuola e sanità) e quella per la spesa infrastrutturale va
fatta direttamente dallo Stato centrale. Che si deve dotare di una squadra di
prim’ordine, composta badando esclusivamente alla competenza e alla esperienza,
e adottare un criterio rigoroso nella ripartizione territoriale della spesa che
assomigli a quello del proporzionale puro se no il vento del Nord e dei suoi
irresponsabili nocchieri continuerà a impoverire il Sud e a fare
assistenzialismo al Nord violando la Costituzione e portando l’Italia intera ai
margini dell’Europa. Parallelamente va disegnato e attuato un progetto organico
di interventi con un modello che metta insieme Alta velocità ferroviaria, porti,
retroporti, Ponte sullo Stretto e fiscalità di vantaggio chiamandolo per quello
che è: progetto Italia, non progetto Mezzogiorno. Non si scherza più perché
questa volta indulgere alla solita regola ottusa dei ricchi che espropriano i
poveri significa l’eutanasia dell’Italia. È l’ultimo obiettivo che gli è rimasto
da raggiungere con la loro gioiosa macchina da guerra. Se non li si ferma in
tempo, si placheranno solo quando tutto sarà raso al suolo in una spirale di
egoismi senza freni. Siccome da soli non si fermeranno mai bisogna togliergli il
giochetto dalle mani. Per un po’ sbraiteranno, ma non fanno più paura a nessuno.
Dopo qualche anno ringrazieranno. Perché capiranno la differenza tra un’idea
generosa di Paese che si muove unito costruendo il suo futuro e un’idea egoista
che racconta la favola del Nord produttivo senza rendersi conto che è diventato
Sud da quel dì perché si è tagliato le gambe da solo. Questo non lo ammetteranno
mai, sarebbe troppo, ma ringrazieranno le classi dirigenti europee e italiane
che li avranno fatti ragionare.
Il disastro della politica che omaggia il Nord: il Pil pro
capite sprofonda sotto la media Ue. Adriano Giannola,
Presidente Svimez, l'11 agosto 2020 su Il Quotidiano del Sud. invano – si
provava a mettere in guardia i nocchieri che la scialuppa tricolore stava
scendendo, in omaggio all’ormai risibile questione settentrionale, con
inesorabile, rara maestria nel gorgo con la prospettiva di infrangersi sul
fondale roccioso della realtà. È ora ufficiale la notizia (Eurostat) che nel
prepandemico 2019 il Pil pro capite italiano, espresso in euro 2010, ha toccato
quota 26.860, attestandosi su un livello inferiore alla media Ue del 6,18%
(-1769,3 euro), e (udite, udite) ha accusato un calo del 3,9% (-1090 euro)
rispetto al 2001. Che questo esito fosse ineluttabile era chiaro da anni, ma non
era politicamente corretto parlarne senza essere accusati di essere una
“Cassandra sfascista”, tanto più se il fastidioso flebile richiamo veniva dal
ghetto meridionale ove i nocchieri avevano confinato circa venti milioni di
persone in regime di cittadinanza limitata.
LA LINEA D’OMBRA. Il postino della Ue non ha avuto bisogno di
suonare due volte per notificare che il Bel Paese da orgoglioso “contributore
netto” passa a “prenditore netto”. Abbiamo superato la linea d’ombra, uno
spartiacque che dovrebbe far seriamente riflettere lombardi, emiliani, veneti,
per non dire liguri, friulani, piemontesi e toscani che non potranno più fingere
di non sapere e non vedere o, come si dice a Napoli, non potranno continuare a
fare gli scemi per non andare alla guerra. Che siamo in guerra lo si dice da
anni; che la stavamo perdendo era evidente, non fosse altro per il fatto che con
buona pace delle locomotive, il “vento del Nord” nel 2019 era ancora in debito
rispetto al Pil del 2007 di 3 punti percentuali, per non parlare degli oltre 8
punti resi dal Sud. Ritardi che ora si moltiplicano a valle del corto circuito
della pandemia e che – pur considerata la ripresa del 2021 – aumenta a dismisura
il ritardo dall’Europa. A complemento del dato nazionale la tabella in basso
mostra come già nel 2017,oltre a Marche e Umbria già arruolate, Piemonte,
Toscana e Friuli erano buone candidate a entrare nel gregge delle regioni della
coesione e tutte le regioni, a partire da Lombardia ed Emilia Romagna, patiscono
vistosi arretramenti nei ranghi delle 280 regioni europee.
IL PD NON VEDE OLTRE. L’attesa, o meglio l’auspicio di una seria
presa d’atto del disastro annunciato e di una franca disponibilità di fare punto
e a capo, è andata finora completamente delusa. Certo – dismessa la iniziale
baldanzosa tracotanza – il ridotto del Lombardo-Veneto-Emiliano oggi implora di
non dimenticare il Nord, non tanto per bocca della frastornata Lega (partito
“neo-nazionale” né carne né pesce) bensì per bocca del solipsistico Pd a
trazione emiliana ancora ebbro della vittoria – sardine, nume tutelare di non si
sa quale progetto di usurato localismo mitteleuropeo oggi in oggettiva sintonia
con una incomprensibile Confindustria. Preoccupante che il Pd nazionale si
accodi, non riesca a vedere molto oltre i campanili, succube dell’assioma che
l’Italia è il ridotto Lombardo-Veneto-Emiliano.
IL PROGETTO-SISTEMA. Ragionare per assiomi – per definizione
indimostrabili – è già pericoloso. Diabolico sarebbe insistere su questo mal
posto, che in oltre venti anni ha provocato danni incalcolabili. Ricordiamo
sempre che all’alba del 20 luglio a Bruxelles l’Italia ha vinto solo una
battaglia; ha ottenuto un mandato dall’Unione che chiede un drastico cambiamento
di rotta, non per la manutenzione del motore bensì per un’operazione capace di
attivare da Sud quel secondo motore indispensabile per riagganciare il
Mediterraneo all’Europa. Che questa transizione si accompagni a una macroscopica
operazione perequativa nell’uso delle risorse non è una novità; caso mai
dovrebbe essere l’occasione di un confronto oggi reso possibile proprio perché
la disponibilità delle risorse consente di intervenire sulle scandalose evidenze
documentate dall’operazione verità senza avviare una strisciante guerra civile.
Spetta perciò all’Unione europea garantire il rispetto di
condizionalità perentorie: investimenti su progetti finalizzati a ridurre le
disuguaglianze e a garantire sviluppo sostenibile; spetta al governo avere il
coraggio di avere coraggio e di impegnarsi su un progetto-sistema che non può
continuare a esorcizzare il tema del dualismo alimentando vizi e storture che
hanno fatto di noi il grande malato d’Europa.
L’INQUALIFICABILE SCIPPO AL SUD CHE MANDA IN ROVINA L’INTERO
PAESE. Un’ingiustizia, certificata da Corte dei Conti
e Parlamento, che sottrae al Mezzogiorno i servizi essenziali. Vincenzo Damiani
l'11 agosto 2020 su Il Quotidiano del Sud. L’Italia resta spaccata in due e lo
Stato continua a fare figli e figliastri. Un’evidenza certificata da fonti
autorevoli: dalla Corte dei conti alla Svimez, passando dal Parlamento stesso e
dalla recente indagine promossa dalla presidente della commissione Finanze. I
numeri sono sotto gli occhi di chi vuol vedere, il primo è il più macroscopico:
62,5 miliardi. Sono le risorse che nel solo 2017 sono state dirottate
dall’Italia meridionale al Centro-Nord. Risorse che avrebbero potuto garantire
asili nido, cure mediche dignitose, un welfare più equo ai cittadini del Sud.
SCARTO INIQUO. Il calcolo è messo nero su bianco dai Conti
pubblici territoriali, istituto statistico facente capo all’Agenzia per la
Coesione territoriale, che si occupa di misurare e analizzare i flussi
finanziari di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli
enti appartenenti alla componente allargata del settore pubblico. Quei 62,5
miliardi rappresentano uno scarto del 6,4%, in crescita dello 0,4% rispetto al
triennio precedente, fra quanto il Sud avrebbe dovuto ricevere in termini di
spesa pubblica, sulla base della popolazione residente, e quanto ha avuto in
realtà. I cittadini del Sud, vale a dire il 34,2% degli italiani, portano a casa
appena il 27,8% dei trasferimenti provenienti dallo Stato centrale. Tendenza
invertita dal Centro- Nord che riesce ad accaparrarsi molto più di quello che
l’aritmetica consentirebbe: il 65,7% della popolazione accede al 72,1% delle
risorse statali. Per un cittadino del Nord lo Stato spende in media 17.506 euro
all’anno; per uno del Sud appena 13.144.
GLI INVESTIMENTI. La situazione non cambia se guardiamo a quanto
spende lo Stato per gli investimenti, cioè la spesa in conto capitale: se negli
anni Settanta allo sviluppo del Sud veniva destinato lo 0,85% del Pil, nel
periodo 2011-2015 tutto si è ridotto allo 0,15%. Altro che Alta velocità,
infrastrutture moderne, ponti sullo Stretto: di questo passo continuerà a essere
difficile rattoppare una strada provinciale del Sud.
FONDI DI COESIONE. Come se non bastasse, lo scippo è proseguito
sui soldi che spettano di diritto al Mezzogiorno, quello del Fondo coesione: in
questi anni i fondi europei sono stati la pezza sui buchi creai dai governi
nazionali. Una pezza che in teoria dovrebbe essere “aggiuntiva” rispetto agli
investimenti nazionali, ma negli ultimi 13 anni è successo esattamente il
contrario: l’Italia ha tagliato i fondi di Sviluppo e coesione, destinati per
l’85 per cento al Sud, e ha dirottato le relative risorse su altre voci di
spesa. Ecco i numeri, elaborati sui dati della Ragioneria generale dello Stato.
L’importo complessivo destinato dalla Finanziaria per il 2007 al Fondo sviluppo
e coesione per la programmazione 2007- 2013 ammontava a 63,273 miliardi. Oltre
un terzo, 22,3 miliardi, è stato dirottato con una successiva delibera Cipe sul
risanamento dei conti pubblici durante la crisi dei debiti sovrani. A crisi
arginata, nel periodo di programmazione 2014- 2020, i 68,8 miliardi del Fondo
hanno subito una decurtazione di 9,5 miliardi, che sono andati a coprire altri
provvedimenti legislativi. A conti fatti, 31,8 miliardi di tagli in 13, di cui
oltre 27 (l’85%) pagati dal Mezzogiorno.
GLI AIUTI DI STATO. E non è finita qui: a completare l’opera
l’impiego degli aiuti di Stato, risorse destinate dall’Amministrazione centrale
alle imprese, nel rispetto delle norme europee. Da agosto 2017, la Lombardia ha
ricevuto 3,5 miliardi di euro in aiuti di Stato, quasi sei volte i 600 milioni
incassati dalla Calabria. A primo impatto, il dato generale risulta equilibrato:
le risorse concesse vanno infatti per il 38,3% a imprese delle regioni
Meridionali e per il 61,7% ad aziende del Centro Nord. Ma approfondendo la
questione, ecco che salta fuori qualcosa che non va: basta scomputare dal totale
il denaro proveniente dai fondi europei, per trovarsi davanti tutto un altro
film. Il Centro Nord si accaparra il 73,2% degli aiuti, al Sud va appena il
26,8%. Ben al di sotto della quota di garanzia del 34%. Nel Mezzogiorno solo tre
regioni su otto ricevono risorse uguali o superiori al miliardo di euro: la
Campania (2,2 miliardi), la Sicilia (1,7 miliardi) e la Puglia (1,6 miliardi).
L’Abruzzo, regione il cui tessuto economico è stato messo in difficoltà anche
dagli eventi sismici degli ultimi anni, si fermato a 600 milioni.
BANKITALIA. Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco,
recentemente ha ribadito due concetti fondamentali per la ripresa: giustizia
sociale e riduzione delle disuguaglianze. Non è entrato nel merito dei temi, ma
è evidente che l’unica manovra economica che abbia un senso è quella che mette
al centro il rilancio del Sud, per azzerare le diseguaglianze con il Nord. Il
primo punto che Visco ha posto è il recupero del ritardo accumulato nelle
infrastrutture: sia quelle tradizionali, da rinnovare e rendere funzionali, sia
quelle ad alto contenuto innovativo, come le reti di telecomunicazione. Ecco,
all’Italia serve correggere questa stortura. Come? Riportando gli investimenti
per lo sviluppo del Mezzogiorno lontano da quello 0,15% del Pil (dati dei Conti
pubblici territoriali) a cui sono ancorati oggi.
LA RETE STRADALE. Nel Mezzogiorno si contano anche meno
autostrade, a discapito di cittadini e del tessuto produttivo nazionale: al Sud
ogni impresa può contare su meno di 20 km di reti, la metà di quelle a
disposizione nel Nord-Ovest, con la Puglia fanalino di coda con appena 7,9 km
per azienda. Partiamo dalle autostrade: a fronte di una media nazionale di 23 km
ogni 1.000 kmq, al Sud si scende a 20 km/1.000 kmq, con la Basilicata ferma a 3
km/1.000 kmq e il Molise a 8 km/1.000 kmq.
LA SANITÀ. Persino in un settore delicato come la sanità, il Sud
è storicamente penalizzato: dal 2012 al 2017, nella ripartizione del fondo
sanitario nazionale, sei regioni del Nord hanno, infatti, visto aumentare la
loro quota, in media del 2,36%; mentre per altrettante regioni del Mezzogiorno
la fetta è lievitata solo dell’1,75%, cioè oltre mezzo punto percentuale in
meno. Sembra poca roba, ma tradotto in euro significa che, dal 2012 al 2017,
Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno ricevuto
dallo Stato 944 milioni in più rispetto ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata,
Campania e Calabria. Infatti, mentre al Nord sono stati trasferiti 1,629
miliardi in più nel 2017 rispetto al 2012, al Sud sono arrivati solo 685 milioni
in più. Lo squilibrio ha permesso alle Regioni del Nord, non in Piano, di
investire e assumere: le Regioni settentrionali, nel 2018, hanno speso 14
miliardi e 190 milioni per gli stipendi del personale sanitario a tempo
indeterminato, nel 2019 c’è stato un incremento sino a 14 miliardi e 475
milioni. Le Regioni del Sud, invece, per i contratti di medici, infermieri,
operatori sanitari a tempo indeterminato hanno potuto spendere meno della metà,
cioè 6 miliardi e 726 milioni nel 2018, divenuti 6 miliardi e 805 milioni nel
2019. Gli aiuti e i soldi vanno quasi sempre al Nord, è un dato di fatto.
COVID E PRESTITI. Persino durante l’emergenza Covid-19 è stato
così: lo ha denunciato a maggio la Federazione autonomi bancari italiani (Fabi)
che ha svolto uno studio su come e a chi sono stati elargiti i prestiti
garantiti dallo Stato da 25 a 800mila euro sino a quel periodo. Bene, il 50,7%
era ad appannaggio di quattro regioni del Nord dove, però, era attivo solo il
38% di partite Iva e pmi italiane. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna
si erano assicurate oltre la metà dei finanziamenti con paracadute pubblico, ma
in quelle zone del Paese opera, in proporzione, un numero di imprese e
professionisti nettamente inferiore alla quota di crediti in arrivo grazie al
decreto liquidità. Nel resto del Paese, opera il 62% di soggetti economici, ma
la quota di prestiti a fine maggio si era fermata al 49,3%. Nulla di nuovo,
d’altronde ogni giorno il Sud “perde” circa 170 milioni: a tanto ammonta, su
base giornaliera, il bottino da 62,3 miliardi che ogni anno, dati del Sistema
dei conti pubblici territoriali alla mano, viene sottratto al Sud e dirottato
verso il Nord. Parliamo di circa 5,2 miliardi al mese di spesa pubblica
allargata, non solo statale.
LA QUESTIONE SETTENTRIONALE CHE L’ITALIA NON VUOLE VEDERE.
L'editoriale di Roberto Napoletano il 10 agosto 2020
su Il Quotidiano del Sud. Così si è riusciti nel capolavoro di fare vincere
clientelismo e criminalità organizzata in territori sempre più estesi del Nord e
di ridurre il reddito pro capite delle donne e degli uomini del Sud alla metà di
quello del resto del Paese. Privando il Nord del suo primo mercato di
“esportazioni” e l’economia nazionale di una dimensione di impresa diffusa sui
suoi territori e degna di un grande Paese. Il punto di forza dell’Italia di oggi
è un Presidente del Consiglio libero dal condizionamento di questi interessi
deteriori che sono quelli degli egoismi miopi del Nord che stanno conducendo
l’Italia fuori dal novero dei Paesi industrializzati. La vera questione
settentrionale sono i 600 miliardi malcontati indebitamente sottratti dalle
Regioni del Nord alle risorse pubbliche di spesa sociale e di sviluppo dovute
alle Regioni del Sud negli ultimi dieci anni. La vera questione settentrionale è
l’azzeramento (0,15% del Pil) degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno
d’Italia per consentire alla Regione Piemonte di spendere per i suoi servizi
generali cinque volte di più della Regione Campania riuscendo nel capolavoro di
fare vincere clientelismo e criminalità organizzata in territori sempre più
estesi del Nord e di ridurre il reddito pro capite delle donne e degli uomini
del Sud alla metà di quello del resto del Paese. Privando così il Nord del suo
primo mercato di “esportazioni” che sono i consumi interni di venti milioni di
persone e l’economia nazionale di una dimensione di impresa diffusa sui suoi
territori e degna di un grande Paese industrializzato. La vera questione
settentrionale sono gli spifferi lombardo-emiliani sull’imminente lockdown fatti
filtrare dalla conferenza Stato-Regioni nei giorni caldi del Covid 19 che hanno
determinato la fuga di notte dal Nord al Sud di studenti e lavoratori
meridionali e hanno costretto la classe politica di governo e delle Regioni
meridionali a chiudere economie regionali che potevano rimanere aperte.
Sorvoliamo sul tam tam sanitario lombardo-emiliano che accusa le Regioni più
indecentemente foraggiate dal bilancio pubblico italiano di avere voluto
“scaricare” nelle regioni meridionali parte della loro emergenza sanitaria. Non
ce la facevano con tutti i soldi in più che ingiustificatamente ricevono e
volevano trasferire parte del problema su chi ingiustificatamente riceve molto
meno di loro. La vera questione settentrionale è la caduta totale, rovinosa,
delle grandi famiglie del capitalismo privato del Nord drogato da questa massa
di denaro pubblico “rubata” per decenni al Sud che ha dato alla testa a molti e
ha fatto smarrire il gusto della fatica e di competere nell’arena globale. La
vera questione settentrionale è la perdita di un’idea di Paese come fu negli
anni del Dopoguerra e che fu patrimonio comune del trentino De Gasperi e dei
grandi lombardi come Vanoni e Bassetti. Ma davvero davvero vogliamo andare
avanti con i Bonaccini che scappano dai loro doveri istituzionali di fare il
fondo perequativo per la spesa sociale e per le infrastrutture di modo che il
saccheggio continui indisturbato fino a radere al suolo l’economia del Nord e
del Sud e che si preoccupano solo di proteggere il loro orticello di indebiti
finanziamenti pubblici? Che cosa deve accadere perché i Bonaccini, i Gori, le
Gualmini si rendano conto che il vero interesse del Nord, dell’Emilia-Romagna e
della Lombardia, è la fiscalità di vantaggio e un piano di opere da attuare in
quattro anni per fare ripartire il mercato interno del Sud e ridare al Nord la
sua gallina dalle uova d’oro? È possibile che lo abbiano capito l’Europa tutta,
la Bce, la Bei, la Banca d’Italia e non lo abbiano capito i big della Sinistra
Padronale? Che cosa di terribile è accaduto perché persone di spessore come
Bonaccini, Gori, Gualmini parlino e si comportino come il peggiore Bossi e
ripetano il peggiore urlo padano secessionista nelle sue varie salse leghiste?
Ma vi rendete conto di quanto pesa il silenzio della impresa privata e delle sue
organizzazioni di rappresentanza che avrebbero dovuto chiedere loro, pretendere
loro, e poi plaudire, la fiscalità di vantaggio nelle aree svantaggiate? In
queste ore sarebbero dovute andare tutte insieme dal Capo del governo a
ringraziarlo e a comunicargli: questi sono i nuovi investimenti che andremo a
fare noi nel Mezzogiorno, questi sono quelli che siamo in grado di attrarre
dall’estero. Che cosa possiamo fare noi per aiutare la comunicazione nel mondo
che il nuovo mercato degli investimenti in Europa è il nostro Mezzogiorno oltre
a dare il buon esempio? Invece no, senti addirittura dire nei conciliaboli
privati: a noi non ce ne frega niente! Ma dove siamo finiti? Di che razza di
capitalismo stiamo parlando? Lo diciamo con la consueta franchezza: crediamo che
il punto di forza dell’Italia di oggi sia un presidente del Consiglio libero dai
condizionamenti di questi interessi deteriori che sono quelli degli egoismi
miopi del Nord che stanno conducendo l’Italia intera fuori dal novero dei Paesi
industrializzati. Lo si accusa di essere un temporeggiatore ignorando che nella
politica ci sono momenti in cui bisogna accelerare e altri in cui bisogna
rallentare perché le cose vanno fatte nel momento giusto per farle. Sulla
fiscalità di vantaggio Conte si è rivelato una teste d’ariete e così è stato
anche per l’abuso d’ufficio e la responsabilità erariale, ancora prima quando si
è trattato di buttare giù il muro della iniqua distribuzione della spesa
pubblica e questo giornale era assolutamente solo, dopo le nostre inchieste e
gli autorevoli interventi di Conte sul tema sono venuti dietro tutti. Così è
stato e sempre più sarà per il pacchetto organico di interventi al Sud – alta
velocità ferroviaria porti e retroporti – e sarà anche, auspichiamo, per il
Ponte sullo Stretto. Oggi si parla di tunnel marino, poi si farà il Ponte perché
abbiamo un Presidente del Consiglio che sa coinvolgere la sua base grillina e sa
leggere i numeri. Al momento giusto il temporeggiatore tornerà a essere testa
d’ariete. Ovviamente vigileremo.
Benvenuti
al Sud: qui la vita si allunga. Al Nord l’aspettativa si sta accorciando.
Nel
Meridione si può arrivare in media a 82 anni ma in certe zone della Sicilia si
va oltre. Carlo Porcaro il 25 giugno 2020 su Il Quotidiano del Sud. Al Sud è
stata bloccata l’ondata del virus e si vive di più. Al Nord il Covid ha assunto
i contorni della tragedia e si vive mediamente di meno. A fotografare la
longevità degli italiani è l’Istat alla luce della pandemia, i cui effetti sono
ancora in corso. Lo “scatto” è impietoso per chi ha già sofferto molto la
cattiva gestione sanitaria del coronavirus. È infatti calata di 2 anni, da 84 a
82, l’aspettativa di vita nelle province del Nord Italia, in particolar modo in
quelle colpite dal Covid-19, soprattutto nel Nord-ovest e lungo la dorsale
appenninica. Si può vivere fino a 82 anni in media nel Meridione, ma in alcune
province della Sicilia il post-Covid ha fatto persino salire la media e si
“campa” di più.
I DATI. Sono i
dati emersi dal Report dell’Istat focalizzato sugli “scenari di mortalità da
Covid-19”, secondo cui invece «l’intensità nel cambiamento della speranza di
vita alla nascita appare decisamente minore, e nella maggior parte dei casi
trascurabile, in corrispondenza di buona parte delle province del Centro e del
Sud. Per alcune di esse – ha registrato l’Istituto di statistica – si ha persino
modo di registrare un miglioramento, ad esempio per talune province della
Sicilia». I problemi più preoccupanti riguardano gli anziani, già deboli di
loro, vittime preferite dal virus. Le stime sulla speranza di vita degli over
65enni si sono abbassate molto. In particolare, in tutte le province del Nord e
parte di quelle del Centro un individuo al 65° compleanno poteva aspettarsi di
vivere, in epoca pre-Covid, per altri 21 anni (mediamente), mentre con gli
effetti di mortalità dovuti alla pandemia, tale durata – facendo riferimento
allo scenario intermedio “moderato” – scenderebbe a circa 19. E il Mezzogiorno?
Le Province meridionali «non sembrano tuttavia registrare variazioni di
rilievo», il che significa che la situazione è rimasta di fatto invariata o
leggermente migliorata. Stare chiusi in casa è servito a salvare la pelle, oggi
e domani insomma.
LA CLASSIFICA.
Bergamo e Cremona segnano una riduzione della speranza di vita alla nascita che
risulta superiore ai 5 anni; riduzione che a Bergamo arriva a raggiungere i sei
anni allorché la si misura al 65° compleanno. Per cogliere meglio il significato
delle variazioni osservate, «può essere utile collocare i livelli della speranza
di vita localmente ipotizzati attraverso gli scenari disegnati per il 2020 nel
quadro delle dinamiche rilevate, nel corso degli anni, per quegli stessi
indicatori». Per alcuni territori si torna indietro di circa 20 anni, mentre al
Sud la longevità è la stessa di prima. «La marcata incidenza della mortalità in
corrispondenza della popolazione in età più avanzata porta con sé, là dove è
presente, anche un significativo allentamento di quel fenomeno, noto come
invecchiamento demografico, che identifica la crescita della componente anziana
e che tradizionalmente era stato visto – almeno sino ad ora e stante le
dinamiche demografiche da tempo in atto – come qualcosa di ineluttabile. Non a
caso – si legge nel Report dell’Istat – la simulazione per il 2020 in assenza di
Covid-19, mette chiaramente in luce come la quota di ultra 65enni sul totale dei
residenti fosse destinata ad aumentare di altri 0,3 punti percentuali a livello
nazionale, segnalando un incremento in pressoché tutte le Province».
PATRIMONIO
DEMOGRAFICO. Il “patrimonio demografico” di ogni Provincia, inteso come il
totale di anni-vita che competono ai suoi residenti in base alle aspettative di
vita (e di riflesso alle condizioni di mortalità) di un dato periodo. In questo
senso, «se si tiene conto dei cambiamenti nella speranza di vita alle diverse
età prospettati dai diversi scenari si ha modo di cogliere come, ad esempio
nello scenario moderato, alle condizioni di mortalità (di speranza di vita)
ipotizzate vi siano alcune Province in cui si registra una riduzione del
patrimonio demografico anche nell’ordine del 5-10%. Ciò è quanto accade per le
Province di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, Brescia, Lecco, Parma e Pavia,
mentre nel Centro e nel Sud, ad eccezione della Puglia, Calabria e Sardegna, si
registrano variazioni del patrimonio demografico sostanzialmente nulle o in
molti casi positive. In generale, va ricordato che la popolazione italiana di
età tra 15 e 64 anni si ridurrà di oltre 3 milioni nei prossimi quindici anni.
Lo ha detto Bankitalia nella sua ultima relazione annuale. «Le nostre proiezioni
demografiche non sono favorevoli, anche tenendo conto del contributo
dell’immigrazione, stimato da Eurostat in circa 200.000 persone in media
all’anno», annunciò il governatore Ignazio Visco.
SUDISMI - Geo-paradosso e alta incapacità: isolati i porti del
Sud vicini a Suez. Il Paese non si è attrezzato per
sfruttare la posizione geografica che ne fa una piattaforma logistica nel
Mediterraneo. Pietro Massimo Busetta il 24 giugno 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Quattro cose da fare subito! Così la campagna che ha iniziato il nostro
quotidiano ieri. La prima cosa da fare sarebbe di partire con gli investimenti
pubblici. In particolare fare un elenco di quelli che si possono realizzare,
partendo dall’alta velocità al Sud. Sembrerebbe tale priorità dettata solo da
una voglia di perequare il territorio e dare gli stessi diritti di cittadinanza
a tutti, anche nel diritto al trasporto. Ma in realtà questo diritto in Italia
non lo hanno tutti allo stesso livello. Se uno abita sulle Dolomiti ha una
possibilità di movimento inferiore rispetto a chi abita a Milano e nessuno pensa
di costruire una linea di alta velocità ferroviaria per raggiungere da lì un
grande centro, anche se con il decreto rilancio sono stati destinati 2 miliardi
per la Bergamo -San Candido, per quelle Olimpiadi, che dovevano essere a costo
zero per il Paese.
TEMPI DI PERCORRENZA. Quindi se qualcuno avesse in Calabria tempi
di percorrenza per raggiungere un grande centro superiori a chi abita in Toscana
non sarebbe scandaloso. Invece la logica é un’altra ed é solo economica: il
nostro Paese ha la fortuna di essere a forma di uno stivale che si protende
verso l’Africa, con la Sicilia che é a 100 chilometri dalla Tunisia. Tanto che
nei giorni limpidi da Pantelleria si sorgono le coste tunisine. E lo sanno bene
i Nord africani che arrivano in surf o in barchini improvvisati. L’unico che
sembra non saperlo é il nostro Governo e la nostra classe dirigente che consente
a Mario Monti, complici tutti i partiti che lo appoggiavano, di cancellare il
collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, che doveva servire a fare arrivare
quell’alta capacità/ velocità ferroviaria che congiungendosi con la linea in
funzione che parte da Salerno avrebbe potuto collegare Berlino ad Augusta e
quindi a Hong Kong tramite la piattaforma italica. Ed il Paese negli ultimi
cinquant’anni non si é attrezzato per sfruttare la posizione geografica che ne
fa una piattaforma logistica nel Mediterraneo, proiettata verso Suez. Quindi ci
troviamo a due passi da Canale di Suez raddoppiato ma non ne utilizziamo il
vantaggio. Nel frattempo il Mondo va a velocità supersonica. Qualche giorno fa
La HMM Algeciras, la più grande nave portacontainer al mondo, ha concluso il suo
viaggio inaugurale a Londra.
LA HMM ALGECIRAS. Partita il 26 aprile dal porto di Qingdao nella
provincia dello Shandong, in Cina orientale, lunga 399,9 metri, ha una larghezza
massima di 61,03 metri e una superficie di oltre 24.000 metri quadrati, circa le
dimensioni di tre campi e mezzo di calcio regolamentari. La HMM Algeciras può
trasportare circa 200 container in più rispetto alla precedente nave
portacontainer più grande. A pieno carico, tutti i 24.000 container, se posti in
fila, raggiungerebbero una lunghezza totale di 150 chilometri. La nave prima di
raggiungere Londra ha navigato verso Busan con 4.560 TEU di prodotti chimici,
meccanici ed elettrici e prodotti alimentari non di base. I porti nella
rotazione della nave portacontainer sono stati anche Ningbo, Shanghai, Yantian,
il canale di Suez, Rotterdam, Amburgo e Anversa. Ha viaggiato ad una velocità
massima di 12,9 nodi e una velocità media di 10,9 nodi. Questa la notizia che
riportano le agenzie del 16 giugno scorso. Tutti i numeri sono impressionanti:
dalla lunghezza dei container messi uno dietro l’altro, alla dimensione di tre
campi di calcio della tolda, alla velocitá.
I TRAFFICI. Ma quello che é veramente impressionante é che nel
Mediterraneo lungo le coste del Nord Africa si concentra attualmente il 19% del
traffico mondiale. Per capire di cosa stiamo parlando i numeri sono importanti.
Nei porti che si affacciano sul Mediterraneo transitano ogni anno 2 miliardi di
tonnellate di merci: i primi 30 scali nel 2015 hanno movimentato 48 milioni di
teu. L’incremento di questi trasporti negli ultimi 20 anni è stato esponenziale
(+ 425%) se si tiene conto che nel 1995 erano stati 9,1 milioni. Ed il nostro
Paese si é trovato impreparato ad intercettare tali traffici, dimostrando la
mancanza di visione che abbiamo avuto.
L’ASSURDO. Invece di potenziare i porti più vicini a Suez, come
Augusta, Catania, Palermo, Gioia Tauro, Taranto, Bari, Napoli abbiamo lasciato
che gli altri da Atene a Tangeri si attrezzassero. Noi abbiamo lasciato Augusta
con il suo inquinamento, aspettando la verità e le bonifiche da oltre mezzo
secolo. Situazione molto simile a Taranto come abbiamo appreso dalle cronache
sulla ex Ilva. Un Mezzogiorno che é servito da discarica per le produzioni
inquinanti, e che poi é stato abbandonato a se stesso. E adesso ci ritroviamo a
dover correre per recuperare il ritardo accumulato; il rischio é di rimanere
emarginati dai grandi traffici internazionali pur essendo geograficamente
centrali. E di perdere migliaia di posti di lavoro che invece sono stai creati
nei retro porti di Anversa o Rotterdam.
URGENZA NON PERCEPITA. Questo é il motivo dell’alta velocità/
capacità al Sud. Ma non mi pare che questa urgenza sia stata percepita se ancora
Leu o i 5 stelle disquisiscono su ponte si, ponte no, come se il problema
fossero quei tre chilometri di mare e non di completare la lunga linea ferrata
per arrivare ad Augusta, davanti al canale di Suez, ed intercettare una parte
dei traffici. Mentre l’Europa, che sa bene quanto sia rischioso ed inquinante,
da un punto di vista ambientale, far viaggiare questi giganti per lunghi tratti,
ci raccomanda di far presto, magari mettendoci a disposizione le risorse per
completare la rete. Speriamo che il nostro Paese riuscirà a recuperare il tempo
perduto ed a far partire il progetto che ci farebbe diventare i protagonisti del
Mediterraneo e non continuare a rimanere ai margini dei traffici, periferia del
mondo.
IL CASO DELLE ZES. E riuscire dopo gli Stati generali ad avere
una visione per l’Italia 2030. O continueremo a pensare alle prossime elezioni o
alle parole in libertà di Di Battista? Dobbiamo essere ottimisti certo, ma anche
pretendere risposte concrete. Peraltro le Zes potrebbero costituire delle realtà
di retroporto, dove procedere alla trasformazione dei prodotti che arrivano
dalla vicina Cina, niente di diverso di quello che fanno a Rotterdam, creando
migliaia di posti di lavoro. La logistica é uno dei driver che sempre Adriano
Giannola e la Svimez hanno individuato come uno dei pilastri sui quali fondare
lo sviluppo del nostro Paese con la valorizzazione della piattaforma logistica
che il fato ci ha donato insieme alle coste ed al mare. Ma come dice qualcuno
tutto quello che non si paga si pensa non abbia valore .
Per salvare il Meridione il ministro Provenzano deve abbattere
il feudo. Gioacchino Criaco su Il Riformista il 24
Giugno 2020. I piani per il Sud si rinnovano ciclicamente, con una cadenza
sinistra simile alle epidemie o alle carestie. Niente di buono è mai successo se
le condizioni di sottosviluppo, i problemi, continuino a permanere, immutabili,
quasi fosse davvero il destino il padrone del gioco meridionale. Ora è
il ministro Provenzano che si propone di disarticolare il fato. Aree interne,
restanza e ritorno dei giovani, le linee guida del suo rilancio. Cose giuste,
imprescindibili, per chi vuol cambiare le cose, ma perfettamente inutili senza
il verificarsi di una precondizione. E la mafia è un ostacolo enorme allo
sviluppo, ma non è la causa è il prodotto del mancato sviluppo, che in un
circolo vizioso si nutre di fallimenti e a sua volta ne origina di nuovi. Il Sud
ha un sistema produttivo striminzito, embrionale, quello privato non ha le
risorse per fare da solo e ha bisogno di un forte intervento pubblico per
partire, e l’intervento pubblico è saldamente in mano a una classe dirigente che
trova la sua esistenza, sopravvivenza, nel mancato sviluppo. È il feudo il
grande, intonso, problema del Sud. Fino a quando non si scardinerà il feudo
nessuno sviluppo sarà in grado di sovvertire le sorti del Meridione. Le aree
interne si sono spopolate perché le classi dirigenti hanno operato perché si
spopolassero, e i giovani sono stati costretti a partire per sfuggire, non
sottomettersi, non scendere a patti con una razza padrona. In questo sistema
perverso, in fondo, le mafie hanno giocato il ruolo che era loro consono,
soffocare il ribellismo, o farlo confluire in un percorso criminale, soffocare e
assoggettare l’intraprendenza privata, in un meccanismo, tra mafie e classe
dirigente, che quando non è stato di complicità, è stato di reciproca
convenienza, di convergenza di interessi. La magistratura per lungo tempo ha
assistito, per tanto tempo ha poi perseguito il versante mafioso del problema, e
spesso prediligendo la parte stracciona del crimine. E anche quando l’intervento
è diventato massiccio, è mancata l’azione politica, la costruzione di una classe
dirigente capace, libera. Le forze centrali della politica hanno lasciato
sussistere in loco casati che si susseguono di generazione in generazione, con
una logica del ricambio che è quella dei figli al posto dei padri, e poi dei
nipoti. E non è una questione di colori. Un blocco unico, solo apparentemente
variegato continua a governare. Tutto è saldamente in mano al feudo, chi si
integra, è integrato, resta, gli altri si devono arrangiare, nel senso di
partire. E continuerà a esserci un piano per il Sud di tipo epidemico, fino a
quando, la politica, non deciderà di scardinare il feudo, di aprire le porte del
potere politico, istituzionale, imprenditoriale ai figli di nessuno. Fino a
quando ciò non si verificherà, i borghi resteranno deserti e i giovani
continueranno a riempire valigie.
Italia, allunga il passo e torna a essere unita.
Analisi e riflessioni post pandemia in «Il male del Nord» di Pino
Aprile. La divisione del Paese in due parti, una che ha tutto e l’altra niente,
nella spesa pubblica sottrae al Sud 61 miliardi l’anno. Lino Patruno il 21
Giugno 2020 su La Gazzetta del Mezzogiorno. E infine venne il virus a dimostrare
che «il re è nudo». Tutti a chiedersi come mai la Lombardia, la regione più
potente d’Italia, sia stata la peggiore nella lotta alla pandemia. Non solo
compromettendo se stessa, ma compromettendo il resto del Paese. E come la vocina
della bambina nella novella di Andersen, quella del Covid ha rivelato gli
inganni sui quali quella sensazione di intangibilità e immunità si reggeva.
Parliamoci chiaro: sono stati tanti gli errori commessi fra Bergamo e Milano,
che se fossero stati fatti altrove avrebbero portato allo stesso disastro. Il
fatto è che non sono stati commessi altrove, ma proprio lì dove meno ce li si
aspettava. Anzi è andata molto meglio dove più ce li si aspettava. Ma a loro non
poteva succedere. E allora? Ha una spiegazione meno legata al caso «Il male del
Nord», titolo dell’ultimo libro di Pino Aprile (Pienogiorno ed., pag. 171, euro
16,90) uscito mentre ancòra lassù si contano i morti quotidiani e altrove no. È
vero che con un governatore come Fontana e un assessore come Gallera si può
addirittura dire che il male sia andato fin troppo bene. È vero che se lasci
diffondere il contagio negli ospedali e nelle residenze per anziani non è che il
virus faccia finta di niente. È vero che se dici «Milano non si ferma», meno che
mai si ferma la diffusione degli ammalati. È vero che se fai svolgere la partita
(con pubblico) Atalanta-Valencia te la vai proprio a cercare. È vero che se non
istituisci immediatamente le «zone rosse» di blocco totale, la pandemia va e
viene come vuole. Ma ecco, perché le «zone rosse» solo a tempo scaduto? E perché
la leggerezza e la protervia di tutto il resto? Perché appunto il re era nudo,
ma nessuno aveva il coraggio di dirlo. Non sfortunate coincidenze, ma
inevitabili conseguenze di un modo di essere. Una ingordigia economica che ha
fatto tenere aperte il 70 per cento delle aziende trasformate in focolai poi
indomabili (i «danè»). Una indisciplina civica figlia di un’arroganza da
ricchezza e di una concezione sfrontata di autonomia. Un sistema sanitario
pubblico talmente smantellato per far fare soldi ai privati che al momento
opportuno non ci sono state più terapie intensive sufficienti. Tutto quanto
fosse camuffato dai suoni e dalle luci della Milano città europea è miseramente
e dolorosamente esploso alla prova dei fatti. Insomma non è fallita solo una
sanità lombarda. È fallita una presunta locomotiva talmente sfiatata che il
Paese è sempre ultimo nelle classifiche del reddito. Ma questa locomotiva non
arraffa sempre carburante senza che ciò non costi qualcosa al resto d’Italia.
Carburante come spesa pubblica che sottrae al Sud 61 miliardi l’anno che vanno
agli altri. Costa la divisione in due Italie, una che ha tutto l’altra niente.
Costa una sperequazione che non fa crescere l’intera Italia, non solo il Sud.
Una mancanza di equità non solo territoriale, ma umana e sociale in cui la parte
meglio attrezzata, la più ricca, la maggiormente servita e finanziata, quella
alla quale va tutto non capisce il suo male, appunto. Un male di congestione,
inquinamento, accaparramento, abbondanza, scandali, cattiva amministrazione.
Memorabile in tal senso il discorso di Fontana: da noi la bistecca spetta al
padre che lavora, niente ai figli. Insegniamogli la civiltà mediterranea che
tutto divide. Finché, in un giorno di marzo dell’anno bisestile 2020, tutto
diventa un boomerang per mano di un virus. Il libro di Aprile non è solo un
instant book su ciò che è avvenuto (anche se il giornalista-scrittore pugliese
lo scrive al passato come un memoriale che resti nella storia: avvenne, ci fu).
È un libro che parte dallo scandalo di un Paese ingiusto per arrivare alla
urgenza di un Paese più giusto. Partendo da Sud, che così non è il problema del
Paese, ma è la soluzione. E Sud in cui col virus doveva succedere e invece non è
successo. Anche se la notoria vis polemica di Aprile si chiede (per la verità
senza che la polemica sia campata in aria) cosa avrebbero detto a parti inverse.
Un Muro di Berlino avrebbero eretto contro i meridionali peste d’Italia. Contro
i colerosi. E dove, invece, con meno mezzi e meno uomini, si è fatto molto
meglio di dove mezzi e uomini li sottraggono agli altri senza nulla restituire.
Compresi, stavolta, tamponi e reagenti. Aprile non fa la fantacronaca di un
disastro. Ridicolizza il pregiudizio contro il Sud. Smonta il giudizio sul Nord.
Dice chiaro e tondo che se l’Italia non cambia non solo resta ultima, ma si
spezza (a costo di essere tacciato di separatismo). Suggerisce che solo partendo
da Sud c’è un futuro per tutti, dalle terre dimenticate alle terre di mezzo. Sud
come un affare. Si è finora lasciato credere che il male del Paese fosse appunto
il povero Sud. E invece si scopre il male del Nord. Frigge dirlo, ma questo
virus non sarà stato del tutto inutile (e infame).
Pino Aprile, dopo Terroni, Giù al Sud, e saggi seguenti in cui
metteva a nudo l’iniquità italiana, ne “Il male del Nord” toglie anche le
mutande a questa malfatta nazione fondata sulla disparità territoriale, e lo fa
con un’avvertenza: se l’Italia non cambia, è destinata a spezzarsi. Il Sud non
può più tollerare il modello del “Prima il Nord”.
“IL MALE DEL NORD” DI PINO APRILE? IL RE E’ NUDO E QUALCUNO
GLI VEDE IL LATO B. Raffaele Vescera il 18.06.2020 su
Movimento24 agosto.it. Rompere un pregiudizio è più difficile che spezzare un
atomo, diceva il grande Einstein, che l’atomo lo spezzò per davvero, mentre
infuriava il pregiudizio contro gli ebrei, popolo cui apparteneva e che pagò con
milioni di morti innocenti la follia di tale preconcetto razziale. Prevenzione
razziale che, se in Europa infuriava contro gli ebrei, in America dove Einstein
si era rifugiato infuriava contro i neri, trattati men che bestie dagli ottusi
razzisti yankee, dei quali il Ku Klux Klan, estremista e assassino, era solo la
punta dell’iceberg.
Il tutto mentre in Italia infuriava e ancora infuria il
pregiudizio contro i meridionali, “terroni, merdacce, esseri inferiori, topi di
fogna da sterminare con le eruzioni vulcaniche”, nella vulgata leghista. Più
semplicemente “indolenti, scansafatiche, mandolinari, inadatti” in quella
perbenista “democratica”. Ma il pregiudizio, si sa, è funzionale a spogliare i
popoli delle loro ricchezze e a utilizzarli come braccia da lavoro a basso
costo, neri che siano o “mezzi neri” com’erano classificati i meridionali. A tal
fine si impegnano veri e propri plotoni di esecuzione “intellettuali”,
giornalisti, filosofi, storici che, falsificando informazione, sapere e storia,
devono diffondere nel popolo inconsapevole il comodo pregiudizio di superiorità
della propria razza sulla presunta razza inferiore. Ci riescono puntando sullo
spirito da “caporali” piuttosto che da uomini, ampiamente imperante. E Pino
Aprile, che tutti conosciamo come giornalista e scrittore, principale demolitore
del pregiudizio antimeridionale, nel suo appena uscito e già bestseller, “Il
male del Nord”, pubblicato dal nuovo editore “Pienogiorno”, facendo un’analisi
spietata delle cause che affondano questo paese, definisce la “Questione
meridionale” come una questione razzista, con tutte le conseguenze che
discendono da tale trattamento riservato agli “inferiori”. Insulti, derisione,
spallucce, ammiccamenti, sì ma più di tutto impoverimento del Sud,
disoccupazione, mancanza di servizi e quant’altro deve convincere il meridionale
ad emigrare al nord per lavorare, pur se disprezzato, per poi rifarsi con le
successive generazioni una verginità “padana”, magari leghista, per essere
accettato nell’ambiente in cui vive. Nord in cui, per scelta politica della
cattiva unità d’Italia, è stata concentrata l’industria e la finanza italiana, a
danno ed esclusione dell’intero Paese, determinando urbanizzazione forzata e
inquinamento d’ogni genere, lasciando nell’abbandono altri territori in cui si
poteva sviluppare un’economia sostenibile. E’ nelle aree di massima
concentrazione che si è maggiormente diffuso il virus nel mondo, piuttosto che
in quelle scarsamente antropizzate, mostrando il fallimento del modello
capitalistico ultraliberista, creatore di tali diseguaglianze e iniquità.
Fallimento che fa emergere la necessità del cambiamento: ripartire da Sud per
salvare questo Paese disunito, ultimo in Europa per crescita economica, in virtù
della esclusione di oltre un terzo della sua popolazione dai piani di sviluppo e
dalla possibilità di crescita economica, danno che si ripercuote sull’intera
economia nazionale. L’Italia è un uomo che cammina con una sola gamba, usando
l’altra come carne da macello, è un treno munito di una locomotiva che non può
correre perché deve trainare vagoni malandati. Locomotiva man mano sfiatata,
come ci segnala Pino Aprile, enumerandoci la svendita alle multinazionali
straniere delle grandi aziende del Nord, un Nord che ormai vive in modo
parassitario “assorbendo le risorse del Paese, senza nulla restituire”, secondo
la definizione del ministro per il Mezzogiorno Provenzano. I grandi cambiamenti
sociali, avverte Pino Aprile, non procedono con casualità ma per sbalzi e
catastrofi. E, a quanto pare, la catastrofica epidemia da covid convince strati
sempre più ampi di cittadini della necessità di cambiare l’attuale modello di
sviluppo fondato sulla disuguaglianza territoriale. Catastrofe epidemica più che
altro evidente in Lombardia, cuore del Nord, dove ha trovato condizioni ideali
per riprodursi. Non solo per via delle cattive condizioni ambientali, ma anche e
soprattutto a causa delle pessime condizioni politiche. Non data certo da oggi
la cattiva amministrazione della sanità lombarda, definita eufemisticamente
“eccellenza” e “top”, certo non lo è stata nella sciagurata privatizzazione
della sanità pubblica, non lo è stata nella distribuzione di tangenti che vede
che vede il “celeste” Formigoni condannato ad anni di galera, non lo è nella
creazione dell’ospedale in fiera con 21 milioni di euro spesi per 25 posti
letto, come non lo è nella mancata creazione di zone rosse e nello scaricare i
malati di covid nelle case di riposo degli anziani, facendone strage. Ora il re
è nudo, ma lo era già dagli anni delle Tangentopoli uno, due e seguenti, lo era
negli anni della corruzione miliardaria sulla costruzione dell’alta velocità
ferroviaria, al Nord costata 67 milioni al Km, a fronte dei 10 milioni in
Francia, lo era negli sprechi miliardari dell’expo e di altre infrastrutture
utili più a far mangiare i “prenditori” che a far muovere i lombardi. Eppure, la
forza mediatica, concentrata al Nord, ha lasciato credere che il male del Paese
fosse il povero Sud, pur rovinato dalle mafie, con le quali pezzi dello Stato e
finanza del Nord andavano a braccetto.
L’EMERGENZA NAZIONALE E’ IL SUD, ALTRO CHE “QUESTIONE
SETTENTRIONALE”. Raffaele Vescera il
22.06.2020 Movimento24 agosto.it.. Di Enzo Lionetti. Negli ultimi 17 anni, lo
Stato italiano ha tolto 840 miliardi di euro dalle regioni meridionali e li ha
assegnati al Nord ricco e opulento. Nell'ultima legge finanziaria pre-covid, per
le Olimpiadi di Milano-Cortina è stato stanziato 1 miliardo di euro e per la
seconda linea metropolitana di Torino sono stati stanziati 800 milioni di euro.
E' sempre in corso di approvazione lo stanziamento per il TAV Torino - Lione che
ammonta a 10-12 miliardi di euro. Senza dimenticare l'autostrada BREBEMI e la
Pedemontana Veneta. E come non citare il famoso caso storico del MOSE di
Venezia, voragine dello Stato italiano che costa dai 4 ai 6 miliardi di euro,
affidati in maniera grottesca ad un Consorzio privato, senza un minimo di
procedura di evidenza pubblica. Gli stanziamenti per la sanità pubblica e per i
servizi di assistenza sociale sono da decenni a favore del Nord Italia. Al
capitalismo del Nord Italia piace vincere facile. Con i soldi dello Stato
italiano si produce e si guadagna. E questo modello di riferimento, che ha
funzionato e per questo è stato replicato nel corso del tempo in maniera sempre
più crescente, ha visto la complicità di partiti come la Democrazia Cristiana,
come il Partito Comunista negli anni sessanta e settanta, con il Partito
Socialista negli anni ottanta dello scorso secolo. L'evoluzione del modello è
arrivata con la discesa in campo di Berlusconi e della Lega Nord, simboli di un
capitalismo arrembante e di una barbarie culturale e politica, a cui il salotto
buono di Piazzetta Cuccia a Milano e di Viale dell'Astronomia a Roma non hanno
saputo resistere. In molti casi non hanno voluto resistere. Il modello della
Questione settentrionale fondato sul razzismo nei confronti della Popolazione
meridionale per affermare le ragioni della supposta superiorità del sistema
industriale settentrionale, alla ricerca di continue fonti di approvvigionamento
pubblico per mantenere la propria sopravvivenza, ha determinato un tale
sconquasso di proporzioni inimmaginabili, portando il PIL dell’Italia a valori
miseri nei confronti dei competitor mondiali, lasciando una parte del Paese
nell’arretratezza economica. Questo modello non ha più ragion d’essere, non ce
lo possiamo permettere, il sistema Italia non se lo può permettere più. Non ha
senso un’Italia duale, non ha senso infrastrutturare una sola parte dell’Italia
già di per sé ricca, con iniziative ridondanti ed a bassissimo se non nullo
effetto moltiplicatore, anzi foriero di un consumo di suolo e di
un’industrializzazione selvaggia che ha determinato e determinerà sempre più
condizioni di disequilibrio ambientale, di inefficienza e di forti tensioni. La
Questione meridionale si pone come elemento di forte attualità in quanto
applicazione del principio di Equità sancito in Costituzione. I padri
costituenti hanno lasciato un’eredità disattesa, violentata da logiche
partitocratiche saldate da un becero capitalismo, che occorre riprendere e
valorizzare, perché frutto di un lungo ragionamento in Assemblea Costituente che
cementò le istanze territoriali alle giuste rivendicazioni sociali e culturali.
Un lavoro lungo ben 16 mesi, da giugno 1946 a dicembre 1947, in cui una volontà
di riscatto, di rinascita, di rivendicazioni morali e culturali, diede vita ad
un favoloso equilibrio istituzionale e di elementi programmatici per il futuro
del Paese. La Questione Meridionale è il vero anello di congiunzione tra
l’esigenza di apprestare un futuro sviluppo equilibrato ed armonico tra aree
territoriali, di riconquistare un ruolo nel panorama internazionale e di dare
opportunità di libera espressione imprenditoriale, sociale e culturale ad un
territorio, la parte meridionale della penisola italiana ed insulare, fin troppo
bistrattata artatamente ed in maniera beffarda da un sistema
politico-imprenditoriale egoista. Vediamo i risultati che la Questione
settentrionale ha portato. Sulla base di questi risultati analizziamo la
convenienza a ripercorrere un processo di decisioni pubbliche che vede il Nord
in prima fila ed il Sud “a traino” del sistema imprenditoriale nordcentrico. Il
risultato è fallimentare, è inadeguato, è inefficiente, è insulso e retrogrado.
Nel ventesimo secolo ha potuto avere spazio per un
annicchilimento della classe dirigente politica e sociale.
Nel ventunesimo secolo gli spazi di manovra si sono ridotti
ampiamente, la mobilitazione culturale e sociale, oltre che ampi strati di
sistema imprenditoriale, pongono la Questione Meridionale come unica ed
irrinunciabile strategia di azzeramento del divario Nord/Sud, di recupero di una
dignità offesa e di valorizzazione delle risorse presenti nel Meridione
d’Italia.
Solo con forti investimenti in infrastrutture necessarie al
Meridione, il moltiplicatore degli investimenti pubblici può esercitare la sua
funzione di propagazione di effetti positivi nel sistema economico e sociale, in
quanto va ad aumentare l’efficienza e la produttività unitamente
all’innalzamento dei livelli di prestazione sociale che uno Stato moderno ed
efficiente deve perseguire, nel solco degli auspici dei nostri Padri Costituenti
e prefigurati da grandi Economisti come Salvemini o Caffè. Solo con una forte
azione statale di contrasto all’inefficienza e di ampio controllo della spesa
pubblica, possono determinarsi le condizioni idonee allo sviluppo dei territori
meridionali, grazie ad un rinnovato spirito collettivo di Giustizia e Legalità
che sta pervadendo il tessuto connettivo sociale e culturale meridionale,
purtroppo sulla scorta di tragedie collettive come quelle di Falcone e
Borsellino o con l’opera di egregi ed inossidabili uomini di Stato come Nicola
Gratteri e Nino Di Matteo. O con l’abbattimento delle Vele di Scampia, simbolo
di una politica miope di ghettizzazione di ampi strati sociali in quartieri
monstre che il grande Pasolini aveva già denunciato. Il Sud ha voltato pagina.
Le Vele di Scampia sono state demolite. La nuova Questione Meridionale è
l’emergenza nazionale e l’occasione di riscatto di un intero Popolo, che vuole
continuare ad essere unito ma nel rispetto delle reciproche prerogative di
sviluppo ed equità. Lungamente dimenticato e sacrificato sugli altari di un neo
colonialismo capitalistico, bistrattato ed oltraggiato per mano di scribacchini
e per bocca da insulsi politicanti entrambi pagati con le tasse di tutti gli
Italiani, il Sud si appresta a vivere il momento più decisivo della sua Storia.
La sua lunga tradizione di Popolo pacifico ed operoso, culminata nel periodo
dorato ottocentesco del Regno delle Due Sicilie che lo ha portato a divenire la
terza potenza economica europea, dove a Pietrarsa e Mongiana, rispettivamente
Campania e Calabria, erano presenti i due più importanti stabilimenti
siderurgici dell'intera penisola e tra i più grandi in Europa, con migliaia di
addetti, che distanziavano notevolmente gli addetti di Genova della nascente
Ansaldo. Meccanica pesante e di precisione, costruzioni ferroviarie e industria
energetica erano già allora uno dei settori più importanti dell'economia
meridionale. L'unità d'Italia ha provveduto a distruggere il sistema economico
della parte meridionale della penisola italiana, nel nome di una precisa volontà
politica di distruggere tutto ciò che era riconducibile alla famiglia reale dei
Borbone, visti come antagonisti della famiglia reale dei Savoia e quindi da
annientare non solo fisicamente ma anche e soprattutto culturalmente. La
Questione Meridionale parte in quegli anni, suggellata dal radicale lombardo
Antonio Billia, per confezionare la più grande fake news di tutti i tempi,
ovvero dipingere il Regno delle Due Sicilie come il male assoluto ed il luogo
dell'arretratezza economica e sociale, il luogo del malaffare e della
dissolutezza, il luogo della pedante burocrazia borbonica. Il Mezzogiorno,
nell'accezione costituzionale repubblicana, è stato visto come luogo di scambio,
ovvero assistenza versus consenso politico, in cui le industrie di costruzione
del Nord hanno fatto affari d'oro con la Cassa del Mezzogiorno, sottopagando gli
operai con subappalti da miseria, finanziando le Mafie, la Camorra e la
'Ndrangheta per ottenere chissà quali protezioni, ma sempre a spese dello Stato
con revisione dei prezzi e varianti in corso d'opera che hanno portato a costi
esorbitanti le opere pubbliche meridionali. Ma l'elemento distintivo del
capitalismo italiano, prettamente radicato a Nord, è caratterizzato da un
elemento distintivo pregnante, il ricorso al contributo dello Stato italiano che
si è sempre prestato nel concedere indennizzi, elargizioni e grandi appalti
pubblici. L'industrializzazione del Nord Italia avvenuta con il Piano Marshall
ed in seguito con la grande opera di infrastrutturazione del territorio, ha
generato una redditività enorme nelle famiglie capitalistiche, alle spalle di
uno Stato italiano sempre pronto ad approvare leggi di favore e concedere
posizioni di vantaggio alle regione settentrionali. Questo succede anche oggi.
Lo Stato italiano pensa solo al Nord concedendo benefici e contributi senza un
minimo di rendiconto sociale nei confronti dell'intera nazione italiana.
·
Il metodo della “Spesa Storica”. Il ladrocinio degli evasori.
Sorpresa: il Nord si prende la gran parte dei soldi pubblici.
Infrastrutture, 20 anni di spesa iniqua.
Nord batte Sud 139 a 51: Suicidio Italia. Il Paese ha del tutto
abbandonato il giacimento di crescita potenziale che si trova sotto il
Garigliano. Fabrizio Galimberti su Il Quotidiano del Sud il 14 dicembre 2020.
«Datemi una leva e vi solleverò il mondo», disse Archimede. Più modestamente,
quella parte d’Italia in cui visse Archimede potrebbe dire: «Datemi le
infrastrutture e solleverò il tasso di crescita». Chissà se il solito proverbio
cinese – «Se volete creare ricchezza costruite una strada» – data da prima o da
dopo Archimede, ma ambedue i detti esprimono lo stesso concetto: le
infrastrutture sono una precondizione per la crescita. Il recente rapporto della
Svimez si china, in uno dei più pregnanti capitoli, sul divario infrastrutturale
fra Nord e Sud del Paese. La tabella sulla “Dotazione di infrastrutture
terrestri” presenta un confronto fra quelle dotazioni nell’Europa a 15 e
l’Italia, declinata, quest’ultima, per regioni meridionali e per grandi
ripartizioni territoriali. Le infrastrutture terrestri (quantificate in rapporto
alla popolazione) riguardano i trasporti, essenzialmente strade e ferrovie.
LA FOTOGRAFIA. La tabella fotografa la situazione a due date:
1990 e 2017. Gli indici non sono assoluti, ma relativi: cioè a dire, nelle due
date l’Europa a 15 viene fatta eguale a 100, e l’Italia e le regioni sono
parametrate ai valori medi europei. Come si vede, per le autostrade nel 1990
l’Italia era sulla media europea, e il Mezzogiorno, se pure con un indice
inferiore a quello del Centro-Nord, non sfigurava. Ma con l’andar del tempo il
“doppio dualismo” di cui abbiamo già parlato – Italia/Europa e
Centro-Nord/Mezzogiorno – ha colpito ancora. La posizione relativa dell’Italia è
scesa di molto, a quota 72, ma è scesa ancora di più quella del Sud rispetto al
Nord (in queste analisi useremo indifferentemente “Nord” per “Centro-Nord” (C/N)
e “Sud” per “Mezzogiorno”). Per quanto riguarda le ferrovie, l’Italia anche qui
era sulla media europea per l’elettrificazione nel 1990, ma, come i polli di
Trilussa, quel valore medio di 101 era composto di un 118 per il C/N e di un 71
per il Sud. Comunque, passando al 2017, l’Italia è scesa rispetto all’Europa
(dualismo esterno…) ed è continuato, seppure un po’ ridotto, il dualismo
interno. Là dove il confronto si fa più interessante (o desolante) sta nel
comparto ferroviario dell’Alta Velocità (AV). Nel 1990 l’Italia del C/N aveva un
indice perfino superiore a quello europeo (121), ma, a livello della penisola
intera, l’indice scendeva a 77, grazie allo 0 (zero) del Mezzogiorno. Da allora
le cose sono migliorate per l’Italia e nel 2017 l’indice, rispetto all’Europa,
sale da 77 a 93, ma il C/N batte il Mezzogiorno 125 a 34. Le infrastrutture
fisiche, comunque, non sono solo quelle dei trasporti. Se guardiamo all’intero
comparto delle opere pubbliche, abbiamo dati più recenti, aggiornati al 2019. Il
grafico spazia su mezzo secolo, dal 1970 al 2019, e le cifre (in volume, milioni
di euro a prezzi costanti del 2010) descrivono, anche qui, desolanti
traiettorie. Un’osservazione si impone: fin verso il 1990, i fondi spesi per le
opere pubbliche, al Nord e al Sud, non erano molto differenti (anzi, in euro per
abitante, erano più elevati al Sud). Ma dal 1990 in poi si assiste a una
divaricazione; e, guarda caso, è proprio quello il momento in cui inizia la
stagnazione italiana e va crescendo il divario con l’Europa. È come se l’Italia
avesse rinunciato a sfruttare quel giacimento di crescita potenziale che si
trova sotto al Garigliano e così facendo, governo e Parlamento avessero
trasformato il Mezzogiorno in una palla al piede della crescita italiana.
HARAKIRI ECONOMICO. Gli ultimi dati, al 2019, danno, per il Sud –
un’area dove vive il 34% della popolazione – un livello di spesa in opere
pubbliche pari al 19% del totale. Un’interessante analisi degli stadi di
avanzamento per gli investimenti pubblici conclude che «le opere non prioritarie
(cioè non sottoposte ad approvazione del Cipe) presentano uno stato di
avanzamento relativamente migliore, un aspetto che evidenzia il “peso” del Cipe
(con tutti i vari passaggi impliciti, tra Ministeri e Corte dei conti) sul
processo decisionale e di avanzamento programmatico». Torna, insomma, il
problema dei lacci e lacciuoli, delle competenze concorrenti, dei passaggi
burocratici, delle minuzie regolamentari che tanto hanno fatto per impastoiare
la crescita della penisola. Una meritoria elaborazione della Svimez costruisce
un indice sintetico della dotazione infrastrutturale complessiva, che viene
elaborato per le singole ragioni meridionali, oltre che per le ripartizioni
(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole). Il proverbio cinese citato
all’inizio (“Se volete creare ricchezza, costruite una strada”) si potrebbe
declinare in “Se volete creare ricchezza, costruite una strada, una ferrovia, un
porto, un aeroporto, un interporto, un terminale intermodale…”. E tutte queste
reti e questi nodi sono stati collassati in un indice impietoso (vedi tabella):
facendo l’Italia = 100, il Centro/Nord è a quota 139,6 e il Mezzogiorno a 51,1.
Questa non è solo un’ingiustizia; è anche un suicidio economico per l’Italia
tutta.
La propaganda di Stato umilia il Sud: dal Governo solo
promesse e inganni. Ercole Incalza su Il Quotidiano
del Sud il 30 ottobre 2020. In passato il bombardamento di annunci poco
veritieri da parte di chi ricopriva ruoli importanti nel governo del Paese erano
meno virulenti e, quasi sempre, trovavano una immediata denuncia da parte di
coloro che erano alla opposizione o ricoprivano ruoli chiave nel mondo del
sindacato o in quello della informazione.
PROPAGANDA DI STATO. Da almeno due anni assistiamo a sistematiche
dichiarazioni, a quasi giornalieri annunci che, a mio avviso, si configurano
come una vera “propaganda di Stato” e come tale sarebbe opportuno invocare la
stessa norma prevista per la “pubblicità ingannevole”; sì, quella norma che
colpisce chi, con un messaggio falsato e distorto, esalta delle qualità che il
prodotto non possiede, ingannando il consumatore. Secondo l’ordinamento
giuridico italiano la pubblicità ingannevole è «qualsiasi pubblicità che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore
le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che,
a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento
economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente»
(Decreto legislativo 145/2007). Ebbene, per motivare il mio sconcerto e per
poter giustificare questo riferimento alla “pubblicità ingannevole” riporto
alcune dichiarazioni prodotte da personalità che attualmente ricoprono delle
cariche di elevata responsabilità come, solo a titolo di esempio, la ministra De
Micheli, il ministro Gualtieri o, addirittura, il presidente del Consiglio.
L’ELENCO DEGLI INGANNI. Entro la fine del 2020 disporremo di un
vaccino contro il Covid 19. Poi scopriamo che nel migliore dei casi il vaccino
sarà disponibile nel secondo semestre del 2021. Il Trasporto pubblico locale è
sicuro. Poi scopriamo che è sul banco degli imputati per essere sospettato di
alimentare in modo virulento il Covid; poi scopriamo che i mezzi di trasporto
usati hanno ancora una occupazione fino all’80 per cento, numero che deriva da
criteri di omologazione dei mezzi per i quali l’80 per cento di occupazione
degli spazi consente la presenza di 5 persone per metro quadrato, mentre i
servizi ferroviari di lunga distanza Freccia Bianca e Freccia Rossa rimangono
con tassi di occupazione pari al 50 per cento, mettendo in crisi sia Italo che
Trenitalia e generando la più grande forma di discriminazione nell’erogazione
dei livelli di servizio ferroviario che la Repubblica italiana ricordi. Il
Programma Italia Veloce, che contiene un elenco di opere infrastrutturali, ha un
costo globale di circa 200 miliardi di euro, di cui 130 sono già disponibili.
Poi abbiamo appreso che le disponibilità non superavano, nell’arco del triennio
2020-2022 i 6 miliardi di euro. Entro la fine del corrente anno potremo disporre
di un venti per cento della quota che è stata destinata all’Italia dal Recovery
Fund. Poi abbiamo scoperto che il Recovery Fund era semplicemente una
aspirazione e che per difficoltà nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento
europeo non sarebbe stato possibile disporre del Recovery Fund prima della
seconda metà del 2021; sempre se il Parlamento europeo riuscirà ad approvare
tale proposta. Abbiamo stanziato e resi disponibili per gli investimenti
nell’anno 2020 ben 19,7 miliardi di euro. Poi scopriamo, come ho già ricordato
in un precedente blog, che tali risorse dopo dieci mesi non sono ancora state
rese disponibili e ancora che la quota assegnata alle infrastrutture ammonta a
6.091 milioni di euro e che inoltre nel triennio 2020- 2022 sono erogabili
solamente 1.730 milioni di euro (356 milioni nel 2020, 668 milioni nel 2021 e
774 milioni nel 2022). Il terzo trimestre del 2020 ha visto una forte crescita
del Prodotto interno lordo e, addirittura, entro il 2021, massimo il 2022
torneremo ai valori del Pil prima del Covid 19. Poi, però, scopriamo che tra
l’inizio e la fine del 2020 la Piccole e Medie Imprese potrebbero perdere un
milione di posti di lavoro. Arcelor Mittal ha pagato tutte le imprese
dell’indotto del centro siderurgico di Taranto ed è in fase conclusiva
l’ingresso di Invitalia nella Società. Poi scopriamo che Arcelor Mittal non ha
ancora chiuso nessun accordo con Invitalia e che ha chiesto la Cassa
integrazione speciale per altre 13 settimane, ha chiesto una proroga di una
Cassa integrazione speciale (Cigs) che dura dal mese di luglio del 2019. E per
quanto riguarda i pagamenti delle imprese dell’indotto abbiamo appreso che i
pagamenti di tali attività sono piuttosto critici e che i tempi di attesa
superano i 150 giorni. Entro il 30 dicembre 2019 sarà disponibile il nuovo
Regolamento unico del codice dei contratti nel comparto delle opere pubbliche.
Poi scopriamo che pur se tale provvedimento, secondo il decreto Sblocca
cantieri, sarebbe stato disponibile entro dicembre 2019, in realtà il nuovo
Regolamento probabilmente vedrà la luce non prima della fine del 2020. Questo
nonostante, come ripeto spesso, i lavori pubblici siano fermi al palo da almeno
cinque anni a causa di un Codice appalti assolutamente folle e indifendibile. Il
governo si impegna a realizzare e ad inserire nel Recovery Plan l’alta velocità
ferroviaria da Salerno fino a Reggio Calabria-Messina e Palermo e come tale non
ci sono più pregiudiziali per la realizzazione del ponte sullo Stretto; sarebbe
infatti un non senso realizzare un asse ferroviario veloce senza prevedere un
collegamento stabile. Poi scopriamo che il ministro dell’Economia e delle
finanze rilascia questa dichiarazione: «Siccome dubito che costruiremo il ponte
di Messina nei prossimi cinque anni, per me il dibattito può continuare ma non
dovrà essere collegato al Recovery Plan». Ogni futura iniziativa programmatica
legata agli investimenti in infrastrutture contemplerà risorse finanziarie
destinate al Mezzogiorno pari alla quota del 34% e, in particolare, nel Recovery
Plan in corso di definizione tale soglia potrà addirittura superare il 40 – 45
per cento. Poi scopriamo, anche alla luce delle linee guida per la definizione
del Recovery Plan prodotte dal governo, che per il Centro Nord sono pronte opere
per oltre 70 miliardi di euro, mentre per il Mezzogiorno l’importo non supera i
6 miliardi di euro.
CREDIBILITÀ MINATA. Potrei continuare nella triste elencazione di
annunci che, mese dopo mese, incrinano la credibilità di chi attualmente è
preposto alla gestione del Paese, e non è la mia una boutade quella di ricercare
davvero un garante, un certificatore sistematico delle dichiarazioni, ormai
giornaliere, su interpretazioni della realtà e su prospettazioni di un futuro
prossimo che poi, nei fatti, diventa sempre più un futuro lontano o,
addirittura, il nulla. In particolare sarebbe bene che almeno per il Sud il
governo evitasse questo comportamento offensivo per una realtà territoriale che
partecipa alla formazione del Pil del Paese, ma che utilizza limitati benefici
diretti o indiretti dalla sua crescita. Voglio solo ricordare, per pura e banale
informazione, che i cittadini del Sud hanno difeso sempre la realizzazione dei
valichi come il Brennero e il Frejus, perché convinti che tali opere fossero il
cordone ombelicale che legava l’intero Paese all’Europa. Finora, però, non ho
letto una sola frase a difesa della realizzazione del ponte sullo Stretto di
Messina da parte di chi vive nel Centro Nord: eppure il ponte è, a tutti gli
effetti, un cordone ombelicale essenziale per l’economia del Paese, è il terzo
grado di libertà che oggi l’isola, per quanto concerne la mobilità, non
possiede, è la condizione per cui si motivi davvero una rete ferroviaria
efficiente e veloce nell’isola. Sì, lo so, i miei sono sfoghi inutili perché il
ministro Gualtieri ha detto no.
Divario Nord-Sud, anche gli industriali corrono a due
velocità. Ciriaco M. Viggiano su Il Riformista il 15
Ottobre 2020. C’è poco da fare, tenere insieme il Nord e il Sud dell’Italia è
una missione quasi impossibile. Ne sanno qualcosa quei partiti che sfondano
nelle regioni settentrionali e non al Mezzogiorno (vedi la Lega) oppure
viceversa (vedi il Movimento 5 Stelle). Questa difficoltà sembra comune anche
agli imprenditori, stando a quanto emerge dalle recenti dichiarazioni di Carlo
Bonomi, presidente nazionale di Confindustria, e di Maurizio Manfellotto, numero
uno degli industriali napoletani. Del primo è ben nota l’avversione per
il “Sussidistan”, cioè quella giungla di bonus, sussidi e denaro a pioggia in
cui l’Italia rischia di trasformarsi, a cominciare dal Sud. Il secondo ha appena
presentato programma e squadra di governo, chiarendo come il rilancio del
Mezzogiorno costituisca «un pilastro fondamentale per la crescita dell’intero
Paese». Il dualismo sembra evidente e richiama alla memoria le dinamiche interne
a molti partiti. Prendiamo il caso della Lega: vuoi per la mancanza di una
classe dirigente già solida e strutturata, vuoi per le origini
antimeridionaliste, alle ultime regionali il partito di Salvini ha registrato
una battuta d’arresto al Sud. Segno della difficoltà di accreditarsi come forza
politica nazionale con un programma nazionale. Ma la Lega non è l’unica
compagine a vivere una simile contraddizione. Il M5S, per esempio, riscuote più
consensi al Sud che non al Nord. E lo stesso Partito democratico, al suo
interno, accoglie diverse declinazioni del regionalismo.
Anche Confindustria sembra trovare difficoltà nell’individuare una strategia
condivisa. L’obiettivo sembrava più alla portata quando al vertice
dell’associazione c’erano meridionali come Antonio D’Amato e Vincenzo Boccia e,
soprattutto, quando il Covid non aveva ancora messo in crisi l’economia. Ora che
il gruppo degli industriali è a trazione nordista, le divergenze sembrano
esplodere soprattutto su alcuni temi. Il primo? Gli aiuti dello Stato. Bonomi,
per esempio, è contrario ai bonus a pioggia. Questa avversione non si percepisce
nel programma presentato da Manfellotto, dove manca il rifiuto degli aiuti
statali e si ribadisce l’importanza tanto della riserva di spesa del 34% a
favore del Mezzogiorno quanto delle risorse straordinarie messe a disposizione
dall’Europa tramite il Recovery Fund. Altro tema cruciale è quello della
legalità. In occasione dell’assemblea degli industriali di Cremona, Bonomi è
stato chiaro: «Se non si risolve il tema della legalità, non arriveranno gli
investimenti al Sud». Nel merito, l’affermazione è discutibile perché dà l’idea
che le infiltrazioni criminali nell’economia affliggano solo il Mezzogiorno e
non anche il Nord; in più, il problema dell’illegalità si supera proprio
attraverso gli investimenti, cioè creando occasioni di lavoro e di sviluppo, non
solo assecondando le spinte repressive. Al netto di queste considerazioni, però,
è singolare il fatto che Manfellotto, nel testo di presentazione del suo
programma, citi solo incidentalmente il tema della legalità, limitandosi a
sottolineare l’urgenza di riforme che garantiscano la trasparenza degli appalti
pubblici e contrastino l’evasione fiscale. Insomma, le contraddizioni sono
evidenti e rischiano, oltre che di screditare la comunità economica, di
ostacolare la definizione di una politica nazionale che tuteli il Nord, pur
sempre locomotiva del Paese, e nello stesso tempo dia una spinta forte al Sud,
senza l’apporto del quale l’Italia intera resterà ferma al palo. E questo
nessuno se lo può permettere.
Schiena lucida e schiavitù. Cioè il Sud.
Gioacchino Criaco su Il Riformista il 20 Luglio 2020. - “Ti
scriverò” disse lui. Lei si sedette sul bordo del letto e i suoi sei figli, di
sposa bambina, le si cinsero intorno come un cerchio di fate. Lui spinse dentro
gli ultimi panni e chiuse a forza la lampo della valigia di plastica morbida,
maleodorante di petrolio. “Ti scriverò”, disse ancora, e andò via a testa bassa.
Lei si sciolse la corona corvina, i lunghi capelli coprirono le spalle e il
petto e gli occhi scaricarono un temporale di lacrime.- L’emigrazione era un
lutto, e le corone o le trecce delle spose e madri del Sud si scioglievano solo
per il dolore. In quel Sud, l’ultima operazione di poche ore fa,
fra Calabria e Basilicata, ha contato 52 misure cautelari per contrastare
il caporalato che ha per vittime esseri umani che arrivano da un Sud che sta più
giù di questo. E noi che nel Sud ci viviamo, lo sappiamo dei tuguri e degli
accampamenti in cui i migranti vengono costretti, ci vediamo superati a ogni ora
dai furgoni carichi all’inverosimile di lavoratori stranieri. Li incontriamo i
ragazzi indiani, le volte che ci svegliamo all’alba, correre più che camminare
per raggiungere i loro luoghi di pena, avvolti nei turbanti colorati che li
salvano dalle macchine, schivati all’ultimo, e al tramonto scorgiamo il bianco
degli occhi dei ragazzi di colore che finiscono la fatica su vecchie bici che si
mangiano il margine di carreggiate striminzite, ai bordi di disastrate statali.
Il Sud è una terra di schiavi, in cui le tendopoli di Rosarno sono la regola e i
sogni di Riace vengono fatti sparire al sorgere del sole. Il Sud sono le schiene
lucide, piegate a raccogliere ortaggi, le mani allungate all’inverosimile a
raggiungere frutti. Delizie che arriveranno su tavole lontane, profumate per
celare la puzza che le produce. Il Sud è una terra di nuovi schiavi, giunti a
sostituire quelli scappati. Una storia che si ripete, che nessuno ha davvero
voglia di interrompere. Basta farsi un giro fra i campi, fra le tende, tendere
agguati, all’alba e al tramonto, lungo le strade. -A sei anni capii la
partenza, il distacco. Smisi di essere bambino e soffrii tanto da non volerlo
fare più. “Ti scriverò” disse mio padre andando via, con quei suoi ricci in
testa da marocchino. Era ottobre e per dicembre avevo imparato a leggere. La
lettera che arrivò a Natale la rubai di nascosto e la lessi sotto il nespolo
dell’orto. Seppi cos’era la lontananza, la nostalgia, la solitudine, la
condizione di un emigrato -.
Lo scippo al Sud non si ferma più: dirottati al Nord altri
64,5 miliardi. Fabrizio Galimberti il 2 settembre 2020
su Il Quotidiano del Sud. Da un anno e mezzo questo giornale batte, come la
goccia che scava la pietra, su un fatto semplice e iniquo: lo Stato italiano,
che dovrebbe favorire la coesione sociale e alleviare il disagio delle regioni
meno sviluppate, ha pervicacemente fatto il contrario. La spesa pubblica è
andata spargendosi nel territorio in modo da favorire le regioni più ricche e
sfavorire quelle più povere. Senza scomodare il Vangelo, basta guardare
all’Articolo 2 della Costituzione, che statuisce come «La Repubblica… richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale».
QUALE SOLIDARIETÀ. Come può esistere solidarietà quando in una
metà della penisola (il Meridione) il reddito per abitante è poco più della metà
rispetto a quello del Centro-Nord? E c’è da chiedersi perché sia rimasta lettera
morta la disposizione di cui all’articolo 119, secondo cui lo Stato «istituisce
un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». E non basta:
«Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni». Ma le regioni ricche non hanno mai voluto i fondi
perequativi. Per forzare la situazione furono creati i Lep, i Livelli essenziali
di prestazioni. Se si vuole dare “pari dignità” ai cittadini, bisogna che i
servizi pubblici assicurino a tutti un minimo essenziale (per esempio, in
termini di letti di ospedale, addetti ai servizi sanitari, metri quadrati di
spazio scolastico, posti in asili nido… il tutto espresso per 100mila abitanti).
LO SCANDALO DEI LEP. Torna a onore del legislatore di aver
legiferato, almeno dieci anni fa, questi Lep; e torna a disonore di Parlamenti e
governi il fatto di non averli mai realmente introdotti da dieci anni a questa
parte. A livello di Comuni c’è un pallido e parziale rimedio all’assenza dei
Lep, il Fondo di perequazione. Ma a livello regionale non c’è niente. E, in
assenza dei Lep, si è continuato a usare la “spesa storica” per erogare le
risorse: prendendo cioè a base di partenza una situazione iniqua, si continua ad
allargare il solco fra Nord e Sud. Si crea un circolo vizioso: le minori risorse
destinate al Sud indeboliscono l’economia e questa debolezza lascia spazio a
corruzione e criminalità organizzata. Questi secolari difetti vengono presi ad
argomento per giustificare la minore spesa pubblica per il Mezzogiorno: tanto,
poi quei soldi sono spesi male… Per uscire da questa triste situazione bisogna
cominciare col definire i Lep: questa è la base dell’edificio per una vera
coesione territoriale. Ecco una prima linea di azione per il Piano di riforme
che l’Europa chiede all’Italia. Naturalmente, è normale che l’economia e il
benessere delle diverse aree del Paese siano diversi, riflettendo la dotazione
di risorse naturali, il diverso capitale umano e fisico, i diversi fattori
culturali che determinano il grado di sviluppo economico. Non si potrà mai avere
un totale livellamento fra regioni ricche e meno ricche, un certo grado di
dislivello è fisiologico e perfino desiderabile. Ma quando le differenze sono
troppo grandi, è ugualmente desiderabile che lo Stato intervenga per assicurare
un maggiore grado di coesione.
DIVARIO ALLARGATO. Il problema, che è venuto alla luce con le
analisi dei Conti pubblici territoriali (Cpt), sta nel fatto che l’intervento
dello Stato è andato in senso esattamente contrario: come detto sopra, ha
esacerbato le differenze, invece di ridurle. Tutto questo è stato ripetutamente
cifrato, ricorrendo alle meritorie analisi dei Cpt. Quando i dati erano
disponibili solo fino al 2017, questo giornale aveva cifrato in circa 60
miliardi le risorse sottratte al Mezzogiorno; una “sottrazione”, questa, che
deriva da un semplice calcolo: basta confrontare le spese pubbliche del Settore
pubblico allargato che vanno al Mezzogiorno con quelle che “dovrebbero” andare
al Mezzogiorno se le spese fossero ripartite in base all’elementare criterio
della quota della popolazione rispetto al totale nazionale.
CALCOLI CERTIFICATI. Ma questo non è successo, ed è stato così
violato il più elementare parametro della redistribuzione territoriale. Quel
semplice confronto faceva emergere, per il 2017, un ammanco di 61,3 miliardi di
euro. Ora sono disponibili le stime per il 2018 e, come si vede dal grafico, la
“sottrazione” è aumentata a 64,5 miliardi. E questo per un solo anno: come si
vede, ogni 12 mesi le risorse sono sottratte al Mezzogiorno all’incirca allo
stesso ritmo, al passo di quel “furto istituzionalizzato” che è il criterio
della spesa storica. E il criterio usato per cifrare l’ammanco è generoso: in
linea di principio, proprio per soddisfare le esigenze di riequilibrio
territoriale, la spesa pubblica dovrebbe andare alle aree disagiate più che in
proporzione alla quota di popolazione. A proposito di spesa pubblica, va
precisata la ragione per cui l’Agenzia per la Coesione territoriale (un ente
pubblico che ha la missione di assicurare la «pari dignità dei cittadini
attraverso lo sviluppo e la coesione in tutti i territori del nostro Paese» e
che costruisce i Cpt) ha scelto la spesa del Settore pubblico allargato (Spa).
Questo comprende, oltre alla Pubblica amministrazione (Pa, cioè Stato, Comuni,
Province, Regioni ed Enti di previdenza), anche le grandi e piccole imprese
pubbliche, incluse le municipalizzate. La ragione di questa scelta sta nel fatto
che lo Stato, per lenire le diseguaglianze territoriali, ha fra i suoi strumenti
anche le imprese pubbliche e in passato sono stati fatti provvedimenti che
imponevano, per esempio, una distribuzione territoriale degli investimenti di
quelle imprese al fine di attenuare le diseguaglianze. La definizione della
spesa del Spa include le partite finanziarie, dato che, ad esempio, anche i
prestiti sono parte di un’erogazione volta ad aiutare i territori. È stato
insomma documentato, con cifre provenienti da istituzioni ufficiali – dall’Istat
all’Agenzia per la coesione, dalla Corte dei conti alla Ragioneria generale –
come dietro alla minorità del Sud non vi siano solo indubbie insufficienze della
classe dirigente, ma vi sia stata una devastante e ingiusta sottrazione di
risorse da parte di quel bilancio pubblico che avrebbe dovuto invece porsi come
primo obiettivo la redistribuzione in favore delle aree più disagiate.
IL FATTORE CRESCITA. Non si tratta solo di una questione di
equità. Si tratta anche, e principalmente, di una questione di crescita. Il
Mezzogiorno è un giacimento di crescita potenziale per un Paese che non cresce.
E il Mezzogiorno non cresce anche, e magari soprattutto, per le documentate
scandalose disparità nella dotazione infrastrutturale del Sud rispetto al resto
dell’Italia (fra le infrastrutture non contiamo solo le opere pubbliche, pur
essenziali, ma anche i servizi pubblici nella loro dimensione di dotazione di
risorse fisiche e umane). L’Italia – bisogna ricordarlo – è un Paese che,
rispetto ad altri, ha più bisogno di (buona) spesa pubblica: per addensamento
demografico, conformazione orografica, dissesto idrogeologico, inquinamento,
conservazione dell’immenso patrimonio archeologico/artistico, dualismo
territoriale, criminalità organizzata… Tutti problemi, questi, che non
abbisognano, per essere risolti, di “reddito di cittadinanza” o di “quota 100”:
abbisognano di investimenti e ancora investimenti. E il Mezzogiorno più che del
resto del Paese. L’Italia non crescerà se non vengono dati al Meridione i mezzi
per sollevarsi da questa storica e iniqua minorità. Il mercato interno del Sud è
la gallina dalle uova d’oro del Nord. La priorità agli investimenti nel
Mezzogiorno è una soluzione win-win per l’Italia intera.
Feltri straparla sul Sud ma lo sa che in 17 anni il
Mezzogiorno ha regalato al Nord 840 miliardi? Antonio
Tisci giovedì 23 aprile 2020 su Il Secolo D'Italia. 840 miliardi di euro in 17
anni, questa la somma che è stata sottratta al Sud per essere destinata alle
altre aree d’Italia, lo hanno denunciato lo Svimez e Eurispes nelle loro ultime
relazioni. 46,7 miliardi di euro ogni anno che si sarebbero dovuti usare per
realizzare opere pubbliche, università, strade, ferrovie nel Mezzogiorno e che
avrebbero costituito uno strumento moltiplicatore per l’occupazione di cui
avrebbe beneficiato l’intera nazione. A queste somme vanno aggiunte le quote dei
fondi FAS utilizzate fuori dal Mezzogiorno, con i soldi per il Sud è stato
ripianato il disavanzo delle Ferrovie dello Stato, sono state realizzati i
trasporti sul lago di Garda e di Como, è stato realizzato l’aeroporto di
Vicenza, sono stati coperti gli sconti della benzina per le regioni vicino alla
frontiera settentrionale, i contratti di servizio con Trenitalia per l’alta
velocità (che al Sud non arriva), l’alta velocità Milano-Verona e Milano-Genova,
la Metropolitana di Bologna, il tunnel del Frejus, la pedemontana Lecco-Bergamo
e il MOSE di Venezia, infine, anche le risorse per il Jobs Act di Renzi sono
state prese dai fondi FAS. Senza voler contare tutta la vicenda legata al Banco
di Napoli con risorse sottratte all’economia meridionale e destinati ad
implementare il fondo Atlante destinato ad operazioni a favore delle banche del
Nord che hanno privato il Sud di qualsiasi istituto di Credito. Insomma, per
anni i fondi destinati al Mezzogiorno sono stati utilizzati in larga parte per
il Nord e non per gli scopi per i quali gli stessi venivano dati all’Italia.
Oggi, mentre tutti i meridionali sono distratti dalle sciocche quanto vacue
parole di Vittorio Feltri, il governo si accinge, secondo le parole del ministro
Provenzano, non solo a ridurre ulteriormente le quote di investimento per il
Mezzogiorno dei fondi ordinari ma anche ad utilizzare il fondi strutturali per
le misure per la ripartenza su tutto il territorio nazionale. Un vero è proprio
scippo ai danni del Mezzogiorno che si vedrebbe negata la possibilità di
accedere alle proprie risorse per poter immaginare la ripartenza dopo la
chiusura imposta dal governo Conte. E’ necessario ribadire con forza che non
soltanto quota 34% deve essere mantenuta e deve essere estesa a tutto il settore
pubblico allargato (compreso le partecipate e le imprese pubbliche) ma deve
essere investita tutta la somma dei fondi strutturali nelle regioni meridionali.
La maggiore libertà di azione nella spesa di questi fondi, infatti, non deve
essere l’occasione per sottrarne ulteriormente al mezzogiorno ma deve essere
l’occasione per dare alle regioni meridionali la libertà di spendere come meglio
credono i soldi che dall’Europa vengono loro destinati, una libertà di azione,
non una modifica di territorialità nella spesa che sarebbe francamente
insopportabile. Il Sud ha la grande occasione di diventare il motore dello
sviluppo per l’Italia e per l’Europa intera, interesse nazionale sarebbe
investire nella zona d’Europa che ha maggiormente dimostrato capacità di
resistere all’epidemia di Covid anche in considerazione della centralità che il
Mediterraneo sta tornando a rivestire negli scambi globali. Dicono che questo
sia il governo con il maggior numero di ministri meridionali della storia ma la
differenza tra classe politica e classe dirigente è una antica lezione di
Gramsci che non è possibile dimenticare e che, se la sottrazione delle risorse
dovesse avvenire nelle intenzioni del governo, dovrebbe vedere la ferma presa di
posizione di tutti i parlamentari e le forze sociali del Mezzogiorno. La
questione meridionale è quanto mai attuale e una classe dirigente meridionale
non può rimanere silente rispetto a quanto sta per avvenire e tutto ciò non
soltanto per un interesse localista ma perché è interesse nazionale sviluppare
il Mezzogiorno allo stesso livello delle altre aree della nazione.
Recovery Fund, il premier Conte dà la priorità al Mezzogiorno
per ricevere i fondi dell'Europa. Libero Quotidiano il
28 luglio 2020. Giuseppe Conte deve decidere gli interventi del Recovery plan.
Lo farà in un vertice questa sera. Alla vigilia ha dato ai ministri due
indicazioni: arrivare con le bozze dei progetti e dedicare un'attenzione
particolare al Sud. "Perché lo sviluppo del Mezzogiorno deve essere una
priorità. Se si rilancia il Sud, riducendo il divario con il Nord, ripartirà
meglio e con più velocità l'intero Paese". Il Mezzogiorno, insomma, diventa il
primo capitolo del Recovery plan che verrà presentato dal governo alla
Commissione europea a metà ottobre. Anche se i soldi l'Europa ce li ha dati per
aiutare le zone più colpite dal coronavirus che in Italia sono state quelle
del Nord. Da Bruxelles, scrive il Messaggero, arriva un'indicazione precisa:
almeno 70 miliardi dovranno andare a colmare gli squilibri territoriali. Nel
Recovery plan non ci sarà spazio però solo per il Sud. Lucia Azzolina, ministra
dell'Istruzione, ritiene che "la scuola può fare un salto di qualità grazie ai
soldi del Recovery Fund, con stanziamenti per l'edilizia scolastica e per
ridurre il numero degli alunni per classe". E Stefano Patuanelli, responsabile
dello Sviluppo, indica tra gli interventi da finanziare "l'innovazione e la
digitalizzazione delle imprese e il rafforzamento del pacchetto 4.0 per arrivare
alla detassazione totale di quello che viene investito in azienda". Il tutto
verrà deciso nella cabina di regia del Recovery plan che altro non è che
il Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae), con sede a palazzo
Chigi e presieduto da Conte.
Vincenzo
De Luca: «Sarebbe uno scandalo intollerabile perseverare con criteri da rapina
al Sud». Carlo Porcaro il 31 luglio 2020 su Il
Quotidiano del Sud. Non usa mezze misure, come suo consueto, il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alla futura distribuzione dei fondi
derivanti dal Recovery Fund. «Per dieci anni la Campania è stata penalizzata, al
di là di ogni decenza istituzionale e di ogni ragionevolezza. Sarebbe uno
scandalo non tollerabile, perseverare con criteri da rapina verso il Sud e la
Campania perfino per l’assegnazione di risorse aggiuntive e straordinarie», ha
detto. «Rapina al Sud» e «scandalo non tollerabile» i due concetti principali
espressi dal governatore campano adesso ricandidato, fortemente intenzionato ad
abbracciare una battaglia anche col suo partito, il Partito democratico, ed il
governo se non verranno rivisti i criteri della spesa storica. Gli stessi che
non si volevano applicare all’autonomia e gli fecero dire: «Il progetto del
governo e del ministro Boccia è di partire dai livelli essenziali delle
prestazioni, cioè da un punto di equità, che è quello che chiede la Regione
Campania: stesse risorse per tutte le regioni e poi un fondo di perequazione per
recuperare il divario tra Nord e Sud».
CONFERENZA? NO, E' DIFFERENZA STATO-REGIONI.
Perchè bisogna abolirla e rifare il Servizio Sanitario Nazionale.
Roberto Napoletano il 31 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud. Bisogna rifare la
prima Cassa del Mezzogiorno, quella di 300 ingegneri che apriva e chiudeva i
cantieri, che non rubò una lira e consentì all’Italia di raddoppiare il prestito
Marshall. Allora vedrete che il Sud avrà i suoi bandi internazionali e i suoi
treni veloci. Altrimenti sono solo chiacchiere. Vorremmo occuparci di quello che
accade non di quello che si dice accadrà. Soprattutto, cerchiamo di spiegare
perché accade l’esatto contrario di quello che si dice e come fare per uscire
non a parole da questa contraddizione. Assistiamo a una nobile gara tra il
ministro della Sanità, Speranza, che stimiamo, e il ministro delle
Infrastrutture, De Micheli, che non ne ha indovinata una e non stimiamo, a chi
fa prima a annunciare che il Sud avrà finalmente più risorse pubbliche per la
sua sanità e per gli investimenti infrastrutturali, che le cose cambieranno, che
tutto è pronto perché si volti pagina rispetto al passato. Non è vero,
purtroppo. Perché il mostro spesa storica non ha perso in rapacità e rischia di
spostare un altro miliardo dal Sud al Nord per la sanità e se non cambiano le
regole i cantieri si apriranno al centronord entro un anno e se tutto va bene
tra quattro anni al Sud. Tutto nasce da un’anomalia solo italiana che si chiama
Conferenza Stato-Regioni. Ha avuto il sopravvento perché ai governi italiani
alle prese con i famosi vincoli europei di bilancio è convenuto: fate voi,
decidete voi, e loro hanno fatto e deciso come volevano loro, spesso non
rispettando i vincoli sempre a favore di alcuni e a spese di altri. Il controllo
della spesa pubblica sociale e infrastrutturale è finito nelle mani di un
oligopolio di potentati regionali, anzi meglio in quelle del duopolio lombardo e
emiliano-romagnolo che ha gestito di fatto la ripartizione delle risorse e lo ha
fatto a suo uso e consumo. Uno speciale ministero composto di due Regioni ha
fatto il bello e il cattivo tempo. Praticamente la Regione Lombardia fa i
calcoli per tutti e l’unico punto di mediazione è con l’Emilia-Romagna. I
funzionari delle altre Regioni neppure vanno più perché non hanno strumenti per
opporsi e non sono messi politicamente nelle condizioni di farlo. Non si è mai
neppure pensato di fare un servizio studi per le regioni composto da enti
indipendenti che inserisse nei parametri di valutazione i valori della
cosiddetta deprivazione sociale. Per carità, si dovesse mai tenere conto nella
ripartizione dei trasferimenti del tasso di disoccupazione o del tasso di
povertà di questa o quella regione! Benché raccomandato più volte da vari
governi di questo non si è nemmeno parlato, si è sempre scelto senza discutere
che a guidare fosse il criterio della età per cui le regioni del Nord dove ci
sono più anziani e dove le speranze di vita sono superiori fanno bottino pieno e
la Campania, ad esempio, che è piena di giovani senza lavoro e senza reddito e
di poveri si arrangi, si prenda i tagli, e non disturbi il manovratore. Dite
che, forse, ci vorrebbe una commissione di scienziati indipendenti? No, vi
sbagliate! I soldi sono quelli che sono e, quindi, non si cambia nulla:
l’Emilia-Romagna si conferma un modello di sottrazione di risorse altrui, ma
molto attento al territorio e alla sua popolazione con tassi riconosciuti di
efficienza. Il modello lombardo di sottrazione di risorse altrui si conferma
capace di fare quattrini, soprattutto a Milano, con alti tassi di
specializzazione e di ricerca, ma molto meno presente nei territori e troppo
poco attento agli ospedali pubblici. Entrambi i modelli hanno una priorità:
portare l’acqua al proprio mulino e evitare che regioni come la Campania e la
Puglia abbiano le risorse per attrezzarsi meglio e ridurre di conseguenza il
turismo sanitario di cui loro sono beneficiarie nette. Per queste ragioni, a
prescindere dai primati indiscutibili emiliani e lombardi, non si è mai fatto il
fondo di perequazione sanitario e tanto meno quello infrastrutturale, entrambi
previsti dalla legge del federalismo fiscale approvata e mai attuata violando i
diritti costituzionali di cittadinanza. Sono arrivate in compenso le mille
Basilee per le università di modo che gli atenei del Sud pagassero pegno come
gli ospedali e le scuole. Con questo quadro può succedere solo che le regioni
del Sud perdano un altro miliardo in più nella ripartizione dei fondi sanitari,
che si aprano i cantieri al Nord e si continuino a buttare i soldi in studi di
fattibilità al Sud. Servono decisioni coraggiose.
Primo. Abolire la Conferenza Stato-Regioni.
Secondo. Ricostituire il servizio sanitario nazionale che
rispetti i diritti di tutti e favorisca l’efficienza complessiva del Paese.
Terzo. Rifare la prima Cassa del Mezzogiorno, quella fatta di 300
ingegneri che apriva e chiudeva i cantieri, non rubò una lira, e consentì
all’Italia di raddoppiare il prestito Marshall. Allora vedrete che il Sud avrà i
suoi bandi di gara internazionali, i suoi concessionari e i suoi treni veloci.
Se si vuole fare sul serio, si fa così. Se no si prosegue con gli annunci delle
interviste ministeriali e si continua a spargere benzina intorno ai mille
focolai della polveriera sociale italiana. Prima o poi ci scappa l’incendio.
STRANGOLI IL SUD, UCCIDI L'ITALIA. LO SCIPPO IGNORATO:
PRIGIONIERI DEI GIOCHETTI DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI.
Roberto Napoletano il 30 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud. Se
si continua con gli annunci, i cantieri fantasma e la forza inerziale di Sua
Maestà Spesa Storica si impedisce al Paese di affrontare e risolvere il suo
primo problema competitivo. Va cambiata la macchina centrale e regionale e i
governatori del Sud devono chiedere l’intervento della Corte costituzionale.
Questo giornale in assoluta solitudine e prima di tutti dal suo giorno di uscita
ha denunciato lo scandalo ventennale di una distorsione abnorme nella
distribuzione territoriale della spesa pubblica. Siamo arrivati al punto che il
Mezzogiorno è stato abolito nella spesa per infrastrutture di sviluppo. È stata
ridotta allo 0,15% del prodotto interno lordo. Sono stati aboliti i diritti di
cittadinanza della popolazione meridionale nella sanità, nella scuola e nei
trasporti. Abbiamo documentato (dati 2016 RGS-CPT) che al 34,3% della comunità
meridionale dal 2009 a oggi è toccato il 28,3% della spesa pubblica allargata
che riguarda Stato, enti locali, soggetti pubblici economici. Al 65,7% della
popolazione del centronord è andato il 71,7% delle erogazioni della spesa
pubblica allargata. Lo squilibrio ovviamente continua ad aggravarsi. Insomma,
c’è un 6% e passa sottratto al Sud e indebitamente regalato al Nord. Vale oltre
60 miliardi l’anno, sì avete capito bene, 60 e passa miliardi in meno ogni anno
di finanziamenti per costruire ospedali, rifare le scuole, collegare le città
con treni veloci, manutenere le strade, attrezzare le aree portuali e così via.
In una parola 60 miliardi di sviluppo negato al Sud per fare un po’ di sviluppo
e molto assistenzialismo al Nord. Lo abbiamo chiamato scippo e ne abbiamo
denunciato la sua consacrazione giuridica con la legge Calderoli (2009) sul
federalismo fiscale che costituisce l’edizione più moderna del gioco delle tre
carte. Si è detto: non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di
serie B e, quindi, bisogna fissare i livelli essenziali di prestazione e i
fabbisogni standard e varare il fondo di perequazione. Questo dice la legge che
aggiunge, però, siccome ci vorrà un po’ di tempo per farlo, nel frattempo usiamo
il criterio della spesa storica in base al quale il ricco diventa sempre più
ricco e il povero sempre più povero. Per cui carta vince carta perde, le prime
tre carte dell’equità sono finite nel cestino e la carta dei ricchi ha fatto
piazza pulita delle altre. Questa scelta miope ha danneggiato pesantemente le
aree interne del Nord, ma ha messo fuori mercato un terzo del Paese privandolo
di treni veloci, fibra digitale, molto altro, e condannandolo alla povertà. Una
vergogna e una scelta miope. La denuncia del nostro giornale è stata subito
sottoscritta dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, certificata dai Conti
Pubblici Territoriali della Repubblica italiana, dalla Corte dei Conti che
chiede invano ogni anno di superare l’anomalia della spesa storica, e dalla
indagine della commissione finanze nata dalle nostre inchieste e gestita con
maestria dalla presidente Carla Ruocco. Lo scippo decennale è potuto avvenire
grazie alla forza di un’alleanza di interessi tra la Sinistra Padronale del Nord
e la Destra lombardo-veneta e al silenzio complice di troppi esponenti della
classe politica e dirigente del Mezzogiorno. A mio avviso i governatori delle
regioni meridionali devono fare una sola cosa: chiedere tutti insieme
l’intervento della Corte Costituzionale ma in Italia purtroppo c’è sempre
un’elezione che fa rinviare l’appuntamento con la storia. La presa di coscienza
comune dei Governatori del Sud resta comunque un passo gigantesco in avanti e
anche lo sforzo in atto di Conte e di ministri come Provenzano e Boccia per
mettere al primo punto del Recovery plan la fiscalità di vantaggio e l’alta
velocità ferroviaria al Sud è da apprezzare. Il punto è che mancano i fatti.
Perché con i giochetti della ministra De Micheli i cantieri si aprono al Nord e
al Sud si continuano a finanziare gli studi di fattibilità. Perché con i
giochetti della Conferenza Stato-Regioni si è introdotta la “nuova premialità
dei ricchi” per cui il Nord prenderà ancora di più del Sud nella sanità di
quanto prendeva prima dimostrando che la lezione del Covid non ha insegnato
nulla. Questi sono i fatti che sono l’esatto opposto delle numerose interviste
ministeriali che annunciano ogni giorno di dare più soldi al Sud che nessuno ha
visto e nessuno potrà vedere senza cambiamenti profondi nella macchina pubblica
centrale e regionale e una condivisione della parte più illuminata della classe
dirigente del Nord. Se viceversa si continua con gli annunci, i cantieri
fantasma e la forza inerziale di Sua Maestà Spesa Storica non solo si fa il male
del Sud, ma si “uccide” l’Italia perché si impedisce al Paese di affrontare e
risolvere il suo primo problema competitivo. Peraltro si va anche contro le
richieste dell’Europa e della Banca Centrale europea e si mettono perfino a
rischio i fondi europei. Un gioco pericoloso.
NON SI PUÒ PIÙ PROCEDERE IN ORDINE SPARSO.
RECOVERY: FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RIEQUILIBRIO DELLA SPESA
TERRITORIALE LE PRIORITÀ. Robero Napoletano il 29 luglio 2020 su Il Quotidiano
del Sud. Nonostante gli aut aut degli “olandesi emiliani” di casa nostra,
l’Italia si salva se si salva il suo Mezzogiorno, non se si continuano a
rapinare le risorse del bilancio pubblico nazionale e del Fondo di coesione
europeo destinato al Sud per finanziare il privilegio assistenziale del Nord.
Non è più consentito alla classe politica meridionale di non agire unita
riducendosi a scendiletto del potere tosco-emiliano di sinistra e
lombardo-veneto della destra pur di continuare a litigare tra di loro. Piovono
dal cielo 209 miliardi. Non abbiamo mai avuto tanti soldi. Ogni partito fa la
sua proposta. Ogni ministro. Anche quelli che aprono bocca senza mai pensare.
Ogni sindaco. Ogni Presidente di Regione. Facciamo questo. Facciamo quello.
Facciamo la rivoluzione digitale. Apriamo un negozio di pizze e fichi.
Rifacciamo tutti gli ospedali del Sud e diamo più soldi alla sanità del Nord. E
chi più ne ha più ne metta. La verità è che il Paese stava fallendo e rischia
ancora di fallire per cause pandemiche sopravvenute e colpe sue che vengono da
lontano. La verità è che l’Europa franco tedesca non disinteressatamente sta
facendo di tutto per tenerci in vita perché ha paura della pesantezza del botto
che potremmo fare e vuole finalmente provare a fare l’Europa. La verità è che la
Cancelliera Merkel ha dovuto fare ragionare olandesi e austriaci mettendo mano
al portafoglio in nome di un’idea europea solidaristica che chiede all’Italia di
investire sul suo Mezzogiorno e risolvere il problema del riequilibrio
territoriale senza sapere che nulla può (nemmeno lei) contro il muro di
privilegi che “olandesi e austriaci di casa nostra” difendono alla morte. La
verità è che assistiamo sgomenti a una narrazione propagandistica di una valanga
di soldi che sta rotolando sulle nostre teste fino al punto di schiacciarci.
Fino al punto di spezzare il filo che ci consente di danzare sull’orlo del
baratro senza caderci dentro. A tutti questi signori che fanno propaganda
consigliamo la lettura meno amena ma decisamente più veritiera del noiosissimo
ddl sull’assestamento di bilancio dove c’è scritto in italiano che abbiamo un
saldo netto da finanziare con un tetto massimo di 390 miliardi. Ai quali vanno
aggiunti i 250 miliardi di titoli in scadenza che vanno rinnovati e fanno salire
a oltre 600 miliardi il monte titoli italiani da finanziare per fare fronte agli
effetti della crisi che ha determinato un colpo da 51 miliardi di finanza
pubblica tra minori entrate e maggiori spese. Tutta roba scritta, sia chiaro, in
un disegno di legge governativo. A fronte di tutto ciò in versione Mark Rutte in
salsa emiliano-romagnolo dall’alto dei suoi successi elettorali e forte delle
chiavi di comando della cassaforte della Sinistra Padronale, Bonaccini intima al
sottosegretario Fraccaro della Presidenza del Consiglio di non permettersi di
toccare l’impianto dei trasferimenti pubblici alle sanità regionali e, cosa
giusta, che non si fa una legge di assestamento di bilancio senza passare dalla
conferenza Stato-Regioni da lui presieduta. A un Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, che mette sul tavolo in modo sacrosanto le ragioni non più
eludibili di un riequilibrio dei trasferimenti che penalizza in modo abnorme il
cittadino pugliese rispetto a quello emiliano-romagnolo, per non parlare del
cittadino campano al confronto con quello lombardo, la risposta secca è: puoi
dare qualcosa in più al Sud ma guai se tocchi l’impianto dei trasferimenti alla
sanità. Che noi traduciamo: la sanità dei ricchi. L’avvertimento è chiaro: puoi
fare quello che vuoi ma guai se tocchi l’impianto del privilegio che nega i
diritti di cittadinanza sanitaria, ma anche scolastica e ancora di più
infrastrutturale, al Sud e li regala indebitamente al cubo al Nord con i soldi
del Sud. Siccome il bravissimo Bonaccini non può non sapere che questo giochetto
che vale 60 miliardi l’anno è incostituzionale perché è figlio di una legge sul
federalismo fiscale (Calderoli, 2009) mai attuata perché non si sono fatti i
fabbisogni standard, i livelli essenziali e perfino il fondo di perequazione e
non può non sapere che la cassa europea ha il vincolo dell’obiettivo strategico
del riequilibrio territoriale la situazione si fa davvero delicata e ricalca
alla perfezione l’ottuso interessato egoismo che ha segnato il “frugale”
comportamento di olandesi e austriaci intenti solo a scroccare quattrini.
Siccome in autunno la luna di miele finirà e anche se le tensioni sui mercati
saranno ancora una volta attutite dagli acquisti della Bce sarà chiara a tutti
la bomba sociale di milioni di disoccupati che rischia di esplodere nel 2021, le
forze illuminate del Pd hanno il dovere di fare capire ai padroni della Sinistra
Padronale che non si può continuare a scherzare con gli studi di fattibilità per
l’alta velocità ferroviaria al Sud e i cantieri veri che tornano a riaprirsi al
Nord. Deve essere il Nord illuminato a chiedere la fiscalità di vantaggio e la
riunificazione infrastrutturale delle due Italie. Questo ci chiede l’Europa.
Questo ci chiede la Bce. Questo serve all’Italia. Conte, Provenzano e Boccia
hanno in mano la partita del futuro dell’Italia. Quando tutti torneremo con i
piedi per terra, molto presto, si capirà che non si hanno i soldi per fare tutto
e che, questa volta, l’Italia si salva se si salva il suo Mezzogiorno non se si
continuano a rapinare le risorse del bilancio pubblico nazionale e del Fondo di
coesione europeo destinato al Sud per finanziare il privilegio assistenziale del
Nord. Questa operazione verità deve servire a riunire il Paese in casa e a
costruire una credibilità nuova in Europa e nel mondo. Dipende solo da noi
perché in questo caso il problema riguarda noi non l’Europa. Se la classe
politica e dirigente del Mezzogiorno uscisse dal letargo almeno ventennale e
chiedesse alla Corte Costituzionale italiana di intervenire farebbe un quarto
del suo dovere. Se siamo ridotti così, però, è proprio perché questa classe
politica non ha mai saputo agire unita preferendo ridursi a scendiletto del
potere tosco-emiliano di sinistra e lombardo-veneto della destra pur di potere
continuare a litigare al loro interno. Questo mercimonio al ribasso della
dignità loro e nostra non è più consentito.
Sanità, il piano scellerato per sottrarre risorse al Sud: a
rischio un altro miliardo. E intanto è iniziata la
battaglia per la ripartizione delle risorse del Recovery Fund. Il Nord non vuole
perdere i privilegi. Lia Romagno il 31 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud. È
anche sulla sanità che si misura la tutela dei diritti di cittadinanza che un
Paese è in grado di assicurare ai propri cittadini. E se guardiamo al nostro di
Paese non servono i conti della spesa statale per dire che il diritto alla
salute “distingue” i cittadini del Sud da quelli del Nord. Lo provano gli
ospedali poco attrezzati, con strutture spesso fatiscenti, che accolgono i
pazienti nelle regioni meridionali, l’esiguo numero di medici e infermieri che
ne popolano le corsie, i macchinari obsoleti, le liste d’attesa. E i numeri del
turismo sanitario che ogni anno registrano le partenze di calabresi, pugliesi,
siciliani, lucani e campani in cerca di cure migliori negli ospedali del Nord, a
vantaggio di una sanità che crea profitti per i privati, mentre nel Mezzogiorno
apre “buchi” nei bilanci degli enti locali. Ma i numeri contano e in questo caso
spiegano le ragioni di una sanità “malata” al Sud, che risiedono nel riparto dei
fondo sanitario nazionale sulla base della spesa storica che da anni fa sì che,
a parità di popolazione, il Nord riceva più soldi per le sue strutture
ospedaliere. E nel futuro non andrà meglio, dal momento che il nuovo sistema di
valutazione e verifica dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), approvato nel
dicembre del 2018 e che entra in vigore quest’anno, rischia di penalizzare
ulteriormente le regioni meridionali. Nessuna sorpresa, quindi, nello scoprire
che nel documento circolato qualche settimana fa che “abbozzava” la ripartizione
dei 37 miliardi del Mes – su cui nella maggioranza ancora restano alte le
resistenze del Movimento 5 Stelle – ancora una volta veniva cristallizzata la
sperequazione delle dotazione delle risorse a beneficio delle regioni
settentrionali e la sopravvivenza di un sistema sanitario che distingue tra
serie A e serie B. Alle risorse comunitarie del Recovery Fund – e alle pressioni
delle istituzioni europee affinché i Paesi intervengano sui rispettivi divari
territoriali – è affidata la possibilità di un riequilibrio e di dotare il
Mezzogiorno di una sanità efficiente, ma nelle prime riunioni della cabina di
regia sono già emersi orientamenti egoistici e miopi: chiedendo che il
trasferimenti dei dei fondi avvengano secondo i criteri in uso, il presidente
della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini – che è anche presidente della
Conferenza delle Regioni – ha già chiesto più soldi per il Nord.
LO SCIPPO DELLA SPESA STORICA. Da oltre 15 anni il Nord continua
a prendere più soldi per i suoi ospedali. E nel 2020 non è andata diversamente,
dal momento che il riparto del fondo sanitario nazionale ha seguito lo stesso
spartito di sempre. Così, su 113,3 di dotazione complessiva, alla Puglia, 4,1
milioni di abitanti, sono stati riservati 7,49 miliardi mentre all’Emilia
Romagna, con 4,4 milioni, 8,44 miliardi: quasi un miliardo in più nonostante una
popolazione quasi identica. E se si considera il Veneto, con i suoi 4,9 milioni
di abitanti, la sproporzione resta, visto che la Regione governata da Zaia
incassa 9,2 miliardi, quasi due in più rispetto alla regione guidata da
Emiliano. Considerando la spesa pro-capite, ne discende che per curare un
cittadino pugliese lo Stato spende 1.826 euro, contro i 1.918 riservati ad un
emiliano e 1.877 per un veneto. Qualche altro numero per illustrare la scena:
restando al Sud, la Campania, avrà 10,6 miliardi, 1.827 euro per ciascuno dei
suoi 5,8 milioni di residenti che possono far affidamento su 42mila operatori
sanitari impiegati a tempo indeterminato; la Calabria 3,6 miliardi e 1.800 euro
per cittadino (ha quasi due milioni di abitanti che possono contare su un
personale che conta 18mila unità). Guardando al Nord, alla Lombardia e al
Piemonte andranno, rispettivamente, 18,8 miliardi (1.880 euro pro capite per i
10 milioni di residenti curati da 95mila tra medici e infermieri) e 8,33
miliardi (4,35 milioni di abitanti: circa 1.935 euro per residente. E un staff
sanitario di 53mila persone). Dal 2012 al 2017, poi, Liguria, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno visto aumentare la loro quota
del fondo del 2,36%, ricevendo quindi dallo Stato poco meno di un miliardo in
più (944 milioni), rispetto ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e
Calabria per le quali l’aumento è stato pari soltanto dell’1,75%.
LA RIFORMA DEI LEA PENALIZZA IL MEZZOGIORNO. Alla luce di questi
numeri, il nuovo sistema di verifica e valutazione dei Lea rischia di
penalizzare ulteriormente le regioni meridionali, che potrebbero ritrovarsi con
minori trasferimenti da parte dello Stato. Sono previsti, infatti, criteri più
severi per giudicare la qualità e l’efficienza dei sistemi sanitari regionali e
per quelli del Sud, dopo decenni di tagli, è difficile superare l’esame. Come
mostra una simulazione svolta dal Comitato Lea, organo del ministero della
Salute: solo 11 Regioni su 21 risultano essere adempienti, quindi sarebbero
promosse e le “inadempienti” sono quasi tutte del Sud, ovvero Campania,
Calabria, Molise, Basilicata, Sicilia, Lazio, Sardegna. Ad ottenere la
promozione sarebbero soltanto Puglia e Abruzzo. Superare l’esame con la
“sufficienza” vuol dire poter contare su una premialità del 3% nel riparto del
fondo sanitario, al netto delle entrate proprie, che per le regioni del Sud
equivale a circa un miliardo di euro.
LE RISORSE DEL MES. Lo scippo al Sud sulla base della spesa
storica rischierebbe di perpetrarsi anche sulla ripartizione tra le regioni dei
fondi del Mes, stando alla bozza che, secondo quanto si è raccontato, sarebbe
servita per ingolosire i governatori del Veneto e Lombardia, provati
dall’emergenza Covid 19, spingendoli a far pressione sulla Lega e a scioglierne
le resistenze. Alla Lombardia e al Veneto, infatti, andrebbero oltre 9 dei 37
miliardi riservati all’Italia, un quarto di tutta la torta: il 16,64% alla
prima, l’8,14% alla seconda. In particolare, alla Lombardia, che prima del Covid
era considerata una eccellenza sanitaria nazionale, andrebbero 6 miliardi e 158
milioni: più risorse di quante ne spetterebbero a Puglia, Calabria, Basilicata,
Marche, Umbria e Molise messe insieme.
Fontana risponde a De Luca: “14 mila campani si curano in
Lombardia”. Irene Barbato su internapoli.it il 20
Aprile 2020. Non si placa la polemica dopo le esternazioni del
Governatore Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione sarebbe pronto a
chiudere la Campania poichè è preoccupato dai residenti delle regioni del nord.
Oggi Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana lo ha risposto attraverso un
post su Facebook: “Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa
accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, tra cui circa 14mila
campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare“. Nei
giorni scorsi anche il Presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato: “Non penso
che tutti i veneti che vanno in vacanza in Campania siano contenti. Non credo
che il presidente De Luca stia facendo un grande servizio alla sua Regione”.
LE PAROLE DI DE LUCA. “Gli esperti ci dicono che in tante parti
di Italia siamo ancora alla Fase 1, poi sento alcuni miei colleghi che vogliono
ripartire tutto. Invece io credo che ci voglia un maggiore senso di
responsabilità. Lombardia, Veneto e Piemonte hanno una situazione che non è
ancora tranquilla. Lombardia e Veneto, soprattutto, sono in alto mare e vogliono
aprire. Così facendo, però, si rischia di mettere in pericolo tutta l’Italia.
Per questo saremo costretti a chiudere i confini. La cosa più drammatica sarebbe
riaprire tutto e dopo due settimane tornare a chiudere: a quel punto l’Italia
non reggerebbe più. Le riaperture dovranno essere sempre accompagnate da un
piano di sicurezza sanitaria che è imprescindibile. La ripresa sarà su due
piani: economico e sanitario” , ha detto venerdì scorso De Luca.
Dal “Fatto
quotidiano” il 21 aprile 2020. A “Libero” devono aver perso la memoria. Ieri il
direttore Vittorio Feltri si è lanciato in un editoriale per tentare di
convincere i lettori che il suo quotidiano sia estraneo ad Antonio Angelucci,
deputato berlusconiano proprietario di diverse cliniche private oltreché di
giornali (Libero, Il Tempo, il Corriere dell'Umbria ecc.). E se l'è presa con la
5 Stelle Barbara Lezzi, rea di aver insinuato, ribattendo al direttore Pietro
Senaldi, “che l'editore del foglio che leggete (Libero, appunto, ndr) sia
Antonio Angelucci, mentre la testata è di una fondazione con le carte
perfettamente in regola”. Certo. Angelucci è talmente estraneo a Libero che sul
sito della Tosinvest, il gruppo di famiglia, si legge: “... proprietaria della
testata giornalistica Opinioni Nuove - Libero Quotidiano”. Sul finire
dell'editoriale, già che c'è, Feltri si concede il lusso di un pizzino sui
palinsesti televisivi: non essendogli piaciuto come Veronica Gentili (Stasera
Italia, Rete4) ha gestito l'ospitata della Lezzi contro Senaldi (non l’ha uccisa
su due piedi, a distanza), prima la insulta e poi chiede “che la rete
berlusconiana possa rimediare”. Magari cacciandola? Nel caso, Veronica non provi
neanche a chiedere un lavoro ad Angelucci: lui con Libero non c'entra niente.
Lezzi:
“L’on. Angelucci è colui che fa insultare i Meridionali dai suoi Senaldi e
Senalducci”.
Alfredo Di
Costanzoil 19 aprile 2020 su iltabloid.it. Così Barbara Lezzi sulla sua pagina
Facebook: L’ on. Antonio Angelucci è colui che fa insultare i Meridionali dai
suoi Senaldi e Senalducci tacciandoli di essere nullafacenti e mantenuti mentre
intasca finanziamenti pubblici, dal 2003 al 2017, per la bellezza di 53 milioni
di Euro. Poco più di 3 milioni l’anno. Poco meno di 260 mila Euro al mese. Una
scena pietosa ieri sera resa ancora più squallida dalla conduttrice. Senaldi
attacca gratuitamente i cittadini del Mezzogiorno d’Italia. Una provocazione
inutile in quel contesto ma che io non lascio passare. Detesto le ingiustizie e
ancor di più detesto chi succhia dalle casse pubbliche e poi fa il liberale dei
miei stivali con la pelle degli altri. Il grande e coraggioso Senaldi si cimenta
in un piagnisteo da premio Oscar chiedendo aiuto alla conduttrice, Veronica
Gentili: “gne gne gne, non mi hai difeso.” Guardate il video, dice davvero così.
E lì la Gentili a scusarsi quasi prostrata senza minimamente prendere in
considerazione, magari per un retaggio di una lontana buona educazione, di
chiedere scusa al 34% della popolazione del Paese che era stata bellamente
infamata dal suo gradito ospite. Non paghi entrambi, hanno ribadito, in
chiusura, le scuse per mio conto (io non mi scuso affatto) ad Angelucci sol
perché avevo parlato della sua grigia reputazione. Questo mi ha molto
infastidita non per il merito che qualifica lo spessore (infinitamente basso)
dei due giornalisti che confondono la sacra libertà d’opinione con la libertà di
insulto ma perché non mi ha permesso di rispondere all’altro giornalista “molto
indipendente” che ha accusato il m5s di non volere le grandi industrie come, ad
esempio, l’ex Ilva. Beh, Barisoni, caro il mio competente giornalista economico,
se le multinazionali devono venire in Italia a farsi i fatti loro scudate da una
bella immunità penale e amministrativa, in me avranno sempre un nemico. Ma
chiunque voglia far crescere il nostro Paese nel rispetto della legge e della
salute dei miei concittadini è il benvenuto. Chiaro? Spero di sì. Per il resto,
sugli interessi passivi che non contano, sulla politica monetaria contrapposta
agli eurobond come se la prima potesse durare per sempre, sulla lezioncina con
la quale voleva svelarmi il gran segreto che gli eurobond sono prestiti ( il MES
che lei vorrebbe cosa sarebbe, Barisoni?) magari avremo qualche altra occasione
per discuterne, sempre se riuscirà a liberarsi dal desiderio che la muove più
per contraddirmi che per fare informazione. Perché le Barisonate “competenti”
sono la ragione per cui finora abbiamo ingoiato austerità e trattati capestro. A
Maria Giovanna Maglie che pettegola in mia assenza glielo regaliamo un velo
pietoso, anzi penoso? Ma sì, perché negarlo.
Carlo Tarallo
per Dagospia il 22 aprile 2020. “Follow the money”, dice il saggio. Segui il
denaro e arriverai alla verità. In questo caso, se si vuole andare oltre le
sparate cabarettistiche che in queste settimane alcuni giornalisti e politici
del Nord stanno mettendo in scena contro le regioni meridionali, che fino ad ora
hanno contrastato con maggiore efficacia l’epidemia da coronavirus, bisogna
ricordare bene cosa è il “turismo sanitario”. Comprendere il meccanismo è
semplicissimo, come bere un bicchiere di vino (anche due) e andare in tv a
sparare contro i “meridionali inferiori”. Il tema è questo. Il Servizio
sanitario nazionale è articolato su base regionale, per cui ogni cittadino ha
diritto a prestazioni gratuite, ovviamente nei limiti dei ticket così via, su
tutto il territorio nazionale, ma chi paga è la Regione di residenza. Quindi il
signor Gennaro Esposito, residente a Napoli, ha diritto a farsi curare in
Calabria, in Trentino o in Lombardia, ma i costi saranno a carico della Regione
Campania. Cosa accade, dunque: ogni anno, per effetto di questa migrazione
sanitaria, il saldo è negativo, per la Regione Campania,per circa 320 milioni di
euro. Soldi che ogni anno la Campania paga alle regioni del Nord dove vanno a
farsi curare i pazienti campani. Ogni anno, dalle regioni del Sud partono
centinaia di migliaia di malati che vanno a farsi curare al Nord, portando con
sé un vero e proprio fiume di denaro. Secondo il Sole24Ore, le Regioni con saldo
positivo superiore a 100 milioni di euro in relazione a questo fenomeno (dati
2017) sono tutte del Nord, quelle con saldo negativo maggiore di 100 milioni
tutte del Centro-Sud. In particolare: in Lombardia il saldo è pari a 784,1
milioni, in Emilia Romagna a 307,5 milioni, in Veneto a 143,1 milioni e in
Toscana a 139,3 milioni. Saldo negativo rilevante per Puglia (-201,3 milioni di
euro), Sicilia (-236,9 milioni), Lazio (-239,4 milioni), Calabria (-281,1
milioni), Campania (-318 milioni). Se si aggiunge a tutto ciò l’indotto
rappresentato dai familiari dei pazienti, che spendono soldi per vitto,
alloggio, spostamenti, annessi e connessi, la cifra aumenta ancora.
Naturalmente, la scelta di andare a curarsi al Nord è dettata dalle croniche
inefficienze della sanità meridionale, in particolare riguardo alle lunghissime
liste d’attesa, ma c’è anche un fattore per così dire “emotivo”, che spinge i
meridionali a fidarsi di più della sanità settentrionale. Anzi, per meglio dire,
spingeva. Con l’epidemia coronavirus che ha flagellato il Nord, infatti, questo
fiume di denaro è destinato a ridursi e di molto: innanzitutto, per i prossimi
mesi i cittadini del Sud avranno oggettive difficoltà a raggiungere le strutture
sanitarie del Nord; in secondo luogo, ci sarà un’inevitabile preoccupazione
dovuta al coronavirus; in terzo luogo, la sanità settentrionale dal punto di
vista dell’immagine esce male da questa emergenza, mentre quella meridionale sta
dimostrando di poter raggiungere risultati di eccellenza. Meno turisti della
salute, meno soldi che vanno dalle regioni del Sud a quelle del Nord, quindi.
Questo è quanto, il resto è cabaret.
IL BUSINESS DELLA SANITA’. LA NEGAZIONE DEL SUD.
Michele Di Pace il 27.09.2020 su Movimento 24 agosto. Di Ambrogio
Carpentieri. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna vendono una sanità che assorbe
risorse pubbliche del Sud a centinaia di milioni di euro, spingendo il Sud a
funzionare sempre peggio cosicchè il Nord possa guadagnare sempre di più. I
cervelli migliori emigrano insieme ai clienti. La riforma del titolo V della
Costituzione e il federalismo fiscale hanno indotto le Regioni non virtuose a
pagare un prezzo alto. E non si tratta di maggiori capacità o migliore
organizzazione ma soprattutto di marketing. I mass media italiani e i
giornalisti compiacenti sono nelle mani dei giganti della finanza ed è acclarato
la loro appartenenza alle lobby del Nord. “Nelle aree regionali maggiormente
colpite dal Covid19, quali Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi, si è assistito ad
una straordinaria capacità degli ospedali di passare da un sistema competitivo
ad una cooperazione positiva e solo così, in uno sforzo comune, si è potuto
evitare il collasso del sistema ospedaliero. In particolare, in regione
Lombardia gli ospedali sono stati in grado di passare dai circa 850 posti letto
in terapia intensiva di febbraio agli oltre 1500 di fine aprile. Uno sforzo
immane che si è ottenuto grazie alla capacità dei manager ospedalieri (pubblici
e privati) di ridisegnare il proprio assetto organizzativo. Nessun’altra Regione
ha ottenuto risultati paragonabili.(sussidiario.net)”. “I dati ufficiali sulla
diffusione del virus in Lombardia, fondamentali per valutare la riapertura dei
confini a fine maggio, sono verosimilmente sottostimati» ribadisce il presidente
Gimbe. “La Lombardia, la più colpita dall’epidemia, non è pronta per quattro
motivi. Uno: la percentuale di positivi al giorno è più alta di quella che viene
comunicata. Due: il numero dei positivi è sottostimato perché manca ancora un
tamponamento massiccio. Tre: i nuovi casi giornalieri, per 100 mila abitanti,
sono il triplo della media nazionale, ma sono i meno noti. Quattro: la Lombardia
sovrastima i guariti perché li comunica insieme ai dimessi di cui non è noto lo
status di guarigione, clinica o virologica.” Il Nord, che sfrutta l'arte della
manipolazione mediatica, è capace di un marketing più incisivo, che trae
vantaggio dal pregiudizio: tutti credono che la sanità al Sud non funziona ed è
pericolosa! A partire dal 2018 sono stati riscontrati 96 casi di infezione da
batterio killer presso l'Ospedale della donna e del bambino di Verona. Il
Citrobacter era presente nel rubinetto del lavandino usato dal personale della
Terapia intensiva neonatale per prendere l'acqua e darla ai bambini, mescolata
anche con il latte. Per questo motivo sono morti quattro bambini e altri nove
hanno subito danni cerebrali permanenti. Il TGR Veneto sottolineava che si
tratta di un batterio solitamente innocuo e definiva l’Ospedale “una colonna
portante della sanità regionale”.
Gli affari della Sanità privata padana a danno di quella del
Sud, sotto tutela dello Stato.
Con il principio della spesa storica (riferimento a quanto
percepito negli anni precedenti), il Nord Italia si “fotte” più di quanto
dovuto, a spese del Sud Italia.
In virtù, anche, di quel dipiù la Sanità padana spende di più
perché è foraggiata dallo Stato a danno della Sanità meridionale, che spende di
meno perchè vincolata a dei parametri contabili prestabiliti.
Poi c’è un altro fenomeno sottaciuto:
Nelle strutture private del Nord, costo pieno di rimborso;
Nelle strutture private del Sud, costo calmierato di rimborso.
Con questa situazione si crea una contabilità sbilanciata e un
potere di spesa diversificato.
In questo modo i migliori chirurghi del meridione sono assoldati
dalle strutture settentrionali e pagati di più. Questi, spostandosi, con armi,
bagagli e pazienti meridionali affezionati, creano il turismo sanitario.
Con una finanza rinforzata la Sanità padana è pubblicizzata dalle
tv commerciali e propagandata dalla tv di Stato.
Ergo: loro diventano più ricchi e reclamizzati. Noi diventiamo
sempre più poveri e dileggiati.
Poi arriva il Coronavirus e ristabilisce la verità:
la presunta efficienza crea morte nei loro territori;
la presunta arretratezza contiene la pandemia, nonostante,
artatamente, dal Nord per salvare la loro sanità, siano stati fatti scappare i
buoi infetti con destinazione Sud.
Michele Emiliano a Stasera Italia su Rete4 (Rete Lega) del 3
maggio 2020. «Innanzitutto noi abbiamo aumentato di millecinquecento posti i
posti letto autorizzati da Roma. E abbiamo subito approfittato di questa cosa.
Devo essere sincero: il sistema sanitario pugliese è un sistema sanitario
regolare. Noi non abbiamo mai avuto problemi sulle terapie intensive. Quindi
però, Pomicino evidentemente è intuitivo, capisce che questo è il momento per
cui le sanità del Sud…siccome i nostri non possono più andare al Nord per
curarsi perché è troppo pericoloso, devono essere rinforzate per limitare la
cosiddetta mobilità passiva. Quindi io l’ho detto chiaro: io non terrò più conto
dei limiti, posti letto, assunzioni, di tutta questa roba, perché non siamo in
emergenza. Farò tutte le assunzioni necessarie, assumerò tutte le star della
medicina che riuscirò a procurarmi, cercherò di rinforzare i reparti. Manterrò i
posti letto in aumento. Anche di più se possibile. Chiederò ai grandi gruppi
privati della Lombardia per i quali c’è una norma che li tutelava in modo
blindato. Immaginate: io potevo pagare senza limite i pugliesi che andavano in
Lombardia presso queste strutture, se queste strutture erano in Puglia c’era un
tetto massimo di spesa fatto apposta…Siccome questo tetto deve saltare, io sto
proponendo a questi grandi gruppi di venire e spostarsi al Sud per evitare il
rischi Covid, ma soprattutto per evitare il rischio aziendale per loro. Perché è
giusto che questa mobilità passiva: 320 milioni di euro di prestazioni sanitarie
che la Puglia paga alla Lombardia in prevalenza, solo perché quel sistema è
stato supertutelato. Adesso tutti dovremmo trovare il nostro equilibrio e la
nostra armonia».
Radiografie e Tac, affare d'oro per la sanità lombarda.
Vincenzo Damiani il 7 marzo 2020 su Il Quotidiano del Sud.
In Lombardia il sorpasso del privato sanitario sul pubblico è già avvenuto e si
registra in una branca nemmeno secondaria, quella della diagnostica strumentale
e per immagini: già nel 2015 il valore delle prestazioni erogate
ambulatorialmente dal privato ha inciso per il 52% sul valore totale delle
prestazioni (fonte: Opendata della Regione Lombardia). Parliamo di Tac,
ecografie, risonanze, endoscopia, insomma una grossa fetta degli esami a cui si
sottopongono, quotidianamente, migliaia di persone.
IL SORPASSO. Ma il sopravvento del privato sul pubblico è
attestato da altri dati e altre fonti autorevoli che andiamo a presentare. Ad
esempio: l’Osservatorio Assolombarda Bocconi, analizzando quanto accaduto nel
decennio tra il 1997 e il 2006, consegna alla Lombardia anche il record di
crescita degli ospedali privati. Nel 1997 erano 55, nel 2006 sono diventati 73,
+18, una variazione che non ha eguali nel resto dell’Italia. L’unica regione che
mostra un andamento simile è la Sicilia (che sale da 49 a 61, +12), ma
complessivamente nel resto del Paese c’è addirittura una contrazione: nel Lazio,
ad esempio, si riducono di 15 unità, la Campania perde 4 ospedali privati,
complessivamente in tutto il Paese si passa da 537 strutture ospedaliere private
a 563, +26. Abbiamo parlato di esami medici e ospedali, ora vediamo quanto
accade sui costi: secondo quanto certifica il ministero della Salute (anno 2016)
in Lombardia su 1.931 euro di spesa sanitaria pro capite totale il 27,9% è
incassato dalle strutture private (ospedali, ambulatori, laboratori), cioè 538
euro. Nessun’altra regione come la Lombardia: il Lazio si avvicina (24,6%) ma
resta distante, in Calabria dei 1.749 euro pro capite ai privati ne vanno 265
(15,1%), in Basilicata la fetta scende addirittura all’11,8% (219 euro su
1.854), in Campania si attesta al 20,6%, in Sicilia al 20,7% e in Puglia al
21.4%.
RICOVERI E AMBULATORI. Lo sbilanciamento lombardo a favore del
privato è fotografato da altri numeri ancora, ad esempio quello dei ricoveri
relativi all’anno 2017: su 1.441.657 ricoveri totali, il privato ne ha eseguiti
494.501, il 35% circa, il pubblico 947.157, pari al 65%. Nel complesso, i
ricoveri hanno generato un valore di 5,4 miliardi di euro e la Lombardia ha
versato a titolo di rimborso ai privati circa 2,1 miliardi, cioè il 40% dei 5,4
miliardi. Ricapitolando: nel 2017 le strutture private hanno garantito il 35%
dei ricoveri, ma hanno incassato il 40% di quanto il sistema sanitario lombardo
ha generato. Come è possibile? C’è solo una spiegazione: i servizi offerti dai
privati costano di più rispetto alle prestazioni del pubblico. Stesso discorso,
anche se in maniera meno evidente, per visite ambulatoriali ed esami: nel 2017,
su 160 milioni di prestazioni, il 42% è stato svolto in centri privati (66
milioni); le strutture, però, hanno incassato il 43% del valore totale di visite
ed esami, 1,24 miliardi su 2,8 miliardi complessivi (fonte Regione Lombardia).
LA DIAGNOSTICA. Se ci spostiamo sul campo della diagnostica
strumentale e per immagini, il sorpasso del privato sul pubblico c’è già stato
nel 2015: infatti, se consideriamo il valore delle prestazioni erogate
ambulatorialmente dal privato sul valore totale delle prestazioni pubbliche e
private dello stesso ambito, il privato incide per il 52% (Fonte: Opendata della
Regione Lombardia). Scendendo più nel dettaglio e nel locale, a Milano e
provincia sono presenti 57 strutture di ricovero ordinario e day hospital, 26
sono pubbliche, 31 a gestione privata (54,4%), a Bergamo 14 su 23 sono private
(60,9%), a Brescia 14 su 28. In Lombardia gli Irccs privati sono circa il triplo
dei pubblici (14 contro 5, fonte ministero della Salute). Nel 2018, in una
struttura privata che non lavorava con il servizio sanitario, una risonanza
magnetica muscoloscheletrica (ginocchio, spalla, mano, anca, piede) costava ai
cittadini circa 90 euro.
RIMBORSI E DIVARIO. Qual è il rimborso che la Lombardia garantiva
nel 2018 ai suoi centri privati convenzionati? Circa 169 euro, l’89% in più. Il
gruppo San Donato – GSD è il principale gruppo privato d’Italia e in Lombardia,
solo a Milano e provincia le strutture di ricovero e cura sono 7, delle quali 3
sono istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Nel 2017, in
termini di valorizzazione dei ricoveri, il gruppo San Donato ha raggiunto il 35%
del totale privato, mentre complessivamente, calcolando anche il pubblico, ha
superato il 14% della valorizzazione dei ricoveri. Questa è la fotografia della
sanità lombarda che in media ogni anno può contare su circa 19 miliardi di soldi
pubblici. Nel 2019, la Regione Lombardia – che ha il doppio della popolazione
della Puglia – ha speso quasi il triplo della regione amministrata da Emiliano.
Circa 19,3 miliardi per 10 milioni di residenti, contro i 7,7 pugliesi per 4,2
milioni di abitanti. I dati sono estrapolati dai bilanci di previsione 2019-2021
delle singole Regioni. Alla voce “Tutela della salute”, nel suo bilancio la
Puglia (4,1 milioni di residenti) nel 2019 iscrive la somma 7,7 miliardi.
L’Emilia Romagna (popolazione 4,4 milioni), invece, quasi 10,2, ben 2,5 in più
nonostante uno scarto residuale di abitanti; il Veneto (4,9 milioni) spende 10,1
miliardi; la Lombardia che ha poco più del doppio della popolazione della Puglia
(10 milioni di residenti) addirittura spende quasi il triplo, 19,3 miliardi.
Insomma, una “tutela della salute” a macchia di leopardo: in alcune zone è più
garantita, in altre meno grazie a una distribuzione del fondo nazionale non
propriamente equo. D’altronde, è accertato dalla Corte dei conti che dal 2012 al
2017 nella ripartizione del fondo sanitario nazionale, sei Regioni del Nord
hanno aumentato la loro quota, in media, del 2,36%; altrettante regioni del Sud,
invece, già penalizzate perché beneficiarie di fette più piccole della torta dal
2009 in poi, hanno visto lievitare la loro parte solo dell’1,75%. Tradotto,
significa che, dal 2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato 944 milioni di euro in più rispetto
ad Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata, Campania e Calabria. Così è lievitato il
divario tra le due aree del Paese: mentre al Nord sono stati trasferiti 1,629
miliardi in più nel 2017 rispetto al 2012, al Sud sono arrivati soltanto 685
milioni in più. Nel 2017 il 42% del totale delle risorse finanziarie per la
sanità è stato assorbito dalle Regioni del Nord, il 20% da quelle del Centro, il
23% da quelle del Sud, il 15% dalle Autonomie speciali.
Da Bergamo a Chieti, le cliniche assoldano i più bravi. Il
cardiochirurgo lombardo: "Su 532 persone operate, 150 sono pugliesi".
La Regione Puglia spende ogni anno 200 milioni per le cure in
trasferta. Antonello Cassano l'11 aprile 2016 su La Repubblica. A metà strada
tra le star e i guru. Sono i grandi professionisti della medicina, specialisti
in branche importanti come l’oncologia o la cardiochirurgia, camici bianchi
dalle mani d’oro che con la loro fama e il loro talento riescono a far spostare
masse importanti di pazienti dalla Puglia verso altre regioni. Anche di questo
si nutre la mobilità passiva pugliese, flusso in uscita di pazienti che ogni
anno costa alle casse della Regione Puglia più di 200 milioni di euro. Secondo
il Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero in Italia, nel 2014 i
ricoveri fatti fuori dalla Puglia sono stati 39.615, pari all’8,1 per cento dei
ricoveri totali erogati. Dove vanno principalmente i pugliesi per farsi curare?
Lombardia (8.308 ricoveri), Emilia Romagna (7.641), Lazio (4.791). Non si tratta
di semplice turismo sanitario, ma di una reale ricerca dell’eccellenza nelle
cure. Ed è qui che intervengono i grandi professionisti del settore. Molti di
questi sono pugliesi, si sono formati nelle nostre università, poi hanno
lavorato all’estero per qualche anno e sono tornati in Italia. Anni di lavoro
tra i corridoi degli ospedali pubblici di Bari o Lecce, poi il salto nelle
cliniche private o private convenzionate. In questo modo riescono a creare un
bacino di pazienti considerevole, diventando “appetibili” per le grandi cliniche
del Nord. E quando decidono di trasferirsi per lavoro negli Irccs o nelle
cliniche del Centro- Nord, “portano via” un gran numero di pazienti pugliesi. Il
fenomeno è esteso. Nel centro nazionale di alta tecnologia dell’università di
Chieti-Pescara, diretta dal professore Leonardo Mastropasqua (originario di
Barletta), arrivano pazienti da tutta Italia. «Nella mia clinica facciamo 5800
operazioni all’anno, dalla cornea alla retina — conferma Mastropasqua — e il 60
per cento dei ricoveri è effettuato su pazienti provenienti da fuori regione,
molti pugliesi, attratti anche perché sono miei conterranei». Qualche centinaio
di chilometri più a nord, precisamente a Bergamo, c’è l’Irccs privato Humanitas.
Ed è qui che, dopo anni di lavoro in Puglia, è arrivato Giampiero Esposito,
cardiochirurgo salentino di fama internazionale. I suoi pazienti non lo hanno
abbandonato. Solo lo scorso anno su 528 ricoveri totali effettuati da Esposito,
130 riguardavano pazienti pugliesi: «Ma devo dire la verità — ammette Esposito —
mi dispiace molto vedere intere famiglie spostarsi insieme ai pazienti in cerca
di cure». Basta scendere un po’ più a sud, in Emilia Romagna, per trovare altri
pazienti pugliesi. Succede alla Casa di cura San Lorenzino di Cesena. Qui ogni
anno centinaia di pugliesi, spesso giovani sportivi, vengono a sottoporsi alle
cure di Antonio Rizzo, chirurgo ortopedico di origini salentine. «Molti pazienti
pugliesi che hanno problemi seri come la rottura del crociato — dice Rizzo, che
ha lavorato nel privato convenzionato pugliese — vengono qui da noi. L’anno
scorso lo hanno fatto in duecento circa». Ma quello dei grandi chirurghi
pugliesi che “portano via” pazienti dalla Puglia è solo uno dei motivi che
alimentano il fenomeno della mobilità passiva. Ora la Regione sta provando a
organizzare una strategia difensiva. L’idea è quella di consentire ai più grandi
ospedali di eccellenza di riportare i pugliesi a curarsi nella loro regione
anche attraverso premialità extra tetto. Un’idea che trova sostegno pure tra i
banchi dell’opposizione. È quello che pensa Luigi Manca, consigliere regionale
dei Conservatori e Riformisti: «Su questo fenomeno bisogna lavorare molto, anche
attraverso un aumento del tetto di spesa delle cliniche private accreditate
pugliesi. Solo così si possono sostenere le punte di eccellenza della nostra
sanità».
Mobilità Sanitaria, ecco come la Campania “foraggia” le casse
delle Regioni settentrionali. Rocco Corvaglia il 22
Aprile 2020 su anteprima24.it. Ieri sera è andato in onda, negli studi della
nota trasmissione televisiva “Porta a Porta“, il dibattito tra il governatore
della Regione Lombardia Attilio Fontana e il governatore
della Campania Vincenzo De Luca. Un “duello” atteso al pari di una finale
di Champions League, tra i due personaggi politici che – per ragioni opposte –
hanno saputo catalizzare l’attenzione pubblica in questo periodo di emergenza
sanitaria. Ora, è proprio da una dichiarazione di Attilio Fontana che vogliamo
partire. Qualche giorno fa, in risposta a una provocazione di De
Luca, Fontana sentenziava tronfio: “Noi non chiuderemo le porte ai campani che
si curano nei nostri ospedali“. Bene. Anzi, benissimo ci verrebbe da dire. Lo
slancio umanitario di un governatore leghista è sempre meritevole di
considerazione. Ma – cosa volete? – nell’ascoltare questa dichiarazione il tarlo
del dubbio si è impossessato di noi. Pertanto, abbiamo deciso di porci qualche
domanda. Banalmente: ha la Lombardia un qualche interesse economico ad
accogliere i cittadini campani nelle proprie strutture sanitarie? Ecco, la
risposta non la forniamo noi, ma il rapporto elaborato dalla “Fondazione GIMBE”
che si occupa da anni di monitorare lo stato di salute del Servizio Sanitario
Nazionale. Il Rapporto della Fondazione Gimbe (anno 2017) affronta il tema della
Mobilità Sanitaria nazionale (in sostanza, quanti pazienti si spostano da una
regione all’altra per usufruire di prestazioni sanitarie): “Dal punto di vista
economico, la mobilità attiva rappresenta per le Regioni una voce di credito,
mentre quella passiva una voce di debito; ogni anno la Regione che eroga la
prestazione viene rimborsata da quella di residenza del cittadino“. Di fatto, le
prestazioni sanitarie offerte dalle regioni che accolgono pazienti da altre
regioni vengono rimborsate dalle regioni nelle quali questi ultimi risiedono. Se
un cittadino campano si cura in Lombardia, alla Regione Campania toccherà
l’onere del rimborso. Nel 2017 il valore della mobilità sanitaria ammonta a €
4.578,5 milioni (oltre 4.5 miliardi di euro). Nella tabella di seguito i valori
in termini di crediti, debiti e saldi per le 19 Regioni e 2 Province autonome
per l’anno 2017 (fonte Fondazione GIBEM): Come si evince dalla Tabella,
la Campania presenta il peggior saldo con un passivo di oltre 320 milioni di
euro, mentre la Lombardia presenta un attivo per oltre 800 milioni di euro.
Di seguito una tabella che mostra la Mobilità Sanitaria Attiva,
che identifica le prestazioni erogate da ciascuna Regione per cittadini non
residenti: in termini di performance esprime il cosiddetto “indice di
attrazione” e in termini economici identifica i crediti esigibili da
ciascuna Regione:
Di converso una tabella che mostra la Mobilità sanitaria
passiva, che identifica le prestazioni erogate ai cittadini al di fuori
della Regione di residenza: in termini di performance esprime il cosiddetto
“indice di fuga” e in termini economici identifica i debiti di ciascuna Regione:
“Il valore della mobilità sanitaria regionale nel 2017 supera i € 4.578,5
milioni, una percentuale apparentemente contenuta (4%) della spesa sanitaria
totale (€ 113.131 milioni), ma che assume particolare rilevanza per tre ragioni
fondamentali. Innanzitutto, per l’impatto sull’equilibrio finanziario di alcune
Regioni, sia in saldo positivo (es. Lombardia + € 784 milioni), sia in saldo
negativo (es. Calabria -€ 281 milioni; Campania -€ 318); in secondo luogo, per
la dispersione di risorse pubbliche e private nelle Regioni con offerta carente
di servizi“, queste alcune delle conclusioni del Rapporto della Fondazione
GIMBE.
Senza voler incorrere in banali semplificazioni (appare evidente
che se vi è mobilità sanitaria ciò lo si deve, anche e soprattutto, alla
diversità – in termini di qualità – di prestazioni sanitarie offerte), il tema è
proprio quello di un riequilibrio complessivo della qualità del nostro Sistema
Sanitario Nazionale su tutto il territorio nazionale.
Se, come scriveva Barbara Gobbi dalle colonne del Il Sole 24
Ore “l’88% del saldo in attivo (chi riceve pazienti) va ad alimentare le casse
di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto – che sono anche le tre Regioni più avanti
nel processo di autonomia differenziata – mentre il 77% di quello passivo (chi
“esporta” pazienti) pesa su Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria e Campania”, è
chiaro che il sistema non può reggere e che forse le parole di Fontana non erano
animate solo da francescano spirito di solidarietà.
La Calabria è la Beirut dell’assistenza socio sanitaria.
Ettore Jorio, Università della Calabria, il 7 gennaio
2020 su quotidianosanita.it. Speranza cercasi in Calabria. Una ce l'ha regalata
la DDA di Catanzaro. L'altra è insita nel cognome dell'attuale ministro della
salute e, soprattutto, fondata sulla sua storia politica e la sua sensibilità
sul tema. Io ci credo, nonostante le debolezze dimostrate nel lasciare in
vigenza un provvedimento dagli effetti macabri. La Calabria ha chiuso il proprio
bilancio, quello del 2019. È più maledetto dei precedenti. Come ogni documento
«contabile» che si rispetti anche quello politico-istituzionale calabrese
rintraccia nei suoi saldi finali il valore del risultato. Il prodotto finale è
certamente da bancarotta, verosimilmente fraudolenta. A fronte delle «rimanenze
finali», invero mai state così precarie e pericolose per la popolazione, c'è
necessità di effettuare velocemente, nell'anno appena iniziato, un importante
«reso ai fornitori»: il decreto legge Grillo, convertito nella legge 60/2019.
Uno strumento legislativo che, a memoria d'uomo, non ha modo di rintracciare
uguale perniciosità sociale, da restituire pertanto al mittente. Esso ha
generato un autentico disastro per i calabresi, solo perché capricciosamente
voluto dalla allora ministra alla salute che, si spera, abbia a suo tempo agito
inconsapevolmente.
Le colpe e i rimedi elusi. L'anno appena trascorso è iniziato
male e finito peggio, così come meritava. I calabresi (gente onesta e
sofferente, compromessa dai ben noti!) sono finiti nel solito mirino della
solita peggiore ignominia, solo perché considerati come soggetti appartenenti
alla patria della 'ndrangheta e alla regione infiltrata nelle istituzioni e nei
ceti dominanti. Un bel regalo per i nostri giovani costretti a lavorare altrove.
Una responsabilità grave, la nostra, quella di non aver saputo generare, negli
anni che furono e che sono, gli anticorpi giusti per porvi rimedio. Per imporre
quel freno sociale e istituzionale che il fenomeno avrebbero meritato, man mano
che andava ad assumere l'attuale dimensione. Certamente un adempimento
collettivo molto difficile da concretizzare a causa dell'efficienza «aziendale»
del nemico e delle megarisorse a disposizione della 'ndrangheta. Basta, infatti,
constatare il proliferarsi ovunque di una siffatta organizzazione
delinquenziale, tale da rendere permeabile con la sua vis mafiosa qualsivoglia
organismo pubblico/privato e tutti i segmenti che costituiscono il Mercato. Da
qui, la certezza che la 'ndrangheta rappresenta un problema nazionale (e non
solo) con la conseguenza che le politiche governative devono essere improntate
alla depurazione del sistema, cominciando dalla Calabria, con la previsione di
importanti investimenti strutturali, sia in termini di bonifica che di
prevenzione.
Il catalogo dei princìpi. Meno male che quest'anno c'è stato il
giudice Nicola Gratteri e il gruppo dei bravi magistrati che gli collaborano
alla DDA di Catanzaro a lasciare la speranza sotto l'albero di Natale dei
calabresi. Essi non si sono resi solo autori di una importante retata ma hanno
somministrato a tutti noi una lezione dalla quale assumere il «catalogo» dei
nuovi principi e dei rinnovati canoni cui deve ispirarsi la società civile. Non
solo. Anche quelli cui deve attenersi il sistema istituzionale ed essere
improntato l'andamento della Pubblica amministrazione nostrana. In proposito,
spero proprio - da calabrese desideroso di investire sul futuro della propria
regione - che i candidati alle elezioni del prossimo 26 gennaio ne sappiano
approfittare, assumendo le nuove regole ad ispirazione, prima da parte di tutti
i competitor, della campagna elettorale e, poi per gli eletti, dell'esercizio
del mandato legislativo regionale!
Toccano alla politica i presupposti per la rinascita. Ritornando
alle «giacenze di magazzino», a risorgere dovrebbe essere soprattutto la sanità
che, dalle nostre parti, oltre ad essere terreno fertile per le consorterie di
ogni genere e grado, è fonte di disperazione, di morti colpevoli, di spreco di
danaro pubblico, del peggiore clientelismo ma soprattutto di insicurezza
sociale. Ivi, fanno gola i 320 milioni di euro di mobilità passiva, che la
Calabria regala al centro-nord (Lombardia in primis), in favore della quale,
pare, lavorino personaggi che eccellono molto di più nell'esercizio della
mediazione commerciale retribuita dai destinatari che in quello delle arti
mediche. Ivi, oggi più che mai attraggono gli incarichi extraregionali e le
conduzioni straordinarie delle aziende della salute (Asp, Ao e Aou),
caratterizzate da decenni da una malagestio da manuale e dall'assenza assoluta
dei controlli aziendali, regionali e commissariali. A tal proposito, risulta da
dieci anni inutile e costosissima la presenza degli advisor, nei confronti dei
quali si fa davvero fatica a giustificare l'inerzia di chi dovrebbe mandarli a
casa. Insomma in Calabria, tra sprechi vergognosi e incapacità, si registra una
inefficienza da scandalizzare chiunque. Basterebbe pensare che da queste parti
vengono ancora tollerate aziende sanitarie territoriali senza bilancio da anni,
altre sciolte per 'ndrangheta, aziende ospedaliere che, pare, non esercitino il
pronto soccorso e chiudano nei week-end. Tutto questo nonostante dieci anni di
commissariamento ad acta, che si sta svendendo la pelle dei calabresi anche
attraverso pratiche occupazionali orride e gestite nel peggiore cinismo verso il
fabbisogno epidemiologico e sociale, che (audite!) mai nessuno ha rilevato.
Peccato non aver usato la scopa della Befana per spazzare via il
decreto Grillo. A tutto questo ha ampiamente contribuito il decreto
salva-Calabria, vero campione di sadismo certificato, che a distanza di
otto/nove mesi impone la conta dei saldi, con le partite in dare che non provano
alcun apporto migliorativo e quelle in avere che registrano danni irreversibili
alle persone e al sistema, destinati sensibilmente a crescere! Insomma, un
provvedimento così cinico e un risultato così aberrante sarebbero stati ovunque
improponibili e assolutamente non tollerati dalla società civile, certamente
produttivi di dimostrazioni pubbliche ad elevatissima partecipazione sociale.
Avrebbero meritato altro che sardine! In Calabria nulla, nonostante
l'incredibile prodotto generato a sfavore dell'utenza, finanche demolitivo di
quel poco che c'era. Neppure nei programmi dei candidati alle elezioni regionali
del 26 gennaio prossimo c'è la proposta della benché minima soluzione. Tutto
scorre come se qui ci fosse l'assistenza sanitaria della Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna, Toscana ecc.Per non parlare dell'assistenza sociale
ulteriormente affossata da un improvvido e improvvisato regolamento approvato
dalla Giunta regionale uscente che metterà al tappeto imprese del settore, che a
fatica sbarcano il lunario aziendale, e famiglie con persone disabili e
caratterizzate da fragilità psico-fisiche.
La Calabria è la Beirut dell'assistenza socio sanitaria.
L'inventario di fine anno. Tre aziende ospedaliere della quali, per il momento,
soltanto una con una manager ufficiale concretamente preposta alla direzione di
una Ao (Cosenza) e due mandate avanti alla bene meglio da esponenti della
burocrazia interna, che hanno campicchiato tra una dimissione e l'altra.
Un'azienda ospedaliera universitaria senza testa né coda ovverosia senza manager
e impegnata in un molto creativo percorso di integrazione, "interpretativo" di
una procedura di fusione che non c'è con l'azienda ospedaliera operante nel
territorio cittadino di Catanzaro. Cinque aziende territoriali provinciali delle
quali nessuna gestita sino ad oggi da manager nominati, atteso che ci vorrà
ancora qualche giorno perché si insedino quelli individuati a circa un anno
dalla loro previsione normativa. Due aziende territoriali (l'Asp di Reggio
Calabria e quella di Catanzaro) sciolte per infiltrazione/condizionamento
mafioso, ex artt. 143 e 146 Tuel ed entrambe "fantasiosamente" dichiarate in
dissesto, ex art. 244 Tuel e seguenti, con qualcun'altra destinata più che
verosimilmente a seguire la medesima (assurda) sorte. Una novità in assoluto in
diritto, quest'ultima, intendendo per tale il superamento (incostituzionale) di
quell'autonomia riconosciuta alla Regione dalla Carta, atteso che le aziende
sanitarie in default obbligano le Regioni di appartenenza al risanamento dei
loro bilanci, a partire dalla copertura delle loro perdite annue sino ad
arrivare al ripianamento dei deficit patrimoniali prodotti. Un dovere
ineludibile e una prassi peraltro evidenziabile dal pagamento del rateo annuo di
circa 31 milioni di euro del mutuo a suo tempo contratto a fronte del debito
pregresso contabilizzato al 2009 dal Commissariamento di protezione civile
all'epoca attivo. E ancora. I danni sono tendenzialmente in crescita per
incapacità gestionale di preposti a generare la programmazione del cambiamento.
L'attuale improvvisata governance commissariale sta facendo, infatti, di peggio
di quanto si faceva prima del suo insediamento, che rappresentava il massimo del
deterioramento progressivo del servizio. L'ultima vicenda è il segno evidente
dell'assenza totale di una saggia pianificazione degli investimenti che
sottolinea la mancanza di una idea complessiva di organizzazione della salute
che si ha il dovere costituzionale di rendere ivi efficiente ed efficace come
altrove. A fronte di programmazione di spesa delle risorse ex art. 20 legge
67/1988, finalizzate all'acquisizione di tecnologie rafforzative delle
eccellenze operanti in Calabria (tra tutte, in contrapposizione ad una
programmazione aziendale tendente a consolidare quelle già rese dall'AO di
Cosenza, gli stop: all'acquisizione di una risonanza magnetica di tipo 3Tesla da
rendere disponibile alla neuroradiologia interventistica di assoluto
riconosciuto pregio nazionale; all'acquisto del robot chirurgico Leonardo da
Vinci da «consegnare» alla urologia e alla chirurgia toracica di altrettanto
indiscusso valore professionale, attività peraltro segnatamente impattanti
positivamente avverso l'enorme mobilità passiva di settore che impoverisce
annualmente il Ssr), si è pensato di disperdere le relative risorse
distribuendole a pioggia nei diversi presidi spock e di conseguenze renderle di
fatto improduttive di erogazione qualificata di assistenza.
Tante le aspettative, sino ad oggi deluse. Speranza cercasi in
Calabria. Una ce l'ha regalata la DDA di Catanzaro. L'altra è insita nel cognome
dell'attuale ministro della salute e, soprattutto, fondata sulla sua storia
politica e la sua sensibilità sul tema. Io ci credo, nonostante le debolezze
dimostrate nel lasciare in vigenza un provvedimento dagli effetti macabri.
L'augurio è anche quello che la Calabria riesca a trovare un/una Presidente
della Regione capace di esercitare la riscossa e materializzare il rinascimento
di una terra che ha ormai capitalizzato un credito di civiltà così alto da
apparire difficile da essere riscosso nonché il risarcimento dei drammi
sopportati da una società generalmente impoverita.
TURISMO
SANITARIO. I PAZIENTI CON LA VALIGIA SPOSTANO 4,6 MILIARDI DI EURO DA SUD A
NORD.
Barbara Gobbi per amp.ilsole24ore.com il 31 Luglio 2019. Le Regioni del Nord
come una calamita per il Sud Italia. La mobilità sanitaria, il fenomeno dei
pazienti con la valigia in cerca di assistenza migliore che muove ogni anno
circa un milione di malati più i familiari, si traduce in un fiume di denaro
pari nel 2017 a 4,6 miliardi di euro, certificati dalla Conferenza delle Regioni
nei mesi scorsi previa compensazione dei saldi. E il flusso ha una direzione
chiara: l’88% del saldo in attivo (chi riceve pazienti) va ad alimentare le
casse di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto – che sono anche le tre Regioni più
avanti nel processo di autonomia differenziata - mentre il 77% di quello passivo
(chi “esporta” pazienti) pesa su Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria e Campania. Un
quadro che racchiude sfaccettature fisiologiche ma anche patologiche, imputabili
alle liste d’attesa o alla scarsa qualità dell'assistenza nelle Regioni di
partenza, da cui riesce a “fuggire” per curarsi solo chi può permetterselo. A
fare il punto è la Fondazione Gimbe: «Abbiamo analizzato – spiega il presidente
Nino Cartabellotta – esclusivamente i dati economici della mobilità sanitaria
aggregati in crediti, debiti e relativi saldi, in attesa di ottenere il
prospetto dei flussi integrali trasmessi dalle Regioni al ministero della
Salute, che permetterebbero di analizzare la distribuzione delle tipologie di
prestazioni erogate in mobilità, la differente capacità di attrazione del
pubblico e del privato e la Regione di residenza dei cittadini si curano fuori
casa». Elementi fondamentali per scovare il «lato oscuro» della mobilità
sanitaria e su cui non a caso indagherà il Patto per la salute in via di
definizione tra governo e Regioni. Perché il fenomeno è la cartina di tornasole
di un'Italia delle cure spaccata in due, dove troppo spesso si emigra in assenza
di alternative valide nella propria realtà. E «in tempi di regionalismo
differenziato – avvisa Cartabellotta – il report Gimbe non solo dimostra che il
flusso di denaro scorre prevalentemente da Sud a Nord, ma che anche se la bozza
di Patto per la Salute prevede misure per migliorare la governance,
difficilmente la fuga in avanti delle tre Regioni che cumulano l'88% del saldo
attivo potrà ridurre l'impatto di un fenomeno dalle enormi implicazioni
sanitarie, sociali, etiche ed economiche».
Sei Regioni
vantano crediti superiori a 200 milioni di euro (mobilità attiva): in testa
Lombardia (25,5%) ed Emilia Romagna (12,6%) che insieme contribuiscono ad oltre
1/3 della mobilità attiva. Un ulteriore 29,2% viene attratto da Veneto (8,6%),
Lazio (7,8%), Toscana (7,5%) e Piemonte (5,2%). Il rimanente 32,7% della
mobilità attiva si distribuisce nelle altre 15 Regioni, oltre che all'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (217,4 milioni di euro) e all'Associazione dei Cavalieri
di Malta (39,7 milioni).
Le 6 Regioni
con maggiore indice di fuga (mobilità passiva) generano debiti per oltre 300
milioni: in testa Lazio (13,2%) e Campania (10,3%) che insieme contribuiscono a
circa 1/4 della mobilità passiva; un ulteriore 28,5% riguarda Lombardia (7,9%),
Puglia (7,4%), Calabria (6,7%), Sicilia (6,5%).
Il restante
48% si distribuisce nelle altre 15 Regioni. Le differenze Nord-Sud risultano più
sfumate quando si guarda al passivo: gli indici di fuga, alti in quasi tutte le
Regioni del Sud, sono rilevanti anche al Nord grazie alla facilità di
spostamento dei cittadini. In Lombardia si arriva a -362,3 milioni di euro, in
Piemonte a -284,9 milioni, in Emilia Romagna a -276 milioni, in Veneto a -256,6
milioni e in Toscana a -205,3 milioni.
Le Regioni con
saldo positivo superiore a 100 milioni di euro sono tutte del Nord, quelle con
saldo negativo maggiore di 100 milioni tutte del Centro-Sud. In particolare: in
Lombardia il saldo è pari a 784,1 milioni, in Emilia Romagna a 307,5 milioni, in
Veneto a 143,1 milioni e in Toscana a 139,3 milioni. Saldo negativo rilevante
per Puglia (-201,3 milioni di euro), Sicilia (-236,9 milioni), Lazio (-239,4
milioni), Calabria (-281,1 milioni), Campania (-318 milioni)
INIQUITÀ E MOBILITÀ SANITARIA.
Ambrogio Carpentieri, Antonio Milici, Giuseppe (Josè) Galiero, Marcello
Fulgione, Francesco Carbone, Antonio Marsiglia, Elio de Lorenzis, Pippo
Satriano, Commissione Sanità ET-M24A, il 02.05.2020 su Movimento 24 Agosto. La
mobilità sanitaria annuale dovuta a cittadini meridionali che vanno a curarsi al
Nord ha spostato soprattutto nelle casse di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
4,6miliardi di euro che vanno a sommarsi ai 4 miliardi di euro che annualmente
sono sottratti al Sud per una iniqua distribuzione dei fondi. Di conseguenza,
pur avendo una Sanità di eccellenza, le Regioni meridionali sono costrette ad
offrire una assistenza in mancanza di 100.000 medici e operatori sanitari e
nella situazione carente di 2 posti letto contro gli 8 posti letto per 1000
abitanti negli ospedali del Nord. Eppure i Centri di Eccellenza del Sud sono
particolarmente attivi. Basti pensare agli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati come:
Oncologia: Istituto nazionale tumori Fondazione G. Pascale –
Napoli
Gastroenterologia: Ente ospedaliero S. De Bellis – Castellana
Grotte (BA)
Oncologia: Istituto Tumori Giovanni Paolo II - Bari
Oncologia: CROB Centro di riferimento oncologico della Basilicata
– Rionero in Vulture (PZ)
Neuroscienze: Centro Neurolesi Bonino Pulejo – Messina
Neuroscienze: Istituto neurologico mediterraneo Neuromed –
Pozzilli (IS)
Diagnostica: SDN Istituto di ricerca diagnostica e nucleare –
Napoli
Genetica: Ospedale Casa sollievo della sofferenza – San Giovanni
Rotondo (FG)
Insufficienze terminali d'organo: ISMETT Istituto mediterraneo
per i trapianti e terapie ad alta specializzazione – Palermo
Ritardo mentale: Oasi di Maria santissima – Troina (EN)
In Italia esistono 49 Irccs di cui 21 pubblici e 28 privati. Solo
5+5 sono localizzati al Sud e nessuno in Sardegna, Abruzzo e Calabria. In tali
casi è auspicabile un polo oculistico in Sardegna, un polo pediatrico in
Calabria e un centro per le malattie immunitarie in Abruzzo. Da evidenziare
anche la mancanza della Facoltà di Medicina e chirurgia presso la Università
della Basilicata. Ma i centri di Eccellenza non si limitano agli Irccs
trattandosi di Ospedali specializzati in grado di affrontare prestazioni ad alta
complessità che richiedono sicurezza e realizzano una condizione favorevole
all'efficacia dei risultati. Basti pensare per esempio al Monaldi ad indirizzo
cardio-pneumologico o al Cotugno di Napoli ad indirizzo infettivologico o il DCA
di Chiaromonte (PZ) per i disturbi del comportamento alimentare e del peso. Il
concetto di EvidencedBasedMedicine oramai è surclassato dal ValueBM dove per
Valore si intende non certo una entità astratta o una parola in codice per
indicare tagli finanziari ma rappresenta l'unità di misura più concreta e
innovativa per guidare le strategie organizzative e le politiche sanitarie del
terzo millennio, perchè mette in relazione diretta i risultati ottenuti
dall'assistenza sanitaria (efficacia, sicurezza) con le risorse utilizzate
(efficienza). (Gimbe) La organizzazione sanitaria, secondo cui tali Centri
dovrebbero lavorare con i Presidi ospedalieri della “periferia” fondamentali per
la cura e assistenza in prossimità dei cittadini, è la modalità della rete
articolata in hub e spoke. Le Reti nascono quando nei sistemi aumentano le
interazioni e si aprono opportunità per rendere più conveniente la
collaborazione rispetto alla competizione. Tale modello organizzativo si è reso
indispensabile in sanità per la crescente complessità dei percorsi di cura che
difficilmente possono trovare risposte in un'unica struttura. Favorisce un
accesso equo e tempestivo del malato diffuso su tutto il territorio, concentra
esperienze professionali e tecnologie nelle sedi opportune, migliora la
circolazione del know how con il riconoscimento delle vere dalle false
innovazioni, è in grado di monitorare la qualità delle prestazioni erogate,
rende possibile al paziente una scelta informata e consapevole dei Centri di
Riferimento. La iniquità sanitaria particolarmente vissuta al Sud, secondo
quanto disse Francesco II partendo da Gaeta il 14 febbraio 1861 al comandante
Vincenzo Criscuolo: “Ai Napoletani non lasceranno neanche gli occhi per
piangere”, va contrastata non in termini di profitto (che danni incommensurabili
ha fatto al Nord) ma in termini di partecipazione alla creazione di salute.
LA SCHEDA O IL FUCILE. Di Salvatore
Domenico Bevilacqua M24A Spagna. Pubblicato da Michele Di Pace il 02.05.2020 su
Movimento 24 Agosto. Il 3 di aprile del 1964 davanti ad una folla ammutolita
Malcom X incitava tutta la fratellanza afroamericana con il mítico discorso La
scheda o il Fucile. Il fulcro dell’oratoria era una analisi sulla possibile
rivolta della nazione negra e le conseguenze della stessa. Malcom X citava gli
altri attivisti afroamericani e affermava che nonostante avessero differenze
sostanziali nel come la comunità dovesse identificarsi nella società, il momento
richiedeva unità . Non importa se siete colti o analfabeti, se abitate in zone
eleganti o nel ghetto, siete anche voi in questo inferno, proprio come me. Siamo
tutti nelle stesse condizioni e tutti dovremo vivere nello stesso inferno che ha
organizzato per noi lo stesso uomo. Quell'uomo è il bianco e tutti noi abbiamo
sofferto qui, in questo paese, l'oppressione politica, lo sfruttamento
economico, la degradazione sociale ad opera dell'uomo bianco. Il dire queste
cose non significa che siamo contro i bianchi come tali, ma contro lo
sfruttamento, contro la degradazione e contro l'oppressione. (Malcom X) Esiste
una incredibile analogia, nel 1964 il discorso veniva rivolto a una comunità di
22000000 di persone, tante quante siamo oggi noi TERRONI. Esiste un passaggio di
quel mítico discorso che urlato oggi da un palco alla nostra platea calzerebbe a
pennello: “A questo punto vorrei fermarmi per sottolineare una cosa. Cercate di
capire che quando volete ottenere ciò che vi appartiene, chiunque vi privi di
tale diritto è un criminale. Quando volete ottenere ciò che è vostro, siete nel
pieno diritto di esigerlo e chiunque cerca di privarvene infrange la legge ed è
un criminale.” (Malcom X). Oramai tutti sappiamo che lo stato ogni anno ci da
meno di quello che ci spetta, ci toglie invece di darci, lo dicono quelli della
SVIMEZ,EURISPES, giornalisti, ricercatori, attivisti, etc… ogni anno 65 miliardi
di euro che ci servirebbero per i nostri figli, i nostri padri ci vengono tolti.
La nostra terra viene volontariamente abbandonata per farcela abbandonare, ma
noi siamo in tanti e loro lo sanno, siamo 22000000 di persone, tre volte il
Portogallo, tanti come la Svezia, Danimarca e Norvegia assieme, 3 volte l’Olanda
e non abbiamo neanche treni che ci uniscono in tempi decenti, strade che ci
facciano incontrare e lo sapete perchè? Ci vogliono divisi!!!!! Uniti facciamo
paura!!!! Sorelle e Fratelli meridionali il cambio è lento e alle volte doloroso
per quelli che veramente lo cercano e per questo che in questo viaggio dobbiamo
imbarcarci tutti assieme e cercare il valore e la forza nella compagna e
compagno di fianco a noi. Quello che in cui possiamo fare unicamente affidamento
è la nostra fratellanza ,la nostra nazione. Nessuno ci dirà mai che il viaggio
sarà corto, lungo o doloroso, però sappiamo che il camino sarà illuminato,
perché il popolo sarà la luce del camino. Per fare un popolo ci vuole il tempo e
quello ne abbiamo di più che tanti altri, sono quasi 1000 anni che viviamo
assieme. Per fare un popolo ci vuole il sangue e di sangue ne abbiamo versato
tanto e oggi più che mai sappiamo che non fu invano. Il sangue è quello che ci
vogliono togliere lentamente, separando figli dai padri, fratelli dalle sorelle,
amici dagli amici ,amori dagli amori, perché il sangue serve da sfruttare in
un'altra parte di questa penisola. Non si tratta più di una lotta di classe, non
si tratta più di rivendicare diritti social, si tratta di una oppressione ad un
intero popolo, il nostro. Catalani, Baschi, Scozzesi riescono ad ottenere
risultati nelle lotte ai propri diritti sociali, perché? Perchè lo rivendicano
come popolo ,lo rivendicano tutti assieme. Dobbiamo finalmente capire che
assieme siamo un popolo ,separati siamo la regione più povera d'Europa, assieme
siamo 22000000 di persone, soli siamo povera gente. Salvatore Domenico
Bevilacqua M24A Spagna
Coronavirus, Feltri: «Santelli dice che se non si riapre
arriva la 'ndrangheta? Non se ne è mai andata». Il
Quotidiano del Sud il 2 maggio 2020. Lo scorso giovedì 30 aprile la governatrice
della Calabria Jole Santelli aveva sottolineato in collegamento con “La Vita in
diretta” su Rai 1 la necessità di partire al più presto con la fase 2, per
scongiurare un’avanzata della criminalità organizzata. Una difesa della discussa
ordinanza firmata qualche ora prima), in netto contrasto con le disposizioni del
governo nazionale sul contenimento del contagio da coronavirus. Tra le reazioni
si registra quella di Vittorio Feltri, che ha commentato così su Twitter le
parole della presidente di Regione: Jole Santelli, governatrice della Calabria
avverte: “se restiamo fermi arriva la ‘Ndrangheta”. Non si preoccupi: é già
arrivata, anzi non se ne è mai andata. 10:49 - 2 mag 2020. Risale a pochi giorni
fa la polemica che ha visto protagonista il giornalista lombardo a causa delle
sue parole contro i meridionali che scatenarono la reazione indignata di tanti
cittadini calabresi.
CARO FELTRI, TI RACCONTO LA NOSTRA STORIA E TI INVITO IN
CALABRIA PER DIMOSTRARTI CHI È DAVVERO INFERIORE. Di
Francesco Patrizio Lapietra. Pubblicato da Raffaele Vescera il 30.04.2020 su
Movimento 24 Agosto. Dopo aver sentito le ignobili e gratuite offese al popolo
meridionale, non me la sono sentita a far finta di nulla e tacere. È d’obbligo
mettere mano alla tastiera del pc e urlare tutta la mia indignazione quando, per
la ennesima volta, Vittorio Feltri si permettere di offendere il mio popolo.
Andando ai fatti, il giornalista Feltri, ospite della trasmissione televisiva su
Rete 4 Fuori dal coro, dopo aver prima rinfacciato che 14mila malati oncologici
campani vengono curati in Lombardia, si lancia in una esternazione lombrosiana
dicendo che «i meridionali, in molti casi, sono inferiori a quelli del nord», il
tutto alla presenza di un giornalista, Mario Giordano, a tratti compiacente, che
con il sorriso sulle labbra si è solo limitato ad accennare un minimo di
rimprovero di circostanza al suo collega. Feltri, non pago di quanto avesse
detto, quando Giordano gli rammenta che qualche meridionale avrebbe potuto
prendersela a male per le espressioni utilizzate, questi infierisce dicendo «chi
se ne frega». Mi sono domandato se fosse stato giusto adottare indifferenza nei
confronti dell’offesa perpetrata ai danni di noi meridionali in diretta
nazionale. La risposta che mi sono data è che non si può e non si deve più
chinare il capo. Il sottoscritto è un meridionale, fiero ed orgoglioso di
esserlo, il quale ha studiato e si è formato nella sua terra superando le
difficoltà, non poche, che ogni giorno ci vengono dal nostro Sud depauperato e
umiliato. Premesso che, come ho detto tante altre volte, il Sud oggi è
impoverito dalla criminalità organizzata e dalla mala gestione politica che va
di pari passo con il malaffare, è altrettanto doveroso non dimenticare chi siamo
stati, cosa abbiamo fatto e capire il perché della arretratezza odierna.
CHI SONO DAVVERO I MERIDIONALI. Visto che il Feltri è molto
perspicace nel capire le cose, vorrei ricordargli quando e quanto i meridionali
erano inferiori. Un tempo, se non vado errato su taluni testi è riportato che,
esisteva una certa Magna Graecia, culla di cultura filosofica, arte,
letteratura, scienza medica. Nell’attuale zona del Catanzarese, pare vi fosse
una popolazione denominata “italioti” e che, da questi derivi il nome della
nostra penisola. Nell’attuale Crotone (Kroton) si dice che predicasse un
certo Pitagora, dicono che sia stato un matematico e un filosofo scopritore di
alcune cose che ancora oggi sono utili alla umanità. Alcuni hanno, tra l’altro,
l’ardire di dire che i l’Impero Romano conquistò la Grecia (e la Magna Graecia)
con la forza delle armi ma, Roma – popolo di guerrieri e pastori – imparò e
trasfuse a sé tutto dalla cultura greca. La Democrazia, quella nata da Pericle
in avanti, è frutto della inferiorità delle popolazioni meridionali della Magna
Grecia. Per arrivare ad una storia un po’ meno remota, il nostro popolo era
assai inferiore, arretrato, povero ed incolto.
Ecco, allora, quanto noi terroni eravamo inferiori, su alcune
cose: prima cattedra di astronomia in Italia (1735), prima cattedra di economia
al mondo; primo cimitero in Italia per inumare i poveri (1763); primo codice
marittimo al modo (1781); primo intervento di profilassi anti tubercolosi in
Italia (1782); prima assegnazione di case popolari in Italia (1789- San leuco,
Caserta); prima istituzione di assistenza sanitaria gratuita (1789); prima
scuola di ballo in Italia (1812); primo istituto per sordomuti in Italia (1835);
primo tratto ferroviario in Italia (1839- Napoli, Portici); Napoli prima
illuminazione a gas in una città italiana, terza in Europa dopo Londra e Parigi
(1839); prima fabbrica metalmeccanica in Italia per numero di assunti (1839
Pietrarsa); primo centro sismologico in Italia (1840) e primo sismografo (1856);
primo telegrafo elettrico (1852); prima luce elettrica (1852 Capodimonte); più
grande industria navale in Italia (1860); prima della unificazione il
mezzogiorno era il primo in Italia per numero di orfanotrofi e ospizi, collegi,
centri di formazione, conservatori musicali, nel 1860 il sud varò il primo piano
regolatore in Italia e, Napoli fu la prima città al mondo a portare l’acqua
corrente nelle case; Mongiana, in Calabria, era il primo complesso siderurgico
in Italia; nel 1860 si aveva ala più alta percentuale di medici per numero di
abitanti e il più basso tasso di analfabetismo , mortalità infantile in Italia,
indici di benessere e di sviluppo.
Ragionando in termini economici, il sud aveva la migliore finanza
pubblica in Italia, con la più alta rendita dei titolo di Stato pari al 120%
(1860 Borsa di Parigi) e, il minor carico tributario erariale in Europa.
Non dobbiamo dimenticarci che il meridione, all’atto
dell’annessione possedeva il 65,7% di tutte le monete circolanti in Italia, più
di tutti gli altri Stati pre unitari messi insieme (fonte tratta dal saggio
“Nord e Sud” di Francesco Saverio Nitti).
Premesso che in alcun modo deve essere messa in discussione
l’Unità della nostra Nazione, non si può e non si deve infangare il meridione
con aggettivi non degni di un paese civile.
La storia chi ha consegnato pensieri abominevoli che per forza di
cose ci hanno resi volutamente, inferiori, basti pensare a quanto affermato
da Carlo Bombrini (Governatore della Banca Nazionale del Regno d’Italia dal 1861
al 1882) il quale asserì che «i meridionali non dovranno mai essere più in grado
di intraprendere». Una ferita altrettanto indimenticabile fu quanto detto dal
Generale e Senatore del Regno Enrico Cialdini, che con impavido disprezzo cosi
affermò:«Li voglio tutti morti! questi terroni sono tutti africani e contadini.
A morte i nemici del Piemonte, dei Savoia, dei Bersaglieri e del mondo intero.
Non vogliamo testimoni, diremo che sono stati briganti».
ANCHE IN QUESTO PERIODO DI PANDEMIA dal meridione, è iniziata
la sperimentazione del farmaco anti artrite contro la polmonite da Covid-19 che,
ha prodotto ottimi risultati ed è stato inserito nei protocolli farmaceutici. A
dare inizio a questa sperimentazione è stato l’acume e la scienza del Dottore
Paolo Ascierto, direttore dell’unità di oncologia e terapie innovative
dell’istituto tumori Pascale di Napoli. Il Dottore Ascierto dopo i primi
interventi in lacune dirette televisive per la sua scoperta che ha salvato,
certamente, molte vite, ora i media di “regime” non ne fanno più accenno.
POSSIBILE DANNO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI. Ritornando al caso
Feltri, pare che nelle ultime ore il presidente dell’ordine dei giornalisti
abbia deciso di procedere legalmente contro questi per valutare il danno di
immagine all’Ordine stesso. Pare, che lo stesso Ordine stia puntando il dito
anche contro Giordano, puntualizzando che questi avesse l’obbligo di intervenire
nel momento dello sproloquio riprendendo Feltri. Sembra che anche il presidente
dell’ordine della Lombardia, voglia trasmettere al consiglio di disciplina
quanto accaduto. Nei prossimi giorni sapremo cosa succederà, professionalmente,
a Feltri. Immediata, invece, è stata la reazione di molti edicolanti del sud che
hanno deciso di non vendere il giornale Libero diretto da Feltri, in alcuni casi
le edicole hanno affisso delle vere e proprie locandine in cui si dice che i
meridionali essendo inferiori non sono in grado di comprendere gli articoli
contenenti nello stesso giornale. Noi giovani generazioni, siamo consci della
nostra storia, di cui ne andiamo orgogliosi perché, chi non conosce il proprio
passato e non ne fa tesoro non potrà mai capire il presente ed il futuro.
Nessuno deve arrogarsi il diritto di reputarci inferiori perché non lo siamo mai
stati e né mai lo saremo. Siamo solo consapevoli di una cosa, che alcune,
pochissime, menti del Nord che, purtroppo, godono di una penna e di una cassa di
risonanza ignorando la storia del loro Paese infangano ed offendono gli altri.
Se c’è qualcuno che è in debito con qualcun’altro, di certo quel qualcuno non
siamo noi meridionali perché, abbiamo pagato (24 milioni di emigrati) e paghiamo
(80mila nuove emigrazioni l’anno di laureati) un prezzo salatissimo. Sono del
parere che alle offese si risponde con gentilezza e con la propria storia.
LA STORIA DEVE ESSERE MAESTRA DI VITA per non ricadere in errore,
in questo caso, noi meridionali non dimenticheremo mai da dove proveniamo e chi
erano i nostri avi. Sarò lieto, dopo aver chiesto venia (ovviamente),
di invitare personalmente il Dottore Feltri a far visita alla nostra
Calabria cosi da potersi rendere conto chi tra lui e la storia, la cultura,
l’arte del mezzogiorno sia realmente l’inferiore…in molti casi.
Dichiarazioni Feltri, Wanda Ferro: “Tra delirio e falso storico”.
I due pazienti di Bergamo guariti a Catanzaro sono stati un momento di
commozione e verità. Redazione catanzaroinforma.it il 22 Aprile 2020. «Le
considerazioni di Vittorio Feltri sulla presunta inferiorità dei meridionali non
meritano commento, tanto sono stupide e deliranti, così come le farneticazioni
secondo cui qualcuno avrebbe gioito per l’ecatombe causata dal coronavirus in
Lombardia. Non è neppure il caso di ribadire quante siano le eccellenze
calabresi – e meridionali – nei più svariati campi delle professioni, della
cultura, delle arti, della ricerca, del giornalismo: non abbiamo complessi di
inferiorità che ci spingono a rivendicare il riconoscimento del nostro valore».
E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che prosegue:
«Meritano invece una replica, anche perché rappresentano una narrazione molto
diffusa, le considerazioni secondo le quali i meridionali scelgono di curarsi
nelle strutture sanitarie del Nord perché più “rassicuranti”, come dice Feltri,
o comunque più valide o efficienti. Questo è solo un racconto parziale della
realtà, perché è vero che molti pazienti calabresi, ad esempio, sono costretti a
rivolgersi alle strutture del nord per farsi curare, ma questo non avviene certo
per la mancanza di medici di grande competenza e professionalità – sanno tutti
che moltissimi dei luminari che guidano le strutture di eccellenza del nord sono
meridionali – o per la situazione disastrata di alcune strutture sanitarie
depredate dalle inefficienze, dal malaffare e dalla ‘ndrangheta, che continuano
ad arricchire giustamente i reportage televisivi. Ma anche quella è solo una
parte della realtà, perché in Calabria ci sono tantissime strutture
d’eccellenza, nella sanità pubblica e in quella privata, con dotazioni
strutturali efficienti, a volte all’avanguardia, e che soprattutto possono
contare su risorse professionali di straordinario valore. La guarigione dal
coronavirus di due pazienti lombardi curati a Catanzaro è stato un momento
emozionante, ma in fondo solo una delle infinite pagine di buona sanità che i
medici e gli operatori sanitari che hanno scelto di restare in Calabria
continuano a scrivere ogni giorno, anche operando in condizioni difficili. Il
vero problema è proprio il circolo vizioso dell’emigrazione sanitaria, che
sottrae al Sud risorse che potrebbero essere investite nel potenziamento delle
strutture, e che invece continua a ingrossare i bilanci delle regioni del Nord
con risorse che vengono così investite nei sistemi sanitari che continueranno
così a richiamare pazienti meridionali e così via. Il bisogno di salute del Sud,
quindi, è usato come un bancomat dalle regioni settentrionali, che per decenni
hanno costruito e retto i propri sistemi di eccellenza proprio sulla mobilità
sanitaria interregionale. Che la sanità meridionale non sia capace di dare cure
di elevato livello è un falso storico, un racconto che serve proprio ad
alimentare il sentimento di sfiducia nei cittadini, che si trasforma in un fiume
di risorse che in maniera ormai strutturale passa da Sud a Nord, depauperando i
sistemi sanitari delle regioni meridionali per consentire a quelli
settentrionali di dotarsi delle strutture a cinque stelle di cui parla Feltri.
E’ giusto raccontare il marcio che si annida in tanti gangli della sanità
meridionale, ma è giusto dire che quella è solo una parte del racconto, e non
può essere il pretesto per sfuggire alla responsabilità dei governi nazionali
dopo anni di tagli alle risorse e commissariamenti che non hanno raggiunto
l’obiettivo di migliorare i livelli di assistenza, e soprattutto per sottrarsi
al dovere di destinare al Sud gli stessi investimenti che vengono da sempre
indirizzati, copiosi, al Nord. Per fare della sanità meridionale una realtà
“rassicurante” e spezzare finalmente la catena della migrazione sanitaria».
Non è l'Arena, le Sardine contro Massimo Giletti:
"Trasmissione contro il Sud e in difesa della Lombardia".
Libero Quotidiano il 20 aprile 2020. Le Sardine sono sempre ben
liete di comparire in tv - soprattutto in un periodo in cui sono irrilevanti
politicamente - non importa che sia una puntata di Amici di Maria De Filippi o
di Non è l’arena. Alla trasmissione della domenica sera di La7 ha preso
parte Jasmine Cristallo, una delle esponenti di punta del movimento ittico, che
però non è parso molto grato a Massimo Giletti per l'ospitata in prima serata.
“Non avremmo voluto essere interrotti su Tina Anselmi - frignano le Sardine sui
social - partigiana e primo ministro donna che sulla sanità molto ha fatto. Né
avremmo voluto ascoltare una trasmissione contro gli ospedali del Sud, tacendo
invece le responsabilità della Lombardia. Ma questo è Giletti”. La prossima
volta allora i pesciolini possono gentilmente declinare l’invito, se non aggrada
loro la discussione prevista in trasmissione.
Giletti fa il giustiziere fazioso e getta ancora fango sul
sud. Claudio Marincola il 31 marzo 2020 su Il
Quotidiano del Sud. Chi lo conosce lo evita. Ma se proprio non ci riuscite e
incappate nel suo programma fatelo proteggendovi, tipo mascherina, e comunque a
vostro rischio e pericolo. Lui è Massimo Giletti, già da tempo caparbio
testimone di sé stesso, ostinato Torquemada da salotto. Il suo programma si
chiama “Non è L’Arena” e va in onda la domenica sera su La7, un clone rivisitato
e corretto del vecchio format targato Rai. In questi giorni in cui le tv di casa
si surriscaldano con facilità, anche lui, Giletti, è salito di qualche decibel.
Il suo pezzo forte sono le “inchieste” sul Sud, un Sud che dipinge sempre allo
stesso modo. Terra di malaffare, ‘ndrangheta, camorra, mafia. Insomma, tutte
queste cose che sappiamo benissimo anche da soli e che vorremmo estirpare sia
nel Mezzogiorno che altrove. Più le immagini si fanno crude, più la sua
espressione rivela sofferenza, patimento. E sì, il Sud gli procura un consumo di
succhi gastrici sempre molto elevato. Anche in queste ore drammatiche in cui Il
Nord, compreso il suo Piemonte, gli offrirebbe materiale in abbondanza, Giletti
si esibisce nella specialità della casa. Puntare i riflettori sul Mezzogiorno.
Prima mette le mani avanti, «lo faccio con lo spirito di chi fa servizio
pubblico». Un talk style alla Funari ma senza le sue battute tranchant: l’indice
puntato, la giustizia sommaria che si compie in favore di telecamera, capo
d’accusa, sentenza, condanna per direttissima. Un metodo intriso di
grillo-leghismo che lasciò perplessi anche i vertici di viale Mazzini, che
infatti lo fecero fuori. Uno che tratta più o meno tutti con il bazooka,
Giletti. Non se la prenderà dunque se per una volta gli ricambiamo il
trattamento. Non dopo aver chiarito, però, qualora ve ne fosse bisogno, che noi,
più di lui, abbiamo in grande considerazione il procuratore della Repubblica,
Nicola Gratteri. Ma sappiamo anche che il patto di sangue della criminalità
organizzata da tempo ha stretto vincoli ovunque. Che la versione stracciona,
casereccia, da fenomeno tipico dell’arretratezza e della monocultura da faida, è
una narrazione che non sta più in piedi. I continui arresti di camorristi e
mafiosi in Lombardia, Piemonte, Veneto, e di recente anche in Val d’Aosta,
descrivono qualcosa di molto più ampio e tentacolare del vecchio focolaio e
della scoppola. Ma torniamo al suo programma tv. Eccolo allora mostrarci, come
se fosse il video del secolo, le immagini dell’Umberto I, a Mottola, una
struttura post Codiv-19 in provincia di Taranto. Per i giornalisti locali, cioè
per chi conosce tutta la storia dell’ospedale, è un evergreen. Un’opera compiuta
a metà, finanziamenti a singhiozzo, lungaggini, etc., etc., un dejà vu.
Risultato: corridoi deserti, reparti vuoti, fili che pendono dalle pareti. In
tempi in cui nella Bergamasca e nel Bresciano si allestiscono tende all’esterno
degli ospedali è un pugno allo stomaco. Da qui l’indignazione degli ospiti della
trasmissione, e tra questi del vice e ministro alla Sanità Pierpaolo Sileri che
si limita ad annuire. Prima ancora del servizio sull’ospedale di Mottola era
andata in onda un’intervista al sindaco di Messina, Cateno De Luca, entrato in
rotta di collisione con il ministro dell’Interno Lamorgese per aver cercato di
bloccare lo sbarco dai traghetti sullo Stretto. Ma lo sguardo sul Mezzogiorno
resta lo stesso, idem per i veri o presunti assenteisti di Crotone. Cosa avrebbe
fatto il servizio pubblico, caro a Giletti? Per fare informazione e non
disinformatio, si poteva forse ricordare in che modo il Sud è stato ridotto:
investimenti passati da 3,4 miliardi del 2010 a 1,4 del 2017, un terzo delle
risorse destinate al Nord. Con gli stessi tagli in Lombardia o in Veneto
immaginate che le cose sarebbero andate diversamente? Altro che Mottola! Si
poteva ricordare che il maggior contributo al deficit sanitario, fonte Corte dei
conti, viene da Piemonte, Liguria e Toscana. Qualcuno insomma dica a Giletti, e
a beneficio di chi facendo zapping, finisse su quelle frequenze, che gli
investimenti pubblici in sanità hanno creato squilibri e disuguaglianza forse
ormai irrecuperabili. La spesa per ogni cittadino calabrese è pari a 15,9 euro
pro-capite. In Emilia-Romagna è di 89,4 euro. Lombardia 40,8; Veneto 61,3;
Marche 48,8%; Umbria 34,9; Valle d’Aosta 89,4, Bolzano 183,8, Trento 116,2,
Liguria 43,9 e Piemonte,44,1. Tre volte la Calabria, il doppio della Campania,
22,6 e del Lazio. Si fa a cambio? No. Lo scandalo sono i 28 traghettati da Villa
San Giovanni a Messina. Possibili untori. Ma non si parla dei 4,5 milioni di
persone che secondo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana dal 10
marzo, giorno del primo decreto, si sarebbero diretti al Sud e in altre zone del
Paese. Magari si poteva ricordare che a Catanzaro è stato trasportato dal Nord
un paziente in terapia intensiva. E che la stessa cosa è avvenuta in Molise. Che
550 sanitari sono partiti per il fronte. Che nonostante la disparità di
dotazioni tra regioni Puglia e Calabria hanno lasciato la porta aperta. Che la
mobilità in uscita degli ammalati oncologici del Sud è diventata l’unica
possibilità di farsi operare in tempi più o meno rapidi e che ora, data
l’emergenza, chi ha il cancro se lo tiene. Il graduale depotenziamento ha messo
alle corde il sistema sanitario pubblico del Mezzogiorno. Vogliamo dirlo, caro
Giletti? Certo, è difficile. Specie se gli ospiti sono il leader del Carroccio
Matteo Salvini. O Vittorio Sgarbi, un critico d’arte di valore che si accapiglia
con un virologo. O la sua ex Alessandra Moretti e Flavio Briatore, collegato dal
suo resort a Malindi. Quando si dice un servizio pubblico senza frontiere.
Nunzia De Girolamo a Non è l'arena: "Se metti le mani nella
sanità muori. Calci nel sedere a chi non sa usare i soldi".
Libero Quotidiano il 20 aprile 2020. "Se ci metti le mani, muori". Nunzia De
Girolamo è drastica: a Non è l'Arena da Massimo Giletti si para ancora di sanità
al Sud e l'ex ministra puntualizza: "Si tratta di un settore pieno di interessi,
non trasparente. Se parli, vieni punito e quando fai inchiesta improvvisamente
si svegliano". Poi però il Sud non ha preso il 34% degli investimenti pubblici,
ha preso il 24% per anni, quando non il 19%, e questo è un altro discorso, "Ma
come fai a chiedere più soldi se li sprechi o li rubi?", le chiede Alessandro
Cecchi Paone, in collegamento video. "No, i soldi devono arrivare perché i
cittadini non possono pagare per la loro classe dirigente. E chi non li sa usare
va preso a calci nel sedere".
Sanità in Puglia, lo scandalo dell'Ospedale di Mottola.
La7 30/03/2020. Nell'Italia in emergenza per il Coronavirus a Mottola, vicino
Taranto, c'è un Ospedale nuovo che è praticamente chiuso. Danilo Lupo è andato a
scoprirlo. Giampiero Barulli, il Sindaco di Mottola: "E' una vergogna
italiana!".
Tgnobaonline 31-03-2020. Ospedale di Mottola attaccato da La 7,
ma la Asl svela falso scoop. Un ospedale nuovissimo, chiuso e inutilizzato per
l’emergenza coronavirus, parliamo dell’Umberto primo di Mottola finito nel
tritacarne mediatico
Servizio di Francesco Iato. Riprese e montaggio di Pasquale
D'Attoma. Intervista a Stefano Rossi, direttore generale Asl Taranto.
Giletti fa il giustiziere fazioso e getta ancora fango sul
sud. Claudio Marincola il 31 marzo 2020 su Il
Quotidiano del Sud. Chi lo conosce lo evita. Ma se proprio non ci riuscite e
incappate nel suo programma fatelo proteggendovi, tipo mascherina, e comunque a
vostro rischio e pericolo. Lui è Massimo Giletti, già da tempo caparbio
testimone di sé stesso, ostinato Torquemada da salotto. Il suo programma si
chiama “Non è L’Arena” e va in onda la domenica sera su La7, un clone rivisitato
e corretto del vecchio format targato Rai. In questi giorni in cui le tv di casa
si surriscaldano con facilità, anche lui, Giletti, è salito di qualche decibel.
Il suo pezzo forte sono le “inchieste” sul Sud, un Sud che dipinge sempre allo
stesso modo. Terra di malaffare, ‘ndrangheta, camorra, mafia. Insomma, tutte
queste cose che sappiamo benissimo anche da soli e che vorremmo estirpare sia
nel Mezzogiorno che altrove. Più le immagini si fanno crude, più la sua
espressione rivela sofferenza, patimento. E sì, il Sud gli procura un consumo di
succhi gastrici sempre molto elevato. Anche in queste ore drammatiche in cui Il
Nord, compreso il suo Piemonte, gli offrirebbe materiale in abbondanza, Giletti
si esibisce nella specialità della casa. Puntare i riflettori sul Mezzogiorno.
Prima mette le mani avanti, «lo faccio con lo spirito di chi fa servizio
pubblico». Un talk style alla Funari ma senza le sue battute tranchant: l’indice
puntato, la giustizia sommaria che si compie in favore di telecamera, capo
d’accusa, sentenza, condanna per direttissima. Un metodo intriso di
grillo-leghismo che lasciò perplessi anche i vertici di viale Mazzini, che
infatti lo fecero fuori. Uno che tratta più o meno tutti con il bazooka,
Giletti. Non se la prenderà dunque se per una volta gli ricambiamo il
trattamento. Non dopo aver chiarito, però, qualora ve ne fosse bisogno, che noi,
più di lui, abbiamo in grande considerazione il procuratore della Repubblica,
Nicola Gratteri. Ma sappiamo anche che il patto di sangue della criminalità
organizzata da tempo ha stretto vincoli ovunque. Che la versione stracciona,
casereccia, da fenomeno tipico dell’arretratezza e della monocultura da faida, è
una narrazione che non sta più in piedi. I continui arresti di camorristi e
mafiosi in Lombardia, Piemonte, Veneto, e di recente anche in Val d’Aosta,
descrivono qualcosa di molto più ampio e tentacolare del vecchio focolaio e
della scoppola. Ma torniamo al suo programma tv. Eccolo allora mostrarci, come
se fosse il video del secolo, le immagini dell’Umberto I, a Mottola, una
struttura post Codiv-19 in provincia di Taranto. Per i giornalisti locali, cioè
per chi conosce tutta la storia dell’ospedale, è un evergreen. Un’opera compiuta
a metà, finanziamenti a singhiozzo, lungaggini, etc., etc., un dejà vu.
Risultato: corridoi deserti, reparti vuoti, fili che pendono dalle pareti. In
tempi in cui nella Bergamasca e nel Bresciano si allestiscono tende all’esterno
degli ospedali è un pugno allo stomaco. Da qui l’indignazione degli ospiti della
trasmissione, e tra questi del vice e ministro alla Sanità Pierpaolo Sileri che
si limita ad annuire. Prima ancora del servizio sull’ospedale di Mottola era
andata in onda un’intervista al sindaco di Messina, Cateno De Luca, entrato in
rotta di collisione con il ministro dell’Interno Lamorgese per aver cercato di
bloccare lo sbarco dai traghetti sullo Stretto. Ma lo sguardo sul Mezzogiorno
resta lo stesso, idem per i veri o presunti assenteisti di Crotone. Cosa avrebbe
fatto il servizio pubblico, caro a Giletti? Per fare informazione e non
disinformatio, si poteva forse ricordare in che modo il Sud è stato ridotto:
investimenti passati da 3,4 miliardi del 2010 a 1,4 del 2017, un terzo delle
risorse destinate al Nord. Con gli stessi tagli in Lombardia o in Veneto
immaginate che le cose sarebbero andate diversamente? Altro che Mottola! Si
poteva ricordare che il maggior contributo al deficit sanitario, fonte Corte dei
conti, viene da Piemonte, Liguria e Toscana. Qualcuno insomma dica a Giletti, e
a beneficio di chi facendo zapping, finisse su quelle frequenze, che gli
investimenti pubblici in sanità hanno creato squilibri e disuguaglianza forse
ormai irrecuperabili. La spesa per ogni cittadino calabrese è pari a 15,9 euro
pro-capite. In Emilia-Romagna è di 89,4 euro. Lombardia 40,8; Veneto 61,3;
Marche 48,8%; Umbria 34,9; Valle d’Aosta 89,4, Bolzano 183,8, Trento 116,2,
Liguria 43,9 e Piemonte,44,1. Tre volte la Calabria, il doppio della Campania,
22,6 e del Lazio.
Si fa a cambio? No. Lo scandalo sono i 28 traghettati da Villa
San Giovanni a Messina. Possibili untori. Ma non si parla dei 4,5 milioni di
persone che secondo il governatore della Lombardia, Attilio Fontana dal 10
marzo, giorno del primo decreto, si sarebbero diretti al Sud e in altre zone del
Paese. Magari si poteva ricordare che a Catanzaro è stato trasportato dal Nord
un paziente in terapia intensiva. E che la stessa cosa è avvenuta in Molise. Che
550 sanitari sono partiti per il fronte. Che nonostante la disparità di
dotazioni tra regioni Puglia e Calabria hanno lasciato la porta aperta. Che la
mobilità in uscita degli ammalati oncologici del Sud è diventata l’unica
possibilità di farsi operare in tempi più o meno rapidi e che ora, data
l’emergenza, chi ha il cancro se lo tiene. Il graduale depotenziamento ha messo
alle corde il sistema sanitario pubblico del Mezzogiorno. Vogliamo dirlo, caro
Giletti? Certo, è difficile. Specie se gli ospiti sono il leader del Carroccio
Matteo Salvini. O Vittorio Sgarbi, un critico d’arte di valore che si accapiglia
con un virologo. O la sua ex Alessandra Moretti e Flavio Briatore, collegato dal
suo resort a Malindi. Quando si dice un servizio pubblico senza frontiere.
Numeri. Caro Giletti, così ci siamo.
Roberto Napoletano il 6 aprile 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Bravo Giletti, il suo viaggio nel Sud a Non è l’Arena questa volta ci è
piaciuto. Ai nostri occhi si è riscattato perché ha coperto con onestà il buco
nero informativo della sua trasmissione che questo giornale ha denunciato perché
insopportabile. Che a un cittadino calabrese lo Stato italiano elargisca 15,9
euro per investimenti in attrezzature sanitarie contro gli 89,9 che riceve un
cittadino della Valle d’Aosta è uno scandalo morale, prima ancora che economico,
perché lede i diritti di cittadinanza inviolabili della Repubblica italiana. A
prescindere dal fatto, sia chiaro, che gli amministratori della Valle d’Aosta si
sono dimessi perché indagati per associazione politico elettorale mafiosa e che
il Comune di Saint Pierre è stato sciolto per ‘Ndrangheta. Giletti ha mostrato
le tabelle del Quotidiano del Sud che sono poi quelle dei Conti Pubblici
Territoriali e ha detto con assoluta chiarezza che il capitolo degli
investimenti sanitari dopo lo tsunami Coronavirus dovrà essere riscritto perché
non equo. Non era scontato. Queste parole gli fanno onore e sono quelle che
avremmo voluto sentire già due domeniche fa. Ogni volta che il conduttore di Non
è l’Arena denuncerà gli sprechi e il malaffare calabrese nella sanità pubblica e
privata ci avrà sempre al suo fianco. Perché questo giornale, come ho scritto la
settimana scorsa, non ha e non avrà mai nessuna indulgenza di fronte alla
peggiore classe politica meridionale che ha lucrato sui fondi pubblici e al
coacervo di interessi massonici e amministrativi che a volte hanno spartito con
essa il bottino e a volte ne hanno bloccato l’impiego per calcoli inverecondi.
Questa vergogna deve essere esplorata e denunciata senza riguardi per nessuno
perché la sanità è un bene pubblico e le vittime sono le donne e gli uomini del
Mezzogiorno. Saremo sempre in prima linea nel sostenere a tutto campo l’azione
di un grande uomo di Stato come Gratteri che sta alzando il coperchio più
nauseabondo del malaffare in Calabria, in tutta Italia e fuori dall’Italia, e
non ci stancheremo mai di ringraziarlo. C’è un punto rimasto in sospeso che
aiuta a capire come sono andate davvero le cose, caro Giletti. È vero che i
commissariamenti delle regioni del Sud hanno comportato un taglio dei
trasferimenti per colpe loro, come hai opportunamente sottolineato, ma sono
scattati per bilanci regionali in rosso per importi rilevanti che non hanno però
paragone con quanto prima, durante e dopo è stato tolto alle stesse regioni del
Sud per regalarlo alle regioni del Nord. Dal 2000 al 2017 su 47 miliardi di
investimenti complessivi 27,4 sono andati al Nord, poco più di un terzo al Sud
(10,5). Per la sanità italiana, un cittadino della Calabria ha ricevuto cinque
volte di meno di un cittadino emiliano-romagnolo. A seguito dei giusti
commissariamenti frutto di sprechi e inefficienze le Regioni del Mezzogiorno
taglieggiate pesantemente per quasi un ventennio nella distribuzione delle
risorse pubbliche hanno dovuto mandare a casa un altro 10% di personale. Ho
scritto la Grande Balla perché questa ineludibile operazione verità che riguarda
la sanità come la scuola, gli asili nido come i treni veloci, fosse chiara a
tutti. Questa distorsione incostituzionale della spesa pubblica è tra l’altro
all’origine dell’abnorme crescita della rendita sanitaria privata lombarda a
discapito degli ospedali pubblici lombardi e del Mezzogiorno. Ogni battaglia
sacrosanta di moralizzazione e di ricostruzione economica e sociale del Paese
può partire solo da questi numeri. Che parlano perché hanno un cuore e
un’anima.
VERGOGNA. Questo giornale sostiene
l’azione a tutto campo di un grande uomo di Stato come Gratteri contro il
malaffare in Calabria, in Italia e fuori dall’Italia ma denuncia un racconto sul
Sud che nasconde il taglieggiamento degli investimenti pubblici per la sanità.
Al Mezzogiorno va un terzo rispetto al Nord e lo Stato spende per un calabrese
15,9 euro e per un valdostano 89,9 euro. Robero Napoletano il 30 marzo 2020 su
Il Quotidiano del Sud. DAL 2000 al 2017 ogni cittadino calabrese ha ricevuto pro
capite 15,9 euro per investimenti fissi in sanità dal bilancio della Repubblica
italiana. Ogni cittadino piemontese tre volte tanto (44,1), chi è nato in
Emilia-Romagna cinque volte di più (84,4), ai cittadini veneti la dote personale
(61,3) è pari a quattro volte la spesa pubblica attribuita a un abitante di Vibo
Valentia o di Reggio Calabria. Campani e pugliesi si devono accontentare della
metà esatta di quanto ricevono i lombardi e di un terzo di quello che incassano
i veneti. Al colmo dell’equità in Valle d’Aosta dove il Governatore si è dimesso
perché indagato per scambio elettorale politico mafioso e il Comune di
Saint-Pierre è stato sciolto per ‘Ndrangheta ogni cittadino riceve 89,9 euro: i
suoi diritti di cittadinanza sanitaria pubblica sono di quasi sei volte
superiori a quelli dei concittadini calabresi e valgono quattro volte di più di
quelli dei suoi concittadini campani e pugliesi. Questo certificano i Conti
Pubblici Territoriali della Repubblica italiana voluti da Carlo Azeglio Ciampi
per cercare almeno di capire a che cosa avrebbe condotto, anno dopo anno, la
scelta di abolire il servizio sanitario nazionale e la nascita dei venti
staterelli in guerra tra di loro chiamati Regioni. Che cosa si intende, mi
chiederete, quando si parla di investimenti fissi in sanità? Per capirci, sono
attrezzature scientifiche e sanitarie, macchinari, respiratori, posti letto di
terapia intensiva, unità ospedaliere pubbliche. Tutto ciò che abbiamo scoperto
mancare drammaticamente come dimostra l’ecatombe di vite umane da Coronavirus di
questi giorni. Ci permettiamo, altresì, di ricordare che, parola della Corte dei
Conti, il peggioramento dei conti della sanità pubblica italiana è interamente
attribuibile a Regioni a statuto ordinario del Nord, a partire dal Piemonte.
Scusate se sono andato lungo, ma era solo per esprimervi compiutamente il senso
di ribrezzo che ha determinato in me assistere a un’ora e mezza di processo
televisivo alla sanità del Mezzogiorno, ai suoi medici, ai suoi ospedali (Non è
l’Arena di Massimo Giletti, La7) senza che si desse conto mai di uno solo dei
numeri del taglieggiamento dei fondi per gli ospedali pubblici del Sud a favore
dei prenditori della rendita sanitaria privata del Nord. Questo giornale non
avrà mai nessuna indulgenza di fronte alla peggiore classe politica meridionale
che ha lucrato sui fondi della sanità pubblica e al coacervo di interessi
criminali, massonici e amministrativi a essa collegati ed è in prima linea nel
sostenere l’azione a tutto campo di un grande uomo di Stato come Gratteri che
sta alzando il coperchio più nauseabondo del malaffare in Calabria, in tutta
Italia e fuori Italia (grazie Procuratore), ma non può nascondere il sentimento
di vergogna per un racconto omissivo che appartiene a uno scenario scolastico di
informazione leggerissima già mal digeribile nei tempi di pace. Non si rinuncia
al più becero sensazionalismo saltellando sulle macerie italiane. La grande
guerra è cominciata, ma ci sono alcuni “colonnelli della politica” e i loro
“portavoce” che non hanno capito niente. Giocano alla guerra senza sapere che
siamo in guerra per davvero non per finta. Sono i padroni delle telerisse. Non
hanno rispetto nemmeno dei morti. Sono accecati da loro stessi, l’ego sconfinato
del nulla. Dio ce ne scampi.
Dall’estero elogi al Cotugno: “E’ l’ospedale migliore d’Italia
contro il coronavirus”. Redazione de Il Riformista il
1 Aprile 2020. E’ il Cotugno l’ospedale modello in Italia per la lotta
al coronavirus. L’elogio arriva dalla stampa inglese e nello specifico da Sky
News britannico che in un lungo e dettagliato servizio sull’emergenza pandemia
covid-19 sottolinea il duro lavoro di tutto il personale sanitario dell’ospedale
che rientra nell’azienda dei Colli insieme al Mondali e al Cto. “Questo ospedale
è un’eccezione nel sud del paese” spiega l’inviato Stuart Ramsay, l’unico dove
non ci sono medici e infermieri contagiati. “Mentre il diffondersi
dell’epidemia ha colto tutti di sorpresa nel nord e il personale medico si è
trovato senza protezioni, le cose in questo ospedale sono andate diversamente.
Siamo stati portati, completamente vestiti di tute e occhiali di protezione, in
una delle loro Unità Intensive. Qui siamo ad un livello completamente
differente rispetto a tutto quanto visto finora”. Sky News spiega come nel “nord
Italia in centinaia del personale sanitario si sono ammalati combattendo la
pandemia del coronavirus e dozzine hanno perso la vita”. Al sud invece hanno
avuto tempo per prepararsi. Il Cotugno, che ora tratta solo pazienti malati di
covid-19, “era già il più avanzato, ma adesso ci rendiamo conto che tenere al
sicuro il personale sanitario è possibile. Quello che ci dicono è che tutti e
nessuno si possono infettare, non solo gli anziani. Ci sono molti giovani
pazienti giovani in trattamento ed è interessante notare che i più colpiti sono
della classe sociale media. Chiedo perché? La risposta è ovvia: lavorano. Quello
che ci preme sottolineare è che le severe regole di separazione tra materiale
infetto e pulito vengono seguite da tutti, ma le guardie di sicurezza nei
corridoi di connessione lo ricordano in caso qualcuno lo dimentichi”. E poi
ancora: “Le guardie di sicurezza sorvegliano i corridoi. Entrando, passiamo
sotto un macchinario di disinfezione che sembra lo scanner di un aeroporto, ma
che ti pulisce completamente. Lo staff che assiste i pazienti indossa maschere
super avanzate simili a maschere antigas diverse da quelle normalmente indossate
negli altri ospedali. Sono rivestiti da una tuta ermetica che fa in modo che
medici ed infermieri siano davvero isolati. Incredibilmente, almeno per ora,
nessun membro dello staff si è infettato, sembra che quindi questo sia
possibile, basta avere le giuste forniture e seguire i giusti protocolli”.
Protocolli rispettati anche nell’assistere i pazienti: “Avvertiamo un improvviso
cambiamento. Un infermiere ci passa disperatamente veloce accanto con una
siringa, Un paziente all’interno di una camera è improvvisamente peggiorato.
Possiamo vedere che prepara un’iniezione fuori dalla stanza del trattamento. Non
entra mai nella stanza ma comunica attraverso una finestra collegata col
paziente. Questi non escono mai dalle loro stanze durante la crisi, e questo è
uno. Quando è pronta, la medicina passa attraverso una porta a compartimento.
Ricordate: non è mai entrato nella camera, non ha toccato niente e nessuno, ma
immediatamente si toglie guanti e camice. l’attenzione ai dettagli è costante”.
La
napoletana Myrta Merlino: “E’ incredibile, non mi sarei mai aspettata
un’eccellenza come il Cotugno” .
Redazione de Il Riformista il 7 Aprile 2020. La conduttrice de “L’aria che tira”
su La7 si è lasciata andare a una considerazione infelice sull’eccellenza
dell’ospedale Cotugno, rimarcata la scorsa settimana anche da Sky News
britannico. Nel corso della trasmissione andata in onda questa mattina, martedì
7 aprile, la Merlino, durante un collegamento con il direttore del giornale
Alessandro Sallusti si è lasciata andare a una dichiarazione del genere: “Poi a
Napoli… per me è incredibile, non ci aspettavamo mai che l’eccellenza arrivasse
da Napoli… la storia del Cotugno napoletano ci ha tutti sorpresi”. Il solito
luogo comune arriva al termine di un discorso sull’impreparazione degli ospedali
della Lombardia, messi in ginocchio dal boom di contagi di coronavirus, compresi
medici e infermieri. “Il vero tema – ha argomentato la Merlino – è questo:
quando il Covid-19 arriva, un ospedale deve avere la capacità di creare una
sorta di chiusura ermetica. Questo è mancato in una fase iniziale. E’ anche il
motivo per cui a Napoli, invece… Ecco, per me è incredibile: non ci aspettavamo
mai che l’eccellenza arrivasse da Napoli, ma la storia del Cotugno ci ha
sorpreso, perché hanno creato una situazione quasi da astronave rispetto
all’elemento Covid”.
Pandemia di coronavirus, se le eccellenze le trovi nella
sanità del sud. L’equipe del professor Paolo Ascierto
(al centro) dell’Istituto Pascale di Napoli, il primo a sperimentare l’efficacia
di un farmaco anti-artritico contro il Covid-19. Carlo Porcaro il 9 aprile 2020
su Il Quotidiano del Sud. Lo storytelling del Coronavirus svela un’Italia
rovesciata. Le storie crude, dai reparti Covid degli ospedali, raccontano la
caduta contemporanea di due miti: il primato della sanità lombarda,
l’inefficienza di quella meridionale. È stato il Sud ad aiutare il Nord, a
praticare con i fatti quella solidarietà nazionale tanto auspicata dal Quirinale
in questa drammatica emergenza. Tre le ragioni sostanziali di questo
capovolgimento destinato a riscrivere gli equilibri geopolitici e le relative
narrazioni: il vantaggio di essersi organizzati per tempo in attesa dello
tsunami; le straordinarie eccellenze mediche presenti in molte strutture del
Mezzogiorno; il rispetto del divieto di uscire di casa da parte della
maggioranza dei cittadini. I numeri parlano chiaro, andrebbero forse scanditi ad
alta voce: su circa 17mila morti, il Sud isole comprese ne ha fatti registrare
850 vale a dire appena il 5 per cento; i contagiati a livello nazionale sono
oltre i 95mila, ma da Roma in giù (insieme a Sicilia e Sardegna) se ne sono
contati circa 10mila il che significa poco più del 10 per cento del totale. Il
sistema, seppur con meno risorse e mezzi della parte settentrionale del Paese,
non solo ha retto ma si è persino distinto. Allungando la mano a chi soffriva ed
aveva bisogno di aiuto immediato. Tanti i casi da citare, a dimostrazione che
non conta la provenienza geografica quanto la qualità associata alla passione.
IL CASO. In queste settimane la Cross, Centrale Remota Operazioni
Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti, ha
attivato la rete tra gli ospedali del Nord e quelli del Sud. Ieri, per fare un
primo esempio, è uscito dalla rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo uno
dei due bergamaschi che erano stati trasportati a Palermo in aereo nei giorni
scorsi per mancanza dei posti in terapia intensiva al nord; l’altro paziente
arrivato dalla città lombarda si trova ricoverato ancora in rianimazione. Poi
sono stati estubati e sono in via di guarigione i due pazienti lombardi, uno di
Bergamo e l’altro di Cremona, ricoverati nelle scorse settimane in gravi
condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro: vi
erano arrivati a bordo di un aereo militare atterrato nel vicino aeroporto di
Lamezia Terme. Ora sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive. “È
stato un atto di grande generosità – ha commentato il direttore della struttura
Giuseppe Zuccatelli – da parte della Calabria. È ora di smettere di dipingere
questa regione in termini negativi”. Non è finita qui. È guarito il primo
paziente Covid atterrato in Puglia da Bergamo la notte del 20 marzo scorso a
bordo di un aereo C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa con una barella ad
alto biocontenimento: a darne notizia sono stati direttamente i medici
dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), dove l’uomo, 56 anni, era
stato ricoverato con una insufficienza respiratoria severa, a seguito della
richiesta dell’azienda ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo. Il paziente adesso
è stato dichiarato fuori pericolo dopo essere stato sottoposto a due tamponi
risultati negativi. In Campania, infine, dall’ospedale di Boscotrecase alle
pendici del Vesuvio sono stati dimessi ben 11 pazienti affetti da Coronavirus,
alcuni dei quali anziani. A Napoli, la Regione sta facendo costruire con uno
stanziamento di oltre 7 milioni di euro un ospedale da campo con 72 nuovi posti
di terapia intensiva.
LA POLEMICA. Incredibile. Letteralmente da non credere, la
risposta del Sud all’emergenza secondo alcuni giornalisti e opinionisti. Il caso
che in queste ore ha fatto indignare riguarda la giornalista napoletana Myrta
Merlino su La7. Quest’ultima, in diretta tv si è detta meravigliata (“che
sorpresa”, la sua espressione) che l’ospedale Cotugno di Napoli fosse stato
un’eccellenza nazionale e internazionale con il suo zero contagiati. Una
meraviglia del tutto fuori luogo per chi dovrebbe conoscere in maniera
approfondita le caratteristiche di un territorio che, tra mille difficoltà e
senza le risorse di altre parti d’Italia, riesce ad esprimere le migliori
intelligenze in tanti settori. Poi, una volta tornata a casa, la conduttrice di
‘L’aria che tira’ ha provato a chiarire il suo pensiero. “So benissimo che a
Napoli ci sono moltissime eccellenze, ma le eccellenze che abbiamo non
cancellano i nostri problemi e non mi va di essere ipocrita. Io però amo Napoli,
viva Napoli, è la mia città”. In studio si è scusata, ma il dado era ormai
tratto. In una fase in cui si discetta tanto di fake news e corretta
informazione, non si dovrebbero cavalcare luoghi comuni né si dovrebbero
alimentare pregiudizi evidentemente inconsci. Basterebbe fare la cronaca. Di
ritardi ed inefficienze, dove emergono, e di eccellenze e primati dove si
palesano. La cronaca di queste settimane, come sopra elencato, ha parlato di una
Napoli pronta e di un Sud efficiente. Non si tratta di una questione di
appartenenza campanilistica. L’Italia, e la sua opinion-leadership, è
decisamente nord-centrica e tende a tutelare gli interessi del Nord. La classe
dirigente meridionale, per lo più grillina dopo le elezioni di due anni fa, non
sa farsi rispettare a livello centrale ed ha fatto consolidare l’idea di un
Meridione piagnone seduto sul divano a godersi il reddito di cittadinanza. Il
vento però è cambiato, è nato un variegato movimento di pensiero – va detto,
anche grazie ai social – che finalmente respinge al mittente le “scivolate”
mediatiche e si libera dalla condizione di colonizzazione mentale. Ognuno faccia
la sua parte.
L’accusa della Gabanelli: “Il Nord non ha interesse che il Sud
e la sua Sanità si sviluppino”. Da Salvatore Russo su
Vesuviolive 19 marzo 2020. “Esiste un interesse del Nord che il Sud non si
sviluppi?“. La domanda viene posta dal giornalista Giovanni Floris alla
collega Milena Gabanelli, nel corso della trasmissione Di Martedì in onda su
LA7. La conduttrice di Report non si lascia pregare e risponde in maniera
inequivocabile: “Il Nord ha certamente questo interesse, attrae i pazienti dal
Sud. Vale sia per gli ospedali pubblici che per le strutture private. Quindi
certamente non ha interesse a spingere affinché la sanità al Sud
migliori”. Dall’asserzione della Gabanelli si intravede un filo conduttore che
riporta alla mente ai fatti incresciosi accaduti nelle ultime ore, rafforzando
la tesi della giornalista. A “Carta Bianca” il dottore napoletano Ascierto,
l’uomo che ha avuto l’intuizione di utilizzare un farmaco per combattere i
sintomi del Covid, è stato duramente attaccato da un suo collega del Nord,
Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano. L’accusa è quella di aver scippato
“alla napoletana” un’idea della cosiddetta eccellenza sanitaria lombarda che
avrebbe prima dell’equipe napoletana utilizzato quel farmaco. Ascierto in quella
sede è stato accusato di fare del provincialismo. La ciliegina sulla torta è
arrivata meno di 24 ore fa quando un servizio di Striscia La Notizia, seguito da
milioni di telespettatori, rafforza la denuncia di Galli, con la consegna di un
tapiro d’oro al professore partenopeo. Agli occhi di molti italiani, Ascierto
viene presentato come il solito napoletano furbetto che ruba il lavoro altrui.
Eppure bastava porre una domanda al dottore del Sacco. Come mai se il farmaco
veniva utilizzato da tempo, nessuno era stato avvertito? Come mai
l’efficientissima sanità lombarda, oggi al collasso, non si è accorta che il
virus era probabilmente arrivato già alla fine del 2019 quando si sono
registrati dei picchi di polmoniti cosiddette anomali? Forse si vuole provare a
soffiare l’intuizione per paura che in futuro gli ospedali napoletani possano
ricevere più trasferimenti da parte dello Stato? I fatti parlano di altro. E
contato questi, non le chiacchiere. L’AIFA (Agenzia italiana del Farmaco)
approva l’utilizzo del farmaco, cominciando la sperimentazione proprio a partire
dai casi positivi della Campania. Il New York Times, non un giornaletto
rionale, dedica un articolo interamente all’ingegnosità di Ascierto e del
Pascale. Solo i media italiani sembrano non digerire la circostanza che sia
proprio un cervello napoletano ad aver elaborato una strategia efficace per
contrastare i sintomi del Covid-19. Perché evitando prematuri trionfalismi, il
farmaco comincia a dare segnali molto positivi. Non si manda giù che un prodotto
della sanità campana stia emergendo, nonostante i fondi destinati al settore
siano ai minimi termini. Lo ha ribadito il Governatore Vincenzo De Luca qualche
giorno fa in una video postato sulla sua pagina facebook. I trasferimenti in
materia di sanità che lo Stato gira alla Campania sono i più bassi d’Italia. Un
malato di Napoli, di Avellino o di Caserta vale molto meno di uno di Milano o
Reggio Emilia. Per ogni 1000 abitanti la Regione può mettere a disposizione 2
posti letto, al Nord la media è di 8. A questa storica sperequazione Nord-Sud va
ad aggiungersi il dirottamento in 17 anni di ben 840 miliardi di euro
stranamente dirottati al Nord (fonte Eurispes). Parte di questi quattrini
potevano servire per rafforzare un sistema precario e pieno zeppo di buche da
rattoppare.
Report copre Consip e attacca la sanità, ma Napoli esulta per
nuovo centro Covid. Redazione de Il Riformista il 6
Aprile 2020. Non poteva essere meno opportuno il servizio di Report. La
trasmissione di RaiTre, infatti, ha mostrato lunedì sera un servizio in cui ha
pesantemente attaccato la sanità campana e in particolare l’Asl Napoli 1 Centro
diretta dall’ingegner Ciro Verdoliva. In particolare nel video un anonimo parla
addirittura di “omicidio colposo di massa” per il fatto che medici e operatori
sanitari non avrebbero mascherine e i cosiddetti DPI. Il servizio prima fa
vedere le tende inutilizzate al San Giovanni Bosco (che non è ospedale Covid) e
al San Gennaro (che non ha pronto soccorso…) e poi parla di mascherine e DPI che
non sarebbero adeguati. Forse i colleghi di Report non sono aggiornati sul fatto
che, come sottolineato dal governatore De Luca, “le forniture di Consip sono
saltate” per cui la regione sta facendo da se per quel che può in una situazione
di emergenza non solo nazionale ma mondiale. Infatti il governatore ha
annunciato di aver chiesto 400 ventilatori ma di averne ricevuti solo 41
dalla Protezione Civile (il 10%), mentre il 50% sono stati donati da un
privato, Alfredo Romeo (editore di questo giornale ndr). Il giornalista poi si è
avventurato negli ospedali ormai chiusi da anni di Napoli e della Campania
facendo diventare il servizio la classica inchiesta di Report sugli sprechi che
forse in questo momento si poteva anche evitare. Intanto il video di Report è
uscito proprio nel momento in cui Napoli è esplosa letteralmente in un tifo da
stadio. Infatti negli stessi minuti della messa in onda della trasmissione di
RaiTre, all’Ospedale del Mare sono arrivati gli oltre 50 automezzi che
trasportavano i moduli per il nuovo centro Covid che l’Asl Napoli 1 Centro sta
realizzando a tempo di record. Il tutto per incrementare i posti in terapia
intensiva e sub intensiva e costruire i tre monoblocchi per oltre una settantina
di posti. Una risposta che più concreta non si può ad accuse strumentali e
inopportune nel momento in cui, come sottolineato anche da Giulio Cavalli su
queste pagine, “non è il momento delle polemiche ma di salvarci tutti”.
Coronavirus, Palombelli: “Al Nord più
diffuso perché ligi al dovere”.
Asia Angaroni il 21/03/2020 su Notizie.it. Sono le regioni del Nord Italia a
essere più colpite dall'allarme Coronavirus: Barbara Palombelli ha dato una
spiegazione, ma molti non hanno gradito. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e
Piemonte: è il Nord Italia a essere più coinvolto dall’emergenza Covid-19.
Secondo gli esperti, sono le polveri sottili ad accelerare la diffusione
dell’infezione, in particolare nella Pianura Padana. Intervenuta
sull’allarme Coronavirus al Nord, Barbara Palombelli ne ha dato una sua
interpretazione. In molti, tuttavia, pare non abbiano gradito il suo commento.
Spiazzati i cittadini del Sud, che ora fanno appello al marito Francesco
Rutelli, affinché prenda le distanze dalle moglie. “Il 90% dei morti è al Nord
perché sono tutti ligi e vanno a lavorare”. Con queste parole Barbara
Palombelli, nel corso della sua trasmissione Stasera Italia, in onda su Rete 4,
ha spiegato qual è per lei il motivo per cui siano più numerosi al Nord Italia i
contagi e i morti causati dal Covid-19. Sicuramente la celebre
presentatrice, moglie dell’ex sindaco di Roma, si riferiva alla facile
trasmissione del virus legata al maggior numero di persone che si muove da una
città all’altra. Le cifre, nelle grandi metropoli del Nord, risultano più
consistenti. Essendoci più gente che si muove, la rapidità e la facilità del
contagio rischiano di salire esponenzialmente. Tuttavia, il Sud non ci sta e
attacca: “Non ci sono giustificazioni: è un’infamia“. Per alcuni, simili parole
esigevano delle “scuse immediate” da parte della Palombelli. E ancora: “Uno
scivolone, anche se intollerabile, può capitare”. Ma a dare l’esempio, secondo
il giudizio di alcuni, deve essere il marito Francesco Rutelli. A detta di
alcuni, infatti, in nome del suo ruolo istituzionale e del suo passato politico,
dovrebbe discostarsi dalle affermazioni della moglie, prendendo le difese del
Sud.
Barbara Palombelli, polemica sul coronavirus: "Più morti al
nord perché più ligi? E il Sud insorge. Libero
Quotidiano il 21 marzo 2020. Barbara Palombelli nel mirino dei social. La
conduttrice di Stasera Italia è finita al centro della polemica a causa di una
frase sul coronavirus. "Il 90 per cento dei morti è nelle regioni del nord. Cosa
può esserci di diverso? Persone più ligie, che vanno tutte a lavorare?" ha
chiesto la Palombelli ai suoi ospiti nello studio di Rete Quattro. Una frase che
ha immediatamente fatto indignare gli utenti del web che si sono scagliati così:
"Un esempio di razzismo, in piena emergenza coronavirus. Seconda la Palombelli,
il coronavirus ha fatto più morti al Nord perché lì 'sono più ligi e vanno a
lavorare'", è uno dei commenti più leggeri che su Twitter si sono susseguiti.
Eppure il contesto era totalmente diverso e la frase estrapolata e interpretata
in malo modo.
L’assurda tesi anti Sud della Palombelli: “Al Nord più contagiati
perché vanno a lavorare”. «Come il 90% dei morti da coronavirus in Italia si è
registrato al nord?”. Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice del
programma d’informazione, ‘Stasera Italia’ (Rete 4), porge la domanda al sindaco
di Bergamo, Giorgio Gori, una delle aree più colpite dal coronavirus. Ma prima
di passare la parola al sindaco, Palombelli aggiunge: “Vi sono delle motivazioni
particolari? Ci sono delle persone più ligie che vanno sempre a lavorare?”.
Redazione de Il Riformista 21 Marzo 2020
Barbara Palombelli nella bufera per battuta
sul Sud: «Più casi di coronavirus al Nord perché tutti lavorano?»
Il Mattino Sabato 21 Marzo 2020. Barbara Palombelli nella bufera sui social per
una domanda sul coronavirus. «È venuto fuori che il 90% dei morti» per
coronavirus «è nelle regioni del Nord. Che cosa ci può essere stato di più?
Comportamenti di persone più ligie che vanno tutti a lavorare?». Così Barbara
Palombelli parlando dell'emergenza coronavirus in Italia durante la
trasmissione Stasera Italia su Rete4. La domanda che la conduttrice del
programma ha rivolto ai suoi ospiti ha innescato una bufera sui social. «Cara
Barbara Palombelli, che brutta caduta di stile. In un momento così difficile per
l'Italia intera, lei cosa fa? Squallide insinuazioni»; «Per cotanta bassezza
intellettuale provo solo tanta pena»; «Scivolone assurdo di Barbara Palombelli,
considerazione spicciola e gretta. Andiamo anche noi terun a lavurà»; «Ma
davvero? Ma questa gente non è mai stata a sud di Assago? Ma che credono che noi
viviamo sugli alberi? Io non ho parole!!! #barbarapalombelli si vergogni!», sono
alcuni dei commenti che si leggono su twitter.
Simioli: "Ascierto l'ha fatta grossa: il
vaccino per il Covid-19! Voglio dire una cosa a Gerry Scotti".
Francesco Manno il 22 marzo 2020 su
areanapoli.it. Gianni Simioli, speaker di Radio Marte e di Rtl 102.5, ha
pubblicato un messaggio sui suoi profili ufficiali social. Lo speaker di Radio
Marte e Rtl 102.5, Gianni Simioli, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo
ufficiale Facebook. Ecco quanto si legge: "Caro Dott. Gerry Scotti, di seguito
le giro le ultimissime sulla cura Ascierto. E’ lo stesso Ascierto che lei ha
deriso e ridicolizzato a Striscia la notizia: si deve vergognare! Lo so, poi ha
spiegato a una radio locale che lei legge un copione e che la “colpa” del suo
“errore di valutazione“ è tutta da addebitare a chi scrive i testi del
programma. Ma lei veramente pensa che siamo i meridionali napoletani che le ha
raccontato qualcuno? Signor Gerry Scotti io non sono nessuno, non valgo ciò che
vale lei per le aziende del sud che la pagano, spero profumatamente, per dire
che è buonissimo questo o quel prodotto di Napoli o del meridione d’Italia (pur
di conquistare i mercati del nord), eppure sono in grado di rifiutarmi di
leggere una promozione che trovo distante kilometri dalla mia etica, filosofia o
sentimento di vita". Gianni Simioli ha poi aggiunto: "È arrivata un’altra
notizia da accogliere con ottimismo e un orgoglioso sorriso. Mentre la penisola
si divide tra i runner che non rinunciano alla corsetta e la Palombelli che non
si da ragione delle basse percentuali di contagio al Sud, qui, a Napoli, c’è un
pazzo visionario, spinto da un’intera regione, che non si ferma. Si, sempre Lui,
il Dottor Ascierto. Questa volta ha deciso di farla grossa: il vaccino per il
Covid19! È di queste ore una sua intervista, registrata ai microfoni di SKY,
nella quale è riassunta una speranza di tutto il paese. Il Dottore ha infatti
dichiarato: “La Takis è un’azienda che lavora con noi per dei vaccini su alcuni
melanoma che studiamo. In collaborazione con il Pascale e il Cotugno
sperimenteranno anche un vaccino per il Coronavirus. Proprio qui al Cotugno, e
questa è certamente una buona notizia. Non sarà una cosa di domani ma
l’impressione è che con cauto ottimismo e lavoro ce la faremo, noi andiamo
avanti”. Questa è la risposta di Napoli e di Ascierto a giorni di mala stampa e
fake news su di Lui e sulla sanità campana. Questa è la risposta che unirà
l’Italia di coloro che da Nord a Sud lottano e sperano di festeggiare presto,
insieme, l’uscita dal periodo più buio della nostra storia. E ci arriveremo,
credetemi. Non so quando ma così sarà. E sarà una grande festa per tutti. Anche
per Striscia la Notizia, Barbara Palombelli e ilFatto Quotidiano. Si, esatto,
perché noi siamo l’Italia che lotta, vince, ama ed include tutti. Anche chi non
lo meriterebbe".
Luca Marconi per corriere.it il 22 marzo 2020.
«Diffamazione aggravata», per un servizio televisivo «gravemente lesivo» nei
confronti del direttore della Struttura complessa Melanoma e Terapie intensive
del Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, il «promotore» dello studio Aifa ,
l’Agenzia italiana del farmaco, sul Tocilizumab, il farmaco per le complicanze
da artrite reumatoide che agisce anche sulle polmoniti da covid-19, liberando
quota parte delle terapie intensive di cui oggi si ha tanto bisogno: è quel che
contestano i vertici dell’istituto Pascale a Striscia la Notizia, intervenuta a
suo modo per raccontare l’attacco polemico subìto da Ascierto a “Carta Bianca”,
da parte dell’infettivologo Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie
Infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Nel servizio ancora online Striscia
riprende l’intervento di Galli, ma affidandosi ai commenti di Gerry Scotti («il
professore Galli ha scoperto che l’alunno Ascierto ha copiato») per poi
recuperare un vecchio meme con un incolpevole Emilio Fede che conclude: «Che
figura ...». Ma ecco il comunicato del Pascale: «Con riferimento al programma
televisivo “Striscia la notizia” del 17 marzo 2020, nel corso del quale è andato
in onda un servizio che ha richiamato la trasmissione “Carta Bianca” di Bianca
Berlinguer e il confronto avvenuto tra il prof. Paolo Ascierto del Pascale di
Napoli e il prof. Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano, si precisa quanto
segue: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale e il prof. Paolo
Ascierto esprimono innanzitutto la più viva gratitudine verso tutti coloro che
in questi giorni hanno manifestato la loro solidarietà e vicinanza nei confronti
al prof. Ascierto». «Ritengono il servizio di “Striscia la notizia”, montato ad
arte, gravemente lesivo dell’onore e della reputazione del prof. Paolo Ascierto
e dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, oltre che del tutto
inopportuno e inappropriato in relazione alla drammaticità del momento che si
vive, denotando una mancanza assoluta di sensibilità, specie nei confronti dei
medici impegnati in prima linea e di quanti, come il prof. Ascierto,
sommessamente sperimentano trattamenti terapeutici e cure, peraltro con
risultati positivi. Per tali motivi, la Direzione Generale dell’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale e il prof. Paolo Ascierto hanno dato
mandato all’avv. prof. Andrea R. Castaldo per sporgere querela per diffamazione
aggravata nei confronti del conduttore della trasmissione, di quanti hanno
curato il servizio e del Direttore Responsabile».
Dal profilo
Facebook di Barbara Palombelli il 23 marzo 2020: Venerdì sera, si parlava dei
bergamaschi e del loro senso del dovere e del lavoro... di andare a lavorare
anche con la febbre. Con il sindaco Gori e gli ospiti in collegamento ci si
chiedeva come mai proprio Bergamo fosse la città martire, se le aziende aperte
fossero state, insieme alla partita giocata col Valencia, responsabili di questo
dramma... qualcuno ha capito male e ha montato una immaginaria tempesta... non è
il momento delle polemiche, non risponderò a nessuno.
Da liberoquotidiano.it il 23 marzo 2020. Barbara Palombelli con un post duro su
Facebook annuncia che passerà alle vie legali. Tutto parte dalla sua
trasmissione, Stasera Italia in onda tutte le sere su Retequattro, in
collegamento con diversi ospiti tra cui il sindaco di Bergamo Giorgio Gori,
commentando la drammatica situazione della città bergamasca, piegata dal
Coronavirus, la giornalista specificava: “Il 90% dei morti è nelle regioni del
Nord. Cosa può esserci di diverso? Persone più ligie, che vanno tutte a
lavorare?. Considerazione che ha causato una pioggia di insulti e critiche.
“La libertà di opinione è sacra. La diffamazione via web è un reato. Tutti i
post e gli autori contenenti ingiurie, calunnie e diffamazioni vengono e
verranno identificati e chiamati a rispondere in sede civile di quanto hanno
scritto“. Così la moglie di Francesco Rutelli sul suo profilo Facebook. “I miei
avvocati sono al lavoro. Estrapolare una frase da un contesto in cui si parlava
esclusivamente della tragedia di Bergamo, travisandone il contenuto, è
un’operazione scorretta. Di tutto il resto si occuperanno polizia postale,
magistratura e avvocati.”
“Ascierto non ha saputo replicare a Galli”, niente scuse di
Striscia la Notizia. Redazione de Il Riformista il 22
Marzo 2020. Niente scuse e nessun passo indietro da parte di “Striscia la
Notizia” dopo la querela presentata dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione Pascale e dal professor Paolo Ascierto in seguito al servizio andato
in onda la scorso 17 marzo che ha richiamato la trasmissione “Carta Bianca” di
Bianca Berlinguer e il confronto medico-scientifico avvenuto tra l’oncologo
campano e il profersso Massimo Galli, dell’Istituto Sacco di Milano. La
trasmissione di Canale 5 in una nota fornisce alcune precisazioni sul tipo di
servizio andato in onda, dove accusava Ascierto di aver “copiato” il trattamento
del farmaco anti-artrite Tocilizumab dai cinesi accusandolo di una “pessima
figura”. “In merito alla notizia della querela presentata dalla Direzione
dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale e dal prof. Paolo
Ascierto nei confronti di Striscia la notizia, vogliamo precisare, come già
specificato nei giorni scorsi, che non era nostra intenzione entrare nel merito
del curriculum e della storia professionale dei due esperti. Né, a maggior
ragione, valutare i protocolli sanitari in atto per attribuire il primato della
scoperta a uno o all’altro o a nessuno dei due. Il nostro servizio si è
semplicemente limitato a riproporre il confronto televisivo tra i due medici,
andato in onda nel programma di Bianca Berlinguer, durante il quale il dottor
Ascierto non è stato in grado di controbattere in modo efficace alle
contestazioni del professor Galli. La missione di Striscia la notizia è da
sempre quella di fare satira televisiva ed è quello che continuerà a fare.
Cogliamo l’occasione per ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari e
tutte le figure coinvolte per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo”. La
controparte ha invece ritenuto il servizio” montato ad arte e gravemente lesivo
dell’onore e della reputazione del prof. Paolo Ascierto e dell’Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, oltre che del tutto inopportuno e
inappropriato in relazione alla drammaticità del momento che si vive, denotando
una mancanza assoluta di sensibilità, specie nei confronti dei medici impegnati
in prima linea e di quanti, come il prof. Ascierto, sommessamente sperimentano
trattamenti terapeutici e cure, peraltro con risultati positivi”.
Perchè Striscia la Notizia dimentica le parole di Galli e si
accanisce con Ascierto? Data cruciale.... Il noto
giornale satirico dovrebbe ricordare le parole del famoso infettivologo
dell'ospedale "Sacco" di Milano: una previsione totalmente sbagliata. Luca
Cirillo su areanapoli.it il 20 marzo 2020. E' di oggi la notizia che
la Direzione generale dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale e
il professor Paolo Ascierto hanno dato mandato all'avvocato Andrea Castaldo per
sporgere querela per diffamazione aggravata nei confronti del direttore
responsabile e del conduttore di Striscia la Notizia e di quanti hanno curato il
servizio trasmesso il 17 marzo che ha richiamato la trasmissione "Carta Bianca"
di Bianca Berlinguer e il confronto medico-scientifico avvenuto tra Ascierto e
il professor Massimo Galli sul tema della sperimentazione del
farmaco Tocilizumab su pazienti affetti da coronavirus. L'Istituto Pascale e il
professor Ascierto "ritengono il servizio su richiamato di Striscia la notizia,
montato ad arte, gravemente lesivo dell'onore e della reputazione di Paolo
Ascierto e dell'Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione Pascale, oltre che
del tutto inopportuno e inappropriato in relazione alla drammaticità del momento
che si vive, denotando una mancanza assoluta di sensibilità, specie nei
confronti dei medici impegnati in prima linea e di quanti, come Ascierto,
sommessamente sperimentano trattamenti terapeutici e cure, peraltro con
risultati positivi". Al di là di ogni possibile polemica e satira, una domanda
sorge spontanea senza alcun tono polemico: perchè Striscia la Notizia che
definisce "figuraccia" quella del Prof. Ascierto (ovviamente in maniera forzata
e del tutto fuori luogo anche se è un giornale satirico), non va a ripescare le
parole del Prof. Galli? Quali? C'è una data cruciale, ovvero il giorno 10
febbraio. Quel giorno, in un convegno Medico a Milano, il noto infettivologo
dichiarò: "In Cina è in netta crescita per quanto riguarda la zona di Wuhan,
anche se negli ultimi due giorni l’incremento è stato proporzionalmente
inferiore rispetto ai giorni precedenti. Quindi dobbiamo attendere una o due
settimane per capire dove si andrà a parare e sarà molto importante considerare
le epidemie satelliti, ovvero la presenza del virus in altre grandi aree urbane
della Cina. Rispetto a quanto ci si poteva attendere, la diffusione a livello
internazionale di questo virus è stata molto inferiore rispetto a quanto è
capitato ad esempio per la SARS nel 2003. Questo vuol dire che le misure di
limitazione dei viaggi assunte abbastanza presto hanno consentito di contenere
il fenomeno e questo vale soprattutto per il nostro Paese dove abbiamo solo tre
casi importati. Si tratta – ha proseguito – di due cittadini cinesi e uno
italiano, persone che si sono infettate poco prima di partire dalla Cina e da
Wuhan nel caso specifico. La malattia da noi difficilmente potrà diffondersi:
l’esiguità del numero dei casi riscontrati fino ad ora e la modalità con cui si
sono manifestati in persone che si sono infettate poco prima di partire da
Wuhan, ci dà la dimensione del contenimento complessivo della problematica".
Forse è più questa una brutta figura? Forse... Del resto, errare è umano.
Restiamo umani.
Striscia la Notizia nei guai: la fake news su Reggio Calabria.
Linda l'01/04/2020 su Notizie.it. Striscia la Notizia
smentita dall'ospedale di Reggio Calabria: la fake news denunciata dalla
struttura sanitaria. Tutti sono ormai a conoscenza del grande gesto compiuto
da Fedez e Chiara Ferragni nel raccogliere fondi per il San Raffaele di Milano.
La loro iniziativa ha del resto spinto molte persone ad aprire altre
sottoscrizioni destinate a diverse strutture ospedaliere di tutta Italia.
Proprio in questo frangente anche Striscia la Notizia ha voluto realizzare un
servizio per aiutare gli italiani a scegliere delle campagne solidali serie e
che non siano delle truffe. Prima di fare la propria donazione, ognuno deve
quindi assicurarsi che l’attività sia svolta su siti web ufficiali e confermati.
In tale contesto, anche l’ospedale di Reggio Calabria ha deciso di aprire una
campagna solidale sul sito GoFundMe. Tuttavia qualche giorno fa Striscia la
Notizia ha fatto notare al suo pubblico come sulla piattaforma non risultasse
ancora tale struttura nell’accettazione della campagna. Il tg satirico di
Antonio Ricci ha invece precisato come il San Raffaele di Milano abbia dato la
propria autorizzazione. Stando dunque al programma di Canale 5, il rischio era
che il denaro raccolto potesse finire sul conto corretto del soggetto creatore
della campagna e non all’ospedale vero e proprio. La replica non è tuttavia
tardata ad arrivare. La notizia è stata infatti smentita direttamente dei
colleghi del tg satirico di Mediaset. Nelle ultime ore il GOM ha di fatto
firmato una delibera con cui ha autorizzato ufficialmente la donazione della
raccolta fondi dei cittadini calabresi. È stato infine messo in chiaro come nel
servizio di Striscia la Notizia sia stata data sostanzialmente una fake news.
Enrico Mentana, un "anche" di troppo? Criticato da alcuni
napoletani, replica: "Ridicoli piagnoni, imparate l'italiano".
Libero Quotidiano il 02 aprile 2020. Enrico Mentana nella bufera.
A far discutere è un post pubblicato dal direttore del Tg La7 sul suo profilo
Facebook. Qui il giornalista condivide un articolo dal titolo: “Ma a Napoli c’è
anche un’eccellenza nella lotta al coronavirus: il Cotugno”. A rimarcare il
pezzo, il suo commento: "A Napoli c’è anche un’eccellenza“. E così, per
l'"anche", è stato preso di mira da non pochi utenti: sono più di 9mila i
commenti lasciati e ai quali Mentana non evita di rispondere. “Ridicoli
piagnoni che vi attaccate a un semplice anche, imparate l’italiano - scrive
-. Amo Napoli più di voi evidentemente”. Una frase che ha gettato benzina sul
fuoco, alimentando ancora di più la polemica in corso: "'Anche', è proprio più
forte di voi. Intanto qui nessuno ci pensa e l'eccellente personale sanitario fa
i salti mortali per assistere con i pochissimi mezzi messi a disposizione chi ha
la "fortuna" di poter essere curato. L'eccellenza qui c'è sempre!" scrive una
ragazza mentre qualcuno le fa eco: " ... “anche”...Non cambierà mai. E non parlo
di lei, direttore. Ma della discriminazione generale verso il Sud. Insomma,
tutti contro Mentana.
Per i media inglesi il Cotugno è un modello per l’Italia. Per
Mentana: “A Napoli c’è anche un’eccellenza”. Da Chiara
Di Tommaso l'1 aprile 2020 su Vesuvio Live.
Il Cotugno di Napoli è un’ospedale modello per tutta l’Italia,
una mosca bianca. A dirlo è un servizio, ricco di elogi, fatto da Skynews, una
delle fonti più autorevoli nel campo dell’informazione. Sotto la lente di
ingrandimento finisce un dato significativo: quello dei medici e infermieri che
non sono stati contagiati dal coronavirus nell’Ospedale napoletano. Un dato in
controtendenza rispetto a quello di tutta Italia dove si registrano oltre 8 mila
contagi nel personale sanitario. Ma in un articolo di Open, questa notizia viene
leggermente cambiata. Come? Semplicemente nel titolo:
“Ma a Napoli c’è anche
un’eccellenza nella lotta contro il Coronavirus: il Cotugno”.
Il ma a inizio frase indica un certo
atteggiamento avversativo a una notizia che è invece solo positiva. Una scelta
ben precisa perché come sostiene la Treccani, “Il caso
più noto e studiato è quello del ma che, oltre a essere usato come congiunzione
coordinativa con valore avversativo, ha una serie di usi pragmatici, che
segnalano cioè un atteggiamento del parlante rispetto all’enunciato stesso o
all’enunciazione. In questi casi il ma è solitamente collocato in apertura di
frase. Un primo esempio è rappresentato da frasi esclamative abrupte in cui il
ma segnala la contrarietà del parlante (ma tu guarda!, ma bravo!, ma no!). Il ma
può essere inoltre usato a inizio di frase con un valore parafrasabile
all’incirca come «nonostante sia vero quanto detto (o presupposto) finora, più
importante ancora è quello che segue …». Lo si incontra nello scritto dopo una
pausa forte (marcata da un punto o punto e virgola) o a inizio assoluto di
testo, per segnare il passaggio ad altro argomento o per rinviare enfaticamente
a un argomento noto”.
Peccato che l’intero articolo racconti
solo dell’elogio di Sky News al Cotugno e manchi del tutto il riferimento a un
altro argomento, appunto avversartivo. Resta quindi un titolo fuorviante che
genera solo commenti negativi. Anche il fondatore di Open, Enrico Mentana, posta
questa notizia sul suo profilo Facebook riportando, in parte, il titolo
dell’articolo.
“A Napoli c’è anche un’eccellenza”
Qui è la parola ‘anche’ ad aver
suscitato più di una reazione nei lettori. In tantissimi infatti sotto al post
criticano la scelta del giornalista di aver usato quella congiunzione.
Scrive Raffaele:
“Che significa “a Napoli c’ è anche un eccellenza”? lo ritengo abbastanza
offensivo da un professionista come lei. Ha perso tutta la mia stima”.
Mentre Tiziana commenta:
“L”anche” poteva essere evitato… mettendolo sta affermando che il resto non è
eccellenza o, addirittura, induce a pensare che il resto è al di sotto dei
livelli standard (per non dire, alla napoletana, il resto è munnezz)”.
Ma c’è anche chi pensa che questa sia
stata solo una mossa per ottenere più like, come Paolo che scrive:
“Quell’ “anche” è molto triste, so che l’ha messo per far sollevare un ennesima
polemica, ma offende tanti che in questo momento, fuuri dal Cotugno, si stanno
facendo in quattro contro il Virus. Rettifichi il titolo, non approfitti di
questo momento di grande emotività per racimolare qualche commento o like in
più”.
La gaffe l'inviata di Agorà: "Non siamo fortunati, non c'è
nessuno". Delusione per l'inviata Rai a Napoli per
testimoniare il rispetto del decreto coronavirus: voleva documentare le
violazioni ma la strada è deserta. Le sue parole scatenano l'indignazione sui
social. Paola Francioni, Mercoledì 15/04/2020 su Il Giornale. Da oltre un mese
la televisione italiana è diventata quasi monotematica. L'argomento principale,
trattato in ogni sua sfaccettatura, è il coronavirus. Difficilmente potrebbe
essere diversamente, visto che siamo nel bel mezzo di una pandemia mondiale che
sta facendo decine di migliaia di morti. I programmi televisivi delle reti
nazionali si occupano prevalentemente di questo: sono stati soppressi
momentaneamente tutti gli spazi di intrattenimento, relegati nella maggior parte
dei casi a repliche di programmi già editi. Gli editori hanno preferito mettere
momentaneamente da parte l'attualità leggera per concentrare le energie sul
racconto del coronavirus. In questa spasmodica caccia alla notizia si è inserito
anche Agorà, che negli ultimi giorni sta facendo discutere animatamente la rete.
Il programma di informazione che va in onda al mattino su Rai3 è spesso elogiato
la qualità del suo lavoro e dei suoi servizi ma in queste giornate così
complesse i social hanno qualcosa da ridire sulle modalità con le quali la
trasmissione ha deciso di informare. La polemica più accesa è scoppiata oggi e
la protagonista è un'inviata del programma in collegamento da Napoli. La città
Partenopea è spesso presa come esempio della scarsa attitudine degli italiani di
rispettare le regole imposte dal governo. In un momento in cui si chiede il
massimo rispetto delle distanze di sicurezza e in cui si chiede ai cittadini di
limitare le loro uscire per contenere il contagio da coronavirus, sono molte le
testimonianze contrarie che giungono da Napoli. In rete girano i video delle
strade brulicanti di pedoni e di auto, sui social rimbalzano le immagini
provenienti da ogni angolo della città che vorrebbero documentare una sorta di
"allergia" alle regole da parte del sud. Forse in quest'ottica voleva inserirsi
il servizio di Agorà di questa mattina, quando l'inviata si è recata in una
delle principali arterie commerciali di Napoli per riprendere e testimoniare con
la sua viva voce l'elevata circolazione dei mezzi nella città campana. Eppure,
alle 8.37, alle sue spalle non circolavano che pochissime auto, nulla a che
vedere con i racconti che provengono dalla città campana. "Io ti voglio far
vedere quest'immagine. Noi siamo in una zona che sarebbe pedonale, siamo qui da
circa mezz'ora. C'è in realtà un passaggio di auto abbastanza numerose, abbiamo
visto furgoncini", racconta la giornalista ma, alle sue spalle, si vedono
pochissime auto in transito. A quel punto, l'inviata pronuncia una frase che ha
fatto indignare ben più di qualche telespettatore: "Non siamo fortunati in
realtà, in questo momento si stanno comportando... Non c'è nessuno, ma fino a
pochi minuti fa c'era un passaggio intenso." Il fatto che la giornalista
consideri una circostanza sfortunata quella di non poter rilevare con le
telecamere un elevato passaggio veicolare, sinonimo di possibile trasgressione
del decreto contro il coronavirus, sarebbe una circostanza sfortunata. Non la
pensano così i napoletani, che sui social hanno fatto sentire la loro voce: "Ore
8.30, la giornalista in diretta dice che a Napoli c'è troppa gente per strada ma
la telecamera inquadra una via Scarlatti deserta. Lei: 'Non siamo stati
fortunati, fino a pochi minuti fa qui c'era un traffico intenso'... Come fate a
non vergognarvi?", "Mi spiace non se ne parli, ma nel mio piccolo vorrei
sottolineare quanto in basso stia scavando #agorai: l'inviata, in barba a ogni
regola di distanziamento, tocca l'ospite; 'Non siamo fortunati, i napoletani si
stanno comportando bene'. Mi vergogno per loro." Questi sono solo alcuni dei
commenti che si trovano su Twitter, dove per altro si fa anche notare come
l'inviata, trasgredendo una delle regole base imposte dal decreto contro il
coronavirus, mette una mano sulla spalla di un suo ospite e non rispetta il
distanziamento sociale. Solo poche ore fa il programma era stato criticato per
aver mandato in onda un concitato inseguimento a un anziano runner con un drone
della polizia, utilizzando come sottofondo la Cavalcata delle Valchirie.
“A Napoli traffico intenso”: in strada non c’è nessuno e la
giornalista tocca l’uomo. Da Francesco Pipitone il 15
Aprile 2020 su VesuvioLive. Questa mattina è andata in onda, come al solito, il
programma di informazione Agorà in onda su Rai Tre. In collegamento da via Luca
Giordano al Vomero c’era la giornalista Elena Biggioggero, che ha intervistato
Luigi Sparano, segretario della sezione napoletana della Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale. In realtà la Biggioggero fa domande molto
interessanti a Sparano, il quale mette in luce problematiche estremamente
importanti per quanto riguarda la gestione del pericolo della diffusione del
contagio da coronavirus. Napoli, viene evidenziato, è una città in cui ci sono
molti nuclei familiari numerosi, dunque il contagio avviene spesso tra le mura
domestiche. Situazione che si fa più grave nei quartieri più popolari, dove le
esigenze economiche spingono alla convivenza tra più persone, in particolar modo
con gli anziani. Il problema sorge quando la conduttrice, Serena Bortone, si
collega alle polemiche dei giorni scorsi sulla presunta eccessiva presenza di
persone in strada domandando ad Elena Biggioggero se fosse vero o meno: “Siccome
sono state fatte un po’ di polemiche – Napoli vuota, strade occupate eccetera –
da testimone – per altro tu sei milanese, per questo hai uno sguardo nordico sul
nostro amato Sud… non toccarlo, non vi avvicinate… – voglio sapere se Napoli è
vuota oppure no, se si rispettano le regole oppure no”. A quel punto la
giornalista fa girare il cameraman per fargli inquadrare la strada, che però in
quel momento è vuota: “Guarda Serena, io ti voglio far vedere questa immagine.
Noi stiamo in una zona che sarebbe pedonale. Siamo qua da circa una mezz’ora.
C’è un passaggio di auto, insomma, abbastanza numerose; abbiamo visto
furgoncini, sarebbe una zona commerciale in cui il commercio è interrotto perché
i negozi sono chiusi. Ecco, non siamo fortunati in realtà perché in questo
momento non c’è nessuno ma fino a pochi minuti fa c’era un passaggio intenso”.
Serena Bortone replica: “No perché ieri ci siamo sentiti con Elena e mi ha detto
che Napoli era deserta. Quindi se poi qualcuno si sposta, insomma…”. In realtà
via Luca Giordano è sì pedonale, ma soltanto in parte, come sa bene qualsiasi
napoletano. Elena Biggioggero ha dunque fornito un’informazione sostanzialmente
sbagliata, poiché fa intendere che nonostante la pedonalizzazione ci sia un
passaggio intenso di auto. Secondo, quando la giornalista fa inquadrare la
strada, viene ripresa la parte dove le auto possono passare e se ne vede
transitare soltanto una, poi un autobus. Durante il collegamento furgoncini non
se ne vedono, soltanto un mezzo dell’Asia per la raccolta dei rifiuti, e tra
l’altro se anche fossero passati dei furgoncini molto probabilmente poteva
trattarsi di lavoratori che consegnavano merci, chissà. Giornalisticamente
l’informazione che ha dato è irrilevante poiché nulla faceva intendere una
illiceità del passaggio – presunto – dei furgoncini. Ma la parte “migliore”
l’abbiamo vista quando la Biggioggero ha messo la mano sulla spalla del dottor
Sparano passandogli molto vicino, sfiorandolo addirittura, ed entrambi non
avevano la mascherina posizionata sul volto. Serena Bertone infatti l’ha
avvertita: “…non toccarlo, non vi avvicinate…”.
Ennesima figuraccia Rai. Napoli Est applaude la polizia, Tg1
vergogna: “Ma da voi non è ben accetta”. Redazione de
Il Riformista il 18 Aprile 2020. Sorprendersi perché i residenti del Bronx di
San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, applaudono la polizia
intervenuta con mezzi speciali per sanificare le strade durante l’emergenza
coronavirus. La Rai ci ricasca ancora e a pochi giorni dall’inviata della
trasmissione Agorà, che dal nord è stata spedita a Napoli per dichiarare in
diretta televisiva di essere stata sfortunata a non beccare auto o persone in
strada, porta a casa un’altra figuraccia con un servizio andato in onda venerdì
sera, 17 aprile, al Tg1. “Qua di solito la polizia non è ben accetta” chiede il
giornalista a un residente del Bronx dopo aver ripreso l’accoglienza calorosa
riservata dagli abitanti delle case popolari omaggiate qualche anno fa da due
dipinti dello street artist Jorit. Un pregiudizio gratuito che resta tale a
prescindere nella concezione di chi viene spedito a raccontare quello che accade
nel capoluogo partenopeo senza conoscere a fondo la realtà stessa che dovrebbe
documentare. Per l’opinione pubblica nel Bronx c’è solo la camorra, così come a
Scampia, nel Rione Traiano, nel rione Conocal a Ponticelli o nel centro storico
a Forcella. Tutte le persone oneste che vi abitano sono destinate a portarsi
dietro questa etichetta e a finire, in chiave negativa, in un servizio del Tg1
nonostante gli applausi alla polizia.
STATO DI SALUTE AL SUD E INIQUITA’ SANITARIA.
Michele Di Pace - Ambrogio Carpentieri il 30.07.2020 su movimento24agosto.it.
Sono stati analizzati i dati di Health Search e Osservatorio Salute negli anni
2016-2018 relativamente ad alcuni indicatori sullo stato di salute dei cittadini
tra il Sud e il Nord del Paese.
ASPETTI DEMOGRAFICI (tasso di fecondità totale e speranza di vita
alla nascita), MORTALITA', STILI DI VITA e PREVENZIONE (quota di fumatori tra la
popolazione di età 14 anni e oltre e trend, prevalenza di persone di età 18 anni
e oltre in condizione di sovrappeso, prevalenza di persone di età 18 anni e
oltre obese, coloro che dichiarano di non praticare sport, copertura vaccinale
antinfluenzale negli ultra-sessantacinquenni), SALUTE MENTALE (consumo di
farmaci antidepressivi e trend), SALUTE MATERNO-INFANTILE (proporzione di parti
con taglio cesareo), ASPETTI ECONOMICI (spesa sanitaria pubblica pro-capite),
ASSISTENZA OSPEDALIERA (percentuale di pazienti di età 65 anni e oltre operati
entro 2 giorni per frattura del collo del femore) esaminandone la variabilità
territoriale in un’ottica di valutazione dell’efficacia dei singoli SSR e di
equità a livello nazionale.
Le condizioni di salute degli italiani si mantengono buone in
termini di sopravvivenza, ma non migliorano le condizioni patologiche per le
quali è forte il ruolo della prevenzione e degli stili di vita. In particolare,
andamenti non positivi si riscontrano per alcune patologie tumorali causate
dalle abitudini al fumo, dalla condizione di obesità e dalla scarsa adesione ai
programmi di screening. Un altro elemento di criticità riguarda la qualità degli
anni di vita degli anziani, vissuti in cattive condizioni di salute.
Infatti per gli aspetti demografici il tasso di fecondità totale
rimane alto per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, pur inferiore al livello di
sostituzione (circa 2,1 figli per donna) che consentirebbe il ricambio
generazionale, mentre è basso per Sardegna ma anche Molise, Basilicata e Puglia.
Inoltre la speranza di vita alla nascita risulta più alta in Toscana e Veneto
per gli uomini e ancora Veneto per le donne seguite da Emilia Romagna, Lombardia
mentre è il più basso in Campania sia per uomini che donne seguita da Sicilia.
I dati di mortalità (per 10000) risultano elevati per la Campania
rispetto alla media nazionale seguiti dalla Sicilia mentre sono bassi per le
donne in Molise e gli uomini in Toscana.
Seguire corretti stili di vita è un eufemismo per il Sud dove si
fuma molto in Campania anche se in diminuzione, si è in sovrappeso in Basilicata
e obesi in Puglia mentre in Sicilia si segue poco sport rispetto ai pochi
fumatori in Calabria con trend in aumento, pochi in sovrappeso in Piemonte e
obesi in Toscana e molto sportivi in Veneto.
La copertura vaccinale contro la influenza, nel campo della
prevenzione, si mantiene nella media su tutto il territorio nazionale ed è basso
solo in Sardegna.
Il consumo di farmaci antidepressivi è molto elevato in Toscana
con trend in aumento e alto in Emilia-Romagna mentre è inferiore alla media in
Campania seguita da Puglia, Molise, Basilicata e Sicilia.
La proporzione di parti con taglio cesareo, indice di salute
materno-infantile, è molto basso, quindi positivo, in Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana ed alto nelle regioni del Sud in particolar modo in Campania.
Il valore dell'indicatore relativo alla spesa pubblica pro-capite
è alto rispetto alla media in Sardegna e Molise, più basso in Campania seguita
da Calabria e Sicilia.
Infine la assistenza ospedaliera rappresentata dalla percentuale
di pazienti di età 65 anni e oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo
del femore è ottima in Toscana, buona in Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte,
nella media per le altre regioni e scarsa in Molise seguita da Calabria.
Ambrogio Carpentieri - Commissione Sanità ET M24A
LA MOBILITA’ SANITARIA DA SUD VERSO NORD, FORMA DI
SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI MERIDIONALI. Michele Di
Pace - Pasquale Biscari il 29.07.2020 su movimento24agosto.it.
1°- Studio dei Fattori Primari. Seguiranno : 2° - Studio dei
Fattori Secondari, Criticità, Eccellenze; 3° - Correttivi, Proposte e
Considerazioni finali. Il problema della Mobilità Sanitaria in Italia è da
sempre l’emblema delle disuguaglianze regionali e del colonialismo economico
imposti alle regioni del Meridione. Oggi si può dire che questa criticità sia
diventata il primo paradigma responsabile dello squilibrio nella Struttura
Sociologica della Sanità. Lo è in quanto ne mina la qualità sociale, la qualità
organizzativa e la qualità erogata attraverso le prestazioni sanitarie. Sia pure
esistesse fin dal secolo scorso, la Mobilità Sanitaria ha manifestato tutta la
sua criticità con la Riforma del Titolo V° della Costituzione (ottobre 2001) e
con l’art 117 che afferma il Principio della Sussidiarietà Verticale; un
criterio di ripartizione delle funzioni amministrative tra organi di governo,
che inverte il riparto delle competenze e riconosce in capo alle Regioni il
compito di legiferare in tema di Sanità. La gestione della Salute viene di fatto
affidata alle Regioni e il tutto con una marcata scelta federalista che lascia
allo Stato Centrale la competenza sulle cosiddette “Leggi Quadro di Cornice”.
Allo Stato viene riconosciuta in modo esclusivo la competenza sui Livelli
Essenziali dell’Assistenza (LEA) e delle Prestazioni Sanitarie (LEP), con
livelli minimi al di sotto dei quali non è possibile andare; il tutto
finalizzato a garantire l’uniformità delle prestazioni sull’intero territorio
nazionale. Da questo momento legislativo, le Regioni del Sud coi servizi
sanitari già ai limiti dei minimi costituzionali, hanno subito tagli al
personale ( numero chiuso a Medicina, mancato turnover degli operatori) e ai
posti letto ospedalieri (rapporto posti letto per numero abitanti), ancora più
consistenti di quelli operati in passato da ministri e governi disorganici. La
Fondazione Gimbe nella sua attività di monitoraggio indipendente delle emergenze
globali ha accertato e documentato in circa 40 miliardi di euro i fondi
sottratti alla Sanità del Sud e fatti affluire al Nord solo negli ultimi dieci
anni. In nome di una ingiustificata Spesa Storica, costantemente pretesa e
applicata a favore della Sanità Privata e affaristica del Nord, si è creato un
divario ipertrofico tra le Strutture Sanitarie. Un divario alimentato dallo
spostamento di pazienti verso le Regioni del Nord a cui le Regioni del
Mezzogiorno pagano, a un prezzo maggiorato, i DRG dei migranti della salute
(circa 4,5 miliardi l’anno). Si tratta di una criticità cronica che, nel tempo,
ha generato un disparità sul territorio nazionale nel godimento del servizi
sanitari da parte del cittadino utente. Una criticità nazionale perdurante che
ha gravato e grava sui cittadini del Meridione che vedono sempre più ridotta la
loro aspettativa di vita nei confronti dei cittadini del Settentrione. Una
disparità diventata ancora più manifesta oggi, a causa dell’attuale pandemia da
Covid19, che ha evidenziato la gestione sanitaria fallimentare nelle Regioni del
Nord. Nonostante le maggiori entrate, queste, si sono trovate impreparate a
reggere l’onda d’urto del virus per aver privilegiato una sanità imprenditoriale
privata, di èlite, di liberismo spinto e di profitto, a una sanità pubblica di
servizio per l’Emergenza - Pronto Soccorso e per le Terapie Intensive -
Rianimatorie. Quantunque penalizzato dalle risorse sottratte, dalle nequizie di
sedicenti governatori di regione e dalle invettive di una stampa asservita, il
Sud ha dimostrato di reggere molto meglio la virulenza del Covid19, ivi compresi
i flussi di studenti e lavoratori fatti arrivare, a ondate, dalle regioni del
Nord nella prima fase disordinata della pandemia. Tutti questi fattori hanno
avuto l’amara conseguenza di evidenziare maggiormente il fenomeno migratorio
della salute denominato “della speranza”. I pazienti che migrano nelle strutture
sanitarie del Settentrione per una presunta aspettativa di assistenza sanitaria
qualificata, in realtà, si vedono ancora più utilizzati e sfruttati a fini di un
mero guadagno economico barattato sulla loro pelle. E non sono neppure da
trascurare le ripercussioni che tale squilibrio esercita sulla economia sociale.
Nell’ultimo rapporto Kelony si evidenzia come, il rischio di una crescente
esasperazione causata dalla insufficiente soddisfazione delle popolazioni, possa
portare a forme di rivolta senza precedenti. In questo rapporto viene ipotizzata
persino una sorta di “dittatura sanitaria” a cui potrebbe seguire una rivolta
sociale con conseguenti interventi repressivi da parte di Stati autoritari.
Destabilizzare, impaurire, terrorizzare è sempre servito a garantire la
sicurezza delle oligarchie finanziarie e a conservare i loro privilegi a
discapito delle fasce sociali deboli. Se qualcosa di simile dovesse accadere,
perderebbe del tutto i suoi effetti la legge quadro 328/ del 2000, nata per
regolamentare l’Assistenza finalizzata agli interventi socio sanitari. Non
verrebbe più garantito un aiuto concreto alle persone non autosufficienti, ai
minori, agli anziani e alle famiglie in difficoltà all’interno del loro nucleo
familiare. Ancora più di queste ne soffrirebbero le strutture speciali come le
RSA e gli altri Centri Assistenziali. C’è da dire, inoltre, come nuove
situazioni di precarietà e instabilità politica, neppure tante remote,
porterebbero a veri disastri sociali ed economici qualora i mezzi della generosa
Recovery Fund appena elargiti dall’Europa e mai visti prima di adesso, non
andassero nella direzione giusta. Bisogna augurarsi davvero che si metta fine
alle egemonie ideologiche partitiche e si dia luogo a un impegno comune nello
spendere subito e bene i tanti miliardi che arriveranno, sia pure con un certo
ritardo. Intanto restano e continuano a esistere i “cammini della speranza” che
ogni anno costano alle Regioni del Sud l’esborso di oltre quattro miliardi di
euro. Sicuramente ci vorrà del tempo per fermare e invertire il cammino di
queste migrazioni. Non sarà semplice correggere le disuguaglianze che hanno
generato i migranti della salute e dirottarli verso le strutture del Sud dove,
come vedremo nel prossimo studio, se ne contano tante di eccellenze sanitarie
distribuite sul territorio. Al fine di evitare malcontenti e insoddisfazioni nel
tessuto sociale ed economico della Nazione diventa, dunque, necessario procedere
con le riforme raccomandate anche dall’Europa e approntare un Piano di Spesa
equo ed efficace che risollevi il Sud e vada incontro alle esigenze dei
cittadini, degli indigenti, dei lavoratori cassa integrati, degli esercenti del
terziario, del manifatturiero e dei piccoli e grandi imprenditori dei settori
primari agricolo e industriale.
Sanità, bugie sul Nord virtuoso: il buco fatto da Piemonte e
Liguria. Il falso mito che le Regioni settentrionali
ricevano più fondi dallo Stato perché li spendono meglio. Invece il disavanzo è
proprio creato da queste. Perché un calabrese deve ricevere 1800 euro l’anno e
un piemontese 1935 o un toscano 1917? Vincenzo Damiani l'1 agosto 2020 su Il
Quotidiano del Sud. Per la salute e le cure sanitarie dei propri cittadini, lo
Stato italiano fa figli e figliastri. Per un pugliese, ad esempio, al termine
del 2020 spenderà complessivamente 1.826 euro, contro i 1.918 riservati ad un
emiliano e i 1.877 ad un veneto. È questa la quota pro-capite che emerge dalla
ripartizione del fondo sanitario nazionale dell’anno in corso. Per ogni
lombardo, lo Stato destina 1.880 euro; per un campano, invece, 1.827 euro. Ma
peggio va ai calabresi, ai quale spetta appena 1.800 euro a testa, contro i
1.916 euro che “riceve” ogni friulano, i 1.935 euro di spesa pro capite del
Piemonte o i 1.917 euro della Toscana. Chi sperava in una inversione di rotta
almeno dopo una pandemia che ha stravolto le nostre vite e i nostri sistemi
sanitari resterà deluso. Il Nord continua a prendere più soldi per i suoi
ospedali, come accade ormai da oltre 15 anni. E nel 2021 potrebbe persino
incassarne ancora di più, la doppia beffa si potrebbe concretizzare a fine anno.
Anziché ricevere più risorse, quasi tutte le Regioni del Sud per la loro sanità
rischiano seriamente di ritrovarsi con meno fondi trasferiti dallo Stato. Il
nuovo sistema di verifica e valutazione dei Lea (i Livelli essenziali di
assistenza), che entra in vigore da quest’anno, prevede criteri più severi per
giudicare la qualità e l’efficienza dei sistemi sanitari regionali e, stando ad
una simulazione svolta dal Comitato Lea – organo del ministero della Salute –
solo 11 Regioni su 21 risultano essere adempienti, quindi sarebbero promosse. Le
“inadempienti” sono quasi tutte del Sud: Campania, Calabria, Molise, Basilicata,
Sicilia, Lazio, Sardegna, si salvano soltanto Puglia e Abruzzo. Il documento
della simulazione è riportato dalla Corte dei Conti nel suo ultimo Report sul
coordinamento della Finanza pubblica. Superare il giudizio del Comitato Lea non
è fine a sé stesso: riuscire a raggiungere un punteggio di sufficienza
garantisce alle Regioni lo sblocco di ulteriori fondi, una quota premiale pari
al 3% del riparto del fondo sanitario al netto delle entrate proprie. Per
intenderci, parliamo di svariati milioni di euro, complessivamente per il
Mezzogiorno circa un miliardo di euro. Insomma, superare “l’esame Lea” significa
poter ricevere soldi. Peccato, però, che prima di “inasprire” i criteri per
valutare la qualità delle cure, nessuno si sia preoccupato di mettere fine allo
“scippo” che il Mezzogiorno subisce da almeno 15 anni anche nel settore
sanitario. Depauperate delle risorse economiche, le Regioni del Sud oggi si
ritrovano con meno personale, meno soldi da spendere e macchinari più obsoleti.
E adesso, rischiano di perdere un’altra barca di soldi. Da una prima simulazione
di valutazione dei Lea svolta sui dati già consolidati del 2017, quasi tutto il
Sud risulta inadempiente, ma appare evidente che non avendo messo il Mezzogiorno
nelle condizioni di recuperare il gap dal Nord, inasprire i criteri di
valutazione finisce per danneggiarlo due volte. È un dato di fatto certificato
che il Nord continua a prendere più soldi per i suoi ospedali. Anche nel 2020,
infatti, il riparto del fondo sanitario nazionale ha seguito logiche inique:
meno risorse a parità di popolazione. È lo scippo della spesa storica che
prosegue, qualche esempio? Alla Puglia, 4,1 milioni di abitanti, dei 113,3
miliardi complessivi, sono stati riservati 7,49 miliardi; l’Emilia Romagna (4,4
milioni di residenti) riceverà 8,44 miliardi: quasi un miliardo in più
nonostante una popolazione quasi identica. Prendendo in considerazione il Veneto
(4,9 milioni di abitanti) la sproporzione resta, visto che la Regione di Zaia
incassa 9,2 miliardi, quasi due in più rispetto alla regione di Michele
Emiliano. Le differenze si fanno ancora più palesi se prendiamo la spesa pro
capite dello Stato per ogni cittadino: per la salute e le cure di un pugliese,
lo Stato investe 1.826 euro, contro i 1.918 riservati ad un emiliano e 1.877 per
un veneto. La Lombardia, che conta 10 milioni di residenti, riceve 18,8 miliardi
per la sua sanità che non ha brillato durante l’emergenza Coronavirus: fatti due
calcoli, significa 1.880 euro per ogni sua cittadino. La Campania, 5,8 milioni
di residenti, avrà 10,6 miliardi: 1.827 euro pro capite. La Calabria (quasi due
milioni di abitanti) ottiene nella ripartizione del fondo sanitario nazionale da
113 miliardi solamente 3,6 miliardi: 1.800 euro per ogni cittadino. Potremmo
continuare: il Friuli Venezia Giulia che conta 1,2 milioni di residenti, incassa
2,33 miliardi: 1.916 euro per ogni suo cittadino. E ancora: il Piemonte, che
pure negli ultimi anni come certificato dalla Corte dei Conti, non ha brillato
nell’obiettivo di tenere sotto controllo la spesa sanitaria, incassa dallo Stato
8,33 miliardi per 4,35 milioni di abitanti: circa 1.935 euro per residente.
Chiudiamo con la Toscana, 3,73 milioni di abitanti e 7,1 miliardi: 1.917 euro
pro capite. Figli e figliastri, dicevamo. Nel confronto tra il 2010 e il 2020,
l’incremento percentuale del Fondo sanitario nazionale premia ancora il Nord:
negli ultimi 10 anni la Lombardia ha visto aumentare la propria fetta
dell’11,4%, l’Emilia Romagna del 9,9%; 8,2% in più per la Toscana. La
Basilicata, invece, ha avuto un incremento percentuale molto più modesto
(+4,9%); l’Abruzzo del 6,7%; Calabria +5,7%; la Puglia e la Campania di circa
l’8,1%. Non solo: dal 2012 al 2017, nella ripartizione del fondo sanitario
nazionale, sei regioni del Nord hanno visto aumentare la loro quota, mediamente,
del 2,36%; mentre altrettante regioni del Sud, già penalizzate perché
beneficiare di fette più piccole della torta dal 2009 in poi, hanno visto
lievitare la loro parte solo dell’1,75%, oltre mezzo punto percentuale in meno.
Tradotto in euro, significa che, dal 2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato poco meno di un
miliardo in più (per la precisione 944 milioni) rispetto ad Abruzzo, Puglia,
Molise, Basilicata, Campania e Calabria. Si dirà, le Regioni del Nord ricevono
più soldi perché le spendono meglio. Falso mito. Tra il 2018 e il 2019, in
Italia si è registrato un peggioramento del disavanzo nei conti del settore
sanitario del 10 per cento: dai 990 milioni del 2018 si è passati a poco meno di
1,1 miliardi nell’esercizio appena concluso. Un peggioramento – certifica la
Corte dei Conti nel Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica – da
ricondurre “in prevalenza alle regioni non in Piano e a statuto ordinario, che
vedono ampliarsi il disavanzo dai 69,1 milioni del 2018 ai 165,5 del 2019”. I
giudici contabili stanno parlando proprio delle Regioni del Nord, lo chiariscono
in un passaggio successivo: “Un risultato – si legge nella relazione – dovuto
soprattutto al Piemonte, che quest’anno sembra chiudere l’esercizio con uno
squilibrio di circa 79 milioni. Più limitati gli squilibri di Liguria, Toscana e
Basilicata”. L’esame dei dati è tratto dai conti economici consolidati. Le
regioni a statuto speciale segnano un incremento più contenuto (+6,6 per cento),
pur confermando il risultato fortemente negativo a cui fanno fronte immettendo
risorse aggiuntive. Le regioni in Piano, cioè sostanzialmente quasi tutti quelle
del Mezzogiorno, nel 2019 continuano a registrare un riassorbimento degli
squilibri. Le differenze sono palesi anche sul numero di dipendenti a
disposizione: in Puglia, dove si conta una popolazione di 4,1 milioni di
abitanti, il personale sanitario a tempo indeterminato impegnato negli ospedali
supera di poco le 35mila unità; in Emilia Romagna (4,4 milioni) i dipendenti
sono invece oltre 57mila, in Veneto (4,9 milioni) quasi 58mila, in Toscana (3,7
milioni) sono quasi 49mila, in Piemonte (4,3 milioni) sono 53mila, non parliamo
della Lombardia dove si sfiora le 100mila unità. La Campania, che fa 5,8 milioni
di residenti, può contare soltanto su 42mila operatori sanitari, persino il
Lazio (5,8 milioni di abitanti) ha appena 41mila dipendenti a tempo
indeterminato al lavoro nella sua sanità.
La cicala e la formica. Giulia
Carcasi il 26 luglio 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Trenta gradi all’ombra. Sbracata sotto la tettoia de ‘na foglia,
‘na cicala cantava a voce alta. Quer canto, monotono e continuo, infastidiva ‘na
formica che s’affannava a fa provviste pe’ l’inverno e, barcollando, trasportava
sulla schina ‘na briciola grossa quanto ‘na collina.
«Pe’ cortesia. Puoi sta un minuto zitta?» chiese alla cicala.
Ma quella de canta’ nun smise affatto: «Si nun canto mo che è
estate, quanno lo faccio?».
«C’ho mal de testa» la pregò la formica. «Solo un minuto, damme
tregua. Smettila co’ ‘sto fri fri».
«Fri fri?!?» sbottò a ride’ la cicala, sfottendo la formica «Come
sei antica! Sei rimasta alla preistoria. ‘Na volta noi cicale facevamo fri fri,
ma ormai semo internazionali, parlamo inglese come lingua madre, l’avemo
imparato dai turisti al camping» e sottolineando la differenza de pronuncia
disse «Io non dico mica “fri fri”, ma “free free”, che vor di’ “libera,
libera”…».
«A me me pare uguale…» commentò la formica tra sé e sé.
«Ma che ne voi capi’ te che nun fai manco ‘n verso…» l’offese la
cicala «Raccatta le molliche, va’, ch’é mejo…».
Fino a quer punto s’era spinta l’ingratitudine! Da che mondo è
mondo, le cicale, a furia de canta n’intera estate, se ritrovano d’inverno a
mani vote e, si nun morono de fame, è proprio grazie alle fatiche costanti e
silenziose delle formiche, che generosamente condividono er cibo della loro
dispensa. Ner tempo nun solo la riconoscenza era scomparsa, ma le frivolette ce
battevano pure de cassa e l’aiuto pareva dovuto.
Mentre la formica s’allontanava risentita, la cicala sapeva
d’esse stata indelicata, ma nun voleva abbassa’ le antenne e, anziché chiede
scusa, rincarò la dose: «Cara mia, lo sai perché te la piji a male? Perché te
piacerebbe esse’ come me. La tua se chiama invidia. Te nun lo sai cos’è la vita.
Sai solo sgobba tutto er giorno. Nun c’hai da fa altro. D’altronde la natura
mica t’ha dato le qualità ch’ha dato a me. Canta’ nun sai canta, le ali nun ce
l’hai…».
«Vedi de falla finita» l’avvertì la formica. «E st’inverno nun
veni’ a frignare alla mia porta. Anzi, pardon, a freegnare. I tempi so’
cambiati, nun te ne sei accorta? Quest’anno nun se trovano più tante molliche a
terra. Esse generosi è diventato un mestieraccio e, a forza d’offese, pure su un
cuore morbido se fa er callo.»
La cicala capì d’avella detta grossa: «Ascolta. Poggia ‘nattimo
sta briciola». La formica se tolse quer carico dalle spalle e se fermò a
sentilla. «Io nun so vive come te,» le spiegò la cicala «ma nun te crede che so
felice de canta tutto er giorno. Certe vorte ce s’annoia pure. Tu ce sai sta ar
buio, io devo anna’ sempre a sbatte’ contro la luce. È tarmente breve la vita
nostra che, si me fermo a pensa’, m’assale l’angoscia…»
Allora anche la formica se rabbuiò. «E a me chi m’assicura che
nun me capita un colpo secco de ‘na scarpa in testa o ‘na spruzzata
d’insetticida? E che me so’ goduta? La vita è pe’ tutti n’incognita.»
C’hai ragione pure te» ammise la cicala. «Si tu me dai ‘na mano a
porta’ sta mollica, si famo mezzo e mezzo de fatica come famo mezzo e mezzo de
raccolto, tu forse nun t’annoieresti tanto, c’avresti meno angoscia, e io
c’avrei er tempo d’assaporà la vita. È vero, nun so canta’ e nun c’ho l’ali, ma
nun sai quanto me piacerebbe sta ‘na settimana in ferie a nun fa niente, a
riposa’ la schina, a fa ‘na camminata a vanvera, a fa du’ chiacchiere co quarche
amica» disse la formica. «Pe’ ‘na settima vorrei falla pure io la cicala».
A buon intenditor poche parole. E pe’ la prima volta ne la
storia, ‘na cicala e ‘na formica se caricarono, una da un lato e una dall’altro,
‘na briciola.
La lepre e la tartaruga. Giulia
Carcasi il 2 agosto 2020 su Il Quotidiano del Sud.
Te puoi sforza’ quanto te pare, ma certe doti o ce l’hai o nun ce
l’hai: nun se imparano.
La lepre c’era nata veloce e s’era meritata er titolo de scheggia
der bosco. A vedella pareva ‘n conijo un po’ più grosso, ma mentre quello
c’aveva l’espressione domestica de chi s’acquatta dentro a ‘n nascondiglio, la
lepre nell’occhi selvatici c’aveva ‘n guizzo. Faceva certi salti che pure i
grilli je facevano i complimenti.
Un giorno nacque ‘na tartaruga col complesso de superiorità: a
tutte quelle della sua specie spettava ‘na vita lunga e lenta, ma a lei nun je
bastava. “Mamma, papà, guardate come so’ svelta!” se metteva ar centro
dell’attenzioni, muovendo a più non posso le sue zampe a rallentatore. Era più
rapida la terra a gira’ attorno al sole.
“Ammappa!” fingevano de stupisse i genitori pe’ falla contenta,
“se continui de ‘sto passo a te la lepre te fa ‘n baffo”.
Dall’apprezzamenti familiari era passata a pretende’ pure quelli
dell’altri animali. E un po’ pe’ compassione un po’ perché ai matti je se dà
ragione, “Come sei brava!” je ripetevano in coro “Sei ‘n siluro!”. A forza de
bucie era diventata così viziata da nun accetta’ più critiche: si quarcuno
s’azzardava a faje nota’ che in un giorno faceva a stento mezzo metro e nun se
po’ certo definì un record, la tartaruga dava in escandescenze. “Nun t’avvelenà,
nun ne vale la pena” la consolavano allora i genitori credendo de fa’ er suo
bene “Pe’ un meschino che te dice ‘na cattiveria, nun puoi mette’ in dubbio un
talento che tutti te riconoscono…”.
La presunzione si spinse ar punto che la tartaruga un giorno se
presentò alla lepre. “Te sfido a chi arriva prima a quell’albero. Scommetti che
te batto?”
“È ‘no scherzo?” je rispose quella.
“Nun te crede” l’avvertì la tartaruga “Parto piano, ma so’ un
diesel”. E in uno stato di esaltazione aggiunse “Si nun te la senti, lo capisco…
C’hai paura de fa ‘na figuraccia e rovinatte la piazza?”
A ‘na simile provocazione la lepre pensò che era troppo: “Paura
io de te?!?” e accettò la gara.
Stabilirono un orario, un punto de partenza e un punto d’arrivo.
Al “Via!” la tartaruga scattò subito, ma, pur affannandosi,
pareva ferma.
Incontrastata la lepre avanzava, ma sentiva che stava svendendo
quer talento che j’aveva dato la natura: se corre pe’ scappa’ da li cani o dalle
schioppettate dei cacciatori, se corre pe’ senti’ sul muso la libertà der vento,
la carezza dei fili der prato, ma corre pe’ ‘na sfida nun ha senso. Se la vita è
‘na sfida, è solo co’ se stessi e no coll’altri, figurarsi co ‘na tartaruga.
Vincere sarebbe stata ‘na sconfitta. Così, arrivata a ‘n passo dar traguardo, se
fermò e, senza tajiarlo, se mise lì ad aspettare per ore e ore.
La tartaruga, quanno finalmente la raggiunse, esclamò “T’ho
ripreso!” e pe’ l’emozione nun stava più ner carapace. Ma se sgonfiò ben presto,
vedendo che la lepre, scansandosi, la faceva passare avanti e je diceva
“Prego!”.
La corazzata tajò comunque er traguardo, ma fu ‘na misera
conquista, che nun la rese soddisfatta.
A chi je chiede come quer giorno annarono le cose, la tartaruga,
vantandosi, racconta ‘na menzogna: “Er segreto è la costanza! Chi va piano va
sano e va lontano”. Alle lepre je scappa da ride ogni vorta che la voce arriva
alle sue lunghe orecchie. Si je chiedessero de rifa’ la sfida, farebbe vince la
tartaruga n’artra vorta, che tanto sempre e comunque ‘na tartaruga resta.
Sanità, uno scippo senza fine: al Sud sottratto un altro
miliardo. Vincenzo Damiani il 24 luglio 2020 su Il
Quotidiano del Sud. La doppia beffa si potrebbe concretizzare tra pochi mesi, a
fine anno. Anziché ricevere più risorse, quasi tutte le Regioni del Sud per la
loro sanità rischiano seriamente di ritrovarsi con meno fondi trasferiti dallo
Stato. Il nuovo sistema di verifica e valutazione dei Lea (i Livelli essenziali
di assistenza), che entra in vigore da quest’anno, prevede criteri più severi
per giudicare la qualità e l’efficienza dei sistemi sanitari regionali e, stando
ad una simulazione svolta dal Comitato Lea – organo del ministero della Salute –
solo 11 Regioni su 21 risultano essere adempienti, quindi sarebbero promosse. Le
“inadempienti” sono quasi tutte del Sud: Campania, Calabria, Molise, Basilicata,
Sicilia, Lazio, Sardegna, si salvano soltanto Puglia e Abruzzo. Il documento
della simulazione è riportato dalla Corte dei Conti nel suo ultimo Report sul
coordinamento della Finanza pubblica. Attenzione, superare il giudizio del
Comitato Lea non è fine a sé stesso: riuscire a raggiungere un punteggio di
sufficienza garantisce alle Regioni lo sblocco di ulteriori fondi, una quota
premiale pari al 3% del riparto del fondo sanitario al netto delle entrate
proprie. E pensare che il ministro Speranza aveva promesso più risorse per la
Sanità del Sud. Per intenderci, parliamo di svariati milioni di euro: oltre 200
per la Campania, ad esempio, complessivamente per il Mezzogiorno circa un
miliardo di euro. Insomma, superare “l’esame Lea” significa poter ricevere
soldi. Peccato, però, che prima di “inasprire” i criteri per valutare la qualità
delle cure, nessuno si sia preoccupato di mettere fine allo “scippo” che il
Mezzogiorno subisce da almeno 15 anni anche – e non solo – nel settore
sanitario. Depauperate delle risorse economiche, le Regioni del Sud oggi si
ritrovano con meno personale, meno soldi da spendere e macchinari più obsoleti.
E adesso, rischiano di perdere un’altra barca di soldi. Sì perché, come
dicevamo, da fine 2020, sarà in vigore il nuovo sistema di garanzia dei Lea,
approvato nel dicembre 2018 in Conferenza Stato-Regioni. La nuova metodologia
valuta distintamente le tre aree di assistenza e attribuisce loro un valore
compreso in un range 0-100. La garanzia di erogazione dei Lea si intende
raggiunta qualora, entro ciascun livello, sia raggiunto un punteggio pari o
superiore a 60. Il punteggio di ogni area è determinato dalla media pesata di 22
indicatori, così suddivisi: 6 per l’area della prevenzione (copertura vaccinale
pediatrica a 24 mesi per esavalente e MPR, controllo animali e alimenti, stili
di vita, screening oncologici); 9 per l’attività distrettuale (tasso di
ospedalizzazione di adulti per diabete, Bpco e scompenso cardiaco e tasso di
ospedalizzazione di minori per asma e gastroenterite, intervallo chiamata-arrivo
mezzi di soccorso, tempi d’attesa, consumo di antibiotici, percentuale
re-ricoveri in psichiatria, numero decessi da tumore assistiti da cure
palliative, anziani non autosufficienti nelle RSA); 6 per l’attività ospedaliera
(tasso di ospedalizzazione standardizzato rispetto alla popolazione residente,
interventi per tumore maligno al seno eseguiti in reparti con volumi di attività
superiore a 150 interventi annui, ricoveri a rischio inappropriatezza, quota di
colecistectomie con degenza inferiore ai 3 giorni, over 65 operati di frattura
al femore entro 2 giorni; parti cesarei in strutture con più e meno di 1000
parti l’anno). Da una prima simulazione svolta sui dati del 2017, quasi tutto il
Sud risulta inadempiente, ma appare evidente che non avendo messo il Mezzogiorno
nelle condizioni di recuperare il gap dal Nord, inasprire i criteri di
valutazione finisce per danneggiarlo due volte. E’ un dato di fatto certificato
che il Nord continua a prendere più soldi per i suoi ospedali, come accade ormai
da oltre 15 anni. Anche nel 2020, infatti, il riparto del fondo sanitario
nazionale ha seguito logiche inique: meno risorse a parità di popolazione. E’ lo
scippo della spesa storia che prosegue, qualche esempio? Alla Puglia, 4,1
milioni di abitanti, dei 113,3 miliardi complessivi, sono stati riservati 7,49
miliardi; l’Emilia Romagna (4,4 milioni di residenti) riceverà 8,44 miliardi:
quasi un miliardo in più nonostante una popolazione quasi identica. Prendendo in
considerazione il Veneto (4,9 milioni di abitanti) la sproporzione resta, visto
che la Regione di Zaia incassa 9,2 miliardi, quasi due in più rispetto alla
regione di Michele Emiliano. Le differenze si fanno ancora più palesi se
prendiamo la spesa pro capite dello Stato per ogni cittadino: per la salute e le
cure di un pugliese, lo Stato investe 1.826 euro, contro i 1.918 riservati ad un
emiliano e 1.877 per un veneto. La Lombardia, che conta 10 milioni di residenti,
riceve 18,8 miliardi per la sua sanità che non ha brillato durante l’emergenza
Coronavirus: fatti due calcoli, significa 1.880 euro per ogni sua cittadino. La
Campania, 5,8 milioni di residenti, avrà 10,6 miliardi: 1.827 euro pro capite.
La Calabria (quasi due milioni di abitanti) ottiene nella ripartizione del fondo
sanitario nazionale da 113 miliardi solamente 3,6 miliardi: 1.800 euro per ogni
cittadino. Potremmo continuare: il Friuli Venezia Giulia che conta 1,2 milioni
di residenti, incassa 2,33 miliardi: 1.916 euro per ogni suo cittadino. E
ancora: il Piemonte, che pure negli ultimi anni come certificato dalla Corte dei
Conti, non ha brillato nell’obiettivo di tenere sotto controllo la spesa
sanitaria, incassa dallo Stato 8,33 miliardi per 4,35 milioni di abitanti: circa
1.935 euro per residente. Chiudiamo con la Toscana, 3,73 milioni di abitanti e
7,1 miliardi: 1.917 euro pro capite. Figli e figliastri. Nel confronto tra il
2010 e il 2020, l’incremento percentuale del Fondo sanitario nazionale premia
ancora il Nord: negli ultimi 10 anni la Lombardia ha visto aumentare la propria
fetta dell’11,4%, l’Emilia Romagna del 9,9%; 8,2% in più per la Toscana. La
Basilicata, invece, ha avuto un incremento percentuale molto più modesto
(+4,9%); l’Abruzzo del 6,7%; Calabria +5,7%; la Puglia e la Campania di circa
l’8,1%. Non solo: dal 2012 al 2017, nella ripartizione del fondo sanitario
nazionale, sei regioni del Nord hanno visto aumentare la loro quota, mediamente,
del 2,36%; mentre altrettante regioni del Sud, già penalizzate perché
beneficiare di fette più piccole della torta dal 2009 in poi, hanno visto
lievitare la loro parte solo dell’1,75%, oltre mezzo punto percentuale in meno.
Tradotto in euro, significa che, dal 2012 al 2017, Liguria, Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna e Toscana hanno ricevuto dallo Stato poco meno di un
miliardo in più (per la precisione 944 milioni) rispetto ad Abruzzo, Puglia,
Molise, Basilicata, Campania e Calabria. Le differenze sono palesi anche sul
numero di dipendenti a disposizione: in Puglia, dove si conta una popolazione di
4,1 milioni di abitanti, il personale sanitario a tempo indeterminato impegnato
negli ospedali supera di poco le 35mila unità; in Emilia Romagna (4,4 milioni) i
dipendenti sono invece oltre 57mila, in Veneto (4,9 milioni) quasi 58mila, in
Toscana (3,7 milioni) sono quasi 49mila, in Piemonte (4,3 milioni) sono 53mila,
non parliamo della Lombardia dove si sfiora le 100mila unità. La Campania, che
fa 5,8 milioni di residenti, può contare soltanto su 42mila operatori sanitari,
persino il Lazio (5,8 milioni di abitanti) ha appena 41mila dipendenti a tempo
indeterminato al lavoro nella sua sanità . Parlare di liste di attesa e mobilità
passiva a fronte di questi numeri diventa quasi superfluo: provate a immaginare
una partita di calcio dove una squadra schiera regolarmente 11 giocatori e
l’altra invece 5, 6 al massimo 7. Come crediate possa finire? La risposta è
abbastanza scontata. Come si può chiedere alla Puglia, a quasi parità di
popolazione, di riuscire a svolgere lo stesso numero di esami e visite mediche
che si riescono a fare in Emilia Romagna che ha 22mila lavoratori in più? Ecco
perché criteri di valutazione più severi finiranno per danneggiare due volte il
Mezzogiorno.
BERLUSCONI INVOCA UN NUOVO PIANO MARSHALL PER IL SUD? E' PER
PORTARE ALTRI SOLDI AL NORD. GLI "ERPIVORI", QUANDO DE GASPERI RUBO' AL SUD I
RISARCIMENTI AMERICANI DEL DOPOGUERRA. Di Annamaria
Pisapia, vicepresidente nazionale M24A. Su "Il Popolo" del 25 luglio 1948, Don
Luigi Sturzo si scagliò contro gli industriali del nord definendoli "erpivori",
cioè consumatori parassiti di fondi ERP,(european recovery program). Gli ERP,
meglio conosciuti come Piano Marshall, erano i fondi destinati dal governo
americano per la ricostruzione e il rilancio delle aree maggiormente devastate
dall'evento bellico della seconda guerra mondiale. Don Luigi Sturzo, in qualità
di presidente del "Comitato permanente per il Mezzogiorno", si batteva affinchè
gli aiuti del Piano Marshall venissero destinati in massima parte al
Mezzogiorno, che era l'area maggiormente colpita, rispetto al nord, pressando i
ministri in tal senso. Purtroppo il governo, presieduto da De Gasperi, ritenne
di dirottarli in misura dell'87% al nord e solo del 13% al Sud favorendo il
rilancio delle industrie settentrionali. Il ministro dell'agricoltura Segni
inviò una lettera a Don Sturzo il 22 luglio 1948 in cui diceva: " A POCO A POCO,
INDUSTRIA E NORD STANNO TENTANDO DI ACCAPARRARSI TUTTO. IO NEGOZIO, SINO ALLE
ESTREME CONSEGUENZE, MA LA LOTTA E' IMPARI, SOLO, COLL'OTTIMO RONCHI; CONTRO
QUASI TUTTI GLI ALTRI". (ALS 1947-59, cart. 52 fasc. 1948 Piano Marshall ERP).
Era nell'idea del governo e degli industriali del nord di puntare
sull'emigrazione a basso costo del Sud per il decollo dell'economia
italiana(nord). Così, di 1 miliardo e trecentomilioni di dollari, al Sud
arrivarono le briciole. Purtroppo anche quelle briciole Don Sturzo dovette
difenderle con i denti contro la crescente avidità degli industriali
settentrionali. E come era ovvio il pil di zone come il Veneto, fino ad allora
povero, schizzò a +22% e al Sud diminuì del 10%. Ma con grande "magnanimità" nel
1950 il governatore Donato Menichella, dato l'esaurimento dei fondi ERP, mandò
avanti una contrattazione, per protrarre la scadenza degli aiuti del Piano
Marshall con il governatore della Banca Mondiale Eugene Black , per istituire
"La Cassa per il Mezzogiorno". Così, mentre i soldi dei fondi ERP se ne andarono
in silenzio al nord, la "Cassa per il Mezzogiorno" venne annunciata con tanto di
grancassa. Insomma, la prepotenza del nord fece in modo che i fondi ERP
risultassero un risarcimento che gli era dovuto , mentre la "Cassa per il
Mezzogiorno" un'elemosina di cui essere grati. Inutile dire che il parassitismo
erpivoro infesta ancora il nord, che negli anni ha mutato denominazione pur
conservando la modalità trasmessa dai loro avi: succhiare linfa vitale al Sud.
"GLI ERPIVORI: NEL 1948 DE GASPERI DIROTTO' I FONDI DEL PIANO
MARSHALL AL NORD. NEL 2020 CONTE LO EGUAGLIERA'? Di Annamaria Pisapia,
vicepresidente nazionale M24A. Lo stupore è stata la prima reazione dei
lombardi, e di molti seguaci adoratori del nordicopensiero: belli, bravi,
integerrimi, ligi (e vennero a liberarci non ce lo vogliamo mettere?) sul perché
proprio quest’area sia stata la più colpita dal coronavirus, piuttosto che una
del Sud. Non un moto di vergogna sulla serie incredibile di errori, dettati
dalla presunzione di essere favoriti sempre e comunque (ne hanno mai avuta di
fronte ai più grandi scandali della storia del paese avvenuti proprio al nord?).
Nessuna mea culpa né da chi ha gestito l’emergenza, da Fontana, al sindaco Sala
(Milano non si ferma il suo leit motiv, a cui prontamente rispose l’entusiasta
segretario del pd Zingaretti e il sindaco di Bergamo Gori) all’assessore Gallera,
né dagli “illustri” luminari Burioni, Galli che, pur sbagliando qualunque
previsione continuano a deliziarci con le loro elucubrazioni saltellando da un
programma televisivo all’altro, contando sul favore dei media di regime che
fanno a gara per riportarli in vetta. Nessuna traccia della figura meschina
riportata, nei confronti del resto d’Italia per averci trascinati in un incubo
senza fine. Ma nessuna traccia, ahimè, neanche del prof Ascierto (scopritore
dell’efficacia del Tocilizumab sugli effetti nefasti del coronavirus) oscurato
dai media al punto che la scoperta sembra quasi non essere ancora avvenuta. Ma
Il Tg2 e il tgLeonardo si spingono anche oltre e a distanza di oltre un mese
dalla scoperta di Ascierto (la cui terapia è nota e applicata in tutto il mondo)
presentano servizi dall'ospedale di Padova e di Brescia come "primi" ad aver
sperimentato il Tocilizumab, senza menzionare affatto il prof napoletano quale
autore della scoperta. Insomma, sembra proprio che i dirigenti sanitari del nord
vaghino in un’altra galassia e con loro tutta la classe dirigente
politico-amministrativa della Lombardia che, presi da delirio di “superiorità”
non si preoccupano affatto di azionare il cervello e, sperando di farla franca
come sempre, sparano cavolate ad libitum: “La Lombardia ha salvato il Sud dal
contagio coronavirus”, dice Gallera che deve aver rimosso come hanno gestito
l'emergenza e come lo abbiano fatto al Sud. Insomma, un lavoro immane per
ripristinare l’immagine di un nord efficiente e ricco, a cui non si sottrae
neanche Conte che, come il padre di un rampollo a cui tutto si perdona e tutto
si elargisce, promette di prendersi cura in special modo proprio di quel suo
figlio preferito che definisce com“ nord, motore propulsivo". Non intravvede
alcuna stonatura nel riconoscere al nord il ruolo di comando, ed è pronto a
riconfermarlo. Eppure l'unica area su cui sarebbe logico investire per ripartire
è il Sud con contagi vicini allo zero. Sembrano le scene di un film già visto:
quelle della fine della II guerra mondiale. Era il 1947 quando l'America
annunciò l'avvio del Piano Marshall per la ricostruzione post bellica
dell'Europa. Il piano prevedeva l'impiego dei fondi ERP (european recovery
program) nelle aree maggiormente devastate e, per l'Italia, il Sud era l'area
maggiormente danneggiata pur uscendo due anni prima del nord dall'evento
bellica. Ma Il Capo del Governo, il trentino Alcide De Gasperi, non intese
ragioni e mise in piedi un piano ben congegnato: dirottamento dei fondi in
favore degli imprenditori del nord, dando la possibilità all’industria di quell’area
di rimettersi in piedi, e reclutamento di manovalanza a basso costo dal Sud che,
data la profonda miseria in cui versava in seguito alla devastazione bellica del
suo territorio, non era difficile da reperire. Molti provarono a ribellarsi a
questa politica scellerata e predatrice, che vedeva assegnare quasi l'87% di
quei fondi al nord e il restante al sud, tra questi Don Luigi Sturzo che su "Il
Popolo" del 25 luglio 1948 si scagliò contro gli industriali del nord
definendoli "erpivori" (consumatori parassiti di fondi Erp). Don Sturzo, in
qualità di presidente del "Comitato permanente per il Mezzogiorno", si battè
affinché gli aiuti del Piano Marshall venissero destinati in massima parte al
Mezzogiorno. In questo fu appoggiato anche dal ministro dell’agricoltura Segni,
il quale in una lettera a Don Sturzo del 22 luglio 1948 esprimeva tutto il suo
rammarico: "a poco a poco, industria e nord stanno tentando di accaparrarsi
tutto. Io negozio, sino alle estreme conseguenze ma la lotta è impari, solo,
coll’ottimo Ronchi: contro quasi tutti gli altri” (als 1947-59, cart. 52 fasc.
1948 Piano Marshall ERP). Al Sud arrivò il 13% di quei fondi ( briciole) che non
riuscirono a risollevare le sorti del Sud. Il Pil del nord fece un balzo in
avanti registrando un +22%, (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna) al Sud diminuì
al 10% . Don Sturzo dovette difendere con i denti anche le briciole, contro la
crescente avidità degli industriali settentrionali. Con grande "magnanimità" nel
1950 il governatore Donato Menichella, dato l'esaurimento dei fondi ERP, mandò
avanti una contrattazione, per protrarre la scadenza degli aiuti del Piano
Marshall e con il governatore della Banca Mondiale Eugene Black , venne
istituita "La Cassa per il Mezzogiorno" (soldi che servivano a sopperire in
parte alla sottrazione dei fondi erp del Piano Marshall al Sud). L’annuncio di
un aiuto per il mezzogiorno fu fatto a suon di grancassa ( “quanto è buono lei”,
di fantozziana memoria), mentre in devoto silenzio se n’erano andati al nord i
fondi erp. La prepotenza del nord fece sì che i fondi erp risultassero un
risarcimento loro dovuto , mentre la "Cassa per il Mezzogiorno" un'elemosina di
cui essere grati. Il parassitismo erpivoro infesta ancora il nord, che negli
anni ha mutato denominazione pur conservando la modalità trasmessa dai loro avi:
succhiare linfa vitale al Mezzogiorno, Il fato ci ha riproposto uno scenario
simile a quello del 1948 di cui potremo cambiare il finale. Diversamente Il Sud
sarà costretto a una morte definitiva e neanche indolore, data dalla
scarnificazione delle ossa della nostra gente".

Mes, De Luca furioso rilancia i temi dello scippo al Sud e
della Grande Balla. Francesco Ridolfi su Il Quotidiano
del Sud il 30 giugno 2020. «Per dieci anni la Campania è stata penalizzata al di
là di ogni decenza istituzionale e di ogni ragionevolezza. Sarebbe uno scandalo
non tollerabile, perseverare con criteri da rapina verso il Sud e la Campania
perfino per l’assegnazione di risorse aggiuntive e straordinarie. Siamo pronti
ad accettare la sfida dell’efficienza nei confronti di chiunque ma ci tuteleremo
in ogni caso in tutte le sedi», compreso rivolgendosi «al Capo dello Stato oltre
che alla Corte Costituzionale, nel caso in cui dovesse essere formalizzata tale
ipotesi». VIncenzo De Luca, governatore della Campania, rilancia con decisione,
in alcune dichiarazioni quella che è una battaglia che il Quotidiano del Sud l’Altravoce
dell’Italia ha intrapreso fin dal suo primo numero: porre fine allo scippo ai
danni del Mezzogiorno in base al quale miliardi di euro, con il trucco della
spesa storica, vengono fatti confluire verso le regioni del Nord a discapito
delle regioni del Sud. Una operazione che inevitabilmente fa il paio con
la grande balla, denunciata dal direttore Roberto Napoletano, secondo la quale
il Sud vivrebbe sulle spalle del Nord. Una falsità dimostrata dai numeri della
finanza pubblica e certificata dagli enti istituzionali della Repubblica e non
certo da consulenti di parte. L’occasione per tornare sull’argomento a De Luca
l’ha data la simulazione, pubblicata dal Corriere della Sera, in base alla quale
è stata disegnata una mappa delle assegnazioni dei possibili fondi del Mes tra
le regioni Italiane qualora il Governo vi facesse ricorso. Lo schema assegna le
risorse in base agli attuali criteri di spesa, quindi la spesa storica, e porta
come risultato l’ennesimo squilibrio a vantaggio del Nord e discapito del Sud
ossia l’ennesima incarnazione dello Scippo al Sud. Le somme del Mes, sempre se
il governo vi farà ricorso, hanno un unico vincolo ossia devono essere destinate
alla sanità con specifico riferimento ad investimenti e spese dirette e
indirette collegate alla pandemia da coronavirus Covid-19 e da spendere nel 2020
e nel 2021 per un ammontare complessivo di circa 36 miliardi di euro. Fondo
immensi fondamentali per rimettere in piedi un settore, quello sanitario, fatto
letteralmente a pezzi nel corso degli ultimi quindici anni al Sud molto più che
al Nord. Con la scusa dei piani di rientro e delle spese poco chiare, infatti,
in tutto il Mezzogiorno, e non solo in Campania, sono stati progressivamente
tagliati ospedali, punti nascite, poliambulatori, assunzioni di medici e di
infermieri, riducendo la sanità del Sud ad una piccola porzione della sua
struttura originaria. Tagli effettuati badando esclusivamente ai bilanci spessa
senza considerare l’importanza della presenza di un ospedale in un’area montana
o la necessarietà di prevedere la presenza del giusto numero di addetti
(infermieri, medici e personale amministrativo) nei vari reparti
progressivamente ridimensionati o addirittura chiusi. Ma De Luca si infuria
perché quel criterio da oltre un anno denunciato dal Quotidiano Del Sud (LEGGI
TUTTI I NUMERI DELLO SCIPPO AL SUD CHE AFFOSSANO IL FUTURO DEL PAESE) si basa
ricalcandolo pedissequamente sull’attuale criterio di riparto tra le Regioni del
fondo sanitario nazionale basato sul principio che bisogna ignorare il numero
totale degli abitanti presenti in regione in luogo delle incidenze di giovani e
anziani sul totale della popolazione causando in questo modo una forte riduzione
delle somme trasferite al Sud a tutto vantaggio, ancora una volta, del Nord.
Appare palese, a questo punto, che per far ripartire l’Italia serve veramente
cambiare i presupposti di partenza, rompere il diabolico meccanismo per cui chi
è più ricco ottiene più fondi e chi è più povero ne ottiene sempre meno e
ricordarsi che un cittadino italiano è tale in qualunque luogo della Repubblica
risieda e, pertanto, alcuni servizi, e la sanità è indubbiamente il principale
tra questi, non devono assolutamente soffrire decurtazioni in base a latitudine
e longitudine. La crisi del coronavirus può veramente essere l’occasione per
fare quell’Italia unita che in 160 anni non è stata fatta.
TUTTI I NUMERI DELLO SCIPPO AL SUD CHE AFFOSSANO IL FUTURO DEL
PAESE. Dopo le “Operazioni verità”, il “Manifesto per
l’Italia” e l’appello per gli Stati generali dell’economia la battaglia condotta
del nostro giornale continua. Claudio Marincola Il Quotidiano del Sud il 13
giugno 2020. «L’unica battaglia che si è persa in partenza è quella che non si è
mai combattuta». A qualcuno sembrerà esagerato scomodare addirittura il
comandante Che Guevara per raccontare le campagne di questo giornale. Se diciamo
però che aprire l’involucro delle mistificazioni e rovesciare le tante falsità
spacciate per verità non è stato facile, credeteci. Per troppo tempo al Sud sono
state sottratte risorse, investimenti produttivi, spesa pubblica. Un artificio
contabile, un gioco da prestigiatori e, oplà, i conti tornavano. Una foresta
pietrificata di pregiudizi, decenni di affabulazioni da smascherare.
OPERAZIONE VERITÀ SCIPPO SMASCHERATO. Sul Mezzogiorno, per anni,
la fabbrica all’ingrosso della manipolazione ha prodotto fake. Numeri
contraffatti diffusi come granitiche certezze. Presunti vizi antropologici
diventati luoghi comuni, caricature geografiche. Siamo partiti dai numeri. Dai
61,5 miliardi l’anno. Con il trapano della Spesa storica lo Stato ha continuato
a regalare al Nord, finanziando ogni genere di assistenzialismo. Abbiamo
raccontato, cifre alla mano, come la Regione Piemonte spenda per i suoi servizi
generale cinque volte più della Campania pur avendo un milione e mezzo di
abitanti in meno. Da sola più di quanto sommano insieme Campania, Puglia e
Calabria. Da queste colonne s’è sollevata, in britannica solitudine, la campagna
fatta propria da questo governo e inserita nella legge di bilancio: l’iniqua
distribuzione che ha privato il Sud di risorse destinando quote ben inferiori
alla soglia del 34%, la quota di popolazione residente. Scippo raccontato frame
dopo frame, come in un film. Titolo: “Operazione verità”. La banca del buco che
ha scavato sottotraccia per anni – abbiamo scritto – nelle pieghe del bilancio
italiano. Risultato: al Nord 735, 4 miliardi, il 71,7% della spesa pubblica
totale totale, al Sud solo 290,9 miliardi. Uno scarto rispetto alla quota dovuta
del 6%, pari, appunto, a 61,5 miliardi. Che vuole dire meno mense, meno servizi
pubblici, asili zero o quasi, etc., etc.
IL MANIFESTO PER L’ITALIA E LA LETTERA DI CONTE. La lotta per
ridurre le disuguaglianze vale al Nord come al Sud. Questo concetto, valido
anche in Europa, lo abbiamo chiaro, ed è con questo spirito che nel settembre
2019 è stato sottoscritto il Manifesto per l’Italia (LEGGI), uno stimolo per
politici, sindacalisti, ricercatori, studenti per far ripartire il Paese. Senza
tuttavia mai perdere di vista la bussola: il Mezzogiorno, area geografica dal
perimetro ben delimitato, il luogo in cui si è perpetrato un “delitto
all’italiana” gettando le basi culturali ed economiche della mancata crescita
nazionale. A rimetterci è stato infatti l’intero Paese, se è vero come è vero
che già prima del Covid-19 Nord e Sud d’Italia erano gli unici territori europei
a non aver raggiunto i livelli pre-crisi del 2008. Per l’esattezza: il nostro
Meridione 10 punti sotto. Il 12 settembre la lettera del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte: «Caro direttore, accolgo con favore la dichiarazione
di intenti del Manifesto, serve una fase nuova, ho condiviso con von der Leyen i
contenuti dell’agenda riformatrice…». La favola di un Sud pigro e sprecone –
generata da una classe dirigente inadeguata e corrotta – ha fatto da carburante
per alimentare la macchina dello scippo perfetto. Ed ecco in che modo gli aiuti
di Stato sono finiti in larga parte alla locomotiva d’Italia, la Lombardia che
ora riesce a malapena a trainare se stessa. Dalla metà del 2017 la regione del
presidente Fontana – un governatore che a volte sfiora forme di masochismo e si
fa male da solo – ha incassato ben 3,5 miliardi di euro contro i 600 milioni
della Campania. “Aiutini” di Stato andati anche a Veneto (1,5); Piemonte (1,3);
Emilia-Romagna (1,3); Lazio (1,1); Toscana (1,0); Trentino-Alto Adige (1,0).
LE MANI DEL NORD SUI FONDI EUROPEI. Sono i numeri di un’Italia
rovesciata. Con il Mezzogiorno che invece di aumentare la spesa degli
investimenti pubblici la vedeva ridurre dello 0,5% rispetto all’anno precedente
(Fonte Cresme). Il rischio di uno scenario da deriva greca, un Sud dove il
reddito pro-capite è la metà o quasi del Nord, un sistema Paese che non tira
più, il fantasma della Troika che avanza. Appena due mesi prima che si scoprisse
la diffusione del virus a Cologno una nostra inchiesta sui carrozzoni suonava
profetica: Il 42 per cento delle risorse sanitarie incassate dalle Regioni del
Nord, il 20 per cento dalle regioni del Centro e il 23 per cento da quelle del
Sud. Dati della Corte dei conti, diffusi in tempo non sospetti, in cui si diceva
tra l’altro che la quota di riparto del fondo sanitario nazionale era cresciuta
in Lombardia del 1.07 per cento contro lo 0,75 per cento della Calabria, lo 0,42
per cento della Basilicata e lo 0,45 per cento del Molise. In pieno lockdown c’è
stato anche chi, qualche tecnico del Mef, ha pensato di sfruttare la catastrofe
del contagio per dare alla Lombardia i finanziamenti dei fondi europei destinati
al Sud. La catastrofe della catastrofe. Una “rapina di Stato” in tempo di pace.
RI-FATE PRESTO IL DECRETO ILLIQUIDITÀ. Con il protagonismo dei
governatori si è scoperto l’inganno dell’autonomia differenziata. La sanità
pubblica svuotata, i presidi territoriali dismessi, i vantaggi concessi al
privato. I viaggi della speranza dei cittadini del Mezzogiorno per gonfiare le
tasche dei privati. Il modello-Formigoni che stiamo ancora pagando a caro
prezzo. In questo clima è partita la campagna “Ri-fate presto”. Un conto alla
rovescia contro la burocrazia e contro “l’esproprio” del decreto di lancio.
L’assurdo di uno Stato che invece di risarcire il danno arrecato ne approfitta
per entrare nel capitale sociale delle aziende con Invitalia e Cdp. L’assenza di
una cabina di regia, le responsabilità del ministro del Tesoro, Roberto
Gualtieri. Il fallimento del decreto “illiquidità”, l’incapacità di fornire
prestiti agli italiani e alle imprese in difficoltà. Il “tappo” delle banche
ammesso ancora ieri da Bankitalia, la rabbia degli italiani e di quanti saranno
costretti ad abbassare la saracinesca. Il ruolo della Commissione bicamerale
d’inchiesta sul sistema bancario presieduta dalla deputata Carla Ruocco. Il caso
limite degli “appestati”, i tanti italiani finiti per avventura o per disgrazia
nella famigerata Centrale rischi della Banca d’Italia, Condannati “a morte”
magari solo per una rata scaduta.
L’APPELLO PER GLI STATI GENERALI. Difficile in questi giorni
liberarsi dall’impaccio del reale e sognare una ripartenza di slancio. La crisi
da Covid ha messo a dura prova le difese immunitarie di un Paese già in
sofferenza. La liquidità che arriva con il contagocce, le aziende che chiudono,
il terrore di una seconda ondata, le nuove stime negative della Federal Reserve.
Da qui l’urgenza di abbattere le burocrazie ministeriali e bancarie e dotarsi di
un piano strategico di lungo respiro. È partito da queste considerazioni
l’appello lanciato dal Quotidiano del Sud per la convocazione degli Stati
generali dell’economia, l’esigenza di gestire in modo ottimale ed efficiente il
fiume di denaro che arriverà dall’Unione europea. Un appello raccolto dal
premier Conte, osteggiato da falchi, gufi e altri volatili in libera uscita, da
gabbia o da voliera. E la battaglia continua.
Quando il Governo Letta penalizzò le Università del Sud per
favorire quelle del Nord. Michele Eugenio Di Carlo su
I Nuovi Vespri il 6 maggio 2020. La sottrazione di risorse alle Università
povere (quelle del Sud) per favorire le università ricche (quelle del Nord, che
non sono affatto le migliori) ha determinato la migrazione di studenti (e di
risorse finanziarie) dal Sud al Nord. Una vergogna infinita e uno scandalo
ignorato. Sentire che tanti nostri studenti universitari, e i propri familiari,
in questi giorni si lamentano di dover pagare affitti mentre le università sono
praticamente chiuse, mi fa proprio male e mi costringe a riferire quello di cui
pochi sono a conoscenza. Fu un provvedimento del governo di Enrico Letta e della
ministra dell’Istruzione di allora, Maria Grazia Carrozza, a penalizzare
fortemente le università del Sud con una sorta di decreto ammazza università
meridionali che ha dato soldi alle università ricche e li ha sottratti a quelle
povere. Badate bene, non a quelle migliori, a quelle più ricche. Lo scrive
peraltro l’amico Pino Aprile nel suo ultimo testo “L’Italia è finita”, come
sempre una miniera di informazioni. Tanto che l’economista barese Gianfranco
Viesti – ricordo che è anche cittadino onorario della città di Vieste – ne
scrisse un libro di denuncia: “La laurea negata”, arrivando a dire che tanto
valeva farle chiudere. Un decreto che andò a peggiorare le già antimeridionali
norme dei precedenti ministri Profumo e Gelmini. Ora uno studente meridionale su
due (8 su 10 in Basilicata) sceglie un università del Nord e questo comporta
l’ennesimo esborso di miliardi che passano da Sud a Nord, quasi non bastasse la
tristissima e abominevole emigrazione sanitaria. Questa politica di sottrazione
di fondi e di risorse al Sud è stata condotta senza interruzione e
indifferentemente da governi di tutti i colori, destra, centro e sinistra. Ma
pochi di noi se ne sono accorti, perché la politica ormai è diventata il regno
degli incapaci e degli ignoranti. La manipolazione politica-mediatica al
servizio dei poteri finanziari e politici nord-centrici, quotidiana da almeno 35
anni (vedere i dati riportati dagli studiosi di processi comunicativi Cristante
e Cremonesini) ci ha invece fatto credere che sia tutto normale. Non lo è
affatto! Nonostante tutto, nonostante la continua e discriminante sottrazione di
fondi, molte delle nostre università restano ad alti livelli. Vorrei inoltre
ricordare che la prima, grande università italiana è stata la Federico II di
Napoli da cui fino al 1861 uscivano la maggior parte dei laureati in Italia.
Infatti la Federico II è nata nel 1224, mentre le tanto decantate “Politecnico
di Milano” e la super propagandata “Bocconi” sono sorte rispettivamente nel 1863
e nel 1902. Non vi cito neppure poi quelle sorte durante la lunga parentesi
leghista e nordista che abbiamo attraversato e da cui non siamo ancora usciti.
Recensioni - 23 Maggio 2018 “La laurea negata. Le
politiche contro l’istruzione universitaria” di Gianfranco Viesti. Recensione
a: Gianfranco Viesti, La laurea negata. Le politiche contro l’istruzione
universitaria, Laterza, Roma-Bari 2018, pp. 154, 12 euro (scheda libro). Scritto
da Francesco Corti 28 maggio 2018. Un libro tascabile, come recita il nome della
collana dell’editore Laterza che lo ha pubblicato, è la caratteristica
principale dell’ultimo saggio di Gianfranco Viesti La laurea negata. Un testo
che, nelle intenzioni rese subito esplicite dall’autore, ha, in primo luogo,
l’obiettivo di essere divulgativo, di dare al vasto pubblico, quello lontano
dalle università, alcune risposte a domande e interrogativi che spesso
accompagnano il dibattito mediatico sul mondo accademico e sul suo rapporto con
il mondo del lavoro e dell’amministrazione pubblica. Viesti presenta una
rassegna dettagliata e precisa dei principali problemi che investono
l’università italiana, riprendendo alcuni stereotipi ad essa connessi, dalla
bassa qualità dei docenti alla scarsa competizione con le università all’estero.
Per ognuno di questi temi, l’autore offre una presentazione sintetica ma, allo
stesso tempo, esaustiva e soddisfacente, che stimola approfondimenti e nuove
riflessioni. L’obiettivo principale del libro è chiaro: rompere i tabù e i
luoghi comuni intorno all’università italiana, offrire un quadro d’insieme sulle
evoluzioni più recenti del sistema accademico italiano e provare a lanciare
alcuni stimoli per un tavolo di discussione sulle sfide a venire. Per fare
questo, Viesti inizia la sua analisi offrendo una prospettiva storica, che muove
da un’iniziale presentazione delle problematiche strutturali del sistema di
educazione terziaria in Italia per poi concentrarsi, sulle più recenti
evoluzioni. Il dato generale rilevato è allarmante. A partire dal 2010, anno
della riforma Gelmini, e inizio della parabola discendente degli investimenti
pubblici dell’Italia nell’università, il fondo di finanziamento ordinario (FFO)
delle università statali è stato ridotto, in termini reali, di oltre il 20%.
Contrariamente ad altri Paesi dell’Unione Europea, Germania in primis, che,
invece, hanno aumentato la spesa per le università, l’Italia ha assistito ad una
riduzione drastica del personale docente, attraverso il blocco del turnover e
quindi delle assunzioni di giovani ricercatori, i quali hanno rinunciato a
proseguire il percorso accademico in Italia o hanno rinunciato alla prospettiva
accademica in via definitiva. Al taglio strutturale delle risorse, si è
accompagnato un vistoso aumento della tassazione studentesca, mentre la politica
per il diritto allo studio (borse, alloggi, servizi) è rimasta estremamente
modesta. Questo disinvestimento nell’università ha evidentemente determinato,
come conseguenze, maggiori difficoltà da parte delle famiglie a mantenere il
percorso di studi dei figli, e conseguentemente una contrazione delle
immatricolazioni.
Risparmiare sull’istruzione. Questa riduzione delle iscrizioni è
stata ovviamente diversificata a seconda del settore disciplinare, con le
materie di area umanistica che hanno osservato un calo ben superiore al 20%
della media nazionale, e a seconda della provenienza geografica, con un effetto
ben più marcato al Sud Italia rispetto al Nord. La mancanza di un sistema di
infrastrutture e trasporti adeguato, specialmente nel Meridione e la conseguente
necessità di trasferirsi per poter studiare, ha portato le famiglie che hanno
potuto permetterselo a mandare i propri figli nelle università del Nord,
considerate di migliore qualità e con maggiori possibilità di trovare un lavoro
successivamente alla laurea. Anche in questo caso, spiega bene Viesti, la
retorica delle università di serie A e di serie B non ha indubbiamente aiutato a
contenere quello che, oggi, si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di
migrazione dal Sud al Nord Italia. L’esito è stato la creazione di un gruppo
ristretto di università di “eccellenza” in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,
mentre il resto delle università italiane (prevalentemente del Centro, del Sud e
delle Isole, ma anche del Nord “periferico”) sono state lasciate a languire in
una situazione di crescente carenza di risorse. La retorica dell’eccellenza,
supportata da quella che Viesti chiama «una densa cortina di indicatori ed
algoritmi», non ha però aiutato ad individuare i problemi strutturali presenti
nelle regioni meno sviluppate e svantaggiate del paese. Al contrario, essa è
stata utilizzata come giustificazione per l’attuazione di ulteriori
disinvestimenti. Il tutto sotto il motto “meritocrazia virtuosismo valutazione”,
che è stato fatto proprio dal vero nuovo giudice e deus ex machina della
politica universitaria italiana: l’ANVUR. Nata come istituzione deputata ad
assistere il Ministero nelle sue scelte, commenta Viesti, l’Agenzia ha assunto
sempre più un ruolo del tutto improprio di decisore politico. I suoi commissari
sono scelti nominativamente dal Ministro e non sono rappresentativi di tutte le
componenti del sistema universitario. Il potere dell’ANVUR nella valutazione è
pressoché totale tanto da poter ignorare, come già accaduto in passato, anche il
parere dello stesso Parlamento. Solo il ministro ha il potere di controllarne
l’operato ma, spesso, questo non succede. Per questo si lascia che un’agenzia
decida, attraverso una serie di indicatori che si dicono essere “oggettivi”, la
valutazione delle performance degli atenei e la destinazione dei finanziamenti.
Taglio degli investimenti, de-responsabilizzazione politica e delegazione della
valutazione delle performance degli atenei ad un gruppo ristretto di tecnici
sono fattori che hanno determinato un cambio strutturale all’interno del mondo
accademico italiano. A questo cambiamento nelle forme di finanziamento, nei
meccanismi di governance e di controllo, come sottolinea bene Viesti, si è
accompagnato anche un cambio di paradigma, a livello normativo. Insieme agli
attori, si potrebbe dire, sono cambiate anche le idee. A partire dal 2008,
infatti, nel clima delle riforme dettate dalle necessità di maggiore austerità,
l’Italia si è sempre di più avvicinata ad un modello neo-liberale di
finanziamento del sistema universitario, molto simile all’esempio anglosassone.
Commenta Viesti: «L’idealizzazione di un centro riformatore, composto da pochi
“illuminati” (n.d.r. l’ANVUR), in grado di assestare una severa punizione alle
autonomie e di portare il sistema sulla strada giusta, ha mescolato
l’idealizzazione della concorrenza di mercato applicata al sistema universitario
con l’esercizio di un forte potere gerarchico». Troppi studenti, troppi
professori, assunzioni facili, troppi costi, bassi standard internazionali, poca
voglia di studiare, poco merito: questi sono stati gli argomenti che hanno
accompagno la nuova retorica del merito, con la quale poi si sono giustificati,
come necessari, i tagli indistinti ai finanziamenti. Indicatori “oggettivi” per
premiare il “merito” e fermare gli “sprechi”: quale migliore argomento in tempi
di austerità e crisi?
Il modello di università a cui dovremmo ambire secondo Viesti.
Eppure, come mostra bene Viesti, nel suo saggio, le performance del sistema
universitario italiano non sono al di sotto di quelle degli altri stati membri
dell’UE, sia in termini di numero pubblicazioni sia in termini di qualità della
ricerca. Addirittura se confrontati a parità di condizioni di partenza,
l’università italiana avrebbe un potenziale anche maggiore. Il che sorprende se
pensiamo che l’investimento italiano nel settore dell’educazione terziaria è di
gran lunga inferiore agli altri stati membri dell’UE. Per dare un’idea, nel 2015
il finanziamento pubblico in Italia è stato di 7 miliardi, contro i 28,7 della
Germania, dei 23,7 della Francia e dei 9,8 del Regno Unito, che prevalentemente
si basa su un sistema di risorse private. Ancora, rapportando la spesa pubblica
alla popolazione, si vede che nei Paesi Scandinavi la spesa media annua per
l’educazione terziaria per abitante è di 600 euro, 350 in Germania e Francia,
150 nel regno unito e solo 110 in Italia. Se dunque la realtà dell’università
non corrisponde all’immagine che se ne è voluto dare, cadono anche le
giustificazioni retoriche che hanno accompagnato i tagli di questi ultimi anni.
A meno che, chiaramente non si ritenga che, nonostante, tutta l’università non
sia importante. Su questo aspetto, non è mancata la retorica di chi ha voluto
sottolineare l’assenza di un collegamento con il mondo del lavoro, l’incapacità
delle università italiane di fornire ai propri studenti strumenti, capacità e
competenze oltre che nozioni. Anche su questo punto, Viesti offre una
prospettiva alternativa, che non nega il problema esistente relativamente al
passaggio tra mondo dell’università e quello del lavoro, ma inserisce il
dibattito in una cornice più complessa e meno semplicistica. Ad esempio,
portando i dati riguardo l’indice di occupazione dei neo-laureati, che è di gran
lunga maggiore rispetto ai non laureati, a prescindere dal tipo di settore
disciplinare. Ma la riflessione del professore di economia, non si limita ad una
semplice analisi dei costi benefici. L’argomentazione va ben oltre e si
inserisce in un quadro più ampio di visione della politica e della società.
Abbracciare, come è stato fatto in questi anni, un approccio all’università
basato sui tagli e sull’investimento in presunti centri di eccellenza significa,
infatti, perdere di vista la funzione politica dell’università, come motore di
progresso sociale, emancipazione di luoghi e spazi geografici, creazione di idee
e novità e culla di coscienza critica e partecipazione democratica. Ed è proprio
questa riduzione dell’università ad una logica di mercato, ad un’analisi dei
costi e benefici che Viesti critica. Non dovrebbe essere questo, infatti, il
modello di università cui vorremmo ambire, secondo l’autore, che per questo,
alla fine del suo saggio, prova ad offrirci un quadro alternativo e inizia ad
abbozzare anche alcune prime risposte.
Scritto da Francesco Corti. Nato nel 1992. Dottorando in Studi
Politici presso l'Università degli Studi di Milano, dove si occupa di Unione
Europea e politiche sociali. Fa parte del team di ricerca "REScEU: Reconciling
economic and social Europe" e della FEPS YAN. Ha lavorato al Parlamento Europeo
e continua, tuttora, come prestatore di servizi.
“LA LAUREA NEGATA. LE POLITICHE CONTRO L’ISTRUZIONE
UNIVERSITARIA”. Di Gianfranco Viesti su letture.org.
Prof. Gianfranco Viesti, Lei è autore del libro La laurea
negata. Le politiche contro l’istruzione universitaria edito da Laterza: qual è
lo stato dell’università italiana?
«L’università italiana aveva
problemi di quantità e di qualità. Era molto più piccola, in comparazione con
gli altri paesi avanzati. Mostrava criticità nel suo funzionamento. Le riforme
l’hanno portata in una direzione estremamente discutibile: l’hanno fatta
diventare di dimensione inferiore, ma non di migliore qualità. Nel giro di pochi
anni l’Italia ha percorso a grandi passi all’indietro il cammino verso un
maggiore livello di istruzione superiore della sua popolazione. L’università
italiana, per la prima volta nella sua storia, è diventata più piccola: di circa
un quinto. La riduzione è stata molto maggiore di quanto non sia avvenuto negli
altri comparti dell’intervento pubblico. Né ha paragoni negli altri Paesi
colpiti dalla crisi. Va comparato con aumenti anche sensibili registrati
altrove, a partire dalla Germania. Il fondo di finanziamento ordinario (FFO)
delle università statali è stato ridotto, in termini reali, di oltre il 20%. Per
tagliare così tanto la spesa si è ridotto il numero dei docenti (che
rappresentano la principale voce di costo delle università) attraverso un
prolungato blocco del turnover, cioè del ricambio del personale andato in
pensione. I docenti sono diminuiti di quasi quindicimila (e il personale
tecnico-amministrativo si è pure notevolmente ridotto). Le porte dell’università
sono state chiuse a tutta una leva di giovani ricercatori. Una parte di essi si
è dovuta accontentare di posizioni precarie, sottopagate e senza prospettive
chiare di carriera. Un’altra parte ha preso la via dell’estero: ha avuto accesso
ai sistemi universitari degli altri paesi, soprattutto europei, cui abbiamo
regalato un “capitale umano” formato e di qualità. L’età media dei docenti,
senza ricambio, è cresciuta molto. Al taglio draconiano delle risorse pubbliche
è corrisposto un vistoso aumento della tassazione studentesca, mentre la
politica per il diritto allo studio (borse, alloggi, servizi) è rimasta
estremamente modesta. Ciò ha acuito le difficoltà economiche delle famiglie; non
poche hanno rinunciato all’istruzione universitaria per i propri figli. Anche le
immatricolazioni – già molto inferiori a quelle degli altri paesi europei – sono
diminuite di circa un quinto rispetto ai livelli massimi del passato. Hanno
rinunciato all’università più degli altri i diplomati degli istituti tecnici e
professionali; quelli provenienti da famiglie a reddito più modesto; quelli del
Mezzogiorno. I tagli non sono stati uguali per tutti: e il sistema, oltre che
più piccolo è divenuto molto più differenziato al suo interno. Si sono ridotti
molto di più gli insegnamenti di area umanistica. Si è teso a creare una netta
suddivisione fra atenei di serie A, relativamente protetti, e atenei di serie B,
su cui si sono concentrati i tagli. Si è creato un piccolo gruppo di università
di serie A in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; il grosso delle università
italiane (del Nord “periferico”, del Centro e del Sud continentale) sono state
lasciate a languire in una situazione di crescente carenza di risorse; gli
atenei di Sicilia e Sardegna sono stati ridotti ai minimi termini. Si è deciso
di disinvestire, per la prima volta nella storia unitaria, nella formazione
superiore proprio nelle aree del paese in cui i livelli di istruzione sono più
bassi (bassissimi in comparazione europea), e il ruolo delle università più
importante. Sono state messe in atto una serie di misure che hanno favorito la
migrazione degli studenti dal Mezzogiorno verso il resto del paese. Si è provato
a mascherare questa scelta dietro una densa cortina di indicatori ed algoritmi,
e dietro i ripetuti, onnipresenti, richiami al merito e all’eccellenza. In
realtà si è operata una scelta politica esplicita, frutto della convinzione che
sia bene concentrare le risorse sulle aree più forti del paese. La vita delle
università e degli universitari è venuta sempre più ad essere dominata da un
insieme minuzioso di regole e prescrizioni emanate dal Ministero, e, ancor più
dall’Anvur. Nata come istituzione deputata ad assistere il Ministero nelle sue
scelte, l’Agenzia ha assunto sempre più un ruolo del tutto improprio di decisore
politico. Composta da Commissari scelti nominativamente dal Ministro, non
rappresenta le diverse componenti del sistema universitario; non si cura di
raccogliere e suscitare consenso intorno alle sue decisioni. È depositaria della
verità: conosce tutti i problemi, e soprattutto tutte le soluzioni; e le mette
in atto attraverso poteri coercitivi. Il sogno del riformatore illiberale: un
gruppo di saggi, di “prescelti” che finalmente illumina la via, e costringe un
sistema anarchico e irresponsabile a seguirla. In barba al Parlamento e al
dibattito pubblico, l’Anvur ha fatto e fa una parte molto importante della
politica della ricerca nel nostro paese. Stabilisce cosa è ricerca di qualità e
non; quali sono i campi e le metodologie di indagine opportune e quali meno; e a
tutto applica rigidi indicatori numerici. Vicende che potrebbero assumere anche
connotanti divertenti, nelle loro dimensioni orwelliane, se non stessero
plasmando a rigida indicazione di un ristretto numero di sapienti le dimensioni
di istituzioni, che dovrebbero godere di autonomia ed essere fucina di saperi
critici e confronto di opinioni».
Perché l’università è importante?
«In primo luogo perché il minore
livello di istruzione della popolazione, e in particolare la scarsa diffusione
degli studi universitari, è certamente uno dei fattori che ha ostacolato e
ostacola il complessivo sviluppo economico del nostro paese. Quantomeno per
mantenere il proprio posizionamento nel quadro internazionale del futuro,
all’Italia serviranno nei prossimi lustri molti più laureati. Soprattutto
considerando che la percentuale di laureati fra gli occupati italiani è oggi
molto inferiore a quella degli altri paesi europei (circa la metà rispetto a
Regno Unito, Francia, Spagna); lo stesso accade fra i manager e gli stessi
imprenditori. Averli non garantisce di per sé la prosperità futura. È necessario
che siano dei “buoni” laureati: con un elevato bagaglio di conoscenze, ma
soprattutto con un processo formativo che consenta loro di acquisirne
continuamente di nuove. È necessario che essi siano assunti dalle imprese e
dalle amministrazioni pubbliche con contratti che garantiscano loro prospettive
di impiego e di carriera, con stipendi che premino le loro capacità. Va favorita
la loro possibilità di auto-impiego e di avvio di nuove imprese, attraverso lo
sviluppo di canali finanziari specializzati e la riduzione degli ostacoli che
essi trovano sul loro cammino. Una politica per l’istruzione richiede una buona
politica industriale e dell’innovazione per produrre forti risultati economici.
La disponibilità di molti buoni laureati è condizione necessaria ma non
sufficiente. Ma, appunto, è necessaria. Ed è un investimento profittevole per la
collettività. I calcoli dell’OCSE producono risultati indiscutibili: la
circostanza che un cittadino italiano arrivi alla laurea invece che fermarsi al
diploma determina un beneficio monetario pubblico intorno ai duecentomila
dollari, sei volte superiore al costo pubblico dei suoi studi. L’accesso
all’università è, e sarà sempre di più, una opportunità essenziale di
realizzazione personale. Specie per chi proviene da famiglie senza rilevanti
patrimoni o redditi elevati; per le donne; per chi nasce nelle regioni più
deboli. La mobilità intergenerazionale in Italia è bassa: le disparità
economiche e sociali si trasmettono molto dai genitori ai figli. La formazione
universitaria continua a rappresentare un motore di mobilità: fra i laureati
italiani solo tre su dieci hanno almeno un genitore laureato; solo due su dieci
a Bari o a Cagliari; ancora meno in Basilicata: sono le percentuali più basse
fra tutti i paesi avanzati. Offre la possibilità a chi proviene da condizioni
economiche e sociali più modeste di modificare la propria collocazione sociale;
di impedire, per quanto possibile, che le caratteristiche delle famiglie e
dell’ambiente d’origine determinino lo status economico e sociale. Ci si riesce
solo in parte: le probabilità di frequentare l’università resta ad esempio
decisamente più alta per chi proviene da famiglie a maggior reddito. Motivo per
estendere l’istruzione superiore a fasce più ampie di giovani, specie
promuovendo strumenti che rendano concreto il diritto allo studio per chi ha
minori possibilità economiche. Ma l’importanza dell’università non si ferma ai
benefici per chi la frequenta. Come la scuola, svolge un ruolo fondamentale per
lo sviluppo civile e sociale di un paese. Avere più laureati produce effetti
positivi per l’intera collettività. Una popolazione con un maggiore livello di
istruzione è in grado di badare meglio alla propria salute: è maggiore la
consapevolezza dell’importanza della prevenzione, e del costo di comportamenti a
rischio. Questo consente, oltre che un migliore benessere individuale, notevoli
risparmi per i sistemi sanitari pubblici. Le tavole di mortalità per livello di
istruzione mostrano che mediamente un laureato (maschio) ha una aspettativa di
vita di 5,2 anni superiore rispetto ad un italiano con al più la licenza media.
L’istruzione produce cittadini più attivi e responsabili, con una maggiore
partecipazione alla vita politica e culturale: la presenza di università in una
regione è collegata ad un atteggiamento favorevole ai valori democratici dei
suoi cittadini. L’innalzamento del livello medio di scolarizzazione della
popolazione implica una consistente riduzione della probabilità di commettere
reati sia contro la persona che contro il patrimonio; l’istruzione riduce gli
incentivi a delinquere perché ne riduce il guadagno aggiuntivo, aumenta le
opportunità di socializzazione e rende meno probabili gli effetti imitativi
devianti diffusi in comunità deprivate. Anche in Italia, gli ambiti sociali e le
aree geografiche in cui è minore il livello di istruzione sono quelli in cui vi
è maggiore diffusione della criminalità».
Quali politiche universitarie sono state adottate nel nostro
Paese?
«L’Italia ha compiuto, a partire dal
2008, una delle scelte che più peseranno sul suo futuro: quella di comprimere e
distorcere il proprio sistema universitario pubblico. Il processo è stato
avviato prima delle politiche di austerità e dell’enfasi sulle “riforme
strutturali”. Ma dal clima politico-culturale cui si è accennato ha tratto forte
alimento. La volontà politica del Ministro Tremonti di colpire finanziariamente
le università ha incontrato gli interessi di alcuni atenei a definire un sistema
su più livelli di qualità, in cui essi fossero al vertice. Le parole d’ordine
neo-liberali, derivate in particolare dall’esperienza del Regno Unito, sono
penetrate anche in ambienti del centro-sinistra “moderno”. L’idealizzazione di
un centro riformatore, composto da pochi “illuminati”, in grado di assestare una
severa punizione alle autonomie e di portare il sistema sulla strada giusta, ha
mescolato l’idealizzazione della concorrenza di mercato applicata al sistema
universitario con l’esercizio di un forte potere gerarchico. Il sistema è stato
radicalmente trasformato da una valanga di norme. Il Parlamento ha approvato una
legge di riforma (la “Gelmini” del 2010) di portata piuttosto ampia, ai tempi
del governo Berlusconi. Ma i suoi effetti sono stati amplificati e precisati da
un vasto insieme di provvedimenti successivi. Cambiato il governo, non sono
mutate per nulla le scelte politiche; anzi un filo coerente si è dipanato
attraverso l’azione di esecutivi apparentemente di indirizzo ben diverso: da
Berlusconi a Monti, a Letta, con forte slancio con Renzi. Come se questi governi
avessero idee identiche sul presente e sul futuro di una istituzione così
complessa e articolata come l’università. Come se non ci fossero più differenze
sui grandi temi che le politiche universitarie coinvolgono: l’universalismo dei
diritti, costi e benefici dei servizi pubblici, lo sviluppo territoriale, gli
indirizzi per la ricerca. Condividendo un pensiero unico che ha attraversato
tutto il decennio. Un pensiero che corrisponde a una narrazione sommaria:
l’università italiana, come si vede dalle classifiche internazionali, è scadente
e i suoi professori non sono promossi per merito; lavorano poco e in modo
antiquato: fanno poca ricerca sugli standard internazionali; gli studenti sono
troppi, e molti fra di essi sono pigri, “fuori corso” e vogliono studiare sotto
casa. Non vale quanto costa allo Stato. È un prodotto dell’Italia del passato,
della Prima Repubblica, della spesa pubblica e delle assunzioni facili. Occorre
allora praticare la valutazione e premiare il merito; selezionare diversamente i
docenti e incentivare gli studenti a muoversi e a frequentare gli atenei
migliori; è necessario sostenere i corsi di laurea moderni e utili, legati
direttamente al mondo del lavoro. Disboscare la rete delle università;
concentrare le risorse finanziarie su alcune, di eccellenza e fare in modo che
le altre costino molto meno alla collettività. Una comunicazione che a strizza
l’occhio all’Italia preoccupata dalla crisi e attenta al proprio particolare.
“Risparmio”, per tutelare il portafoglio del contribuente; “merito” al posto
della spesa pubblica a pioggia del passato, per combattere i corrotti e i
fannulloni; indicatori “oggettivi” e tecnici al posto di scelte politiche; la
tutela degli interessi dei territori più forti. L’attuazione di questo pensiero
è stato affidata ad una piccola élite: alcuni dei Ministri che si sono
succeduti, specie quelli provenienti dalle fila delle università; alcuni
dirigenti apicali del Ministero; alcuni consulenti della Presidenza del
Consiglio; alcuni docenti chiamati a guidare la nuova Agenzia Nazionale per la
Valutazione dell’Università e della Ricerca, l’Anvur. Come sta avvenendo per
altre importanti politiche pubbliche (ad esempio i criteri di finanziamento
degli enti locali), l’effettivo potere decisionale è stato di fatto sottratto
alle rappresentanze parlamentari e concentrato nelle mani di pochi esperti.
Essi, apparentemente, sono immuni dai condizionamenti deteriori della politica,
sanno quel che serve al paese, operano in base a criteri oggettivi di efficienza
e di merito. In realtà, sono orientati dalle proprie convinzioni
politico-ideologiche, in ossequio alle quali costruiscono gli indicatori e le
norme: che presentano però sempre come scelte tecniche, mascherandone i criteri
di scelta e le conseguenze politiche».
Di quali riforme ha bisogno l’università italiana?
«Non si sfugge: serve un
investimento pubblico molto più grande sull’università italiana; che ci avvicini
progressivamente alla situazione degli altri paesi europei e inverta le tendenze
delle politiche degli ultimi anni. Bisogna investire risorse pubbliche molto
maggiori in primo luogo sul diritto allo studio, e in generale sui servizi per
gli studenti per accrescere progressivamente i tassi di passaggio dalle
superiori all’università, specie per i ragazzi e le ragazze di estrazione
sociale più modesta e provenienti dai territori più deboli; per accompagnarli
meglio nel loro percorso di studio, abbattere gli abbandoni e aumentare così il
livello complessivo di istruzione. È necessario ricondurre la tassazione
universitaria ad una funzione ancillare rispetto al finanziamento statale, ben
delimitata e governata da principi condivisi: tetti invalicabili rispetto al
finanziamento pubblico e interventi di esenzione validi per l’intero paese.
Porsi questi obiettivi significa anche investire sulle città: intervenire sulla
qualità della vita urbana, sui trasporti, sulla produzione e fruizione di
cultura per i ragazzi. Investimenti proficui: città con più studenti non sono
solo più vive e più belle: ma sono anche incubatori di idee, progetti, imprese.
In secondo luogo l’investimento va mirato sui giovani studiosi: umiliati,
vilipesi, tenuti al margine, spinti a fuggire. La politica degli ultimi anni ha
chiuso le porte agli atenei e li ha resi un mondo sempre più anziano. È
necessario un grande investimento per immettere progressivamente nelle
università una nuova leva di studiosi, dare certezze a chi è precario, offrire
una chance a chi è all’estero e accoglienza a giovani stranieri. Attraverso
processi selettivi trasparenti, non bizantini né particolaristici; in cui siano
valutate complessivamente capacità e conoscenze, abilità nell’insegnamento e
qualità dei percorsi di ricerca dei candidati e non solo applicati algoritmi
tanto complicati quanto distorsivi. Non servono regole dettagliate calate
dell’alto: ma pochi principi e direttivi e una grande trasparenza. Un tema,
quello del reclutamento, decisivo per ricreare fiducia nelle università e sulle
università; e per renderle, grazie ad una nuova grande e qualificate leva di
studiosi, un’infrastruttura culturale e scientifica di qualità sempre maggiore.
L’investimento va fatto in tutto il paese. Anche in questo campo l’Italia deve
guardare con attenzione molto più al modello tedesco che alle sirene del
neoliberismo anglosassone. Un paese forte ha un sistema universitario diffuso e
di buona qualità, presente sui territori, ricco di opportunità di collaborazione
e con un’ampia mobilità, in tutte le direzioni, di docenti e ricercatori. Fra i
frutti più avvelenati delle politiche degli ultimi anni vi sono certamente la
grande incertezza della disponibilità di risorse, con la conseguente
impossibilità di programmare; una sotterranea guerra fra sedi per spartirsi
qualche briciola del finanziamento; l’attenzione al proprio particolare perdendo
di vista l’interessa generale e del paese. Per raggiungere questo obiettivo, il
sistema di finanziamento va semplificato e reso stabile. Il fondo di
finanziamento ordinario potrebbe essere integralmente costruito sul costo
standard, così come opportunamente, recentemente, riformulato dal Parlamento.
Individuando così le risorse per ogni ateneo; e nella loro somma il fabbisogno
complessivo di base del sistema da soddisfare. Meccanismo che, essendo
parametrato al numero di studenti, stimola non poco le università a disegnare
offerta formativa e servizi sempre migliori. La cosiddetta quota premiale, con i
suoi meccanismi discrezionali e distorsivi andrebbe semplicemente abolita. Si
dovrebbe saggiamente riconoscere di aver realizzato una lunga sperimentazione,
ma con esiti molto negativi, e cambiare verso introducendo nel sistema altri
schemi e meccanismi di governo, di incentivo e di premio per il miglioramento
della qualità».
Gianfranco Viesti è Professore Ordinario di Economia
Applicata presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro
La Grande balla al Tg4, Napoletano: «Il Sud è stato di fatto
escluso dal decreto liquidità». Roberto Napoletano il
16 aprile 2020 su Il Quotidiano del Sud.
(LaPresse il 27 maggio 2020) - Il 50,7% dei prestiti garantiti
dallo Stato, fino a 25.000 euro e fino a 800.000 euro, è appannaggio delle
quattro grandi regioni del Nord dove, però, è attivo “solo” il 38% di partite
Iva e pmi italiane. Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna si assicurano
oltre la metà dei finanziamenti con paracadute pubblico, ma in quelle zone del
Paese opera, in proporzione, un numero di imprese e professionisti nettamente
inferiore alla quota di crediti in arrivo grazie al decreto liquidità; nel resto
del Paese, opera il 62% di soggetti economici, ma la quota di prestiti si ferma
al 49,3%. È quanto emerge da un’elaborazione realizzata dalla Fabi, secondo la
quale, su complessivi 17,1 miliardi di euro di prestiti richiesti in Italia fino
al 25 maggio, sfruttando il Fondo centrale di garanzia, in Lombardia le domande
ammontano a 3,9 miliardi pari al 22,5% del totale, ma le imprese e le partite
Iva, rispetto all’intero territorio nazionale, sono il 15,7%; in Veneto le
domande valgono 1,9 miliardi ovvero l’11,5% del totale, mentre la quota di pmi e
partite Iva si ferma al 7,9%; situazione simile a quella dell’Emilia-Romagna,
con 1,7 miliardi di richieste, pari al 10,1% del totale, da confrontare con il
7,4% di imprese e partite Iva operanti sul territorio regionale; in Piemonte,
unico caso fra le quattro maggiori regioni settentrionali, c’è un sostanziale
equilibrio considerando che le domande valgono 1,1 miliardi, pari al 6,5% del
totale nazionale e la quota di pmi e partite Iva si attesta al 7%. Dall’analisi
della Fabi, dunque, emerge "un evidente divario tra la ripartizione, su base
regionale, dei prestiti protetti dallo Stato col decreto “liquidità” e la
distribuzione territoriale di partite Iva e piccole medie imprese. Ne consegue
che alcune zone del Paese, di fatto, sono significativamente premiate e altre,
specie al Sud, pesantemente penalizzate. Nel resto d’Italia, con l’eccezione di
Marche e Umbria, il rapporto tra prestiti richiesti e percentuale di imprese è
sempre in “deficit”, la quota di finanziamenti, in sostanza, è inferiore alla
quota di pmi e partite Iva presenti rispetto al totale nazionale: nel Lazio le
domande di prestiti valgono il 9,4% del totale (1,6 miliardi), le pmi e partite
Iva rappresentano il 10,9% del bacino nazionale; in Toscana si raffronta il 6,2%
delle richieste di finanziamento (1,1 miliardi) con il 6,2% di soggetti
economici operanti; in Campania, i prestiti arrivano al 7,7% (1,3 miliardi) e le
pmi/partite Iva al 9,8%; in Puglia, il confronto è tra il 4,8% di finanziamenti
(812 milioni) e il 6,3% di operatori economici; in Sicilia il 5,0% di prestiti
(848 milioni) va rapportato al 7,7% di pmi/partite Iva; in Abruzzo, le domande
ammontano al 2,1% del totale (353 milioni), ma imprenditori e professionisti
pesano per il 2,4%; in Calabria, il 3,1% di pmi e partite Iva italiane ha
presentato richieste per l’1,6% del totale; in Liguria il 3,1% di pmi e partite
Iva italiane ha presentato richieste per l’1,6% del totale; in Sardegna si
raffrontano l’1,5% delle richieste di finanziamento (262 milioni) con il 2,8% di
soggetti economici operanti; in Basilicata lo 0,7% di prestiti (114 milioni) va
rapportato all’1% di pmi/partite Iva; in Trentino-Alto Adige, le domande
ammontano all’1,3% del totale (221 milioni), ma imprenditori e professionisti
pesano per l’1,8%; nel Molise le domande di prestiti valgono lo 0,4% del totale
(64 milioni), le pmi e partite Iva rappresentano lo 0,6% del bacino nazionale;
in Val d’Aosta, le domande ammontano allo 0,1% del totale (19 milioni), ma
imprenditori e professionisti pesano per lo 0,2%". Proporzione quasi rispettata
in Friuli-Venezia Giulia - sottolinea Fabi - i prestiti richiesti ammontano
all’1,8% del totale (307 milioni), percentuale leggermente più alta della quota
di pmi e partite Iva rispetto all’intero bacino nazionale (1,7%). Due le
eccezioni ovvero le situazioni “favorevoli” lontane dal Nord: quella della
regione Marche, dove la quota di finanziamenti è pari al 3,6% del totale (618
milioni), mentre le pmi e le partite Iva sono il 2,8%; e quella della regione
Umbria, dove i prestiti valgono l’1,6% (277 milioni), mentre gli operatori
economici sono l’1,5%. "Alcune banche, per loro convenienze, stanno penalizzando
determinati territori e ne stanno favorendo altri: il risultato è che in
specifiche aree del Paese, soprattutto del Sud, si sta allargando il rischio
usura per le imprese, perché chi non ottiene finanziamenti in banca finisce
molto probabilmente in mano alla criminalità organizzata. Sarebbe interessante
conoscere i dati relativi ai tempi di erogazione da parte dei singoli gruppi
bancari". Lo ha dichiarato il segretario generale della Fabi, Lando Maria
Sileoni, intervistato durante la trasmissione Tg2 Italia su Rai2, commentando il
nuovo studio della Fabi sui prestiti a imprese e partite Iva garantiti dallo
Stato. Secondo Sileoni "non c’è proporzione tra l’ammontare dei prestiti e il
numero di partite Iva e pmi, ciò perché da parte di alcuni istituti c’è molta
attenzione verso i territori settentrionali".
Gli aiuti al Nord con i soldi del Sud: lo scippo continua
anche in piena crisi. Vincenzo Damiani su Il
Quotidiano del Sud il 27 maggio 2020. Anche la sanità penalizzata per lo scippo
al Sud. C’è quel 0,15% che dovrebbe essere cancellato e invece il tentativo è
ancora quello di sottrarre soldi al Sud: dai finanziamenti per l’emergenza Covid
che stanno finendo quasi esclusivamente nelle casse delle più grandi aziende del
Nord, alla ridistribuzione e reimpiego dei Fondi coesione per pagare la Cig al
Nord. C’è un’Italia che dovrebbe ripartire e rapidamente, dovrebbe farlo
guardando allo sviluppo del Sud e invece proseguono gli scippi. Servirebbe una
manovra che prenda le mosse da un punto fermo: ridare al Sud quello che gli è
stato sottratto negli ultimi 20 anni.
FARE GIUSTIZIA. Per risollevare il Paese servirebbe un atto
politico che rimetta le cose a posto, rendendo “giustizia” a un Mezzogiorno
rimasto senza investimenti. All’Italia intera servirebbe correggere questa
stortura, riportare gli investimenti per lo sviluppo del Mezzogiorno lontano da
quello 0,15% del Pil (dati dei Conti pubblici territoriali) a cui sono ancorati
oggi. Occorre riequilibrare la spesa pubblica che toglie ai poveri (il Sud) per
dare ai ricchi (il Nord): basti pensare ai 62 miliardi dirottati verso le
Regioni del Centro-Nord Italia. E se la cifra di 62 miliardi di euro riesce a
inquietarvi, beh, pensate che la situazione è addirittura peggiorata: tra il
2016 e il 2017, infatti, il Mezzogiorno ha perso quasi un altro miliardo di euro
l’anno.
IL DECLINO. Insomma, serve una manovra finalmente equa, che ridia
ai cittadini del Sud la stessa qualità di servizi di cui gode chi vive al Nord.
Perché è facile immaginare cosa voglia dire, ad esempio, 62 miliardi in meno:
sanità meno efficiente, meno treni, meno bus, meno asili, scuole più insicure.
In breve: meno diritti e opportunità. Al Mezzogiorno servono strade e ferrovie
moderne. Ma non sulla carta, non solo sui progetti annunciati. La sintesi del
declino della spesa infrastrutturale in Italia, e al Sud in particolare, sta nel
tasso medio annuo di variazione nel periodo 1970-2018, pari a -2% a livello
nazionale: -4,6% al Sud e -0,9% nel Centro-Nord. Gli investimenti
infrastrutturali nel Sud negli anni ’70 erano quasi la metà di quelli globali,
mentre negli anni più recenti sono calati a quasi un sesto del totale nazionale.
In valori pro capite, nel 1970 erano pari a 531,1 euro a livello nazionale, con
il Centro-Nord a 451,5 e il Mezzogiorno a 677 euro. Nel 2017 si è passati a
217,6 euro pro capite a livello nazionale, con il Centro-Nord a 277,6 e il
Mezzogiorno a 102 euro. La conseguenza è che nel ranking regionale
infrastrutturale della Ue a 28, la regione del Mezzogiorno più “competitiva” è
la Campania, a metà graduatoria (134ª su 263), seguita da Abruzzo (161°), Molise
(163°), Puglia (171ª), Calabria (194ª), Basilicata (201ª), Sicilia (207ª) e
Sardegna (225ª). Basterebbe questa graduatoria a raccontare il gap
infrastrutturale che il Sud ha accumulato negli anni non solo rispetto al Nord,
ma nei confronti del resto d’Europa.
IL DISIMPEGNO. Al Sud, a parte la realizzazione di alcune tratte
autostradali con terze corsie e l’adeguamento della Salerno-Reggio Calabria,
l’incremento di autostrade è stato molto limitato e si è concentrato tutto o
quasi in Sicilia. «Il segnale del disimpegno degli investimenti pubblici in
questo ambito – recita l’ultimo rapporto Svimez – sta nel peggioramento della
dotazione relativa di autostrade nel Mezzogiorno. Rispetto alla media europea a
15 (posta uguale a 100), la dotazione di autostrade del Sud è passata dal 1990
al 2015 da 105,2 a 80,7». Per quel che riguarda la dotazione di linee
ferroviarie, molto carente al Sud è lo sviluppo dell’Alta Velocità (AV), con
soli 181 chilometri di linee, pari all’11,4% dei 1.583 chilometri della rete
nazionale; nel Centro-Nord la rete è di 1.402 chilometri, pari all’88,6% del
totale. Nel confronto con la Ue (rete AV ponderata sulla popolazione dei soli
Stati membri dotati), l’indice di dotazione dell’Italia nel 2015 è pari a 116,
con il Centro-Nord a 156,5 e il Mezzogiorno appena a 38,6. D’altronde basta
guardare la cartina delle direttrici dell’Alta velocità – esistenti o ancora da
realizzare – per accorgersi che l’Italia delle ferrovie – non solo quella, per
carità- è spaccata in due: su tutta la linea adriatica, da Bari sino a Bologna,
c’è il vuoto, così come dalla Puglia alla Sicilia. Mentre al Nord è fitta la
“ragnatela” di linee che si intrecciano e uniscono ogni angolo dell’Italia
settentrionale.
OCCASIONI PERSE. Se al Sud c’è solo il 16% dell’Alta velocità è
merito di decenni di mancati investimenti. Si spiega così il fatto che le linee
sono elettrificate per l’80% al Nord e per il 50% al Sud; oppure che al Sud
circolano meno treni che nella sola Lombardia. I porti del Mezzogiorno, pur
vantando numero e lunghezza degli accosti nettamente superiori a quelli del
Centro-Nord, presentano una dotazione estremamente modesta, con un indice
sintetico pari a 58,9, dovuto alla forte carenza di capacità di movimentazione e
stoccaggio delle merci. Relativamente migliore risulta l’indice sintetico degli
aeroporti (69,4), ma anche in questo comparto si scontano carenze qualitative
dell’offerta (distanza dai centri urbani, aree di parcheggio aeromobili e
superficie delle piste).
Basta scempi, svegliati Sud. Lo
scippo della Spesa Storica che toglie al Mezzogiorno e regala al Nord è
l’origine del declino italiano. Ora lo si vuole replicare approfittando della
Pandemia, nonostante il disastro della superforaggiata Lombardia. E tutti i
Governatori del Sud tacciono. Come sempre. Roberto Napoletano il 30 aprile 2020
su Il Quotidiano del Sud. Tutti tacciono. Come hanno fatto negli ultimi venti
anni. Hanno sempre qualche emergenza di cui occuparsi. Spicciano pratiche. Hanno
una conference call dietro l’altra (prima incontravano gente). Zitti e muti. I
soldi loro vanno da un’altra parte, ma loro non se ne accorgono. Se glielo
spieghi, ti guardano strano. Preferiscono il silenzio. Dopo diranno che non
hanno capito. Si spartiranno le briciole – se ci sono – che i ricchi lasceranno
cadere dai tavoli imbanditi con le pietanze rubate ai poveri. Che sono loro.
Quelli che stanno zitti quando dovrebbero urlare e strepitano o piagnucolano
quando non serve a nulla. Allora, prendiamone nel gruppo uno a caso. Ci
rivolgiamo al Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e mettiamo tutto per
iscritto a futura memoria. Non sappiamo con quale lanciafiamme sta facendo
strage di virus contagiosi e non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscerle che ha
dimostrato polso e testa nel contrastare questo brutto mostro. Ora, però, ci
dobbiamo occupare dei morti di debiti e di fame non più di quelli da
Coronavirus. Le facciamo presente che se avere chiuso un occhio con 60 e passa
miliardi di spesa pubblica dovuti al Sud e regalati al Nord ogni anno negli
ultimi dieci anni è stato grave, stare zitti oggi di fronte al nuovo scempio
significa accettare in silenzio la sparizione del Mezzogiorno e di quel che
resta della sua economia. La fervida mente dei burocrati del Tesoro ha
approfittato della debolezza politica del ministro “politico” Gualtieri e ha
fabbricato il più poderoso “decreto di illiquidità” concepito da un Paese
occidentale alle prese con la Grande Depressione Mondiale. Se per avere 25 mila
euro ti devi fermare davanti a 12 stazioni della morte e non vedi il becco di un
quattrino, per i finanziamenti fino a 800 mila euro e poi fino a 5 milioni non
ci sono neppure le istruzioni per chiederli. Il tasso di fragilità delle imprese
meridionali è quattro volte superiore a quello delle imprese del Nord. Non hanno
avuto nulla e quando arriverà qualcosina avranno già chiuso per sempre. A fronte
di tutto ciò si arriva a concepire lo scempio di una dote straordinaria di 50
miliardi alla Cassa Depositi e Prestiti – a sostegno dell’economia l’anno scorso
ha mobilitato 36,4 miliardi di risorse – per prendere partecipazioni temporanee
nel capitale di imprese private ovviamente in crisi ovviamente al Nord. Basta
prendersi in giro. La Cassa Depositi e Prestiti tedesca (Kfw) è il braccio
armato fuori bilancio della Cancelleria Merkel e ha inondato di liquidità le
piccole e medie imprese del suo Paese con passaggi bancari velocissimi. Finanzia
grandi infrastrutture e grandi eccellenze tecnologiche. Noi alla nostra Cdp non
chiediamo di inondare di liquidità le imprese italiane, a partire da quelle
meridionali più vicine al default, ma la vogliamo azionista di Stato delle
imprese decotte del Nord per la bellezza di 50 miliardi. Proprio quelli che
servirebbero per l’unificazione infrastrutturale del Paese tra Nord e Sud a
partire dai treni veloci. Lo scippo della Spesa Storica che toglie al Sud e
regala al Nord – è l’origine del declino italiano – lo si vuole replicare
approfittando della Pandemia, nonostante il disastro della superforaggiata
Lombardia. Mi raccomando Governatore De Luca – lo dico provocatoriamente a lei
ma vale per tutti i suoi colleghi e per chiunque abbia un po’ di sale in zucca
della classe dirigente meridionale – non disturbiamo il manovratore e
occupiamoci di distanze in casa e al bar. Gli acquisti della Banca Centrale
Europea consentono a lei e all’allegra brigata di distrarsi ma non così a lungo.
Qui gli acquisti sono poderosi non illimitati come in America, in Giappone, in
Inghilterra e, per di più, la Lagarde a differenza di Draghi non sa parlare ai
mercati. Consiglierei a tutti da Roma in giù di svegliarsi e di farsi sentire.
Se questo tempo in più che il governo si è preso servirà per fare meglio, allora
questo tempo è benedetto. Se servirà, complice l’imperdonabile silenzio del
Mezzogiorno, a partorire il solito topolino, che si preoccupa di tenere in vita
(male) solo un pezzo di Paese, allora sarà la fine del mondo. Errare è umano.
Perseverare nell’errore è diabolico. Produce effetti non più controllabili.
BASTA
REGALI CON I SOLDI DEL SUD.
Hanno
costruito al Nord tutte le infrastrutture con i soldi del Sud, ora approfittano
della pandemia per regalare 50 miliardi alla Cdp e salvare le aziende
decotte del Nord. Che cosa aspettano i Governatori del Sud a ribellarsi? Ultima
chance per Gualtieri e Rivera: riequilibrate liquidità e spesa pubblica
infrastrutturale. Roberto Napoletano su Il Quotidiano del Sud il 29 aprile
2020. Non abbiamo più voglia di scherzare. Hanno regalato al Nord tutte le
infrastrutture con i soldi del Sud per venti anni. Ora, approfittando della
Pandemia globale, vogliono regalare 50 miliardi alla Cassa Depositi e Prestiti
per dare alle aziende private decotte del Nord un socio di capitale che si
chiama Stato e copre per sempre le loro nefandezze. Ancora una volta vogliono
farlo con i soldi del Sud. Basta! Ministro Gualtieri, direttore del Tesoro
Rivera, ve lo diciamo con chiarezza, la stagione degli scippi in tempi di pace è
maleodorante, ma in tempi di guerra fa ribrezzo. Questo giornale non vi darà
tregua da qui al decreto, vi controllerà a vista. Scruteremo riga per riga il
testo. Andremo a vedere i bilanci a uno a uno delle aziende che finiranno nella
lista dei regali pubblici. A chi appartengono? Dove si trovano? Chi le
sponsorizza e perché? Scoperchieremo il pentolone senza riguardi per nessuno.
Non vi daremo tregua, prima e dopo, perché la misura è colma. Non avete
sbagliato un colpo per il peggiore sottogoverno nelle nomine nei Cda delle
società pubbliche inventando mestieri e facendo strame di ogni regola di
competenza. Non siete riusciti a togliere alle banche un solo vincolo, come la
segnalazione alla centrale rischi, che taglia dall’accesso al credito la
stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese meridionali. Non riuscite a
erogare contributi a fondo perduto perché avete escogitato (vero, dottor
Rivera?) ogni genere di bizantinismo burocratico per cui i soldi a molte piccole
imprese arriveranno quando avranno chiuso per sempre. Mentre voi occultate con
mani sapienti ogni tipo di liquidità possibile tra Sace, Mediocredito, INPS,
banche senza tutela penale, in Lombardia stanno “rimpatriando” dalla Svizzera i
soldi della ‘Ndrangheta nel bresciano e si moltiplicano i faccendieri che danno
le fideiussioni alle aziende che non hanno le garanzie che voi volete per avere
prestiti e mutui. E così, di interposizione fittizia in interposizione fittizia,
gli uomini dell’area grigia mettono un piede sempre più largo in un’economia
reale che ha bisogno per colpe non sue di quella liquidità che una miope classe
burocratica e una servile classe di governo impediscono loro di avere.
Vergognatevi! Al Paese oggi, non domani, serve liquidità. Non azionisti pubblici
amici degli amici che continuano a rapinare il soccorso pubblico dovuto al
Mezzogiorno per foraggiare amministrazioni regionali assistenzialiste del Nord e
un capitalismo privato del Nord che da tempo non sa più vivere di mercato. Al
massimo, si affidino a Cdp strumenti di partecipazione tipo bond convertibili
che finanziano l’impresa ma non entrano nel capitale. Non avremmo francamente
mai creduto che i Gualtieri e i Rivera ci potessero regalare la società
finanziaria comunista per cui, grazie al risparmio postale fortissimo al Sud, si
diventa soci di capitale delle imprese decotte del Nord. Se non sbloccate entro
una settimana la liquidità necessaria, che Paesi come Germania, Francia,
Svizzera, hanno già trasferito da un mese a chi ne ha bisogno, ci sarà la
rottura del patto sociale che garantisce la pace in tempi di guerra, ma se
addirittura non date la liquidità oggi e architettate i vecchi trucchetti per
togliere domani al povero e dare al ricco succede il finimondo. Avete un’ultima,
residua, possibilità per riscattarvi. Siamo davanti a un evento straordinario?
Sì, e ci sia allora un riequilibrio strutturale nella ripartizione di liquidità
a fondo perduto e di spesa pubblica infrastrutturale di questo Paese tra Nord e
Sud. Governatore De Luca, lo stesso lanciafiamme che ha usato nei confronti dei
suoi concittadini per chiuderli in casa, vogliamo usarlo per garantire alla
comunità e alla economia della sua regione i soldi che sono dovuti per la
ripartenza? Vuole continuare a stare zitto e a subire, lei e gli altri
Governatori del Sud, lo scippo da 60 miliardi l’anno di risorse pubbliche dovuti
alle regioni meridionali per le loro sanità, le loro scuole e i loro trasporti,
e regalati invece a un Nord che continua a tenere in scacco l’intero Paese?
Perché non fa in pubblico qualcuno dei suoi numeri televisivi che lo hanno reso
così popolare per difendere diritti che incidono sulla carne viva delle donne e
degli uomini meridionali? Noi attenderemo tutti al varco perché questa volta
sono in gioco la vita e la morte delle persone, la vita e la morte
dell’economia. Questo giornale è nato per fare l’operazione verità sui conti
pubblici e ci è pure riuscito, figuriamoci se ci tiriamo indietro in un momento
come questo. Il Sud, presidente De Luca, deve riaprire prima del Nord, deve
dimostrare di esserne capace, e deve avere le risorse che gli spettano.
Commissario Arcuri, le fabbriche delle mascherine sono in Lombardia, vero, i
soldi vanno in Lombardia, vero? Esiste un piano epidemiologico della Lombardia?
No. Esiste un piano di tamponi? No. Esiste un piano di presidi sul territorio
per affrontare nuove emergenze in Lombardia? No. Legga il grido di allarme che
Carmela Rozza lancia dalle colonne di questo giornale. Siamo consapevoli che
senza una sanità lombarda sotto controllo rischia il sistema produttivo lombardo
e si tengono sotto scacco la società e l’economia di un Mezzogiorno che ha avuto
comportamenti esemplari e continua a pagare un conto pesantissimo che non è suo?
Che cosa si aspetta a commissariare la sua sanità regionale? Nessun Paese può
vivere con una sola locomotiva peraltro “infettata” di provvigioni e prebende
pubbliche senza limiti che hanno diffuso il male dell’assistenzialismo al Nord,
sottratto linfa vitale al Sud, indebolito l’intero Paese. Presidente Conte, lei
ha tenuto la rotta in momenti durissimi in casa e in Europa e è un uomo del Sud,
non consenta a tecnocrati che pure avevamo apprezzato nelle trattative
internazionali di mettere sotto scacco la politica per continuare a fare i
soliti giochetti tra Nord e Sud. Non sappiamo come dirlo, ma non è aria.
Produzione
delle mascherine, un affare appaltato al Nord ai danni del Sud.
Claudio
Marincola il 29 aprile 2020 su Il Quotidiano del Sud. Le mascherine? C’è il
rischio che diventeranno come la polenta o il Lambrusco. Specialità del Nord. Di
origine controllata, made in Lombardia. Dei 50 milioni 195mila euro previsti dal
decreto Cura Italia per riconvertire le aziende e spingerle a produrre
dispositivi di protezione, ben 9 milioni 856.515 sono andati infatti a imprese
lombarde. Prima del Codiv-19 producevano altro. Alla Basilicata, per dire, ne
sono andati solo 960.700 mila, alla Sardegna 567mila, alla Calabria 1 milione
431mila, al Lazio 1.224.455mila. Insomma, la parte del leone, come al solito,
l’ha fatta la nostra locomotiva. Finita in panne, come sappiamo, ma pronta a
ripartire di slancio.
LA LEZIONE NON
È SERVITA. Il grafico è disponibile sul sito di Invitalia.it: il 20% del budget
complessivo è andato alla Lombardia. Alimenta il sospetto che l’esperienza
drammatica che stiamo vivendo non abbia cambiato niente. La lezione del
coronavirus, insomma, non è servita. Tutto, anche la produzione di dispositivi
di protezione, continuerà a concentrarsi entro lo stesso perimetro industriale,
sovrapponibile, guarda caso, alla diffusione del contagio. E agli altri? Le
briciole. Le domande presentate e accolte dall’Ufficio del super commissario
all’emergenza Domenico Arcuri sono state in totale 107. Con l’unica eccezione
della Campania, che se n’è vista accogliere 13, il“ ”visto si finanzi” è andato
a Lombardia, 17; Toscana, 14; Emilia-Romagna, 11; Marche e Puglia, 8; Abruzzo e
Umbria, 5; Sicilia, 3; Basilicata, Sardegna e Piemonte, 2, Liguria, 1. Settanta
domande hanno riguardato la riconversione, 37 l’ampliamento dei locali. Di
mascherine ne servono diverse decine di milioni al giorno. Un business non da
poco. E la truffa è sempre in agguato. Si va da aziende improbabili, pronte a
sfruttare il momento, alle mascherine con il marchio Ce, che, però, non vuol
dire certificate in Europa ma China export. Produrle al Nord vorrà dire intasare
un’area già congestionata. Senza dire che al Mezzogiorno un po’ di posti di
lavoro in più, diciamolo, non avrebbero fatto male. Sono scesi in campo i
colossi: Armani e il gruppo Prada-Montone, inizialmente a scopo benefico. A
ruota gli altri: Fippi Spa di Rho; Malex di Correggio; Nuova Sapi di
Casalgrande; Md Massaflex di Massa Carra, che fino a ieri produceva materassi. E
si è mosso anche il mondo della Legacoop, con 12 cooperative dedicate, In
Veneto, tra le prime a riconvertirsi alla produzione di mascherine la veronese
Quid.
MASCHERINE DI
STATO. A CHI? Ancora da definire resta la questione delle macchine che
serviranno per la produzione. Lo Stato ne ha acquistate 51. Le prime 17 verranno
consegnate in comodato d’uso a 4 aziende di cui ancora non è noto il nome.
Quando il Paese diventerà autosufficiente – sempre troppo tardi, purtroppo – il
Mezzogiorno continuerà probabilmente a dipendere in gran parte dal Nord. E non
viceversa. Occasione persa o solito strapotere? Ci sarebbe anche da dire che le
aziende riconvertite sull’onda dell’emergenza lasceranno ai concorrenti
consistenti quote di mercato. Più dispositivi facciali per difendersi dal virus
malefico vuol dire meno capi di abbigliamento o meno altro che si produceva
prima. Non era meglio, una volta tanto, puntare sul Sud, isole comprese?
LA PROPOSTA
DEI DOCENTI SARDI. Da questa considerazione è partita forse la proposta del
giurista Giuseppe Valditara, dell’Università di Torino e coordinatore di Lettera
150, un gruppo di docenti che si sta battendo per rallentare la corsa alla
riapertura e uscire in sicurezza dal lockdown. La drammatica carenza di tamponi
e reagenti e la chiusura dei mercati internazionali a seguito dei divieti di
esportazione rendono sempre più urgente la necessità di pensare a una
“produzione statale” di presidi strategici, come appunto le mascherine. E cosa
propongono il professore e i suoi colleghi? «Di localizzare la produzione in
aree naturalmente protette come Sardegna e Sicilia», anche perché così si
potrebbero «rivitalizzare aree economicamente depresse oltre a garantire
l’autosufficienza del Paese». Già. È cosi difficile?
Nuova crisi, vecchio rimedio. I soldi? Sempre e solo al Nord.
La proposta indecente dei tecnici del Governo. Ivana Giannone il 19 aprile 2020
su Il Quotidiano del Sud. Nuova crisi economica, vecchi rimedi. Come accadde dal
2009 in poi, anche oggi con l’emergenza Coronavirus in corso, il Governo ha
bisogno di risorse da investire qua e là per salvare il salvabile. Questa volta
non serviranno a ripianare i conti pubblici, che grazie alla sospensione del
patto di stabilità non dovrebbero essere un problema, ma a investire nelle zone
più colpite. Con quali soldi? Con quelli destinati al Mezzogiorno. La proposta
arriva dal Dipe, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica che fa capo a Palazzo Chigi. In un documento dal titolo
“L’Italia e il Covid-19” (aprile 2020), che il Quotidiano del Sud è riuscito a
visionare, si propone la «sospensione del riparto delle risorse dei programmi di
spesa». Tradotto: la messa in pausa della cosiddetta clausola del 34% che
destina alle regioni meridionali una quota di investimenti pari alla popolazione
residente. Un colpo di mano che rischierebbe di mettere una pietra sopra su una
disposizione approvata a fine 2016, ma ancora largamente inattuata. Sospendere,
poi, fino a quando? Questo il Dipe non lo dice. L’emendamento proposto cita
testualmente: «Il riparto delle risorse dei programmi di spesa di cui al comma 2
è sospeso sino al …….».
Puntini sospensivi. Che potrebbero valere mesi, o più
probabilmente anni, di quello che questo giornale ha sempre definito “scippo” e
che questa volta troverebbe una nuova giustificazione nell’emergenza che però, è
bene ricordarlo, colpisce tutto il Paese, specie i territori che già prima
scontavano povertà e disoccupazione. Due rilievi possono aiutare a capire cosa
significherebbe dirottare altrove gli investimenti destinati al Sud. Secondo una
stima della Svimez, già prima dell’inizio dell’emergenza Covid-19, il
Mezzogiorno faceva i conti una pesante recessione: il pil meridionale era circa
dieci punti al di sotto dei livelli pre-crisi del 2009. Secondo dato: il
lockdown dovrebbe far calare il prodotto interno lordo del Mezzogiorno di circa
altri 8 punti. A fine anno quindi il Sud potrebbe contare circa 20 punti di pil
in meno rispetto al 2007. Tutto questo ovviamente al netto della proposta del
Dipe. Senza investimenti o con una quota significativamente ridotta, i numeri
potrebbero essere ben altri.
Le giustificazioni si sprecano: «A seguito dell’esplosione della
crisi sanitaria e delle sue conseguenze economiche nel Paese – si legge nella
relazione illustrativa allegata alla proposta – si rende necessario operare una
sospensione del criterio di riparto delle risorse dei programmi di spesa in
conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti,
consentendo all’Autorità Politica la valutazione delle zone ove concentrare la
maggior quantità di risorse per investimenti in considerazione del mutato
scenario sociale e produttivo». Leggi: i soldi vanno dirottati in quello che
fino a un paio di mesi fa era il cuore produttivo del Paese, con buona pace di
quelle regioni che quest’estate non potranno contare più neanche sulle entrate
garantite dal turismo.
E non finisce qui. Proprio come già accaduto nel 2010, quando il
presidente del Consiglio si chiamava Silvio Berlusconi e il suo ministro
dell’Economia era Giulio Tremonti, si propone una sforbiciata anche ai Fondi di
sviluppo e coesione, le risorse che almeno in teoria sarebbero destinate al
riequilibrio territoriale. L’attuale ripartizione affida l’80% dei fondi al Sud
e il 20% al Centro-Nord. Percentuali che ora si vorrebbero rivedere, anche se il
documento non specifica in quale misura, rimandando tutto al “coinvolgimento
delle Regioni e degli Enti locali”. Le risorse prese in considerazione sono
quelle relative alla programmazione 2014-2020, in particolare i 4,87 miliardi di
euro che oggi risultano ancora «liberi da utilizzi». Un set di proposte
indecenti che non è passato inosservato dalle parti di Montecitorio. «È
imprescindibile che il Governo mantenga, ribadendola con forza, una linea
politica per lo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali che da un
lato favorisca una pronta ripartenza del proprio tessuto produttivo e dall’altro
permetta il recupero progressivo dei divari economici e infrastrutturali con il
resto del Paese», scrivono i deputati meridionali del Partito Democratico. «A
tal fine consideriamo i seguenti punti come componenti fondamentali e non
derogabili di questa strategia: 1. mantenere il vincolo di destinazione
territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc)
congiuntamente a quelle degli altri Fondi strutturali, al fine di promuovere le
politiche per lo sviluppo della coesione sociale e territoriale e la rimozione
degli squilibri economici e infrastrutturali tra le regioni; 2. considerare le
risorse di cui al punto 1) aggiuntive rispetto a qualsiasi altro strumento di
finanziamento ordinario e/o straordinario, non derogando così al criterio
dell’addizionalità previsto per i fondi strutturali dell’Unione Europea; 3.
rispettare la cosiddetta “clausola del 34%” che prevede la distribuzione degli
stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni Pubbliche in proporzione
alla popolazione nelle varie regioni italiane». Ora tocca al ministro
dell’Economia, il democratico Roberto Gualtieri, e al presidente del Consiglio
Giuseppe Conte battere un colpo.
Il virus rischia di togliere i fondi europei alla Calabria:
soldi alle regioni colpite. Massimo Clausi il 19
aprile 2020 su Il Quotidiano del Sud. Altro che Mes. Il vero acronimo che
dovrebbe preoccupare i calabresi è CRII+ (Coronavirus Response Investment
Initiative Plus). Si tratta di un pacchetto di misure finalizzate a fronteggiare
l’emergenza coronavirus in tutta Europa. L’elefantiaco procedimento legislativo
di Bruxelles sul tema non si è ancora concluso, ma in linea di massima il
pacchetto prevede una straordinaria flessibilità dei fondi affinché tutto il
sostegno finanziario non utilizzato a titolo dei Fondi strutturali e di
investimento europei possa essere pienamente mobilitato. Nello specifico la
flessibilità è garantita mediante: possibilità di trasferimento tra i 3 fondi
della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale
europeo e Fondo di coesione); trasferimenti tra le diverse categorie di regioni;
e flessibilità per quanto riguarda la concentrazione tematica. Naturalmente è il
secondo punto quello che più interessa alla Calabria ovvero lo spostamento dei
fondi di Coesione (pensati per colmare i gap socio-economici fra le regioni) a
regioni diverse da quelle definite “convergenza” come la Calabria. In base a
questo pacchetto i fondi non utilizzati dalle regioni più “deboli” possono
essere trasferiti ad altre regioni per contrastare gli effetti della pandemia.
Attualmente gli Stati membri possono trasferire tra le regioni fino al 3% dei
fondi stanziati. Nella proposta odierna non vi è più alcun limite, poiché
l’impatto del coronavirus non rispetta la consueta categorizzazione delle
regioni più o meno sviluppate prevista dalla politica di coesione. Ciò significa
che la Lombardia, dove il virus ha colpito più che altrove, può prendersi i
fondi della Calabria. Al fine di garantire una continua attenzione alle regioni
meno sviluppate, gli Stati membri dovrebbero valutare in primo luogo altre
possibilità di trasferimento dei finanziamenti prima di prendere in
considerazione il trasferimento dai bilanci delle regioni meno sviluppate a
quelli delle regioni più sviluppate. In altre parole, i trasferimenti non
dovrebbero ostacolare gli investimenti essenziali nella regione di origine o
impedire il completamento delle operazioni selezionate in precedenza. Inoltre, i
trasferimenti possono essere richiesti dagli Stati membri solo per operazioni
connesse al coronavirus nel contesto della relativa crisi. Va ricordato che
l’obiettivo della politica di coesione è ridurre il ritardo delle regioni meno
favorite. Tale principio è sancito dal trattato e dovrebbe essere rispettato
anche nelle circostanze attuali. Questo in linea di principio. In Italia però
bisogna sempre prendere tutto con le molle perchè già abbiamo avuto
un’esperienza simile con i fondi Pac “dirottati” sulle quote latte lombarde.
Questa possibilità che i fondi comunitari non impegnati possano essere
trasferiti ad altre regioni interessa molto la Calabria che ha diversi
investimenti ancora fermi al palo. La tabella che potete leggere in pagina è
contenuta fra i documenti allegati al bilancio di previsione 2020 che sarà
discusso nel prossimo consiglio regionale. Secondo i conti del Dipartimento
Bilancio della Regione, la quota delle risorse a fronte delle quali non si
registrano obbligazioni giuridicamente vincolanti ammonta ad almeno 3 miliardi
di euro nel pluriennale 2020-2023. A questi vanno aggiunti anche i quattrini
della programmazione 2016/2020 calata in un quadro economico che oggi è
totalmente mutato per gli effetti del coronavirus. Da qui la proposta del
consigliere regionale del Pd, Carlo Guccione, di approvare insieme al bilancio
un piano strategico per far ripartire gli investimenti pubblici e impegnare
quante più risorse possibile per evitare futuri scherzi da parte del Governo e
della Ue. La maggioranza, dal canto suo, vuole riproporre una commissione
consiliare che i occupi di fondi comunitari proprio per evitare che queste
risorse prendano altre strade. Non sappiamo quale delle due proposte sia
confacente alla situazione, ma quel che è certo è che bisogna iniziare a
discutere della futura programmazione per far ripartire la Calabria. Al momento
si registra solo l’atto di indirizzo della giunta, su proposta dell’assessore
Fausto Orsomarso (approvato con Delibera di Giunta Regionale del 01.04.2020) in
cui vengono stanziati 150 milioni, che verranno gestiti da Fincalabra, per
prestiti alle imprese calabresi. Un primo passo, che a breve verrà
concretizzato, ma il dibattito non può che essere più ampio se non vogliamo
rischiare un altro scippo al Sud.
VOGLIONO FAR PAGARE AL SUD SPRECHI E MALAGESTIONE DEL NORD.
Pino Aprile 20 Aprile 2020.
FONDI COESIONE E 34% A RISCHIO. MINISTRO PROVENZANO, E
SOTTOSEGRETARIO TURCO: NO. “L’Italia è finita”, sembrò un titolo esagerato, ad
alcuni: racconta quello che sta succedendo, e perché, anche se uscito due anni
fa. Preveggenza? Figurati: lo diceva già Indro Montanelli molti anni prima. Il
destino dell’Italia si gioca in questi giorni, forse, in queste ore: dipenderà
da come finisce lo scontro fra chi pensa di “tornare a prima del Covid-19”,
ovvero al Paese diviso fra chi si arroga tutti i diritti e i meriti (ma la
gestione dell’epidemia ha dimostrato quanto sia presuntuoso e falso), e chi è
ritenuto titolare di minori diritti (lo si vorrebbe persino sancire
costituzionalmente, con l’Autonomia differenziata) per la sua pochezza e
incapacità (ma la gestione dell’epidemia ha dimostrato quanto sia presuntuoso e
falso, pur se lo insegnano da cattedre in “Tutta colpa del Sud” generosamente
elargite). Il modo in cui si vorrebbe tornare a “prima del Covid-19” è lo stesso
che ha creato l’Italia duale: una parte che rastrella risorse (e non
“restituisce”, come ha detto il ministro al Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano e
confermano economisti non schierati) e una parte tenuta in stato coloniale, cui
sottrarre risorse e diritti.
L’APPELLO L CAPO DEL GOVERNO: LA RIPARTENZA SIA MERIDIONALE. Le
proposte allo studio del governo sono le peggiori possibili: rubare i fondi per
lo sviluppo e la coesione, FSC, destinati al Sud e darli a chi è stato capace di
buttare da 21 a 50 milioni (non si sa ancora), per attrezzare in un mese una
dozzina di posti letto di terapia intensiva, mentre gli incapaci e ladri, a
Napoli, in 30 ore, costruivano un ospedale (non solo tirando su tramezzi in un
edificio esistente), per 72 posti letto, spendendo 7 milioni. E vorrebbero pure
sospendere la clausola, appena imposta, del 34 per cento della spesa pubblica al
Sud, almeno proporzionale alla popolazione! Questo, mentre centinaia di
cittadini (primi firmatari, decine di docenti universitari, intellettuali,
imprenditori) lanciano una lettera dal Sud al capo del governo, per dire che la
ripartenza dalla tragedia non può che essere meridionale, perché le circostanze
lo consentono, senza rischiare, e perché l’Italia è giunta al punto di rottura:
o si avvia il recupero del divario Nord-Sud (frutto di scellerate scelte
politiche e discriminatore a danno del Mezzogiorno, in un secolo e mezzo), o il
Paese non reggerà alla brutalità di questo ennesimo strappo e si spezzerà.
LA PAROLA D’ORDINE: “FOTTERE IL SUD”. A livello di governo e
dintorni, ormai c’è chi dice, esplicitamente, che “bisogna fottere il Sud” (la
disperazione degli incapaci e ladri fa cadere le finzioni ed emergere la vera
natura delle cose). E i trombettieri di regime coloniale annunciano la
secessione possibile del Nord, se non potrà ancora saccheggiare il Sud, mentre
si dice stufo di mantenerlo (e sono pure bugiardi, visto che ormai anche la
Gazzetta di Paperopoli, non i giornali del Nord, non la Tv di Stato, salvo
eroiche eccezioni, vedi Report, pubblica che l’ente di Stato Conti Pubblici
Territoriali, gli studi della Svimez, le ricerche dell’Eurispes, eccetera
eccetera eccetera, dimostrano che ogni anno son sottratti al Sud, dalle risorse
che gli spetterebbero, almeno 61-62 miliardi. Quindi: chi mantiene chi?
Più volte, il giornale portavoce della Confindustria, il
Sole24ore, nelle settimane scorse, aveva riportato “voci” chiaramente ispirate
da ambienti ministeriali, senza dire quali, secondo cui “era allo studio” l’idea
di “riprogrammare” i fondi per lo sviluppo e la coesione, eliminando il vincolo
della destinazione. Che voleva semplicemente dire: i soldi del Sud, ce li
prendiamo al Nord, e chissene pure del vincolo del 34 per cento (infatti il
ministro ai Trasporti, purtroppo Paola de Micheli, Pd, nella ripartizione di
parte dei fondi per il rinnovo dei parchi degli automezzi per il trasporto
urbano, assegnò tutto alle città del Nord, meno una del Sud: l’equità di
lorsignori). La mossa di oggi, quindi, viene da lontano.
"GLI ERPIVORI: NEL 1948 DE GASPERI DIROTTO' I FONDI DEL PIANO
MARSHALL AL NORD. NEL 2020 CONTE LO EGUAGLIERA'? Annamaria Pisapia il 23 aprile
2020 su Movimento 24 Agosto - Equità Territoriale. Lo stupore è stata la prima
reazione dei lombardi, e di molti seguaci adoratori del nordicopensiero: belli,
bravi, integerrimi, ligi (e vennero a liberarci non ce lo vogliamo mettere?) sul
perché proprio quest’area sia stata la più colpita dal coronavirus, piuttosto
che una del Sud. Non un moto di vergogna sulla serie incredibile di errori,
dettati dalla presunzione di essere favoriti sempre e comunque (ne hanno mai
avuta di fronte ai più grandi scandali della storia del paese avvenuti proprio
al nord?). Nessuna mea culpa né da chi ha gestito l’emergenza, da Fontana, al
sindaco Sala (Milano non si ferma il suo leit motiv, a cui prontamente rispose
l’entusiasta segretario del pd Zingaretti e il sindaco di Bergamo Gori)
all’assessore Gallera, né dagli “illustri” luminari Burioni, Galli che, pur
sbagliando qualunque previsione continuano a deliziarci con le loro
elucubrazioni saltellando da un programma televisivo all’altro, contando sul
favore dei media di regime che fanno a gara per riportarli in vetta. Nessuna
traccia della figura meschina riportata, nei confronti del resto d’Italia per
averci trascinati in un incubo senza fine. Ma nessuna traccia, ahimè, neanche
del prof Ascierto (scopritore dell’efficacia del Tocilizumab sugli effetti
nefasti del coronavirus) oscurato dai media al punto che la scoperta sembra
quasi non essere ancora avvenuta. Ma Il Tg2 e il tgLeonardo si spingono anche
oltre e a distanza di oltre un mese dalla scoperta di Ascierto (la cui terapia è
nota e applicata in tutto il mondo) presentano servizi dall'ospedale di Padova e
di Brescia come "primi" ad aver sperimentato il Tocilizumab, senza menzionare
affatto il prof napoletano quale autore della scoperta. Insomma, sembra proprio
che i dirigenti sanitari del nord vaghino in un’altra galassia e con loro tutta
la classe dirigente politico-amministrativa della Lombardia che, presi da
delirio di “superiorità” non si preoccupano affatto di azionare il cervello e,
sperando di farla franca come sempre, sparano cavolate ad libitum: “La Lombardia
ha salvato il Sud dal contagio coronavirus”, dice Gallera che deve aver rimosso
come hanno gestito l'emergenza e come lo abbiano fatto al Sud. Insomma, un
lavoro immane per ripristinare l’immagine di un nord efficiente e ricco, a cui
non si sottrae neanche Conte che, come il padre di un rampollo a cui tutto si
perdona e tutto si elargisce, promette di prendersi cura in special modo proprio
di quel suo figlio preferito che definisce com“ nord, motore propulsivo". Non
intravvede alcuna stonatura nel riconoscere al nord il ruolo di comando, ed è
pronto a riconfermarlo. Eppure l'unica area su cui sarebbe logico investire per
ripartire è il Sud con contagi vicini allo zero. Sembrano le scene di un film
già visto: quelle della fine della II guerra mondiale. Era il 1947 quando
l'America annunciò l'avvio del Piano Marshall per la ricostruzione post bellica
dell'Europa. Il piano prevedeva l'impiego dei fondi ERP (european recovery
program) nelle aree maggiormente devastate e, per l'Italia, il Sud era l'area
maggiormente danneggiata pur uscendo due anni prima del nord dall'evento
bellica. Ma Il Capo del Governo, il trentino Alcide De Gasperi, non intese
ragioni e mise in piedi un piano ben congegnato: dirottamento dei fondi in
favore degli imprenditori del nord, dando la possibilità all’industria di
quell’area di rimettersi in piedi, e reclutamento di manovalanza a basso costo
dal Sud che, data la profonda miseria in cui versava in seguito alla
devastazione bellica del suo territorio, non era difficile da reperire. Molti
provarono a ribellarsi a questa politica scellerata e predatrice, che vedeva
assegnare quasi l'87% di quei fondi al nord e il restante al sud, tra questi Don
Luigi Sturzo che su "Il Popolo" del 25 luglio 1948 si scagliò contro gli
industriali del nord definendoli "erpivori" (consumatori parassiti di fondi
Erp). Don Sturzo, in qualità di presidente del "Comitato permanente per il
Mezzogiorno", si battè affinché gli aiuti del Piano Marshall venissero destinati
in massima parte al Mezzogiorno. In questo fu appoggiato anche dal ministro
dell’agricoltura Segni, il quale in una lettera a Don Sturzo del 22 luglio 1948
esprimeva tutto il suo rammarico: "a poco a poco, industria e nord stanno
tentando di accaparrarsi tutto. Io negozio, sino alle estreme conseguenze ma la
lotta è impari, solo, coll’ottimo Ronchi: contro quasi tutti gli altri” (als
1947-59, cart. 52 fasc. 1948 Piano Marshall ERP). Al Sud arrivò il 13% di quei
fondi ( briciole) che non riuscirono a risollevare le sorti del Sud. Il Pil del
nord fece un balzo in avanti registrando un +22%, (Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna) al Sud diminuì al 10% . Don Sturzo dovette difendere con i denti anche
le briciole, contro la crescente avidità degli industriali settentrionali. Con
grande "magnanimità" nel 1950 il governatore Donato Menichella, dato
l'esaurimento dei fondi ERP, mandò avanti una contrattazione, per protrarre la
scadenza degli aiuti del Piano Marshall e con il governatore della Banca
Mondiale Eugene Black , venne istituita "La Cassa per il Mezzogiorno" (soldi che
servivano a sopperire in parte alla sottrazione dei fondi erp del Piano Marshall
al Sud). L’annuncio di un aiuto per il mezzogiorno fu fatto a suon di grancassa
( “quanto è buono lei”, di fantozziana memoria), mentre in devoto silenzio se
n’erano andati al nord i fondi erp. La prepotenza del nord fece sì che i fondi
erp risultassero un risarcimento loro dovuto, mentre la "Cassa per il
Mezzogiorno" un'elemosina di cui essere grati. Il parassitismo erpivoro infesta
ancora il nord, che negli anni ha mutato denominazione pur conservando la
modalità trasmessa dai loro avi: succhiare linfa vitale al Mezzogiorno, Il fato
ci ha riproposto uno scenario simile a quello del 1948 di cui potremo cambiare
il finale. Diversamente Il Sud sarà costretto a una morte definitiva e neanche
indolore, data dalla scarnificazione delle ossa della nostra gente".
IL MINISTRO DEL MEZZOGIORNO E IL SOTTOSEGRETARIO ALLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: IL SOLDI DEL SUD NON SI TOCCANO. C’è da dire che, nel
pieno del casino suscitato dalla divulgazione della proposta giunta sul tavolo
di governo, ci sono due esponenti di peso del governo che sono venuti allo
scoperto: il ministro al Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano, e il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica, Mario
Turco. Provenzano, a cui ho chiesto cosa dobbiamo aspettarci, ha risposto:
«Quelle proposte non sono le mie. Non sono state nemmeno discusse nel governo.
Ma la clausola della sospensione del 34 per cento non passa, non può passare; io
la sto già applicando. Quando ai fondi FSC, sviluppo e coesione, ho già detto
pubblicamente che sono già stati programmati e non è previsto il loro
trasferimento». Ricordo che questo, il ministro lo scrisse già replicando al
Sole24ore. Ma… se il governo dovesse decidere diversamente? «Prima di essere
chiamato a fare il ministro, ero vice direttore dello Svimez, e il mio compito
fu documentare la fine che facevano i fondi destinati al Sud, invece di essere
investiti a Sud. Ora quei fondi dipendono dal mio ministero. E non intendo
sprecare questa occasione di rilancio a partire da Sud». E il sottosegretario
Turco, ha diffuso una nota in cui si legge: “Anche se l’Italia è alle prese con
l’emergenza coronavirus, non subiranno alcuna modifica le norme per il
Mezzogiorno”. Spiega che il documento “L’Italia e la risposta al covid-19” è
solo “una bozza di lavoro propedeutico ad uno studio del Dipartimento per la
programmazione ed il coordinamento della politica economica”, non ancora
sottoposta “perché incompleta, al vaglio dell’autorità politica”. Sulla
determinazione del ministro Provenzano e del sottosegretario Turco, non ci
sarebbero dubbi, a giudicare dalle loro parole (che, se non risultassero
coerenti con le azioni, si ritorcerebbero contro). Ma il documento è stato
prodotto e qualcuno lo ha fatto arrivare alla stampa, spiazzando non solo il
ministro Provenzano e il sottosegretario Turco (in quota uno al Pd, l’altro ai
cinquestelle), ma forse lo stesso Conte. Un capitolo di quel documento più
esplicito non potrebbe essere: “Proposta di sospensione della clausola del 34%”;
e altrettanto per i fondi FSC. Qualcuno lo ha scritto e prima che il governo ne
discutesse, divulgato (meglio così, a questo punto, qualunque sia stata
l’intenzione, se far passare la cosa per già fatta o per stroncarla). Provenzano
dice: non passa, e nella nota del sottosegretario Turco, lo di dice due colte:
“le soluzioni alla crisi economica connesse con il coronavirus non vanno
ricercate modificando le norme a tutela del Mezzogiorno”, e quindi “è
impensabile sospendere la clausola che destina il 34% delle risorse dei Fondi
Ordinari per la spesa in conto capitale al Sud. Così come il criterio di
ripartizione dei fondi Fsc”: tutte misure “per garantire una maggiore equità
territoriale” (parole sante…, le ultime due, per fatto quasi personale).
SE ANCOR UNA VOLTA LA FURIA PREDATORIA DEL NORD DOVESSE
PREVALERE, L’ITALIA SI SPEZZEREBBE. Lo scontro si preannuncia duro, quindi.
Abbiamo tutti il dovere di operare e sperare che ci si possa salvare insieme,
perché in una gara planetaria, meglio essere più grandi che più piccoli; ma se
più grandi e divisi, in un conflitto irrisolvibile, allora, meglio piccoli coesi
e forti, senza dover a che fare con il peggior nemico in casa. Le grandi
tragedie sono occasione di verità e di scelte definitive; sono i momenti in cui
si decide se continuare nel modo che ha portato al disastro o cambiare
totalmente indirizzo. L’Italia è migliore di come ce l’hanno descritta e ce la
descrivono: un Nord onesto, efficiente e generoso con il Sud disonesto, incapace
e sprecone. Questo racconto, su cui è stata costruita una economia, non regge
più; e quella economia non è più possibile, appartiene al tempo delle colonie;
il Sud s’è scetato: o un Paese che sia lo stesso per tutti nei diritti, o non ci
sarà più (la finzione di) un Paese, ma due.
PER LA LOMBARDIA, RAZZISTA E’ IL SUD (E LORO CI DAREBBERO 100
MILIARDI L’ANNO). Lino Patruno del direttivo nazionale
M24A-ET. Proprio non la vogliono capire. Neanche un docente universitario e
filosofo come Carlo Lottieri, bresciano. Il quale sul <Giornale> di Milano si
lancia in una difesa della Lombardia a suo parere, e non solo suo al Nord,
oggetto di razzismo da parte del resto d’Italia per i problemi della sua sanità
(così magari capiscono cosa è il razzismo che riservano da sempre al Sud). Poi
però si avventura in tesi sulle quali lui e gli altri farebbero bene a non
insistere: il cosiddetto <residuo fiscale>. Sostiene con coraggio pari alla
avventatezza che il Nord passa al Sud ogni anno 100 miliardi (e la Lombardia in
particolare 54 miliardi). Anche a quella Campania la quale chiude le frontiere
ai lombardi ma poi passa all’incasso. E’ la stessa faccia ineffabile con la
quale Fontana e Zaia meditavano l’autonomia rafforzata. Facendo un autogol
clamoroso. Perché allora si è scoperto (con le cifre ufficiali dei Conti
pubblici territoriali) che:
- non c’è alcun residuo fiscale del Nord verso il Sud
- ogni anno lo Stato spende per ogni cittadino meridionale circa
4 mila euro in meno rispetto a un cittadino settentrionale
- dal 2009 sono stati sottratti al Sud 61 miliardi all’anno
- con un diverso conteggio questi miliardi dal 2000 al 2017 sono
stati 840 (Eurispes)
- i posti fissi che secondo Ottieri i campani e i meridionali
vorrebbero con i soldi del Nord, sono più numerosi al Nord che al Sud (dati
Istat).
Consiglio finale ad Ottieri: studi di più.
Sorpresa:
il Nord si prende la gran parte dei soldi pubblici.
Il Dubbio il 30 gennaio 2020. Dal 2000 al 2007 le otto regioni meridionali
occupano i posti più bassi della classifica per distribuzione della spesa
pubblica. 15.062 euro pro capite al Centro-Nord e 12.040 euro pro capite al
Meridione. In altre parole, ciascun cittadino meridionale ha ricevuto in media
3.022 euro in meno rispetto a un suo connazionale residente al Centro-Nord.
Questi i primi dati della 32esima edizione del Rapporto Italia 2020 di Eurispes
in merito al Mezzogiorno. L’Istituto di ricerca degli italiani nel 2017 rileva
un’ulteriore diminuzione della spesa pubblica al Mezzogiorno, che arriva a
11.939 (-0,8%), mentre al Centro-Nord si riscontra un aumento dell’1,6% (da
15.062 a 15.297 euro). Emerge una realtà dei fatti ben diversa rispetto a quanto
diffuso nell’immaginario collettivo che vorrebbe un Sud «inondato» di una
quantità immane di risorse finanziarie pubbliche, sottratte per contro al
Centro-Nord. Dal 2000 al 2007 le otto regioni meridionali occupano i posti più
bassi della classifica per distribuzione della spesa pubblica. Per contro, tutte
le Regioni del Nord Italia si vedono irrorate dallo Stato di un quantitativo di
spesa annua nettamente superiore alla media nazionale. Se della spesa pubblica
totale, si considera la fetta che ogni anno il Sud avrebbe dovuto ricevere in
percentuale alla sua popolazione, emerge che, complessivamente, dal 2000 al
2017, la somma corrispondente sottrattagli ammonta a più di 840 miliardi di euro
netti (in media, circa 46,7 miliardi di euro l’anno).
Il piano
per il Sud presentato con la foto di Trieste: e tu? Quanto conosci l'Italia?
Pubblicato domenica, 16 febbraio 2020 da Corriere.it. La copertina del progetto
con il titolo «Un piano per il Sud è un progetto per l’italia», l’hashtag
«#Sud2030» e la foto di Duino, il Comune in Friuli-Venezia Giulia, con una
splendida vista sul Golfo di Trieste e le sue falesie. Non proprio un panorama
meridionale, insomma. È stata questa la svista che ha attirato critiche e ironie
contro il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano (Pd) e la ministra
all’Istruzione Lucia Azzolina (M5S). Diventando un caso politico, ma anche una
facile battuta da salotto. E allora, vale la pena mettersi alla prova. Quanto
conosciamo noi i luoghi simbolici dell'Italia? Proviamo a scoprirlo attraverso
questo quiz.
Il governo
presenta il Piano per il Sud ma in copertina c'è il Golfo di Trieste.
Pubblicato venerdì, 14 febbraio 2020 da Corriere.it. Un piano per il Mezzogiorno
da 123 miliardi di euro. Lo hanno presentato venerdì a Gioia Tauro il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano (Pd) e
la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina (M5S). Ma a diventare oggetto di
discussione — e dell’ironia via Twitter — non sono state le misure previste per
i giovani, la svolta ecologica, l’innovazione, il potenziamento dell'edilizia
scolastica o l'estensione della No Tax area bensì la copertina del progetto con
il titolo «Un piano per il Sud è un progetto per l’italia», l’hashtag «#Sud2030»
e la foto di Duino, il Comune in Friuli-Venezia Giulia, con una splendida vista
sul Golfo di Trieste e le sue falesie. Non proprio un panorama meridionale,
insomma. La segnalazione arriva via Twitter dal giornalista Ferdinando
Giugliano, raccoglie centinaia di «Mi piace», retweet e commenti sarcastici: «Il
Sud dell'Impero Austro-ungarico!», «Lo ha fatto per vedere se stiamo attenti»,
«A sud di Oslo». E anche una replica del ministro Provenzano — «È un progetto
per l'Italia, appunto. Sul serio» — che però non riesce a spegnere gli sfottò.
Tolti al
Sud e dati al Nord 840 miliardi di euro in 17 anni.
Chi riteneva e ritiene che parlare di rapina al Sud è una bufala, è servito.
Cosa ti accerta il rapporto 2020 del noto Centro studi? Che dal 2000 al 2017 lo
Stato italiano ha sottratto appunto al Sud 840 miliardi di euro. Lino Patruno il
07 Febbraio 2020 su La Gazzetta del Mezzogiorno. E ora anche l’Eurispes. Chi
riteneva e ritiene che parlare di rapina al Sud è una bufala, è servito. Cosa ti
accerta il rapporto 2020 del noto Centro studi? Che dal 2000 al 2017 lo Stato
italiano ha sottratto appunto al Sud 840 miliardi di euro, in media 46,7
miliardi all’anno. Non solo sottratti, ma dati al Nord. Effetto del mancato
rispetto del famoso 34 per cento, la percentuale della popolazione meridionale
che avrebbe dovuto essere anche la percentuale della spesa al Sud. Ecco perché
il divario aumenta invece di diminuire. Ecco perché i giovani del Sud sono
costretti a partire per la mancanza di lavoro. Uno scandalo nazionale ancòra più
grande quanto più assoluto è stato il silenzio per tutto questo tempo. Con
l’aggiunta delle tre regioni del Nord che chiedono autonomia perché stanche,
dicono, di dare soldi al Sud. Non ha usato mezzi termini Gian Maria Fava, il
sociologo presidente dell’Eurispes. Ha detto che sulla Questione meridionale
dall’Unità a oggi si sono consumate le più <spudorate> menzogne. Col Sud di
volta in volta descritto come la sanguisuga del resto d’Italia. Come luogo di
concentrazione del malaffare. Come ricovero di nullafacenti. Come zavorra che
frena la crescita economica e civile del Paese. Come dissipatore della ricchezza
nazionale. Ma un Sud che attende ancòra una parola di onestà da parte di chi ha
alimentato questo racconto. Mentre la situazione è letteralmente capovolta
rispetto a quanto finora comunemente creduto e spacciato. E rivelata dai dati
delle più autorevoli agenzie nazionale e internazionali. Ma anche questa volta
si è tentato di far scivolare tutto nel silenzio. Scarsi accenni sulla stampa
nazionale, impegnata col Festival di Sanremo. Ancòra più scarse reazioni dal
mondo politico, impegnato a litigare. Eppure l’Eurispes ha più o meno confermato
ciò che pure la Svimez aveva solo qualche mese fa denunciato. E in base agli
stessi dati governativi dei Conti pubblici territoriali, non a piagnonismo
meridionale. E cioè i 61 miliardi all’anno sottratti al Sud dal 2009, da quando
si sarebbe dovuto riequilibrare la spesa pubblica <storica> che favorisce il
Nord. Quanto lo stesso ex ministro nord-leghista Calderoli aveva ammesso
invitando a cambiare. Non se ne è fatto nulla, tranne l’iniziale impegno del
ministro Boccia a provvedere quando si è riparlato dell’autonomia a Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna. E tranne un impegno verbale del presidente Conte. Ma
intanto la spesa storica ai danni del Sud continua. E ai danni del Sud continua
a essere usata la consueta arma di distrazione di massa. Di chi la colpa del suo
incompleto sviluppo? Delle incapaci classi dirigenti meridionali. Della mancanza
di mentalità imprenditoriale. Della società civile che non c’è. Delle mafie che
al Sud farebbe piacere avere. Descrizione con la complicità di anime belle
meridionali, tanto capaci di brillante autocritica (ma quale?) quanto incapaci
di uscire dal loro colonialismo mentale. O forse interessate a non muovere nulla
per sfruttare piccoli miseri vantaggi personali. Così storici, giornalisti,
saggisti, benpensanti. Che molti dei mali attribuiti al Sud ci siano, è sicuro.
Ma sono la causa del suo sottosviluppo o un effetto di questo sottosviluppo?
Scrive in questi giorni un lettore (settentrionale) a un giornale nazionale: non
ci sono dubbi che fare politica al Sud è più difficile con una disoccupazione da
quarto mondo. Non ci sono dubbi che la pressione per avere di che vivere è il
peso con cui ogni amministratore del Sud deve confrontarsi. Non ci sono dubbi
che i bisogni non soddisfatti delle persone sono alla base di ogni problema. Non
ci sono dubbi che senza servizi e infrastrutture adeguati non c’è possibilità di
miglioramento né di allentamento delle tensioni sociali. Ma come si risponde a
tutto questo? Si risponde che il Sud deve rimboccarsi le maniche e riconoscere
le proprie colpe. La colpa è vostra. E troppo Sud ignaro o rassegnato o complice
risponde che, sì, la colpa è solo nostra.
Inutile dire
cosa si poteva fare con 46,7 miliardi l’anno. Quante strade, quanti treni,
quante scuole, quante università, quanti ospedali, quanti asili nido, quanti
anziani curati, quanti figli. Quanto lavoro per i giovani che non emigrino più.
Tutto quanto non c’è mentre si parla di sprechi <del> Sud quando c’è soprattutto
spreco <di> Sud come unica possibilità di crescita dell’intero Paese (che
infatti non cresce). E condizioni di partenza diseguali che restano il comodo
alibi di chi si adegua invece di reagire. Non si trova altrove un tale clima di
colossale ribaltamento della verità e un tale clima di colossale sfruttamento di
una parte del Paese a danno dell’altra. Non si trovano altrove una ingiustizia e
una menzogna così lunghe e impunite. Lino Patruno
IL
MEZZOGIORNO AL DI LÀ DELLE FAKE NEWS NEL RAPPORTO EURISPES 2020.
Michele Eugenio Di Carlo il 4 febbraio 2020 su movimento24agosto.it. Gli studi,
le ricerche, gli articoli dei meridionalisti trovano pieno conforto nella
recentissimo Rapporto Italia 2020 dell’Eurispes, l’Istituto di Studi Politici,
Economici e Sociali degli italiani. Non ha usato mezzi termini il presidente
dell’ Eurispes Gian Maria Fara, prendendo il via nella sua analisi proprio dal
processo unitario italiano: «Sulla questione meridionale, dall’Unità d’Italia ad
oggi, si sono consumate le più spudorate menzogne. Il Sud, di volta in volta
descritto come la sanguisuga del resto d’Italia, come luogo di concentrazione
del malaffare, come ricovero di nullafacenti, come gancio che frena la crescita
economica e civile del Paese, come elemento di dissipazione della ricchezza
nazionale, attende ancora giustizia e una autocritica collettiva da parte di chi
– pezzi interi di classe dirigente anche meridionale e sistema dell’informazione
– ha alimentato questa deriva». L’accusa alla classe dirigente italiana e al
sistema d’informazione è precisa e dello stesso tenore di quella che i
meridionalisti muovono da decenni inascoltati e, spesso, oscurati proprio dai
media. Non è un caso che riguardo all’informazione, tra mille difficoltà, si è
cercato di diffondere ad esempio le conclusioni avanzate nel testo “La parte
cattiva dell’Italia. Sud, media e immaginario collettivo” da Stefano
Cristante e Valeria Cremonesini, docenti di sociologia dei processi comunicativi
e culturali; conclusioni che lasciano sconcertati: negli ultimi 35 anni i media
nazionali hanno messo in rilievo quasi solo i mali del Mezzogiorno creando negli
stessi meridionali un immaginario percepito falsato. Raccapricciante la
constatazione che, come aggiunge Fara, le più autorevoli agenzie nazionali ed
internazionali certificano che riguardo al Mezzogiorno «siamo di fronte ad una
situazione letteralmente capovolta rispetto a quanto creduto». Ed ecco i dati
nero su bianco del Rapporto Italia 2020, che non si differenziano da quelli
spesso divulgati nel passato ma ignobilmente contestati e ignorati:
1 – Lo stato
italiano nel 2016 ha speso per ogni cittadino del Centro-Nord 15.062 euro,
mentre per ogni cittadino del Sud la spesa è stata di 12.040 euro, una
differenza di ben 3022 euro pro-capite;
2 – Nel 2017
l’Eurispes rileva per il Centro-Nord una spesa pro-capite aumentata a 15.297
euro, per il Sud una spesa pro-capite diminuita a 11.939 euro per una differenza
che aumenta a 3358 euro e che moltiplicata per il numero di abitanti del
Mezzogiorno ammonta a oltre 60 miliardi annui.
Dov’è quel Sud
dalle mille risorse finanziarie sprecate raccontato nei salotti televisivi di
quei talk show nazionali dove giacciono onnipresenti i soliti conduttori e
opinionisti? E dov’è quel Sud a cui verrebbe distribuita gran parte della spesa
pubblica, se al contrario i dati confermano che sono le regioni del Nord ad
essere beneficiate da una spesa annua nettamente superiore? Il Rapporto Italia
2020 attesta incontrovertibilmente che, in relazione alla percentuale di
popolazione residente, al Sud dal 2000 al 2017 è stata sottratta una somma pari
a 840 miliardi. Un dato impressionante di cui politica e media non hanno mai
tenuto conto negli ultimi decenni, tanto da averci costretto a coniare
l’acronimo PUN per indicare l’insieme dei partiti nazionali indifferenti alla
crescita economica, sociale e culturale del Sud. Eppure il PIL (prodotto interno
lordo) del Nord si basa essenzialmente sulla vendita di beni e servizi al Sud,
mentre lo scambio import-export tra le due aree del paese è interamente a
vantaggio del Nord, tanto che riesce difficile comprendere come un’intera classe
politica, sostenuta dai media, abbia potuto nell’ultimo trentennio pensare che
lasciare il Sud senza infrastrutture e servizi potesse avvicinare il Nord
all’area ricca dell’Europa. E’ del tutto evidente che abbassare il tenore di
vita dei meridionali ne ha limitato il potere d’acquisto e di conseguenza il PIL
delle regioni più avanzate economicamente d’Italia. Infatti, sempre dal Rapporto
Italia 2020, si rileva che per 45 miliardi annui di trasferimenti da Nord a Sud
ben 70,5 miliardi si trasferiscono in direzione contraria. Dati a noi ben noti
visto che Pino Aprile nel suo recente “L’Italia è finita”, citando gli
economisti Paolo Savona, Riccardo De Bonis della Banca d’Italia e Zeno
Rotondi autore di “Sviluppo, rischio e conti con l’estero delle regioni
italiane”, ha indicato lo stesso saldo attivo per il Nord. Chiaro il monito del
Presidente dell’Eurispes: «… ogni ulteriore impoverimento del Sud si ripercuote
sull’economia del Nord, il quale vendendo di meno al Sud, guadagna di meno, fa
arretrare la propria produzione, danneggiando e mandando in crisi così la sua
stessa economia». Tuttavia, nonostante l’analisi socio-economica dell’Eurispes,
l’altro giorno il Governatore del Veneto Luca Zaia, in un’audizione alla
Commissione Parlamentare per le questioni regionali, ha continuato a sostenere
il suo progetto di Regionalismo differenziato continuando a riferire di sprechi
e di cattiva amministrazione al Sud, mentre anche il neo rieletto Presidente
dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sembra spingere nella stessa direzione.
Una direzione che nel corso degli ultimi dieci anni ha visto aumentare le
disuguaglianze sociali ed economiche tra aree geografiche diverse e che lo
Stato, tenuto per Costituzione a rimuoverle, ha aggravato sostenendo una
ripartizione territoriale per i servizi pubblici in base al principio iniquo
della “spesa storica”. Disuguaglianze che, proprio attraverso il Regionalismo
Differenziato, i Governatori delle regioni del Nord e i partiti nazionali del
PUN (Lega, PD, FI, FDI) vorrebbero conservare stabilmente. Sta maturando il
tempo in cui questi partiti nazionali, per lo più portatori di propaganda
spicciola, pagheranno il prezzo di scelte politiche che hanno imposto condizioni
di vita e di lavoro drammatiche ai cittadini del Sud, due milioni dei quali sono
dovuti dolorosamente emigrare negli ultimi decenni.
Le grandi aziende che lavorano nel Sud Italia hanno la sede
legale al Nord e lì pagano le tasse.
Le grandi aziende del Nord Italia hanno la sede legale nei
paradisi fiscali e lì pagano le tasse.
Gianluca Zapponini per formiche.net il 6 aprile 2020. Un brand
italiano che sposta la sede legale (ma la produzione resta ben piantata qui) in
un Paese dove si pagano meno tasse, magari in Olanda. Film già visto. Fca, su
tutti, ma anche Mediaset, Cementir, Luxottica e Ferrero, quest’ultima però in
Lussemburgo. Ora tocca a Campari e l’Italia paga il conto di certa indifferenza
tutta politica. Gli azionisti dello storico marchio italiano nato nel 1860 (in
primis la famiglia Garavoglia, tramite la cassaforte Lagfin che detiene il 51%
del capitale) e che oggi fattura 1,8 miliardi e fa base a Sesto san Giovanni,
alla fine di marzo hanno dato il via libera definitivo allo spostamento della
sede legale nei Paesi Bassi, mentre quella fiscale rimarrà in Italia. Libero
mercato, si dirà. Forse, ma a rimetterci però è quasi sempre l’Italia e il suo
Pil. Perché spostare la sede legale vuol dire versare tasse in un nuovo Paese. E
con la holding di solito si muove anche un certo indotto: consulenza, audit,
avvocati… con il risultato che il nostro Paese perde entrate non certo
trascurabili, nonostante i ricavi vengano generati sempre qui, negli
stabilimenti italiani. Lo ha sottolineato anche il premier Giuseppe Conte, in
una recente intervista, nel quale oltre a criticare l’atteggiamento di certi
Paesi (Olanda, proprio lei, in testa) verso l’uso degli eurobond, attaccava
proprio la natura di paradiso fiscale del Paese dei tulipani. “L’Olanda è anche
tra i Paesi che si avvantaggiano molto del contributo delle imprese italiane.
Perché molte grandi imprese che pure hanno i principali stabilimenti in Italia e
ricavano i maggiori profitti nel nostro Paese poi beneficiano della legislazione
fiscale olandese, molto più conveniente”, ha detto Conte. E non è stato da meno
l’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che in una recente intervista a
Formiche.net, ha definito l’Olanda un Paese che importa holding. Ma cosa può
fare il governo italiano dinnanzi a tutto questo? Perché se è vero che da una
parte il nostro esecutivo si sta prodigando giustamente, attraverso il Golden
power, per impedire che le imprese che decidono di rimanere vengano acquisite,
non si può dire avvenga lo stesso per impedire che le stesse aziende se ne
vadano all’estero con le loro gambe. Un filtro in entrata, insomma, ma non in
uscita. Un esperto qualificato spiega a Formiche.net cosa c’è dietro la scelta
di certe aziende. Tutto ruota intorno ai diversi trattati stipulati dall’Italia
in passato al fine di evitare a un’azienda di dover pagare le tasse in due Paesi
differenti ma che hanno stipulato l’accordo. Quello con l’Olanda è datato 1990.
“Lo spostamento delle sedi legali in Olanda e Lussemburgo è qualcosa che accade
da molto tempo. La scusa, in parte vera, sono spesso le norme locali per gestire
meglio le società. Ma per l’Italia c’è un danno: questi spostamenti, cambi di
sede non sono indolore”, spiega. “Il punto è che se è vero che il Fisco è
attento in queste situazioni, e spesso fa accertamenti, non dimentichiamoci di
quelli fatti su Fca stessa, in questo momento in cui l’Olanda sembra fare la
furba sugli eurobond, deve esserlo ancora di più. Perché è vero che se io
delocalizzo porto fuori solo la holding. Ma è anche vero che questo vuol dire
non pagare più le tasse in Italia. È un aspetto di cui tener conto. Ricordiamoci
che l’Olanda può beneficiare di tutto ciò perché siamo in un mercato
comunitario, altrimenti lo Stato Italiano non consentirebbe a un’azienda di
spostarsi così. Occorre verificare, controllare, stare insomma ancora più
attenti ai movimenti di chi decide di mettere la sede legale in altri Paesi”,
spiega ancora l’esperto. E pensare che l’Italia “potrebbe anche denunciare quel
trattato. Si può”. In ogni caso vale la pena chiedersi il perché di tale inerzia
politica nel tentare di arginare simili operazioni in uscita, che certo non bene
fanno al nostro Pil.
Grandi evasori e politici corrotti: ecco la lista veneta.
Dalle tangenti del Mose ai conti esteri: scoperte oltre 200 offshore con più di
250 milioni nascosti dal fisco da imprenditori del nordest Paolo Biondani e Leo
Sisti il 26 aprile 2019 su L'Espresso. Si chiama “lista De Boccard”. Dal
computer del professionista svizzero Bruno De Boccard, sequestrato dai
magistrati della Procura di Venezia, è emerso un elenco di dozzine di
imprenditori, soprattutto veneti, protagonisti di una colossale evasione
fiscale, celata all’ombra del super condono targato Berlusconi del 2009-2010. Un
fiume di denaro di “oltre 250 milioni di euro”, finora mai completamente
ricostruito, dove si mescolano le tangenti ai politici e i fondi neri degli
stessi clienti. Soldi nascosti in scatole di scarpe. Pacchi di banconote
consegnati ad anonimi autisti autostradali, in grandi alberghi o studi di
commercialisti. Lo rivela L’Espresso in edicola domenica 28 aprile e in
anteprima online su Espresso+ . L’indagine della Guardia di Finanza, nata sulla
scia dello scandalo del Mose di Venezia, ha già portato al sequestro di oltre 12
milioni di euro. E ha fatto scoprire un traffico di tangenti per 1,5 milioni
nascoste prima in Svizzera e poi in Croazia da una prestanome di Giancarlo
Galan, ex governatore veneto e ministro di Forza Italia, già condannato per le
maxicorruzioni del Mose. Questa nuova indagine ha fatto emergere anche una serie
di documenti informatici con i dati di centinaia di società offshore utilizzate
da politici e imprenditori per nascondere nei paradisi fiscali più di 250
milioni di euro. Molti casi di evasione sono stati però cancellati dalla
prescrizione o dallo scudo fiscale. Secondo L’Espresso, il “re delle valigie”
Giovanni Roncato ha ammesso di aver rimpatriato, grazie proprio allo scudo, 13,5
milioni di euro, detenuti all’estero e accumulati in passato “in seguito a
minacce rivoltemi da un’organizzazione malavitosa…la Mala del Brenta…nel periodo
in cui la banda di Felice Maniero operava molti sequestri di persona”. Ed ecco
partire il carosello del denaro, affidato a “malavitosi ignoti, in due
occasioni, circa 200 milioni di lire alla volta, in contanti, al casello di
Padova Ovest”. Si chiama Alba Asset Inc, la offshore spuntata nei file di De
Boccard, creati insieme al suo boss, il nobile italo-elvetico Filippo San
Germano d’Aglié, nipote della regina del Belgio. Un altro nome eccellente che
compare nell’inchiesta ribattezzata Padova Papers, germinazione dei più famosi
Panama Papers, è quello di René Caovilla, titolare di un famoso marchio di
scarpe, e boutique in tutto il mondo. Anche lui, al quale faceva capo la
offshore Serena Investors, riporta L’Espresso, si è avvalso dello scudo fiscale,
facendo rientrare in Italia 2,2 milioni di euro, “somme non regolarizzate
affidate a professionisti operanti con l’estero al fine di depositarle in
Svizzera”. Anche tre commercialisti di uno affermato studio di Padova, giù
emersi nelle vicende del Mose, entrano qui in scena come presunti organizzatori
del riciclaggio di denaro nero: Paolo Venuti, Guido e Christian Penso. Tutti
collegati al duo San Germano-De Boccard, punti di riferimento di proprietari di
hotel, fabbriche di scarpe, imprese di costruzioni e, ancora, big delle
calzature. Come Damiano Pipinato, che attiva lo spostamento dei soldi attraverso
proprio Guido Penso: “Lui mi telefonava e, in codice, mi chiedeva se avessi due
o tre campioni di scarpe. Io sapevo che mi stava chiedendo 100, 200 o 300 mila
euro da portare fuori…Io predisponevo il contante all’interno di una scatola di
cartone, in un sacchetto, e lo portavo in macchina nel suo studio a Padova”. Il
dottor Penso non contava il denaro, si fidava, si accontentava della cifra
indicata da Pipinato e “rilasciava un post-it manoscritto, con data e importo.
Dopo qualche giorno mi esibiva l’estratto di un conto corrente con la cifra da
me versata. A quel punto il post-it veniva stracciato”. Pipinato ha confessato
di aver esportato all’estero 33 milioni di euro: 25 in Svizzera, 8 a Dubai.
In Veneto si fa, ma non si dice. Lo rivela “Il Corriere della
Sera”. Scoperti dalla Guardia di finanza in Veneto oltre 2.300 falsi poveri che
usufruivano dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Il controllo è
stato svolto, per ora, in cinque Ussl sulle 22 esistenti nella regione, con un
bacino d'utenza di circa 1.200.000 assistiti residenti in 183 comuni delle
province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso e Vicenza. I finanzieri
proseguiranno gli accertamenti per verificare altre 8 mila posizioni di persone
fisiche dichiaratesi «disoccupate». Il report di analisi, condotto su 30 mila
prestazioni in esenzione per «disoccupazione e reddito» nel biennio 2009-2010,
ha evidenziato appunto 2.300 prestazioni elargite nei confronti di cittadini con
redditi superiori alla soglia prevista per godere del beneficio e 10 mila
prestazioni rese nei confronti di assistiti rivelatisi non disoccupati, nei
confronti dei quali le fiamme gialle compiranno ulteriori accertamenti per
escludere ulteriori condotte fraudolente.
Ma di non solo truffe si ciba il ricco nord-est. Vi è anche
l’evasione fiscale. In Veneto sparisce il 22,4% del reddito. E lo racconta “La
Repubblica”. Un Paese unito nel nome dell'evasione fiscale: nascondere una parte
o la totalità del reddito agli occhi dello Stato è un' attività diffusa su tutto
il territorio italiano. Ma gli evasori non sono tutti uguali: c' è chi si
accontenta di truffare il fisco solo in parte, e chi mette via ogni remora pur
di accumulare entrate senza versare le tasse. Al Nord come al Sud, anzi al Nord
un po' di più. Contrariamente a quanto si pensa per via della maggiore
diffusione dell'economia sommersa, il picco dell'evasione si raggiunge nel
Settentrione. La regione che sottrae più ricchezza ai fini dell'Irpef è il
Veneto, che nasconde in media il 22,4 per cento dei suoi redditi, la più
virtuosa è la Sardegna dove l'evasione si contiene al 13,7%. Fra i due estremi,
c'è il ritratto di un Paese che si attrezza in mille modi per ingannare il fisco
quando il contribuente non versa la ritenuta alla fonte: dalle prestazioni
professionali in nero agli scontrini mai emessi. A differenziare il fenomeno in
base al territorio ci ha pensato lo Svimez, l'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno, in uno studio che calcola le percentuali del
reddito dichiarato rispetto a quello disponibile nel 2008 (al netto delle
prestazioni sociali e delle quote esenti, più diffuse al Sud). Il Paese in
complesso ne esce male anche se, contrariamente ai luoghi comuni, la quota di
reddito nascosto è più alta al Centro-Nord, con il 19,3 per cento, che al Sud
(il 18). Al Veneto (22,4), nella classifica dei meno virtuosi, seguono le Marche
(22 per cento di ricchezza evasa). Ma a parte un intermezzo fra il terzo e
quarto posto - Basilicata (21%) e Calabria (20,6 per cento, pari merito con
l'Emilia Romagna) - è l'Italia del Centro Nord a dominare la parte alta della
graduatoria. Lombardia e Sicilia, regioni con notevoli differenze nel livello di
vita, evadono quote simili (17,6 per cento la prima, 17,2 la seconda). Quanto a
virtuosismo, alza la media settentrionale solo la Liguria (14,7 per cento di
reddito evaso). L'andamento non cambia di molto se si considerano le percentuali
di reddito dichiarato rispetto al Pil: il Mezzogiorno dichiara il 51,2 per cento
rispetto al 49,5 del Centro-Nord. E non sembra che nel breve periodo le
posizioni possano invertirsi visto che - secondo una indagine di Contribuenti.it
- nei primi mesi del 2010 l'evasione era data in aumento soprattutto in
Lombardia e in Veneto. Commenta lo Svimez: «Non cadiamo nella tentazione di
etichettare il Centro Nord come terra di evasori fiscali - si legge nello studio
-. Ma questi dati mostrano comunque che non si può attribuire questa stessa
etichetta al Mezzogiorno: la realtà è che l'Italia non ha raggiunto l'unità
economica, ma è unificata dall'evasione». Secondo i ricercatori
dell'associazione una precisazione però va fatta: «Le informazioni della Guardia
di Finanza - che non riguardano tutti i contribuenti, ma solo quelli sottoposti
a controllo fiscale - indicano che nel Mezzogiorno ci sono più evasori che
nascondono importi modesti». Al Centro Nord si verifica il caso opposto: «Al
limitato numero di evasori corrisponde una massa imponibile non dichiarata
rilevante». In sostanza, conclude lo studio Svimez «si può figurare un'evasione
per sopravvivenza al Sud ed una evasione per accumulazione di ricchezza al
Nord».
A tal riguardo Antonio Melli dice la sua Su “La Vera Cronaca”:
Il Veneto leghista campione di evasione fiscale. Se li sentite parlare con
quelle voci stridule ed inequivocabili, non pensereste mai che dietro quelle
urla folkloristiche si nasconde una realtà completamente opposta al senso
politico ingabbiato in esse. Parlano soprattutto della Padania, antica terra
laboriosa dove il senso civico bene si amalgama con l'onestà sociale. Salvo poi
a scoprire che in questo territorio si annida un'evasione fiscale che non
conosce vergogna e che fa del Veneto una regione dove la pratica dell'illegalità
fa quasi parte del Dna di molti dei suoi abitanti. Parlano i numeri. É Venezia
la culla dell’evasione in Veneto dall’alto dei suoi 384 milioni maturati nei
primi quattro mesi dell’anno. La provincia veneziana è seguita a distanza da
Vicenza, con 250 milioni, Verona con 222 e Padova con 59. Fanalino di coda
Belluno con 13. Città che risulta essere "virtuosa" anche per quanto riguarda
l’Iva, il lavoro nero e i lavoratori irregolari. Il quadro del resto del Veneto
è invece alquanto pesante: complessivamente da gennaio ad aprile l’ammontare
dell’evasione è stato di 1 miliardo e 34 milioni di euro. Pesante anche
"l’ammanco" dell’Iva: 242 milioni e mezzo di euro in quattro mesi, sempre con
Venezia in vetta alla classifica con quasi 93 milioni, seguita da Vicenza con 51
e Padova con 49. Anche in questo caso Belluno ha fatto registrare la cifra più
bassa, 1 milione e mezzo di euro. Ma non c’è solo l’ evasione. La Guardia di
finanza ha anche scoperto 975 lavoratori in "nero" o irregolari, sempre nel
periodo che va da gennaio ad aprile 2010. Quello del lavoro nero è un fenomeno
che presenta caratteri diversi e differenze numeriche macroscopiche da provincia
a provincia. La provincia con più violazioni è quella di Treviso, dove sono
stati scoperti 352 lavoratori del tutto "in nero" o irregolari; poi seguono
Verona (149), Venezia (130), Vicenza (119) e Rovigo (115). Ma c’è anche chi è
virtuoso, come Belluno dove le posizioni irregolari sono risultate essere appena
16. Sul fronte imprese e professionisti, quelli risultati completamente
sconosciuti al Fisco sono stati 288; il maggior numero è stato scoperto a
Venezia (83), Verona (57) e Vicenza (47). Detto questo, non vediamo proprio
quali basi etiche la Lega Nord ed i suoi adepti vogliono suggerirci per
adempiere alle loro richieste di federalismo fiscale, senza attendere i giusti
tempi per un'approfondita analisi dei processi che esso andrebbe ad innescare.
Forse sarebbe meglio che continuassero a preoccuparsi di combattere gli
immigrati clandestini che, seppur a costo di lacerazioni culturali senza
precedenti nella storia del nostro Paese, rappresentano per loro il terreno
ideale su cui continuare a consolidare il loro potere politico. Perchè è solo a
quello che essi mirano.
E poi per ripicca contro il Sud c’è chi diventa leghista.
Interessante, però è il pensiero di Emanuele Bellato su “Il Popolo Veneto”. Si è
scritto tanto dello scandalo che ha travolto la Lega Nord, alcune volte con
competenza ed onestà intellettuale, ma il più delle volte propinando il solito
corollario di inutilità e gossip. Comunque il quadro che emerge dalle
indiscrezioni sull’inchiesta è sicuramente squallido: si parla di un vorticoso
giro di soldi e di investimenti all’estero, di versamenti ai famigliari del
Senatùr e al cosiddetto Sindacato Padano di Rosy Mauro. Proprio per questi
motivi l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito, è indagato per riciclaggio,
appropriazione indebita e truffa aggravata ai danni dello Stato. Inoltre la
magistratura indaga sui rapporti del tesoriere Belsito e la ‘ndrangheta. Non
mancano nemmeno le intercettazioni ad inchiodare i “furbetti”, e poi le “gole
profonde”: da Nadia Dagrada, segretaria amministrativa del Carroccio ad
Alessandro Marmello, autista del giovane rampollo di casa Bossi (soprannominato
“Trota”), che hanno già “vuotato il sacco”. Le dimissioni di Bossi senior e
junior (quest’ultime tardive) più che un esempio da imitare rivelano una certa
fragilità nel sostenere una causa ed una posizione troppo scomoda. Se
l’informazione fa più o meno bene il suo dovere, lo stesso non può dirsi per i
partiti dell’arco parlamentare. PDL, PD, UDC nell’attaccare ferocemente
l’avversario in difficoltà hanno ritrovato una verginità che non gli appartiene.
Viene in mente il detto: “il bue che dice cornuto all’asino”. Nel frattempo, la
santa trinità - Alfano, Bersani, Casini - nell’indifferenza più totale, ha
approfittato per approntare una riforma elettorale fondata, come ha giustamente
criticato Vendola, “sulla salvaguardia del trasformismo e del gattopardismo” e
cosa ancor peggiore ha dato il via libera alla manomissione dell’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori, avallando di fatto il licenziamento
discriminatorio sotto mentite spoglie. Il PD si ritaglia un ruolo addirittura
grottesco nell’autoassegnarsi una vittoria inesistente. In Toscana hanno persino
stampato dei manifesti “tragicomici” con su scritto “Vince il lavoro, vince il
PD”. Il trionfalismo regna sovrano anche nelle vuote dichiarazioni del
segretario Bersani e nelle mail inviate dal gruppo dei DeputatiPD.it. Questo il
testo: “Grazie al Pd evitato colpo di mano sull'articolo 18. […] Sono state
apportate correzioni che avvicinano la regolamentazione italiana dei
licenziamenti senza giusta causa a quanto avviene in altri paesi europei.
Aspettiamo di vedere le norme che verranno presentate in Parlamento ma, da
quanto hanno detto il presidente Monti e il Ministro Fornero, è stato recepito
il modello tedesco che prevede la possibilità di reintegrazione dei lavoratori
per ogni caso di ingiusto licenziamento, anche per ragioni economiche”. A
smentire i tanti “Pinocchio” del PD è lo stesso Monti che sul reintegro dei
lavoratori licenziati senza giusta causa dichiara: “avverrà in presenza di
fattispecie molto estreme e improbabili”. E’ dura ammetterlo, ma questi tecnici
stanno riuscendo nell’impresa mancata da Berlusconi, ovvero schiavizzare i
lavoratori, privarli dei diritti fondamentali, o più semplicemente umiliarli. E
poco importa se Confindustria si lamenta, è nel gioco delle parti. Ma ritorniamo
a parlare della Lega. Adesso tutti sembrano accorgersi delle anomalie del
Carroccio. Tutti si indignano per i favoritismi al “Trota”. Finanche dentro alla
Lega i “maroniani” o “barbari sognanti” scalpitano in cerca di notorietà al
grido di “pulizia, pulizia, pulizia”. Ma dove erano questi signori fino a ieri?
Esistono decine di libri sulle malefatte della Lega. Tra i più significativi,
vale la pena di citare alcuni titoli: “Un Po di contraddizioni. Il libro verde
della Lega” a cura di Roberto Busso, Stefano Catone, Andrea Civati, Giuseppe
Civati e Marcello Volpato; “Inganno Padano. La vera storia della Lega Nord” (La
Zisa, 2010) di Fabio Bonasera e Davide Romano con prefazione di Furio Colombo;
“Razza Padana” (Bur, 2008) di Adalberto Signore e Alessandro Trocino; “Il libro
che la Lega Nord non ti farebbe mai leggere. Dichiarazioni e scandali di un
partito” (Newton Compton, 2010) di Eleonora Bianchini; “Lega Nord. Un paradosso
italiano in 5 punti e mezzo” (Laruffa, 2011) di Luigi Pandolfi; “Avanti Po” (Il
Saggiatore, 2010) di Paolo Stefanini; “Dossier Bossi-Lega Nord” (Kaos, 2011) di
Michele de Lucia; “LegaLand. Miti e realtà del Nord Est” (Manifestolibri, 2010)
di Sebastiano Canetta ed Ernesto Milanesi; “Metastasi” (Chiare Lettere, 2010) di
Gianluigi Nuzzi; “Lo spaccone. L'incredibile storia di Umberto Bossi il padrone
della Lega” (Editori Riuniti, 2004) di Rossi Giampieto e Simone Spina; “Umberto
Magno. La vera storia del'imperatore della Padania” (Aliberti, 2010) di Leonardo
Facco. In tutti questi libri si parla delle contraddizioni del partito padano,
degli sperperi di denaro pubblico, delle collusioni con la malavita organizzata,
della tangente Enimont, del fallimento della banca Crediteuronord, degli
investimenti esteri: dal villaggio in Croazia alla Tanzania, del clientelismo,
dei doppi e tripli incarichi, passando per le provocazioni xenofobe e razziste.
Ma il libro più profetico ed illuminante è indubbiamente: “Io, Bossi e la Lega.
Diario segreto dei miei quattro anni sul Carroccio” (Oscar Mondadori 1994) di
Gianfranco Miglio. Si tratta di un libro datato, ormai introvabile se non in
qualche bancarella dell’usato, mai più ristampato dalla casa editrice di
proprietà della famiglia Berlusconi forse per compiacere il leader del
Carroccio, quando l’alleanza tra il Cavaliere e il Senatùr sembrava
inossidabile. In questo volumetto, dedicato “ai miei amici leghisti della base”,
il giurista e politologo lombardo tratteggia un ritratto impietoso di Bossi,
tacciandolo come primitivo, imbroglione, geloso. Il professor Miglio, a dispetto
di chi tuttora lo vuole inserire nel Pantheon degli ideologi della Lega o gli
dedica poli scolastici, senza aver mai letto un suo libro, scriveva del leader
leghista: “Chi ha avuto rapporti continuati con lui (Bossi), sa che il suo primo
e fondamentale difetto è la mancanza di sincerità. Beninteso: in politica
esistono delle occasioni (fortunatamente rare) in cui il dovere di dire la
verità si attenua; ma Bossi mente sempre, e anche gratuitamente: molte volte si
vantò con me, divertendosi, di avere imbrogliato un avversario, o anche un
compagno di strada. Può darsi che questa brutta abitudine sia un retaggio degli
anni difficili, in cui la “lotta per la vita” fu per lui particolarmente dura, e
lo costrinse a sviluppare la furbizia, che egli considera quindi una virtù”.
(pp.37, 38) Continuando nella lettura si viene a conoscenza che il metodo di
selezione della classe dirigente, vedi il “cerchio magico” o il tesoriere, non è
un difetto attribuibile alla recente malattia ed alla presunta perdita di
lucidità: “Dovendo scegliere fra una persona integra ma scomoda, e un’altra più
maneggevole perché dotata di una buona coda di paglia, ha quasi sempre optato
per la seconda. Anche perché qui si è rivelato un altro suo difetto
incoercibile: la gelosia. Bossi è sempre stato morbosamente geloso di chi
ottenesse, fra i “leghisti”, una simpatia e un credito eguali, se non
addirittura superiori, a quelli a lui tributati. (pag.40) […] E naturalmente,
avendo adottato un criterio selettivo “a rovescio” di quel genere, il segretario
non solo impedì a molte persone qualificate di entrare nella Lega, ma riuscì a
circondarsi di una squadra di “colonnelli”, tutti (si fa per dire) meno “dotati”
di lui: magari, presi uno per uno, brava gente (e in attesa dell’occasione
favorevole per mostrare la loro autonomia), ma consapevoli di dovere la loro
fortuna politica esclusivamente alla fiducia del capo, e quindi pronti a
ripetere come pappagalli le sue parole d’ordine. (pag.41) Miglio nutriva seri
dubbi anche sulle reali aspirazioni federaliste dei vertici leghisti (...Il
“federalismo” era per il segretario e per i suoi accoliti uno strumento per la
conquista del potere, una specie di “piede di porco” con il quale scardinare le
difese degli avversari - pag.48), ma questa è un’altra storia. Concentriamoci
piuttosto sulla questione morale. Forte era la delusione dell’inventore di
Bossi, o se non altro della persona che più ha contribuito a dare pensiero e
spessore ad un partito animato solo dal sentimento della protesta. Miglio stese
“sette comandamenti” per la Lega lombarda, con la relativa interpretazione. Il
punto 5 ordinava: “Là dove, e quando, i leghisti prenderanno responsabilità di
amministrazione e di gestione, esercitare su di loro un controllo morale.
Espellere senza pietà i disonesti, gli incapaci e coloro i quali rompono la
solidarietà del gruppo. A questo fine, far firmare a ogni leghista, che assume
un pubblico incarico, una lettera in bianco di dimissioni. Dare la massima
pubblicità a queste operazioni di controllo”. Commento: “Questa regola diventò
sempre più importante man mano che i rappresentanti del movimento entrarono
nelle pubbliche amministrazioni. L’espediente della lettera di dimissioni in
bianco era da parte mia un’ingenuità. Piuttosto avrei dovuto raccomandare il
rigore morale nella gestione (soprattutto finanziaria) delle strutture della
Lega sul territorio. Con il passare del tempo, mi accorsi infatti che il
controllo economico delle organizzazioni periferiche era potenzialmente un punto
molto debole”. (pp.19, 20) Era già tutto scritto, dunque c’è poco da stupirsi,
sia da una parte che dall’altra della barricata. Inutile dipingere Bossi come il
“Caro Leader” di nordcoreana memoria vittima di un complotto, o consideralo solo
ora come il “male assoluto”. I campanelli d’allarme suonavano già da un pezzo ma
nessuno ha voluto ascoltarli. Speriamo almeno che sia altrettanto profetico il
futuro immaginato dal vituperato professor Miglio: “La politica non la si fa
certo con le belle maniere e con i ‘minuetti’; ma quando saremo emersi da questa
vicenda, ci renderemo conto che il bullo di Cassano Magnano ha rappresentato il
momento più clamoroso - ma anche il più triviale - della crisi. Un’esperienza
che un Paese serio non dovrebbe ripetere più”. (pag.71)
Appare strano che si diventi leghisti per differenziarsi dai
meridionali, pur avendo se non di più, almeno gli stessi difetti. A parlare di
mafia nel Nord Est italiano si fa peccato, però…..ne parla Lorenzo Frigerio ed
“Il Fatto Quotidiano”. La presenza della criminalità mafiosa in Veneto fu
ufficialmente ammessa soltanto nel corso dell'ultimo decennio. Fino ad allora si
sostenne che la regione fosse tutt'al più affetta da fisiologici problemi di
criminalità locale. Agli inizi degli anni Ottanta, la vertiginosa ascesa della
"mala del Brenta" e la contemporanea scoperta dei traffici di armi e droga e
delle operazioni di riciclaggio delle cosche furono le drammatiche realtà in cui
si imbatterono improvvisamente le forze dell'ordine e l'opinione pubblica.
Grandi evasori, ecco la lista. Dalle
tangenti per il Mose ai conti esteri: scoperte oltre 200 offshore con soldi
nascosti al fisco da imprenditori e politici. Paolo Biondani e Leo Sisti il 24
aprile 2019 su L'Espresso. Soldi nascosti in scatole di scarpe. Pacchi di
banconote consegnati ad anonimi autisti ai caselli autostradali, in grandi
alberghi, ristoranti o studi professionali. Un traffico di contanti che parte
dal Veneto e arriva in Svizzera, nelle banche di fiducia di due altolocati
tesorieri di denaro nero, con parentele in famiglie reali. Professionisti del
pianeta offshore, al servizio di alcuni dei più rinomati commercialisti veneti.
Tutti accusati di aver gestito per più di vent’anni una centrale internazionale
dell’evasione fiscale. E del riciclaggio di tangenti intascate da politici poi
condannati. Ma collegati da legami societari e familiari con parlamentari ancora
al vertice delle istituzioni. Eccoli qua, i Padova Papers. Sono le carte
riservate della maxi-indagine fiscale della Procura di Venezia, che pochi giorni
fa ha portato al primo sequestro di oltre 12 milioni di euro. Soldi bloccati
setacciando un fiume di denaro molto più ampio, «oltre 250 milioni», scrivono i
magistrati, dove si mescolano le mazzette dei politici e i fondi neri degli
evasori. Tutto parte dalle indagini sul Mose di Venezia, il più grande scandalo
di corruzione in Italia dopo Tangentopoli. Tra il 2013 e il 2014, mentre
scattano decine di arresti e condanne, la Guardia di Finanza scopre che
imprenditori e politici usano gli stessi canali per nascondere soldi all’estero.
In società offshore e conti bancari spesso intestati, sulla carta, a tre
commercialisti di un affermato studio di Padova. Si chiamano Paolo Venuti, Guido
e Christian Penso. E lavorano per molti ricchi imprenditori veneti, proprietari
di grandi alberghi, fabbriche di scarpe, industrie di valigie, aziende di
costruzioni, immobiliari, centrali del gioco d’azzardo e altre ditte che non
c’entrano con il Mose. Nel maggio 2015 le autorità svizzere accolgono la
richiesta del procuratore aggiunto Stefano Ancillotto di perquisire gli uffici
dei due presunti tesorieri del denaro nero: un nobile italo-elvetico, Filippo
San Germano di San Martino d’Agliè, nipote della regina del Belgio, e il suo
braccio destro, Bruno De Boccard. Nel computer di quest’ultimo salta fuori una
lista di clienti, aggiornata dal 2002 fino al 2014, finora inedita. I giudici
veneti la ribattezzano «lista De Boccard». In quel computer il professionista
svizzero ha trascritto i dati di centinaia di società offshore, con gli
azionisti, gli amministratori e l’attività, che si riduce alla gestione di conti
esteri o di partecipazioni (riservate) in aziende italiane. In qualche caso
compare il vero titolare, in molti altri c’è solo il fiduciario: un altro
professionista, in rappresentanza di un cliente che vuole restare anonimo. La
Guardia di Finanza concentra le indagini su 48 offshore, controllate da 46
cittadini italiani e da 9 società di capitali, che sembrano ancora attive. I
dati però riguardano molti altri evasori. Solo nel 2014 risultano annotate 161
offshore. Nel 2011 se ne contavano 190, nel 2007 erano 232. Già nel 2002, il
primo anno inserito nella lista, le offshore erano 228. Questo significa che c’è
un esercito di grandi evasori non ancora smascherati. Visto che la lista è
aggiornata a cinque anni fa, molti casi di evasione sono ormai cancellati dalla
prescrizione. Mentre gli imprenditori più importanti, interrogati in caserma,
spiegano in coro di aver approfittato dello studio fiscale: il super-condono
varato nel 2009-2010 dal governo di Berlusconi e Tremonti (sostenuto dalla
Lega). Un esempio è la deposizione del “re delle valigie” Giovanni Roncato:
«Sono lo storico titolare della Valigeria Roncato spa, attualmente mi occupo di
coltivazioni di riso in Romania. Conosco Filippo San Martino da 15 anni, in
quanto è anch’egli produttore di riso. Siamo diventati amici (...). L’ho
contattato alcuni anni fa, in quanto avevo dei capitali all’estero, da
rimpatriare con lo scudo. Avevo iniziato a tenere soldi all’estero parecchi anni
prima, a seguito di gravi minacce rivoltemi da un’organizzazione malavitosa che
immaginavo essere la Mala del Brenta: si trattava di minacce di morte per i miei
figli fatte nel periodo in cui la banda di Felice Maniero operava molti
sequestri di persona. Queste minacce mi indussero all’epoca a consegnare
cospicue somme di denaro a malavitosi ignoti, in due occasioni, circa 200
milioni di lire alla volta, in contanti, al casello di Padova ovest. Si tratta
di fatti che non ho mai denunciato in quanto temevo per la morte dei miei figli
allora piccoli». Chiudendo il verbale, Roncato sottolinea di aver regolarizzato
tutto con lo scudo fiscale, da cui risulta che ha rimpatriato 13 milioni e
mezzo. Nella lista De Boccard, il suo nome è collegato a una offshore chiamata
Alba Asset Incorporation, attiva proprio fino al 2009. Per lui, quindi, nessuna
contestazione. Il suo interrogatorio apre però uno squarcio sui rapporti tra
imprenditori veneti e criminalità di stampo mafioso: perfino il re delle valigie
pagava il pizzo per evitare rapimenti. Proprio come Silvio Berlusconi ad Arcore
(tramite Marcello Dell’Utri e lo stalliere mafioso Vittorio Mangano). E come gli
impreditori lombardi che negli anni dell’Anonima sequestri affidavano collette
di soldi al generale Delfino per placare la ‘ndrangheta. Anche Renè Caovilla,
titolare di un famoso marchio di calzature, conferma a verbale di avere avuto
soldi in Svizzera e di aver «aderito allo scudo fiscale del 2009».
L’industriale, che controllava la offshore Serena Investors, aggiunge che «le
somme non regolarizzate venivano affidate a professionisti operanti con l’estero
al fine di depositarle in Svizzera», tra cui ricorda proprio Filippo San
Germano, che gli fu presentato da «un commercialista di Venezia, G.B., poi
defunto». Caovilla ha rimpatriato con lo scudo 2 milioni e 287 mila euro. Tra
albergatori di Abano Terme, costruttori e imprenditori del gioco d’azzardo,
l’oscar dell’evasione va a Damiano Pipinato, un altro big delle calzature, che è
anche il più eloquente nella confessione: «Verso il 1997 o 1998 chiesi al mio
commercialista, Guido Penso, come poter gestire i proventi dell’evasione, in
quanto i controlli erano sempre più stringenti. Il commercialista mi propose di
consegnarglieli, affermando che avrebbe messo lui a disposizione gli strumenti
per aprire un conto svizzero, senza necessità che io apparissi. Quindi iniziai a
consegnare somme consistenti a Penso. La cosa funzionava così: lui mi telefonava
e, in codice, mi chiedeva se avessi due o tre campioni di scarpe. Io sapevo,
essendo preconcordato, che mi stava chiedendo 100, 200 o 300 mila euro da
portare fuori. Spesso lui aveva bisogno di liquidità per compensare partite di
giro con altri clienti dello sudio. Infatti più volte ho visto che i miei
accrediti, anche di un milione, venivano spezzettati e mi arrivavano da conti
diversi. Fatto sta che io predisponevo il contante all’interno di una scatola di
cartone, in un sacchetto, e lo portavo in macchina nel suo studio a Padova. Qui
Penso non apriva la scatola, non contava il denaro, in ragione della decennale
fiducia: io gli indicavo la cifra esatta, lui la riponeva nell’armadio e mi
rilasciava un post-it manoscritto, con data e importo. Dopo qualche giorno mi
esibiva l’estratto di un conto corrente con la cifra da me versata. A quel punto
il post-it veniva stracciato». L’imprenditore è il primo a chiamare in causa
anche i partner di Penso: «Alla metà degli anni Duemila, Guido, suo figlio
Christian e il loro socio Paolo Venuti mi proposero di investire
nell’immobiliare a Dubai, con altri imprenditori, spiegandomi che stavano
organizzando una gestione di fondi all’estero per i clienti dello studio.
Iniziai con un piccolo investimento che in un paio di mesi si rivalutò del 40
per cento. Quindi decisi di investire di più, attingendo alle precedenti
disponibilità della mia famiglia nella banca svizzera Zarattini. Allora Guido
Penso mi spiegò che a gestire il denaro in Svizzera era Filippo San Germano, che
era la persona di sua fiducia che copriva anche me. Infatti tutte le mie società
e conti esteri erano amministrati da San Germano». In totale, Damiano Pipinato
ammette di aver portato all’estero, tramite il commercialista padovano e il suo
nobile fiduciario, almeno 33 milioni: 25 in Svizzera, 8 a Dubai. Dove però, dopo
la crisi immobiliare, «nel 2013 ho visto che l’investimento continuava a perdere
valore». Scoppiato lo scandalo del Mose, l’imprenditore cerca di sanare tutto
con la voluntary disclosure, che però non è uno scudo anonimo, ma una vera
autodenuncia: l’interessato deve farsi identificare e rivelare come ha fatto a
creare il nero. Quindi l’Agenzia delle entrate gli boccia l’istanza. E lui alla
fine vuota il sacco. I due fiduciari svizzeri sono accusati di aver occultato e
riciclato fondi neri per molti altri imprenditori veneti. Il tesoro già scoperto
dall’accusa sale così di altri 29 milioni, mandati all’estero (attraverso
apposite offshore) da imprenditori come Flavio Campagnaro (5 milioni, divisi in
50 consegne), Luca e Roberto Frasson (1,5 milioni), Sergio Marangon (1,2
milioni), Primo Faccia (250 mila dollari), Ignazio Baldan (250 mila euro), Mauro
Mastrella (800 mila), Odino Polo (un milione), Maria Rosa e Stefano Bernardi (3
milioni) e Giovanni Gottardo (mezzo milione). In caserma, pur con qualche
imbarazzo, tutti finiscono per ammettere i fatti, sottolineando però di essersi
messi in regola grazie allo scudo. Alcuni rimarcano di aver soltanto ereditato
conti esteri creati dal padre fin dagli anni Sessanta, «quando fare il nero era
la regola». Altri, come Pipinato, si vedono contestare società offshore ancora
attive, ma rispondono di averle dimenticate «perché furono usate per
investimenti in Nicaragua, ma sono andati male e quei soldi li abbiamo perduti».
In almeno vent’anni di traffici di denaro nero, ai tre commercialisti padovani
dello studio Pvp (dalle loro iniziali) non sono mai mancate le coperture
politiche. Paolo Venuti è stato già arrestato e condannato (a due anni) per le
tangenti del Mose, come tesoriere-prestanome di Giancarlo Galan, governatore
veneto dal 1995 al 2010 e poi ministro del governo Berlusconi. Quel troncone
d’indagine ha svelato un nuovo sistema di corruzione: società private svendute a
politici, che incassano le tangenti sotto forma di profitti aziendali. In
particolare la Mantovani spa, azienda leader del Mose, ha intestato proprio a
Venuti, come paravento di Galan, il 5 per cento di Adria Infrastrutture, la
società del gruppo che vinceva appalti stradali con la Regione Veneto. E con lo
stesso sistema la Mantovani ha arricchito anche il super-assessore Renato
Chisso, altro condannato per il Mose. La nuova ordinanza ora accusa il
commercialista di aver nascosto anche contanti incassati da Galan: almeno un
milione e mezzo di euro. Soldi finiti in Croazia su un conto intestato alla
moglie di Venuti, sempre come prestanome dell’ex doge, come conferma
un’intercettazione della coppia in auto, al ritorno da una cena nella villa di
Galan (ristrutturata con altre tangenti e quindi sequestrata). La pista dei
soldi è emersa grazie ai Panama Papers, le carte segrete delle offshore. Dove
L’Espresso nel 2016 ha scoperto un’anonima società panamense, Devon Consultant
Assets, intestata a Venuti e mai dichiarata. Questi, i fattacci del passato,
dalla corruzione per il Mose al riciclaggio. Dallo studio Pvp parte però un filo
segreto di rapporti professionali e familiari che arriva al presente e porta
fino alla seconda carica dello Stato. Lo studio Pvp ha legami molto stretti con
una società di Padova, Delta Erre, che è una specie di club dei più affermati
fiscalisti veneti. Tra gli azionisti compare Paolo Venuti, che si è visto
sequestare la sua quota in questi giorni. La stessa società ha accolto tra i
suoi azionisti anche Giambattista Casellati, un grande avvocato di Padova. Che è
il marito di Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’attuale presidente del
Senato. Che ai tempi dello scudo fiscale era sottosegretario alla Giustizia,
oltre che parlamentare di Forza Italia. Marito e moglie sono anche soci d’affari
in una piccola azienda italiana chiamata Esa, creata nel 1983, che nell’ultimo
bilancio (2017) dichiara 55 mila euro di ricavi. La Delta Erre, costituita nel
lontano 1971, è un club esclusivo, con partner selezionati. Fino al 2017 era una
fiduciaria, poi si è concentrata sulle consulenze fiscali. Da anni è un punto di
riferimento per le aziende di area ciellina. E da sempre ha forti legami con
alcuni protagonisti dello scandalo Mose. Tra i soci fondatori spicca infatti
Guido Penso, che è stato presidente del consiglio d’amministrazione fino al
1996. Già allora il commercialista manovrava fondi neri degli evasori, come
spiega l’ordinanza che oggi accusa lui e suo figlio di aver orchestrato, con il
collega Venuti, anche il riciclaggio del tesoro di Galan. I Panama Papers
confermano che proprio Penso, attraverso un suo studio di Londra, gestiva già
nel 2000 alcune offshore, come la Sorenson Holding delle Bahamas, ora accusate
di nascondere i milioni degli evasori. La Delta Erre non è coinvolta
direttamente in questi scandali. Però compare più volte negli atti delle
indagini. Ad esempio l’imprenditore Damiano Pipinato, oltre ai 33 milioni
dell’evasione, ha parlato anche di una serie di offshore utilizzate per
mascherare le sue proprietà a Padova e spostare all’estero i soldi degli
affitti. Tra quegli immobili così schermati (con una società italiana
controllata da anonime panamensi) c’è una palazzina in via Corciglia 14. Dove ha
sede lo studio Cortellazzo e Soatto. Che paga da anni un affitto notevole: 240
mila euro più Iva, poi ribassato a 185 mila. Soldi che, attraverso le offshore,
finivano nei conti svizzeri di Pipinato. Sia Soatto che Cortellazzo ricompaiono
anche tra i soci della Delta Erre, al fianco di Venuti (il prestanome di Galan)
e dell’avvocato Casellati (il marito della presidente del Senato). Allo studio
Soatto e Cortellazzo è dedicato perfino un capitolo spinoso della sentenza sul
Mose: sono loro ad aver firmato una perizia che, secondo i giudici, ha
consentito alla Mantovani spa, l’azienda simbolo delle tangenti venete, di
sopravvalutare le sue attività. Il loro studio è registrato con la sigla
“Servizi professionali organizzati” e ha come socio di maggioranza il
commercialista Lucio Antonello, che è anche l’attuale numero uno della Delta
Erre. Come presidente del Senato, la signora Casellati è sicuramente dalla parte
della legalità e della lotta all’evasione fiscale. Il problema è che i soci di
suo marito giocano nella squadra avversaria.
DEMOCRISTIANI. L'editoriale di
Roberto Napoletano il 4 marzo 2020 su quotidianodelsud.it. Nessuno fa niente per
il suo Paese. Tutti stanno a guardare quello che fanno gli altri. Lo sport
nazionale è giudicare o porre veti. Il motore dei comportamenti dei singoli sono
il proprio interesse e l’invidia sociale. Una moltitudine ripetitiva di
comportamenti individuali di questo tipo produce una collettività che riconosce
le “capitali” dei loro egoismi e smarrisce l’identità comune di una nazione. Ne
viene fuori una comunità in stato confusionale capace di fabbricare con le sue
parole inutili una recessione in casa. Moro e Fanfani facevano lezione
all’università e poi nel resto della giornata facevano politica. Molti della
classe dirigente di governo di oggi – centrale e, soprattutto, regionale/locale
– non potrebbero nemmeno seguire i corsi dei grandi professori democristiani. Ho
pensato a Moro e Fanfani leggendo le dichiarazioni di Bruno Tabacci, politico di
lungo corso e ex presidente della Regione Lombardia, al nostro Claudio
Marincola: “Eravamo democristiani. E finché ci siamo stati noi la sanità
pubblica non è mai stata messa in discussione. Poi è successo qualcosa, non mi
chieda però cosa. So solo che ci fu un grande cambiamento, famiglie importanti
già attive in altri settori iniziarono a investire nella sanità cifre notevoli e
poco dopo arrivarono i tagli. Meno medici, meno infermieri, meno ospedali, meno
posti-letto”. In queste parole c’è la chiave di quello che è avvenuto a Milano
e, a catena, nell’intero Paese. Dietro la perdita di valore della sanità
pubblica e di ciò che rappresenta in termini di sicurezza, di igiene e di
prevenzione, c’è quello che l’attuale sindaco di Milano, Beppe Sala, ha definito
“l’ecosistema sanitario” lombardo. Qualcosa che coniuga tagli lineari alla
sanità pubblica e business dei privati. Si passa dalla chimica petrolifera alle
cliniche, ma soprattutto si prenotano quote ingenti di risorse pubbliche con il
moltiplicatore della Spesa Storica che favorisce il ricco a discapito del
povero. Nessuno vuole discutere le eccellenze private, ma è sotto gli occhi di
tutti come prevenzione e organizzazione dell’accoglienza pubblica abbiano
sofferto con l’emergenza coronavirus. La sanità privata lombarda ha fatto
incetta di finanziamenti sottratti alle Regioni del Sud – la sanità ospedaliera
meridionale è finita sotto processo per clientele a volte vere ma di più per una
moda funzionale agli interessi privati nordisti – e se ne guarda bene oggi da
restituire qualcosa. Il virus che i focolai di Lodi e della bergamasca portano
in superficie è la perdita del primato della cultura del servizio sanitario
nazionale e della sanità pubblica. Quegli stessi micro-interessi degli
azionisti-clienti di Banca Ubi che si oppongono per ragioni di bottega al
disegno da sistema Paese di Intesa Sanpaolo si possono riscontrare nella cultura
della fatturazione pubblica e dei super-rimborsi che appartiene alle famiglie
private dell’ecosistema sanitario lombardo. Se la politica non dà una spallata a
questi micro-interessi, l’Italia non potrà mai rialzare la testa.
La grande balla, il nuovo libro di Roberto Napoletano: «Il
Nord vive sulle spalle del Sud». Redazione de
ilgolfo24.it il 6 Marzo 2020. Si intitola “La grande balla” ed è il nuovo libro
di Roberto Napoletano, frequentatore di Ischia, “Giornalista dell’Anno” nel 1990
al Premio Internazionale di Giornalismo, già direttore de Il Sole 24 ore. Con
dati e statistiche ufficiali alla mano, l’autore racconta lo scippo di 61
miliardi che ogni anno il Nord effettua ai danni del Sud. E capovolge lo
stereotipo del meridione d’Italia assistito che, al contrario, è stato
abbandonato. Un’inchiesta esplosiva sulle vere cause, e le vere responsabilità,
di un’Italia divisa in due, che si fa la guerra invece di unire le forze. La
questione meridionale come non l’avete mai vista. È quanto assicura Roberto
Napoletano, che torna in libreria con un saggio rigoroso e inedito sul divario
tra Nord e Sud. Il titolo “La grande balla”, edito dalla Nave di Teseo. Secondo
la ricostruzione dell’autore, «la regione Veneto fa pagare allo stato
italiano non ai contribuenti veneti, per la sua sanità, lo stipendio a
sedicimila dipendenti in più, non medici, di quanti ne fa pagare la sempre
vituperata regione Campania che ha un milione di abitanti in più». «Sapete che
l’Emilia Romagna e la Puglia, a quasi parità di popolazione, ricevono la prima
tre miliardi in più e la seconda tre miliardi in meno per la sanità? Che a fare
il deficit sanitario – si legge in un estratto del libro – sono tre regioni a
statuto ordinario del Nord non del Sud, per la precisione Piemonte, Liguria,
Toscana, parola della corte dei conti?». «Vi siete mai chiesti chi ha il primato
dei dipendenti pubblici in Italia? Penserete in automatico ai mille carrozzoni
comunali e regionali dei mille Sud italiani, vero? No, sbagliato! – scrive
Napoletano – Il Nordest, che comprende Veneto, Emilia Romagna, Trentino e
Friuli, vince alla grande: ha cinque dipendenti pubblici ogni cento abitanti
contro i 4,4 del solito diffamato Mezzogiorno e, addirittura, alla pari con
Roma, senza avere neppure uno dei ministeri, delle authority, delle ambasciate
che ‘popolano’ la Capitale di una nazione. Se dubitate dei numeri o il confronto
non vi aggrada prendetevela con l’ISTAT che è la firma statistica dell’Italia
nel mondo». Domande articolate, per certi versi con risposte sorprendenti e del
tutto inedite, quelle che vengono fuori nel volume, appena edito da La nave di
Teseo: quanti cittadini sanno che 61 miliardi dovuti al Sud vengono ogni anno
regalati al Nord? Per Napoletano «si tratta del più grande furto di stato mai
conosciuto nella storia recente della Repubblica italiana. I numeri di questa
operazione verità fanno tremare vene e polsi, e permettono legittimamente di
chiedersi se l’Italia esista ancora». Nord assistito, Sud dimenticato “La grande
balla” di Roberto Napoletano intende portare il lettore a intraprendere un lungo
viaggio nelle piccole grandi patrie dell’assistenzialismo, che – secondo
l’autore – non sono al Sud, ma tutte al Nord. «La politica si è abituata da
vent’anni a togliere investimenti al Sud per soddisfare le pretese dei
questuanti di turno, sistemare gli amici degli amici nel coacervo di enti
pubblici proliferati con la spesa facile. Tutti collocati nelle ricche regioni
del Nord». Non dimentichiamo che il giornalista, per anni è stato direttore
del Sole 24 Ore e, quindi, ha avuto modo di conoscere il sistema economico
italiano dall’ interno.
Il sistema sanitario meridionale nel codice di San Leucio.
Silvia Siniscalchi il 21 Agosto 2017 su iconfronti.it. In considerazione della
disastrosa situazione della sanità campana, si ripropone qui uno studio sui
fondamenti filosofico-giuridici e socio-sanitari del Codice borbonico della
colonia “utopica” di San Leucio, che suscitarono un profondo interesse già
presso i contemporanei (come il Luppoli, il D’Onofri, il Galdi e il Cuoco, tanto
per accennare a dei nomi di intellettuali di valore). Senza volere accogliere le
ragioni del revanscismo borbonico e senza entrare nella questione dell’autentica
paternità del Codice, ci si limita a constatare l’assoluta modernità di una
legislazione sanitaria che rappresenta uno degli esempi in tema più avanzati del
XIX secolo e attuato nel Meridione d’Italia.
Sul colle detto di S. Leucio, adiacente alla famosa reggia
vanvitelliana, nel sito di una diruta chiesetta longobarda dedicata a quel
santo, Ferdinando IV di Borbone, dopo aver murato l’intero bosco circostante,
aveva fatto costruire un piccolo casino di caccia (1773-74), che poco dopo
abbandonò perché vi era morto il suo primogenito Carlo Tito, trasferendo la
propria residenza nell’attigua località detta Belvedere (da allora chiamata
estensivamente, ma a torto, S. Leucio), di bella vista, ottima aria e fertilità
del terreno per ogni tipo di produzione, vite in particolare. «Vi fece perciò
subito costruire – soccorre qui uno stralcio della sintetica “voce” di un quasi
coevo Dizionario – delle nuove fabbriche, ed un’antico salone lo convertì in
chiesa nel 1775, che eresse benanche in parrocchia per la popolazione, che vi
fece radunare al numero di circa 350 individui addetti non solo alla custodia
del bosco, che alla coltivazione de’ terreni, che sono in quei contorni. Nel
1776 ampliò maggiormente le fabbriche, e vi stabilì una casa di educazione, e
quindi da tempo in tempo vieppiù rese il luogo abitabile e popolato con
istabilirvi una colonia di artefici a formare ottime manifatture di seta, cioè
stoffe, fettucce, veli, calze, da non farci affatto invidiare le decantate
manifatture forestiere. Il numero di questi artefici è oggi [fine ‘700] giunto a
circa 800. Nel 1789 il suddivisato nostro Clementissimo Sovrano con molta
saviezza scrisse le leggi per questa sua nuova Colonia, da far veramente in
tutti i tempi avvenire gloria all’Augusto Suo Nome»
L’ultimo riferimento è ovviamente al famoso Statuto della real
Colonia, che sarà analizzato nei paragrafi seguenti, specie per la normativa
socio-sanitaria, ma del quale occorre subito anticipare, in estrema sintesi, una
finalità altamente etica, quella di prevedere una “città degli uguali”, dove
appunto vigesse «l’assoluta uguaglianza tra donne e uomini, il diritto
all’istruzione, alla successione e alla proprietà, alla casa e all’equo salario,
alla tutela in caso di bisogno, all’assistenza sanitaria, alla prevenzione del
vaiolo, alla formazione e al lavoro».
Se questi sono, assai scarnificati, i fatti incontestabili della
nascita e vita primiera della colonia e del suo contenuto statutario, assai più
discutibili e discussi sono i valori e i significati ad essi attribuiti, a
partire dalla paternità dell’idea e fino al processo normativo, progettuale ed
effettuale. Poiché il merito maggiore si riconosce alla stesura dello statuto,
gli studiosi si sono accapigliati sul nome del vero artefice, dando per scontato
che – data l’ignoranza, l’indolenza intellettuale, la rozzezza di comportamenti
del re “nasone” o “lazzarone” (come spregiativamente veniva e verrà chiamato) –
non poteva esser stato lui l’estensore: dopo aver di massima condiviso che
l’autore del codice fosse il massone Antonio Planelli, con varie sfumature al
sovrano si è accreditato al massimo un contributo maldestro ed episodico,
riscontrabile nella scarsa organicità della normativa, come riconoscimento di
un’indole sostanzialmente buona e benevola verso il popolo, con cui “si trovava
bene” e nel quale spesso si identificava nelle sue note stranezze quotidiane
(vari travestimenti, scherzi, ecc.). In questa farragine di titubanti ipotesi è
intervenuta di recente la ricerca, seria e documentata, di una giovane studiosa,
a risolvere forse definitivamente il dilemma. Mi riferisco ai lavori, impostati
anche in utile chiave collegiale e didattica, di Nadia Verdile, in particolare a
quello portato avanti col progetto “Carolinopoli: l’utopia di una regina”,
svolto nell’anno scol. 2003-2004 presso l’ist. Statale d’Arte “San Leucio”, e
concretizzato in un volume intitolato Carolina (2004). Senza disattribuire
l’autoralità materiale al Planelli, la Verdile sostiene che quella spirituale e
filosofica vada riconosciuta alla regina Carolina, cui andrebbe altresì il
merito di tutte le riforme realizzate nel Regno di Napoli prima della
rivoluzione francese. Oltre che sulla bibliografia più accreditata
(Coniglio,1981; Tescione,1932, in testa a decine di altri autori), la
ricercatrice si basa sull’analisi e la parziale stampa delle lettere, custodite
all’archivio di Stato di Napoli e mai prima edite, che da S. Leucio il re inviò
alla regina tra il 1788 e il 1799, nonché di quelle di Carolina al marito
(Verdile, 2008), la cui lettura «ha consentito una lucida definizione delle
personalità dei due sovrani e degli interessi degli stessi» (Verdile, 2004,
p.11). Quanto alla sovrana, emerge il ritratto di una donna che, lungi
dall’essere solo crudele e sanguinaria (come vuole il cliché appostole dopo la
repressione della rivoluzione del 1799), attiva i “malfamati” intrighi di corte
solo nel desiderio alto e nobile di sconfiggere il partito filospagnolo
(incarnato prima dal “tardo” Tanucci e poi dal Sambuca) a favore di quello
filoasburgico, capitanato dall’ammiraglio Francesco Acton e di poi da Domenico
Caracciolo, con il seguito di tutti gli intellettuali, i nobili e i borghesi
progressisti, facenti spesso capo alle logge massoniche, cui stava a cuore il
risollevamento delle sorti del Regno. Di più: Carolina, degna figlia della più
progressista tra le personalità dei principi illuminati (l’imperatrice Maria
Teresa d’Austria), appare come una sovrana coltissima, che legge e scrive
quattro lingue (francese, tedesco, italiano e spagnolo) oltre a saper tradurre
il latino, che, fin dal suo arrivo a Napoli, cura l’incremento della sua
biblioteca (formata da 6443 volumi, oltre a molti periodici) e se la fa
trasportare al seguito nelle parentesi di fuga in Sicilia, che è istruita in
letteratura, storia, botanica, musica, canto e – fatto assai indiziario –
filosofia, etica, diritto, pedagogia, economia e botanica. Dall’altro lato,
troviamo un sovrano meno zotico e tartufesco di come si è voluto far credere, ma
“giustamente” insofferente della etichetta e degli squallidi personaggi di
corte, come della partecipazione al Consiglio di Stato (in cui ben presto sedé
autorevolmente Carolina), in nome di una vita sana, all’aperto, dedita alla
caccia, alla pesca, al nuoto e a varie attività ginniche, nel contatto “diretto”
dei suoi sudditi (spesso al femminile, come si malignava…): un re che ben
volentieri cedette “lo scettro” alla sua metà, con la quale in certo senso
caratteriologicamente si compensava, comunque fungendo da elemento equilibratore
tra i poteri. Sulla base di tali valutazioni, la conclusione della Verdile
appare abbastanza plausibile, anche alla luce della stima che a Carolina
manifestarono personaggi del calibro di Pietro Colletta, Vincenzo Cuoco e altri.
Accantonato, con sufficiente persuasività, il problema
dell’attribuzione autorale, non meno interessante sarà soffermarsi, sia pur in
breve, sulle fonti ispiratrici (teoriche e pratiche) della legislazione e delle
esperienze effettive realizzate dalla colonia reale, compreso il progetto
“utopico” di «Ferdinandopoli». Sapere che l’ideazione fu di Carolina non
semplifica la soluzione e, a parer di chi scrive, la stessa regina avrebbe
trovato difficoltà a rintracciare precisamente i suoi “modelli” ispiratori, in
una temperie storica illuminata da tanta letteratura
utopistico-socialistico-riformistica e da innumerevoli esperimenti pratici,
realizzati in varie parti del mondo, di comunità autogestite. Di antecedenti,
infatti, ce ne sarebbero molti e anche molto remoti nel tempo. Scrive a riguardo
il Tescione: «Se si dovesse risalire ai primi germi delle idee, delle dottrine e
dei progetti di costituzioni politiche a cui potrebbe ricollegarsi la
costituzione di S, Leucio, occorrerebbe fare un ardito volo oltre gli orizzonti
del mondo moderno e medioevale e di là dalle vie battute da Cicerone e da
Aristotele, per raggiungere le pure scaturigini del pensiero platonico. Non
sarebbe fuor di luogo allora ricordare il piano di quella Platonopoli di cui fin
dal terzo secolo dopo Cristo il filosofo Plotino proponeva l’attuazione ad un
tiranno della decadenza romana, il Galieno, chiedendo per lo scopo appunto un
distretto della Campania, o la concezione di quella fantastica repubblica
aristocratica e monastica ch’è la Città del Sole, con cui il Campanella, nel XVI
secolo, perfezionando il sistema comunista di Tommaso Moro, precorreva, in un
certo modo, le utopie del secolo XVIII» (Tescione, 1932, p.’’’..; in proposito
cfr. Dematteis, 1963). Quanto ai precorrimenti teorici più prossimi, il
Battaglini crede di dover citare: Francesco Saverio Salfi nel suo Elogio del
Filangieri; il Dumas, che trova affinità col socialismo e richiama Fourier e il
suo falansterio; lo Stefani che parla di colonia socialistica borbonica e chiama
in causa il pensiero e i tentativi storici di Robert Owen; Francesco Longano, un
riformatore napoletano che distingueva tra il politico che dà lavoro ai
bisognosi, e l’uomo superstizioso che gli fa l’elemosina; il Mercier per un suo
romanzo fantapolitico e la creazione di una città fantastica; il Gori che parla
di impronta comunista; infine il Croce e seguaci, fermi sull’errata
interpretazione del “capriccio” del sovrano.
Circa la posizione ideale e fattuale dell’Owen in confronto a
quella borbonica, intanto, registriamo uno studio specifico condotto dalla più
recente studiosa leuciana, che, al di là delle forti differenze, trova anche
delle collimanze, in questi termini: «Eppure i telai uniscono le due utopie
anche se da San Leucio la seta va verso le grandi residenze del potere mentre da
New Lanark le tele di cotone vengono distribuite ai mercati della nazione. E da
ultimo, ma prima riflessione da fare, l’utopia leuciana e quella newlarkiana
sono nate dalla forza ideologica e culturale di due personalità profondamente
diverse: da una parte il pensiero illuminato di Maria Carolina d’Asburgo, colta,
amica e sostenitrice della massoneria progressista, sovrana, e dall’altra il
pensiero illuminato di Robert Owen, operaio, poi imprenditore, economista. E
dunque è nell’etica dell’Illuminismo che si fonda l’incontro di due grandi
progetti utopici che hanno avuto il merito di dimostrare che una società degli
uguali può e deve essere perseguita» (Verdile, 2006, p. 28). Molto più ricco,
profondo e articolato è il contributo che il Tescione, il maggiore studioso in
materia, aveva offerto in proposito nel suo monumentale volume del 1932, poi
riedito nel 1961 senza sostanziali aggiunte e in forma più agile (senza note a
piè di pagina). Dei più importanti autori richiamati, infatti, egli ricostruiva
articolatamente la storia individuale e il pensiero. In questa sede si possono
solo ricordare i nomi degli esponenti, attivi nel Napoletano già prima
dell’ascesa al trono di Carlo III di «quel progredito movimento intellettuale
mercé il quale lo spirito dell’Europa civile e laica era penetrato nel regno di
Napoli, destandovi scintille di fecondi dibattiti, forza e luce alla lotta per
svincolare lo stato e l’organismo sociale dalle pastoie feudali».
In definitiva, sulla scorta del Tescione (1932, passim) si può
affermare, per un verso, che l’ispirazione più profonda e più prossima delle
leggi di S. Leucio proviene dalla Scienza della legislazione del Filangieri, che
in precedenza aveva dettato i principi anche alla politica del Tanucci contro la
mendicità e per l’educazione del popolo alle arti e ai mestieri (specie con
l’editto del 1769), per l’altro – accogliendo la Verdile e in riferimento alle
ricezione etico-politica da parte di Carolina – dalle «riforme messe in pratica
[…] nell’impero austriaco da sua madre prima e da suo fratello, l’imperatore
Giuseppe II in seguito, e nel Granducato di Toscana dal fratello Pietro
Leopoldo» (Verdile, 2004, p. 25). Meglio chiarisce la questione il Kruft,
sostenendo che lo statuto in parole «è una sintesi delle concezioni
giusnaturaliste-istituzionali e delle teorie economiche formulate a Napoli da
Vico a Filangieri. In questa idea dello Stato è insita una impostazione
paternalistico-monarchica. Il re si pone al vertice di una rivoluzione sociale
fondata sul diritto naturale: è una “rivoluzione dall’alto”. Segno tangibile del
vincolo tra il re e la colonia è il collegamento tra il palazzo e la fabbrica.
L’esperimento filantropico del 1789 diventa involontariamente un’alternativa in
piccolo alla Rivoluzione francese».
Si può infine condividere con il maggior studioso della materia
l’idea che, all’atto pratico, l’istituzione leuciana dava a Carolina «la
possibilità di conciliare, su di un terreno particolarmente favorevole, le sue
tendenze romantiche con i capricci del re» (Tescione, 1932, p. 136): che vale a
riconoscere come l’intrapresa complessiva della colonia fosse l’unica maniera
per la regina di far impegnare un sovrano tendenzialmente refrattario alle cose
di governo verso un obiettivo serio e fruttuoso per la corona e il popolo, in un
sito prediletto perché dava sfogo alle sue passioni e, sul versante aziendale,
gli consentiva inoltre di applicare la sua particolare competenza in fatto di
macchinari e anche di agrimensura.
Ciò ci induce a non sottovalutare il contributo ferdinandeo alla
formulazione pratica (al di là della difettosa conoscenza della lingua
italiana), specie nel settore dell’organizzazione della giornata lavorativa,
della massimizzazione nell’uso ottimale delle macchine e dei risultati
produttivi (e simili), degli articoli del Codice e soprattutto del più analitico
Regolamento di gestione interna della fabbrica, stilato da Domenico Cosmi. Lo
stesso valga rispetto al progetto solo parzialmente realizzato di
«Ferdinandopoli», che – come tra breve diremo – essendo un riflesso degli
statuti leuciani (Schiavo, 1986), conserva sì la sua matrice nella spinta ideale
della regina, ma dovette avere nel “praticone” Ferdinando una sicura e
consapevole guida per l’architetto progettista Collecini. In realtà, da tempo è
maturata in alcuni studiosi la convinzione che il discorso locale di S. Leucio
si inquadrasse in una più ampia strategia politico-territoriale, che – alla luce
dell’intuizione della Verdile – non poteva che maturare nella fervida mente di
Carolina, in accordo col generico “populismo” ferdinandeo. Innanzitutto,
l’esperimento leuciano era la prova che si potesse fare a meno della componente
più retriva della feudalità e si dovesse invece puntare su un rapporto diretto
tra dinastia e popolo, in funzione accentratrice e antibaronale. Inoltre, si
trattava di un tentativo non isolato di diversificazione funzionale dei “siti
reali” (da riserva di caccia a villaggio operaio, azienda agricola o caserma)
per organizzare e valorizzare il territorio tra intorno di Napoli e Caserta
(Alisio, 1976; Caputo, 1977; Battaglini, 1983, p. 25). In tale programma
rientrava infatti anche l’esigenza di trasformare Napoli da parassitaria
metropoli di consumo a centro di produzione, decentrando però nei centri
limitrofi le attività industriali, per decongestionare la capitale e
alleggerirne la pressione demografica (Caputo, 1977; Battaglini, 1983, p. 25).
Del resto nella città partenopea era evidente da tempo la crisi della
sericoltura, per cause complesse che vanno dal peso enorme delle tasse alla
carenza di manodopera specializzata e di strumenti e macchine più moderne:
questo spiega perché l’esperimento delle seterie fosse fatto proprio a S.
Leucio, dove quella industria poteva diventare sicuramente competitiva, grazie
alle caratteristiche geografico-naturali e geoantropiche del sito: come
riconoscerà in una relazione del 1826 il De Welz, appaltatore della ormai
ex-colonia, il clima e suolo amici del gelso (nota pianta di supporto alla
coltivazione del baco) e di tante produzioni agroalimentari (da cui l’abbondanza
di viveri a basso prezzo), la «bassezza della mano d’opera, i prezzi leggieri
delle materie prime, […], il motor d’acqua instancabile e gratuito [azionato
dallo stesso acquedotto della Reggia], operai destri, artefici intelligenti»
(citato da Battaglini, 1983, p. 14) costituivano fattori positivi della
conduzione aziendale. Al fondo dell’operazione non poteva non celarsi la
battaglia contro la miseria, la mendicità, l’accattonaggio e la degradazione
fisica e morale di tanta parte della popolazione urbana e rurale (che era la
causa di temute turbative all’ordine pubblico), per cui tutto l’apparato
economico-manifatturiero e urbanistico aveva una destinazione prevalentemente
sociale: non a caso, per quanto riguarda gli oziosi, lo Statuto prevedeva che i
“Seniori del popolo”, addetti al controllo della colonia, hanno il dovere di
vigilare «rigidamente sul costume degli individui della Società, sull’assidua
applicazione al lavoro, e sull’esatto adempimento del proprio dovere di
ciascuno. E trovando, che in ess’alligni qualche scostumato, qualche ozioso, o
sfaticato, dopo averlo due volte seriamente ammonito, ne posseranno a me
l’avviso, acciò possa mandarsi o in casa di correzione, o espellersi dalla
società, secondo le circostanze». Stessa sorte è riservata ai giovani che,
giunti ai sedici anni di età, si rifiutino di lavorare o di apprendere il
mestiere (Ferdinando IV, 1789, paragrafo XIV). Siamo dunque di fronte a una
utopia laica e paternalistica, a parere dei Eugenio Battisti (cit. in
Battaglini, 1983, p. 25), alla quale è lecito aggiungere anche l’aggettivo
«religioso», sia pur nella particolare accezione dei regnanti borbonici che, pur
avendo in precedenza osteggiato l’ideologia “indipendentista” espressa nelle
colonie paraguayane dai Gesuiti (tanto da espellerli dal regno), dopo la
parentesi rivoluzionaria si accostarono all’”altare” in quanto utile garante del
“trono”.
Il sistema sanitario meridionale nel codice di San Leucio.
Silvia Siniscalchi l'8 Marzo 2018 su iconfronti.it. In Campania − regione dei
maggiori ritardi e disguidi nella politica sanitaria, che tanto pesano su tutti
i cittadini − vi fu un periodo, alla fine del XVIII secolo, di grandi conquiste
civili e sociali proprio in questo settore. Ci riferiamo ad alcuni interessanti
aspetti del Codice borbonico della colonia “utopica” di San Leucio, con
particolare riguardo alla straordinario stadio di avanzamento proprio dei suoi
aspetti sanitari. Analizzare gli aspetti assistenziali e socio-sanitari, quali
emergono dallo Statuto della Real Colonia borbonica dei lavoratori della seta,
costituisce un’impresa alquanto problematica; alla complessità intrinseca
dell’indagine (dove entrano in gioco storia, diritto, medicina e urbanistica),
si aggiunge infatti la scarsità di studi in materia disponibili (soprattutto per
il Mezzogiorno), che si sono dovuti misurare con la multiforme situazione
assistenziale dell’Italia pre-unitaria. Ciò nonostante, gli studi dedicati al
settore si sono notevolmente accresciuti negli ultimi vent’anni, ponendo
l’attenzione sullo sviluppo delle modalità diagnostiche e curative della
medicina nelle varie epoche, sulla sua contaminazione con pratiche magiche,
religiose e credenze popolari, sulla sua attenzione per le malattie legate al
lavoro e, particolarmente, sul processo che da scienza a carattere individuale
l’ha trasformata in sistema di assistenza, cura e prevenzione collettiva
controllato dallo stato. A tal proposito, eventi e riforme del XVIII secolo sono
apparsi determinanti per l’ammodernamento della sanità e la sua trasformazione
in sistema statale, sebbene, secondo alcuni studiosi, solo nel periodo
successivo alla Rivoluzione francese i presupposti sociopolitici, istituzionali,
ideologici ed epistemologici di tale epocale mutamento sarebbero giunti a
maturazione (Keel, 2007). Perciò, in tale prospettiva, il Decennio napoleonico è
stato ritenuto molto significativo, soprattutto per il Mezzogiorno dell’Italia:
grazie ai processi di centralizzazione burocratica avviati dai napoleonidi,
infatti, «l’avocazione degli arrendamenti[3] e l’abolizione di altre entrate
richiesero profonde trasformazioni nelle strutture amministrative
dell’assistenza e della beneficenza e resero necessario un più diretto impegno
finanziario da parte dello stato» (Lepre, 1985, p. 10).
Se il 1789 rappresenta uno spartiacque della storia moderna
europea anche dal punto di vista sanitario, appare sorprendente il tempismo con
cui, proprio nel novembre di questo stesso anno, come già evidenziato, il Re di
Napoli in persona avesse autorizzato la stampa del Codice di S. Leucio, il cui
carattere etico-egualitario (ispirato a un programma di rinnovamento sociale di
stampo illuministico redatto vent’anni prima dall’allora ministro Bernardo
Tanucci) appariva molto aggiornato e moderno anche nella cura degli aspetti
socio-assistenziali. Tale circostanza era del tutto coerente rispetto alle
finalità complessive della colonia leuciana – ispirata al concetto, tipicamente
settecentesco, di “pubblica felicità” (ossia di benessere psico-fisico della
collettività, come ribadito da illuministi del calibro di L. A. Muratori)[4] e,
quindi, di salute pubblica – ma rifletteva, al contempo, un obiettivo politico
primario dei governi “illuminati”, che nella seconda metà del XVIII secolo vi
avevano dato ampio spazio nei loro programmi, ponendo mano a una profonda
riorganizzazione del sistema ospedaliero (Garbellotti, 2003, p. 124). Il Real
Albergo de' Poveri di Napol (stampa di Gatti e Duca). Secondo le sue originarie
finalità doveva essere un luogo di carità e assistenza per bisognosi e
indigenti. L’interesse dei monarchi nei confronti della salute pubblica, d’altra
parte, non era semplicemente un atteggiamento di tipo filantropico, ma
espressione della necessità di controllare globalmente il corpo sociale su cui
esercitavano la propria legislazione nonché «garanzia di efficienza, di
produttività, di ricchezza», che li spingeva altresì a «interessarsi
direttamente delle condizioni di vita di tutta la popolazione e delle condizioni
di lavoro della popolazione attiva» (Cosmacini, 1988, p. 253). Alla luce delle
precedenti considerazioni, è logico supporre che anche sotto questo aspetto il
re Ferdinando dovesse essere stato non poco influenzato dalla cultura e dalle
idee progressiste di sua moglie, Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, nonché dal
confronto con il cognato Pietro Leopoldo, esempio emblematico di riformismo
illuminato nella gestione sanitaria della Toscana. La regolamentazione della
sanità pubblica nella Real Colonia di S. Leucio, organicamente correlata ad
altri tipi di forme assistenziali contemplate dall’intero corpus normativo, non
si limitava tuttavia a emulare le tendenze ideologiche ad essa contemporanee: lo
Statuto, infatti, si ispirava concretamente ai più avanzati criteri sanitari del
XVIII secolo, che si sarebbero affermati in Europa e nel resto della penisola
italiana solo nel corso della prima metà dell’800. Pertanto, diviene possibile
rilevarne e apprezzarne il pregnante significato solo ponendoli in correlazione
con i principi di regolamentazione sociale, istituzionale ed etica che
caratterizzano il documento nel suo insieme, nonché analizzandoli alla luce del
contesto utopistico-pianificatorio e, almeno in parte, della coeva situazione
storica della medicina e della sanità in Italia. Lo studio del medico (tratto da
Paul Lacroix, "L'école et la science jusqu'à la Renaissance", Paris,
Firmin-Didot, 1887) Rispetto a quest’ultima, la concezione sanitaria del Codice
è senza dubbio all’avanguardia, recependo i dettami di «nuova impostazione del
problema salute, sia sul piano individuale che sul piano sociale», alla cui luce
medici e non medici, «nel clima di razionalità e fervore creato a Milano come a
Firenze dalle riforme teresiane-giuseppine-leopoldine, nutrono interessi di
medicina razionale, di salubrità ambientale, di sanità, di scientificità,
fortemente ravvivati dalla circolazione d’idee che muove dall’Inghilterra e
dalla Francia» (Cosmacini, 1988, p. 251). È insomma evidente l’influenza
dell’Austria sull’orientamento ideologico dell’autore dello Statuto, che, a
prescindere dalla sua identità, dà prova di avere ben compreso l’importanza di
alcuni risultati scientifici della scienza medica dell’epoca (spesso contestati
e rifiutati dalla popolazione per ignoranza e sulla base di insensati
pregiudizi), considerando la salute pubblica come un bene da preservare e
curare, sia dal punto di vista materiale che spirituale, sulla base di procedure
controllate e in luoghi deputati allo scopo. Di qui, contrariamente alla prassi
diffusa del tempo, la concezione statutaria dell’ospedale come luogo destinato
esclusivamente alla cura dei malati, dotato di una classe medica fornita
direttamente dal re (al servizio dello stato e quindi qualificata) e monitorato
quotidianamente per il rispetto delle più elementari nozioni igienico-sanitarie
(Ferdinando IV, 1789, pp. 37-38). Il riformismo dello Statuto contribuisce a
dare così avvio al processo formativo dell’ospedale così come oggi concepito,
basandosi su una concezione medico-sanitaria lontana dalle finalità
genericamente assistenziali, curative ma anche formative, rieducative e
repressive degli istituti ospedalieri d’età moderna. Questi ultimi costituivano
infatti dei veri e propri centri di accoglienza, controllo e rieducazione per
malati, mendicanti, indigenti e disadattati in generale, generalmente
considerati (a eccezione dei casi di oggettiva inabilità al lavoro) dei
fannulloni e dei parassiti sociali. Pertanto l’istruzione, a partire dalla
seconda metà del Settecento, «cominciò ad essere considerata anche come una
sorta di arma per sconfiggere l’ignoranza che stava alla base dei comportamenti
devianti», per educare i poveri al lavoro, alla disciplina e ottenerne il
recupero sociale. Tali erano i presupposti ideologici dello stesso Albergo dei
Poveri di Napoli, conformemente al programma di Tanucci («che moveva dalla
premessa etica fondamentale del Genovesi» della necessità di educare il popolo,
sollevandolo dallo stato di ignoranza e abiezione in cui versava: Tescione,
1932, p. 126). Il Codice di S. Leucio, pur accogliendo tali istanze, le affronta
con criteri moderni, predisponendo per ciascuna di esse una differente e
peculiare destinazione istituzionale: la “Cassa della Carità”, per il sostegno
materiale ed economico di quanti fossero divenuti inabili al lavoro per causa di
forza maggiore (nonché, in caso di morte, per il pagamento delle spese
necessarie all’esequie); la “Casa degli Infermi” (ossia l’ospedale), con
funzioni curative e assistenziali di tipo sanitario; la “Scuola normale”, per la
formazione scolastica e lavorativa dei fanciulli di entrambi i sessi,
obbligatoria a partire dai sei anni di età. Tra questi istituti, la “Cassa della
Carità” è dunque delegata a sostenere le spese di assistenza socio-sanitaria ai
coloni in difficoltà. La sua denominazione, tuttavia, risulta ingannevole,
lasciando immaginare che si fondi su principi generici di associazione e di
solidarietà umana (che pure ne costituiscono un presupposto). Al contrario, la
“Cassa della Carità” non rappresenta un istituto di elemosina collettiva, ma una
sorta di “fondo malattie”, con finalità analoghe a quelle degli attuali enti di
previdenza sociale, «nei quali direttamente o indirettamente si attua l’attività
dei gruppi o dello Stato volta ad eliminare negli individui il bisogno di
ricorrere alla beneficenza, a prevenire la miseria mediante il concorso di cloro
stessi che sono destinati a beneficiarne» (Dal Pane, 1958, p. 317). Pertanto, la
“Cassa della carità”, fondata sul risparmio degli interessati (i contributi
mensili e proporzionali al reddito dei lavoratori della colonia) rappresenta un
esempio di ente previdenziale ante litteram. I leuciani caduti in miseria «o per
vecchiaia, o per infermità, o per altra fatal disgrazia, ma non mai per
pigrizia, ovvero infingardaggine» hanno maturato il diritto di essere
assistititi in virtù del loro pregresso e costante contributo “previdenziale”.
Non a caso, i coloni morosi a oltranza perdono il diritto all’assistenza, sia in
caso di disgrazia che di morte, mentre i maleducati, gli oziosi e gli sfaticati
recidivi sono espulsi dalla colonia. La concezione della previdenza
socio-sanitaria dello Statuto di S. Leucio s’inserisce quindi a pieno titolo nel
moderno sistema di norme e istituti fondati sul diritto dei lavoratori
all’assistenza, «compiuta a mezzo di fondi costituiti dai risparmi dei
lavoratori stessi». A tale proposito, risultano molto interessanti anche le
norme sull’orario di lavoro (tanto più perché quasi sconosciute in quest’epoca),
che lo fissavano in due turni, di durata analoga a quella della luce solare, con
il solo intervallo del pranzo. Assistenzialismo, economia e politica, dunque,
nello Statuto s’intrecciano indissolubilmente, a partire da un’idea di pubblica
assistenza, cura e prevenzione molto più ampia di quella strettamente medica,
essendo inteso il benessere della persona nel suo significato complessivo,
fisiologico, morale, psicologico e giuridico (come emerge anche dal nesso
individuato da Ferdinando IV tra il rapido aumento degli abitanti della colonia
e la bontà dell’aria, la tranquillità e la pace domestica in cui vivevano).
La modernità degli aspetti sanitari del Codice è ulteriormente
confermata se comparata con le disposizioni sanitarie relative
all’amministrazione del Regno di Napoli emanate nel 1808 da Gioacchino Murat
(con la separazione delle istituzioni medico-ospedaliere da quelle
filantropiche, la nascita di nuovi ospedali e il controllo statale
dell’assistenza sanitaria), le cui disposizioni sarebbero state ampiamente
recepite dalla legge del ripristinato regno borbonico del 20 ottobre 1819 «sulla
pubblica salute ne’ domini di qua e di là del Faro». Non a caso, negli anni
Venti, data organica e definitiva sistemazione a tutta la decretazione in
materia sanitaria, la legislazione del Regno delle Due Sicilie si rivela «una
delle più analitiche e dettagliate degli stati preunitari» (Botti, 1988, pp.
1222-1223). Se tale circostanza può essere attribuita all’influenza francese
sulla presa di coscienza borbonica dell’importanza della salute pubblica per il
buon governo del Regno (Botti, 1988, p. 1222), non si può tuttavia dimenticare
che il Codice dimostri come, almeno sul piano ideologico e “laboratoriale”, i
Borbone avessero impostato in chiave moderna la gestione del problema sanitario
ben prima della conquista francese del Regno di Napoli. Gli aspetti innovativi
in campo sanitario del Codice, d’altra parte, rientrano nelle finalità sociali
insite nell’esperimento di S. Leucio e nel piano di iniziative organicamente
coordinate promosse da Ferdinando IV, basate su un consolidato corpus
legislativo: gli articoli richiamano infatti elementi di diritto privato,
pubblico, civile e penale e, per alcuni versi, riflettono atteggiamenti
culturali caratteristici della cultura del XVIII secolo (tra cui la condanna
senza appello dei fannulloni e dei renitenti al lavoro). L’ispirazione giuridica
del Codice coesiste inoltre con quella religiosa, subito affermata nella pagina
iniziale del testo, con il richiamo all’obbligo di osservare la Legge divina
dell’amore verso Dio e verso il prossimo (prima regola che Ferdinando impone ai
suoi coloni: Ferdinando IV, 1789, p. 11), seguito dall’elencazione dei “Doveri
negativi” (Cap. I) e dei “Doveri Positivi” (Cap. II: cfr. nota 2). Nell’ambito
di questi ultimi rientrano le regole sanitarie, con preliminari e importanti
richiami alle norme igieniche fondamentali per il vivere civile. Ai
coloni-lavoratori, infatti, è innanzitutto ordinato «che estrema sia la
nettezza, e la polizia sopra le vostre persone […]: che questa polizia sia anche
esattamente osservata nelle vostre case, acciò possa godersi di quella perfetta
sanità, ch’è tanto necessaria nelle persone, che vivono con l’industria delle
braccia». L’osservanza della norma è oggetto di verifica e controllo quotidiano
da parte dei magistrati civili (detti “Seniori del popolo”), vigilanti della
colonia con funzioni di giudici di pace, i cui rapporti sono consegnati
direttamente al re (Ferdinando IV, 1789, pp. 23-24 e p. 44). Se il richiamo alla
scrupolosa cura della pulizia personale e delle abitazioni può oggi sembrare
quasi superfluo, se ne comprenderà appieno la ragione in considerazione della
sua estrema importanza non solo per il decoro personale e il rispetto della
convivenza sociale, ma anche per la prevenzione delle malattie infettive ed
epidemiche, a fronte dell’esistenza tra la popolazione del XVIII secolo di
abitudini e convincimenti arcaici e pseudo-religiosi, spesso sostenuti dagli
stessi medici, tra cui quello di lavarsi poco o di non lavarsi affatto,
soprattutto in caso di malattia (Cosmacini, 1988, pp. 214-215). D’altra parte le
condizioni materiali dei lavoratori del tempo erano decisamente miserrime: nei
primi stabilimenti manifatturieri, tra cui quelli dei fabbricanti di seta, le
testimonianze storiche sottolineano come «gli imprenditori non si preoccupassero
dell’igiene del lavoro»: i procedimenti tecnici in uso, spesso pregiudizievoli
alla salute degli operai, «non erano accompagnati dalle misure igieniche
necessarie a prevenire le dannose esalazioni delle materie lavorate, le attive
condizioni dell’ambiente di lavoro, le malattie professionali […] Del resto lo
stato di fatto si rivela in tutto rispondente alla modesta cultura igienica del
tempo alle scarse preoccupazioni governative per questo ordine di pubblici
interessi, per la stessa igiene generale». Nel secolo successivo la situazione
non era migliore. La “Statistica” del Regno di Napoli (redatta nel 1811 per
volere di G. Murat) offre, per bocca del redattore canonico Francesco Perrini,
ampie testimonianze delle infelici condizioni di vita della popolazione delle
provincie del Regno: colpisce l’abituale uso di acqua poco pulita,
l’alimentazione scadente, le condizioni igieniche disastrose (la vita quotidiana
si svolgeva in case piccole, male areate, umide e fatiscenti, in promiscua
coabitazione con gli animali da cortile e/o da allevamento), la diffusione della
malaria (Demarco, 1988, pp. 209-254). Aggiunta alla denutrizione e alla fatica
eccessiva dei lavoratori, tale situazione favoriva il proliferare dei contagi,
drammaticamente diffusi in questo periodo: se a metà Settecento la peste era
scomparsa dall’Europa (con l’eccezione in Italia dell’epidemia di Marsiglia del
1720 e di quella di Messina e Reggio nel 1743), «un altro flagello, il vaiolo,
ha preso il suo posto nel determinare la morbosità-mortalità catastrofica della
popolazione europea. Ciò vale ancor di più per la popolazione italiana,
risparmiata dalla peste con alcuni decenni d’anticipo rispetto alla popolazione
di altri paesi e flagellata invece dal vaiolo con grande frequenza e intensità»
(Cosmacini, 1988, p. 238). Di qui il richiamo del Codice all’ordine e alla
massima pulizia possibili, con particolare riguardo alla “Casa degli Infermi”,
il centro di accoglienza e di cura per i malati, amministrato da specifici
regolamenti interni, e anch’esso quotidianamente ispezionato dai “Seniori del
Popolo”, aventi il compito di verificarne le condizioni igieniche e l’esatta e
scrupolosa assistenza materiale e spirituale offerta ai malati[18]. La “Casa
degli Infermi” è dunque progettata in ossequio ai principi di salubrità e
disinfezione richiesti dalle sue finalità specifiche. Nel passaggio dalla
cosiddetta medicina ‘al letto del malato’ (ossia a domicilio) a quella clinica
‘ospedaliera’ (secondo la definizione del Keel, 2007), nonché alla luce delle
più avanzate conoscenze scientifiche del tempo, il Codice si allinea in tal modo
alle informative mediche del Settecento, che richiedevano la creazione di
ambienti spaziosi, riscaldati e ben ventilati (Scotti, 1984, citato da
Garbellotti, p. 126), progettando la costruzione di questa Casa come «separata
totalmente dall’altre in luogo d’aria buona, e ventilata», per la cura di tutti
gli ammalati, cronici e non (Ferdinando IV, 1789, p. 47). Questo semplice
progetto, pur rimasto tale, appare in tutta la sua importanza se si considera
l’abituale stato di disordine, sporcizia e cattivo odore degli ospedali
settecenteschi (eclatante, a riguardo, la diffusa e inumana pratica di
risparmiare spazio sistemando due malati in uno stesso letto), progressivamente
superato solo nel corso del XIX secolo. Ciò premesso, la funzione prioritaria
assegnata dal Codice alla “Casa degli Infermi” è innanzitutto di tipo
preventivo: ogni anno, infatti, nei periodi precedenti le grandi epidemie
(primavera e autunno), per tutti i ragazzi e ragazze della colonia leuciana è
«prescritta la inoculazione del vaiuolo, che i magistrati del popolo faranno
eseguire senza che vi s’interponga autorità o tenerezza de’genitori» (Colletta,
1856, tomo I, p. 138), al fine di scongiurare i pericoli derivanti da una loro
eventuale esposizione al contagio della terribile malattia. Il richiamo
all’obbligatorietà dell’innesto del vaiolo si richiamava a un dispaccio reale
che prescriveva tale pratica in tutto il Regno è uno dei principali elementi di
modernità del Codice, che si inserisce in tal modo nel dibattito su una delle
più accese questioni scientifiche e culturali dell’Italia del Settecento. Il
metodo dell’innesto, detto «della variolizzazione, cioè della inoculazione a
scopo profilattico del vaiolo umano (la cui forma più grave, o variola maior,
prevale nel Settecento sulla forma più lieve, o variola minor), nasce da una
pratica che circassi e cinesi, esperti del male […], attuavano da secoli in
Oriente», volta a provocare una manifestazione della malattia in forma lieve,
che immunizzava la persona dal contagio. Il dibattito tra fautori e oppositori
dell’innesto, tuttavia, a cui presero parte anche intellettuali del calibro di
Pietro Verri, non si riduceva schematicamente a una lotta tra progressisti e
conservatori, essendo controversi i risultati dell’inoculazione: quest’ultima,
di fatto, era priva di un sicuro metodo applicativo e, dunque, se praticata in
modo erroneo, diventava rischiosa, in alcuni casi, addirittura letale.
Ciò nonostante, la pratica produceva senza dubbio più benefici
che danni; nel 1756, infatti, l’imperatrice Maria Teresa d’Austria (la cui
stessa famiglia era stata decimata dal male), sentiti i pareri favorevoli di
vari consulenti, dava l’assenso affinché venisse impiegata in Toscana, colpita
da una violenta epidemia di vaiolo. Di qui il «”primato della Toscana nella
battaglia per l’innesto”, sullo sfondo del temperato riformismo della Reggenza
lorenese e poi del riformismo progressista del granduca Pietro Leopoldo» e
ancora di qui la convinta adesione alla pratica dell’innesto da parte di
Ferdinando IV di Borbone, che, dopo aver perduto due figli nel 1788 a causa del
contagio, vi avrebbe sottoposto il resto della prole.
I VENTICINQUE PRIMATI DI MESSINA AL TEMPO DEL BORBONE.
Michele Eugenio Di Carlo su Movimento 24 Agosto - Equità
Territoriale il 250 maggio 2020. Di Alessandro Fumia.
Nel 1735: Primo Teatro d'opera con orchestra (teatro della
Munizione restaurato), fondato nel regno delle due Sicilie nel 1724 durante il
governo della dinastia austriaca.
Nel 1741: Prima Operetta dedicata da un autore italiano a un
ambasciatore turco, giunto a Messina con delegazione imperiale per firmare
trattato di pace, libero commercio e navigazione, stipulato tra il regno delle
due Sicilie e la Porta Ottomana.
Nel 1751: Prima Compagnia di Real Bandiera per il commercio
internazionale in Italia fondata a Messina.
Nel 1752: Prima Banca Commerciale Nel 1752: Prima Banca
Commerciale Azionaria in Italia, attiva nel Regno duo siciliano, fondata a
Messina.
Nel 1801: Prima opera pubblica per dimensione, la Palazzata, fu
considerata l’ottava meraviglia del mondo per estensione lineare duemila metri,
alta venti metri ricopriva tutta la cortina del porto.
Nel 1803: Primo Palazzo della Borsa (stanze della Borsa presso
palazzo Broadbent nella Palazzata) d’Italia fondato a Messina.
Nel 1804: Prima spedizione di casse di cedrate di Messina in
Russia.
Nel 1805: Primo Cacciatorpediniere (gun-boats) costruito nel
cantiere navale di Messina venduto alla marina degli Stati Uniti d’America, su
mandato del presidente Thomas Jefferson.
Nel 1807: Prima spedizione di arance di Messina in America.
Nel 1810; Prima sconfitta di un esercito di Napoleone Bonaparte
presso i villaggi di mezzogiorno di Messina.
Nel 1819: Primo Compressore Chirurgico brevettato in Europa,
eseguito per la fasciatura dell’aorta e dei grandi vasi sanguigni, dal
professore messinese, dottore Natale Catanoso, consistente in una piccola
tenaglia a molla per bloccare le suture aortiche, eseguendo con questa tecnica
due interventi chirurgici riusciti, presso il grande ospedale di Messina.
Nel 1819: Prima Scoperta dell’Acido Borico Libero in Natura al
mondo, del chimico messinese Gioacchino Arrosto, presso una cavea nell’isola di
Vulcano, segnalata dal Sig. Lucas in una lettera emessa e datata a Messina, il
31 luglio 1819.
Nel 1824: Prima riproduzione di Flora Artificiale a Rilievo al
mondo, prodotta per fini scientifici (botanica) dal dottore Anastasio Cocco, e
realizzate in pasta di cera dai maestri messinesi Pasquale Principato ed
Emmanuele Calamita.
Nel 1825: Prima Cattedra di Ostetricia, Anatomia e Clinica
Cerusica del Regno delle due Sicilie fondata in Italia, istituita a Messina
presso l'Accademia Carolina.
Nel 1832: Primo Acquario Pubblico per osservazione animali marini
al mondo, la celebre gabbia alla Power costruita a Messina dall’affermata
studiosa di scienze naturali Jannette Villepreux Power.
Nel 1833: Prima Cattedra di Diritto Nautico Commerciale d'Italia,
istituita a Messina.
Nel 1834: Prima Catena Meccanica di trasmissione, o di trazione
costruita in Italia inventata dal messinese Antonio Grillo.
Nel 1835: Prima Preparazione pura di Acido Citrico al mondo,
inventata da Letterio Centorrino.
Nel 1836: Prima Vettura a Vapore a ruote di ferro per strade
carrabili (automobile), prodotta da Tommaso Anselmi (torinese) e Giuseppe de
Natale (messinese) in Italia, su decreto reale del 1836.
Sempre nel 1836: Prima Pistola a percussione per quattro colpi
inventata da Francesco Moschella di Tripi (Messina) fabbricata in Europa.
Nel 1845: Prima applicazione di Acido Ascorbico solubile per
produrre vitamina C al mondo, scoperta a Messina dal chimico Natale Aloisio.
Sempre l’anno 1845: Prima invenzione di un Sonometro in Italia
realizzato dal fisico messinese Antonio Costa Saya.
Nel 1846: Prima Cura Cataratta incipiente al mondo, eseguita
attraverso un metodo chimico-terapeutico inventato dall'oftalmologo dottor M.
Pugliatti di Messina.
Nel 1851: Primo Smacchiatore per fibre tessili al mondo,
inventato a Messina.
Nel 1860: Prima Pila al cloruro di sodio, brevettata
dall'elettrotecnico messinese Tommaso Lucifero, ma registrata in Italia sei mesi
dopo presentandola nell’esposizione di Firenze.
·
Il Sud Sbancato.
MEZZOGIORNO BANCO-ROTTO: Il sistema bancario del Sud non c’è
più, è stato espropriato dalle banche del Nord. La
soluzione adottata per far fronte ai problemi legati al territorio è stata
quella di azzerare il sistema, sostituendolo con operatori esterni. Pietro
Massimo Busetta su Il Quotidiano del Sud il 10 ottobre 2020. Pubblichiamo la
premessa del libro “Mezzogiorno banco-rotto” scritto da Pietro Massimo Busetta e
Rainer Masera. Presso i romani coloro che commerciavano in denaro, banchieri o
cambia-valute, stavano dinanzi ad un banco che veniva chiamato mensa argentaria,
sul quale disponevano il denaro necessario per gli affari della giornata. Da
tale uso derivano i termini Banchiere e Banca rotta, che poi passarono anche nel
linguaggio inglese e francese grazie ai fiorentini (…) Tale terminologia deriva,
quindi, dal Medioevo: quando un commerciante o un banchiere dichiarava
Bancarotta (…) In realtà il banco che si è rotto, del titolo, è quello del
Mezzogiorno (…) Il tema di fondo, attorno al quale ruotano i lavori che sono
stati raccolti in questo volume, riguarda la domanda se serva un sistema
bancario articolato in realtà piccole, medie e grandi, o piuttosto sia più
efficiente una concentrazione in strutture grandi (…) La teoria che le maggiori
dimensioni siano sempre le più efficienti trova sostenitori ma anche detrattori.
Peraltro le esperienze sul campo dei vari paesi sono molto diversificate. Ed
anche la teoria che le economie di scala debbano riverberarsi positivamente sui
costi di intermediazione è tutta da dimostrare (…) In tale dibattito si
inserisce il tema dei controlli che l’Organo di Vigilanza ormai, con sempre
maggiori oneri, continua ad imporre, con richieste simili alle piccole come alle
grandi strutture bancarie, penalizzando in tal modo le realtà minori o less
significant. In questo volume vi sono cinque contributi, scritti da sette Autori
che hanno grande competenza nel settore del credito (…) Piero Alessandrini e
Luca Papi, partendo da un’analisi sugli effetti della recente crisi finanziaria,
iniziata nel 2007, sul sistema bancario, sia sotto l’aspetto strutturale, che in
rapporto alla qualità del credito, cercano di delineare le possibili prospettive
per il sistema bancario ed in particolare pongono l’attenzione sugli effetti che
l’innovazione tecnologica e la regolamentazione bancaria avranno sulle banche
locali e less significant. Pietro Busetta e Salvatore Sacco, propongono una
riflessione sull’atteggiamento con cui la classe dirigente nazionale ha
costantemente affrontato l’irrisolta problematica del dualismo, che, nella
vicenda del sistema bancario del Mezzogiorno, trova il suo acme e la sua
metafora. Infatti, a fronte degli enormi problemi che, inevitabilmente, per le
banche espressione di quel territorio comportava l’operare in quelle aree
(compresi, talvolta, i collegamenti perversi con la criminalità organizzata), la
soluzione adottata è stata quella dell’azzeramento di quel sistema,
sostituendolo con operatori esterni (…) Il lavoro propone un confronto con
quanto avvenuto a seguito delle due grandi crisi strutturali del sistema
bancario nazionale (1992-95 e 2007-2010), in termini di soluzioni adottate e di
costi per la collettività (e per il Mezzogiorno in particolare). Vengono
evidenziate anche le differenze dell’impatto sui sistemi bancari nazionali di
altri paesi europei, anche in funzione dell’azione delle diverse autorità
competenti, del progressivo appesantimento della regolamentazione comunitaria e
sovranazionale, registratosi negli ultimi due decenni. Giovanni Ferri si
interroga sugli effetti degli interventi di ristrutturazione del sistema
bancario, intercorsi negli ultimi 30 anni, sul processo di convergenza del
Mezzogiorno. Particolare rilevanza assumono nel suo lavoro i temi
dell’allontanamento dei centri decisionali, gravoso per il Mezzogiorno in
termini di perdita di capitale umano, oltre che del mutamento della struttura
proprietaria e quindi dei soggetti di riferimento; non più gli stakeholder ma
gli shareholder, determinando la fine della funzione sociale della banca nel
proprio territorio di riferimento . Viene evidenziato come tale approccio non
sia in linea con quanto avvenuto in realtà confrontabili come il Sud della
Spagna o la Germania Est (…) Adriano Giannola pone l’attenzione sulle
problematicità che comporta l’attuale struttura del sistema creditizio italiano,
che finiscono con l’accentuare, nel contesto nazionale, alcune distorsioni
presenti a livello sovrannazionale. Infatti, proponendo una misurazione
dell’impatto della cosiddetta “austerità espansiva” sul sistema economico nel
suo complesso, evidenzia come il mercato creditizio interno abbia svolto una
rilevante funzione pro ciclica, aggravando ulteriormente la situazione
complessiva del contesto economico italiano (…) Infine, Rainer Masera, nel suo
contributo, cerca di individuare le similarità o le divergenze nella
regolamentazione e nella operatività, delle banche di comunità degli Usa e
dell’Eurozona (…) È necessario per Masera, che i policy maker rivalutino
criticamente il loro operato, che, ricercando oggettive ed astratte economie di
scala, rischia di generare diseconomie di regolamentazione, con gravi effetti
distorsivi sulla concorrenza. In sintesi scopo di questo volume è quello di
alimentare un dibattito sul sistema bancario nazionale, che, contrariamente a
quello che è avvenuto in altri Paesi industrializzati, in Italia ha visto
prevalerne alcune, senza un vero dibattito. (…) Quindi doppio problema, quello
dimensionale e quello localizzativo, che ha portato le piccole e medie imprese a
non avere più quel credito che a loro serve, attraverso l’accentuazione delle
perniciose pratiche di razionamento. Ed il tema che si affronta in diversi
lavori è quello che le realtà più piccole potrebbero avere più bisogno delle
cosiddette banche di contiguità, che per le loro dimensioni, meglio dialogano
con strutture più contenute e con i loro centri decisionali vicini. Senza
contare il fatto che spesso alcune realtà imprenditoriali, per il sommerso che
hanno, mal vengono rappresentate dai dati ufficiali dei bilanci (…). Fatti che
incidono sulla redditività di qualsiasi attività e che, probabilmente, solo una
banca di contiguità può tenere adeguatamente presente. L’obiettivo che si vuole
perseguire con questo lavoro è quello di mettere in discussione alcuni assunti
che sembrano, anche se non dimostrati, assurgere a verità incontrastate,…
IL SUD
SBANCATO: CAUSE E RESPONSABILITA’ DELLA POLITICA AL SERVIZIO DELLA FINANZA DEL
NORD.
Michele Eugenio Di Carlo il 04.09.2020 su movimento24agosto.it.
Negli ultimi trent’anni il sistema bancario del Sud è stato praticamente
smantellato e acquisito in gran parte da istituti del Nord. E’ un altro segno
inequivocabile dello strabismo con cui le politiche governative hanno inteso
garantire un’inesistente Questione settentrionale di fattura leghista al fine di
annullare l’esistente e sempre più preoccupante Questione meridionale, tanto che
il tasso di disuguaglianza del Mezzogiorno nel confronto con il resto d’Italia e
d’Europa è arrivato a livelli tali che chi ha governato negli ultimi trent’anni
non dovrebbe fare altro che pentirsi e chiedere scusa. Giova nuovamente
segnalare il punto di quasi non ritorno in cui politiche discriminatorie hanno
portato il Mezzogiorno: esodo forzato di milioni di cittadini costretti ad
emigrare con perdita di un enorme capitale umano, fattore principale nei
processi di crescita e di sviluppo; desertificazione di intere aree interne che
hanno perso servizi e infrastrutture fondamentali; disoccupazione giovanile in
alcune aree al 60% con un processo di invecchiamento della popolazione che non
riserva nessuna possibilità di futuro; carenze ormai croniche di infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie, aeroportuali, portuali, penalizzanti lo
sviluppo in tutti i settori; nuove tecnologia applicate all’economia, alla
cultura, ai servizi spesso inesistenti, altre volte inadeguate; perdita di
fiducia nelle istituzioni democratiche, fattore che alimenta populismi e genera
disagio sociale.
Quali le cause
che hanno reso cieche le politiche governative degli ultimi trent’anni e del
tutto inutili i partiti nazionali del PUN (partito unico del nord)?
Innanzitutto
il trasferimento del potere decisorio reale dalla politica alla finanza con
politiche che hanno privilegiato gli interessi privati di grandi gruppi
finanziari, spesso multinazionali, a scapito di quel “bene comune” (ambiente,
salute, occupazione e qualità del lavoro, diritti, partecipazione, assistenza,
solidarietà, servizi sociali, cultura, ricerca e formazione), che la politica
aveva saputo conservare e alimentare fino agli anni Ottanta. La foga delle
privatizzazioni, ad esempio: una vera tendenza verso le politiche ultraliberiste
reaganiane e thatcheriane che ha sottratto al controllo dello Stato italiano
importanti e vitali settori, messi a disposizione di gruppi finanziari che hanno
seguito la logica utilitaristica del libero mercato nell’ambito della
finanziarizzazione dell’economia, spesso solo virtuale, e basata su transazioni
finanziarie che spostano senza limiti e senza controllo capitali da una parte
all’altra del mondo. In altre parole, questi gruppi hanno assunto, anche grazie
al devastante sistema del finanziamento ai partiti, un controllo importante
nell’ambito delle decisioni politiche ed economiche, sostituendosi alla
politica, rendendo nulle le pretese sindacali, azzerando i diritti delle classi
lavoratrici e, in generale, dei cittadini comuni appartenenti alla classe media.
La crisi finanziaria che ci portiamo dietro dal 2008, e che penalizza
particolarmente il Mezzogiorno, iniziata con il fallimento della Lehman
Brothers a seguito della bolla immobiliare legata ai prestiti dei
mutui subprime, è il frutto dell’invasione della finanza nella politica con
partiti ridotti ad un ruolo gregario, al comando dei quali spesso vengono ormai
messe personalità vuote di capacità progettualità e manovrati da media asserviti
che li creano e li distruggono a seconda degli interessi di chi controlla
realmente il potere. É sotto questi aspetti complessi e articolati che bisogna
analizzare il crollo che ha portato allo smantellamento del sistema bancario del
sud Italia. Un crollo che presenta fasi ben precise che sono state illustrate
puntualmente, in relazione agli ultimi decenni, dal giornalista del “Mattino”
di Napoli Marco Esposito, nel testo “Separiamoci” (Separiamoci. Il Sud può fare
da sé, Milano, Magenes, 2019, 3ª ediz.). Nel 1990, con la legge del
piemontese Giuliano Amato inizia il processo di trasformazione del sistema
creditizio italiano in soggetto di diritto privato, spingendo con incentivi
fiscali le banche, enti di diritto pubblico, «a separare la propria attività in
due: una fondazione e una banca società per azioni, con la prima proprietaria al
100% della seconda». Se nella prima fase la legge obbliga le fondazioni a
mantenere il controllo delle banche, nella seconda impone l’obbligo di scendere
al di sotto del 50% con il risultato finale che le banche passano ad un sistema
che permette la scalata del più forte. Dopo il referendum del 1993, la nomina
dei vertici delle fondazioni passa dal Governo agli Enti Locali e Antonio Fazio,
governatore della Banca d’Italia, consente che i grandi gruppi finanziari del
Nord assorbano anche i colossi creditizi del Sud, come ad esempio il Banco di
Napoli. Ed ecco che «le fondazioni bancarie erogano fondi e sostengono servizi
per il 93% al Centro-nord e per il 7% al Sud». Nel mentre i gruppi bancari del
Nord acquisiscono una alla volta le banche meridionali e quelle romane,
l’’elenco delle fondazioni, all’origine banchi e casse di risparmio risalenti
anche al Cinquecento, che cedono il controllo negli anni Novanta a Istituti del
Nord è «impressionante». Gli istituti acquisiti dalla sola Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna tra il 1994 e il 2000 sono i seguenti: Banca del Monte di
Foggia, Cassa Rurale di Sicignano negli Alburni, Banca Popolare del Materano,
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca Popolare di Crotone, Credito
Commerciale Tirreno, Banca Popolare della Val D'agri, Banca Popolare del Sinni,
Banca Popolare di Castrovillari e Corigliano Calabro, Banca Popolare di Salerno,
Carispaq-Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, Banca Popolare
dell’Irpinia. Ma l’elenco non sarebbe completo se non si tenesse conto della
perdita dei seguenti altri istituti: Banca Sannitica, Banca del Salento, Banca
Popolare di Napoli, Banca della Provincia di Napoli, Credito Commerciale
Tirreno, Banca Mediterranea. Appena qualche giorno fa, Marco Esposito sulle
pagine del “Mattino” del 21 agosto, in un articolo titolato “Fondazioni
bancarie, trent’anni di egoismi: Nord batte Sud 20-1”, precisa ancora meglio la
questione delle fondazioni bancarie, ripercorrendo le tappe della loro
evoluzione degli ultimi decenni e precisando che gli 88 enti che sostengono
l’arte, la cultura, la sanità, la ricerca, la solidarietà, erogano i propri
fondi con una percentuale sempre più sbilanciata a favore del Nord; infatti dei
40 miliardi assegnati in 28 anni, mai il Sud ha superato la soglia del 5% per
sostenere la propria cultura, sanità, ricerca, arte. Si ripropone nuovamente la
tesi che il divario del Mezzogiorno dal resto del paese non è più un caso a sé,
ma da analizzare e risolvere nel contesto in cui agiscono potenti multinazionali
e lobby finanziarie inseriti pienamente nei gangli vitati della politica, al
fine di condizionarne le scelte. Pubblicato sul quotidiano l'Attacco il 4
settembre 2020.
LA
DISTRUZIONE DELLE BANCHE MERIDIONALI. CONCENTRAZIONE BANCARIA ED ELIMINAZIONE
DEI PLAYERS BANCARI DEL SUD ITALIA: DAL BANCO DI NAPOLI AL BANCO DI SICILIA.
Michele Di Pace il 15.09.2020 su movimento24agosto.it. Di Luca
Lozupone.
Il quadro
normativo. A partire dal 1990 per effetto di pressioni internazionali, e dal
2005 anche di Banca d’Italia, è stato avviato un energico processo di
concentrazione bancaria. La legge Amato del 1990, infatti, recepiva le Direttive
europee ed equiparava gli istituti creditizi pubblici con quelli privati e
favoriva l’adozione, per le imprese sotto il controllo pubblico, di forme
societarie privatistiche. Le banche vengono incentivate a diventare società per
azioni. Per quanto riguarda il credito a medio-lungo termine venne resa
possibile la riunificazione in una sola società dell’attività di intermediazione
mobiliare svolta in precedenza da istituti diversi. Rendendosi necessaria una
separazione tra gestione e controllo delle banche, le partecipazioni bancarie
vennero affidate a determinati enti, le fondazioni, da cui venne scorporata
l’attività bancaria, conferita a società per azioni di cui le fondazioni stesse
possedevano inizialmente l’intero capitale: una forma dunque di privatizzazione
“formale” delle banche. Con la Legge 474 del 1994 si disciplinò poi la
privatizzazione “sostanziale”, cioè la dismissione delle partecipazioni in capo
alle fondazioni, incentivata attraverso vantaggi fiscali. Il Testo Unico del
1994 delle leggi in materia bancaria e creditizia sancisce l’attività bancaria
come attività imprenditoriale: le banche possono operare senza limitazione di
operazioni, servizi, scadenze nella raccolta ed impiego dei fondi, e possono
emettere obbligazioni e strumenti di deposito. Le parole d’ordine diventano
“imprenditorialità e libero mercato”. Cade la distinzione tra le banche di
deposito e istituti speciali di credito, presente fino ad allora nel sistema
italiano. Sotto la vigilanza della Banca d’Italia è consentita la commistione
dell’azionariato di banche e industrie. A partire da questo momento tutte le
banche diventano contendibili e inizia il processo frenetico di fusioni ed
acquisizioni a tutt’oggi non concluso. Se nel 1995 la quota di mercato detenuta
dalle prime cinque banche è del 32,36%, alla fine del 2017 passa al 43,3% (sul
totale degli attivi totali del sistema bancario italiano).
EFFETTI DELLA
DEREGULATION BANCARIA AL SUD ITALIA: IL CASO BANCO DI NAPOLI. Dopo
l’approvazione del Testo Unico bancario l’IRI cede le quote maggioritarie dei
due istituti bancari del Sud Italia: il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia
definiti dal Ministero del Tesoro come in “sostanziale fallimento”. Nel 1997 il
ministero del Tesoro cede il 60% del capitale del Banco di Napoli alla BN
Holding, detenuta al 51% dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA) e al
restante 49% dalla BNL. Nel 2000 la holding verrà acquisita da San Paolo-Imi. La
modalità di questa privatizzazione destarono subito la netta contrarietà
dell’allora presidente della fondazione del Banco di Napoli, Gustavo Minervini.
Infatti nel 1996 il ministero del Tesoro azzera il capitale sociale e
ricapitalizza il Banco, senza riconoscere alcun corrispettivo relativo al
diritto di opzione dei vecchi soci tra cui la Fondazione del Banco di Napoli.
Quindi nel 1997 la Fondazione è stata costretta a vendere ex-lege il Banco per
61 miliardi di lire alla Bnl e Ina (entrambi ancora di proprietà del ministero
del Tesoro), che l’hanno poi rivenduta nel 2000 a San Paolo-Imi per 3.600
miliardi. L’autore Rispoli Farina nel suo libro “Il caso Banco di Napoli”
descrive l’accaduto come una precisa volontà “espropriativa” della principale
banca del Sud Italia, espropriata appunto per salvare una banca italiana come la
Banca Nazionale del Lavoro. Infatti l’enorme plusvalenza permise il salvataggio
della Bnl che prima di allora era in perdita. A rendere l’operazione di
privatizzazione del Banco di Napoli ancora più sospetta è il passaggio a valore
di bilancio e pro soluto dei crediti deteriorati alla SGA (società di gestione
delle attività), quale bad bank. Ricapitolando il Banco paga SGA a valore di
bilancio per liberarsi dei suoi crediti deteriorati e, in caso di minusvalenze,
si impegna a ripianare le perdite della SGA. Quindi era stato predisposto un
ulteriore strumento di garanzia a favore dei futuri acquirenti del Banco di
Napoli che sarebbero stati sollevati dalle eventuali perdite generate dalla SGA.
È da notare che gli utili maturati dalla Società per la Gestione delle Attività
(SGA) sono stati acquisiti dal Tesoro e destinati al fondo Atlante II. Questi
capitali sono stati utilizzati dallo Stato italiano per intervenire nelle crisi
di Mps, banche venete che nulla hanno a che vedere con il territorio in cui
operò il Banco di Napoli. Purtroppo il saldo attivo della SGA non è mai stato
calcolato, e questo ha sicure responsabilità politiche, e quindi è impossibile
ad oggi ristorare i soci, cioè la Fondazione Banco di Napoli.
LA
PRIVATIZZAZIONE DEL BANCO DI SICILIA. Come per il Banco di Napoli, anche per il
Banco di Sicilia e Sicilcassa la legge Amato del 1990 ed il Testo Unico Bancario
del 1994, uniti alla confusione portata dallo scandalo “Tangentopoli”, sono
l’occasione per la sottrazione di importanti istituti di credito alle regioni
del Sud Italia. All’inizio degli anni novanta la linea della Banca d’Italia
appare chiara: togliere alla Regione siciliana il controllo del Banco di
Sicilia. Infatti la regione esprime tre componenti su cinque del Comitato
esecutivo del Banco. Il piano della Banca d’Italia è la sua fusione con la Banca
di Roma. Sarà aiutata in questo dal membro del consiglio di amministrazione
espresso dall’Istituto di vigilanza. Nel 1994 gli azionisti del Banco di Sicilia
sono tre: Fondazione con il 60%, Tesoro e la Regione siciliana con il 20% del
capitale ciascuno. Lo Stato italiano attraverso il Tesoro scende in campo per
realizzare il piano di Banca d’Italia: con 600 miliardi di lire di
ricapitalizzazione punta ad acquisire la maggioranza delle azioni. La fondazione
però, guidata da Carlo Dominici, chiede invece che prima venga determinato il
valore del Banco e poi si passi alla ricapitalizzazione. Dominici riesce a
prevalere. Per la valutazione del patrimonio viene incaricata Sofipa, società di
Mediocredito a sua volta controllato dal Tesoro. Per Sofipa il valore del Banco
di Sicilia ammonta a 3. 400 miliardi di lire. Ciò significa che con 600 miliardi
di lire il Tesoro non potrebbe acquisire il controllo del Banco. Ma questa
valutazione non viene tenuta in conto, anche perché risulta essere superiore
alla stima dei periti del Tribunale in sede di costituzione del Banco di Sicilia
spa. Viene quindi incaricata la Giuberga Worburg che valuta il Banco 1.200
miliardi. Cifra che corrisponde esattamente al capitale sociale. Più che una
valutazione sembra una svalutazione. Nel 1996 esplode il caso Sicilcassa che
registra perdite per 4mila miliardi di lire. L’occasione viene sfruttata da Roma
(Banca d’Italia e Tesoro) per spingere il Banco di Sicilia ad acquisire
Sicilcassa, che era in stato comatoso. Il ministro del Tesoro è Ciampi, Mario
Draghi è il direttore del Ministero del Tesoro e Vincenzo Fazio è il governatore
della Banca d’Italia. Probabilmente l’obiettivo è quello di rendere il rilancio
del Banco impossibile e quindi non in grado di resistere ad un’acquisizione di
un gruppo di fuori regione, quale sarà in seguito la Banca di Roma. Quindi
utilizzando la legge Sindona lo Stato inietta 3 mila e 600 miliardi di lire per
ricapitalizzare il Banco di Sicilia-Sicilcassa attraverso Mediocredito Centrale
che detiene ora il 40% delle azioni. Finalmente lo Stato italiano ha la
maggioranza delle azioni del Banco (forse era questa la vera ragione dietro la
spinta dello Stato ad acquisire la fallimentare Sicilcassa). Il Banco può essere
ora definitivamente spolpato e consegnato alla Banca di Roma. L’ultimo passaggio
avviene nel 2002. La rete bancaria del Banco di Sicilia viene fatta confluire
nella Banca di Roma mentre la holding che ne detiene le azioni prende il nome di
Capitalia. La Regione siciliana e la Fondazione Banco di Sicilia, che detenevano
ancora il 39% del capitale del Banco si ritrovano ora azionisti di minoranza
della holding Capitalia. Quindi il Banco risanato con i soldi statali
contribuirà agli utili della Banca di Roma, che diventerà Capitalia e poi
Unicredit. In conclusione la partecipazione al Banco di Sicilia è costata alla
Regione siciliana 600 miliardi di lire in aumenti di capitale per una banca che
ha spostato il suo centro decisionale prima a Roma e poi a Milano. Questo evento
avrebbe meritato ben altra attenzione pubblica e mediatica.
LA DISTRUZIONE
DEL SISTEMA BANCARIO AL SUD (PARTE II): LA BANCA POPOLARE DI BARI. Michele Di
Pace il 23.09.2020 su movimento24agosto.it. Di Luca Lozupone. “La decisione di
realizzare un’acquisizione resta sempre del vertice delle banche, la Vigilanza
non può imporla”. È quanto affermato dalla vicedirettrice della Banca d’Italia
Alessandra Perrazzelli, nel corso di un’audizione alla Camera dei Deputati il 9
gennaio 2020. Intercettazioni telefoniche e l’analisi dei fatti raccontano però
una storia diversa. La domanda era il perchè Banca d’Italia avesse autorizzato
alla Banca Popolare di Bari (BPB) di acquisire la Cassa di Risparmio di Teramo,
mossa che provocherà la crisi irreversibile della banca pugliese. Non è la prima
volta che Banca d’Italia finisce sul tavolo degli imputati in merito alla
carente vigilanza bancaria negli ultimi anni. Veneto Banca, Banca Popolare di
Vicenza e Monte dei Paschi di Siena sono gli esempi più lampanti. Si ricorda
che, con l’introduzione dell’Euro, la Vigilanza bancaria è l’unico compito
rimasto in capo a Banca d’Italia. La Popolare di Bari è stata una banca guidata,
fin dalla sua fondazione nel 1960, dalla famiglia Jacobini e gestita secondo il
modello di impresa familiare. Nel corso degli anni aveva accresciuto la propria
penetrazione commerciale espandendosi in Italia meridionale e centrale anche
grazie all’acquisizione di piccole banche locali e di sportelli di altre banche.
Nell’aprile 2009, però, dopo che BPB acquisisce la Cassa di Risparmio di Orvieto
la Banca d’Italia le richiede di astenersi da iniziative di ulteriore sviluppo.
La ragione è che deve irrobustire il proprio assetto organizzativo e di
controllo. O forse non si vuole una banca meridionale indipendente ed attiva che
faccia concorrenza ai giganti tosco-padani. È proprio per venire incontro ai
rilievi della Vigilanza che nel luglio 2013 viene nominato Luca Sabetta Chief
Risk Officer con il compito di verificare, ed in caso bloccare, tutte le
operazioni della Banca. A novembre di quell’anno si verifica un evento che
avrebbe cambiato per sempre la storia della Popolare: subentra infatti ad un
prestito di 480 milioni di euro che la Banca d’Italia aveva concesso alla Cassa
di Risparmio di Teramo (Tercas), la quale non era in condizioni ottimali essendo
in amministrazione straordinaria (l’anticamera del fallimento) da 18 mesi. In
pratica Tercas non sarebbe mai stata in grado di ripagare il prestito di quasi
mezzo miliardo di euro e l’intera operazione appariva da subito come un favore
di BPB a Banca d’Italia.
BANCA D’ITALIA
BLOCCA L’ESPANSIONE DELLA POPOLARE BARI. ANZI NO, PER TERCAS SI PUÒ FARE
UN’ECCEZIONE. La cosa stranissima ed inquietante è che BPB continua ad avere il
vincolo alla non espansione da parte della Vigilanza. Infatti per effetto di
questo stesso vincolo non ebbero esito un suo progetto di integrazione con
un’altra popolare nel 2010 e l’acquisizione di una partecipazione qualificata in
una finanziaria nel 2011 (fonte: Banca d’Italia – Domande e risposte sulla crisi
della Banca Popolare di Bari). Quindi integrazione con un’altra banca popolare
no, acquisizione di una banca in amministrazione straordinaria, prossima al
fallimento, sì. Stranissimo ed inquietante. “La decisione di realizzare
un’acquisizione resta sempre del vertice delle banche, la Vigilanza non può
imporla” raccontava in sede istituzionale l’alta dirigente di Banca d’Italia
Alessandra Perrazzelli. Non sembra questo il caso. Le condizioni contabili e
patrimoniali di Tercas appaiono subito drammatiche. “Abbiamo cominciato a
ricevere dei rapporti riservati sulla situazione di questa banca [Tercas] perché
quello che trovo qui è una situazione drammatica. Questi vanno cacciati tutti”
disse l’allora amministratore delegato Vincenzo De Bustis al c.r.o. Sabetta
riferendosi ai dirigenti della banca abruzzese. Il 25 novembre 2013 Sabetta
riceve una presentazione in power point sulla situazione di Tercas in cui
spiccano i 3,46 miliardi di euro di crediti deteriorati. La posizione di
Sabetta, in qualità di capo del rischio, è quella di non approvare
l’aquisizione. La BPB non hai i mezzi per integrare una Banca così problematica.
Ma qui avviene il colpo di scena. Il 13 dicembre del 2013, infatti, De Bustis
convoca Sabetta dicendogli che il Responsabile del Dipartimento di Vigilanza
bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo, ravvisava un
conflitto di interessi tra Sabetta e egli stesso poiché Sabetta e De Bustis
avevano lavorato insieme in altre banche (Banca del Salento-Banca 121 e Monte
dei Paschi di Siena). Barbagallo indicava quindi la necessità di una immediata
risoluzione del conflitto di interessi. Sabetta aveva effettivamente lavorato
con De Bustis, ma dodici anni prima ed in contesti diversi. Secondo
un’intercettazione telefonica della Procura della Repubblica di Bari pubblicata
sul sito fanpage.it sempre quel 13 dicembre De Bustis dice a Sabetta: “No, no,
mo’ prima devo dire ‘sta cosa a te. No, in questa circostanza c’è un po’ di
protezione in Banca d’Italia, no? Però non voglio creare casini a loro con...
per un... proprio quisquilia, capito?” Ora sappiamo che De Bustis considera 4,36
miliardi di crediti deteriorati “quisquilia” e che Banca d’Italia guida
l’operazione. Presumibilmente l’obiettivo della Vigilanza e del Governo era
quello di costringere BPB a trasformarsi in società per azioni, azzerando il
capitale dei soci dei soci, così come abbiamo visto nella distruzione del Banco
di Napoli e Banca di Sicilia, per poi regalarla ad un gruppo bancario
“nazionale” cioè tosco-padano. Piano che si sta velocemente realizzando. Quindi,
senza Sabetta, l’acquisizione di Tercas può procedere spedita. Nel luglio 2014
Banca d’Italia autorizza l’operazione con un contributo di 330 milioni di euro
del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, comunque insufficienti rispetto
alla mole dei crediti deteriorati. Dobbiamo aspettare però il luglio 2016
affinché l’operazione vada in porto a causa della cattiva abitudine del governo
italiano di concedere aiuti senza la preventiva autorizzazione della Commissione
Europea. Infatti i 330 milioni di Euro erano stati considerati “aiuti di Stato”
e pertanto bloccati. Con l’acquisizione di Tercas la situazione di BPB diventa
sempre più preoccupante. Gli NPL (non performing loans) passano dal 14,8 al 21,8
percento nel corso del solo 2014 (fonte: Banca d’Italia). Anche l’aumento di
capitale per 553 milioni di euro (fonte: Banca d’Italia) effettuato nel biennio
2014-2015 tra nuove azioni e emissioni di obbligazioni subordinate, il cui
valore è andato ora distrutto, non saranno sufficienti a puntellare il capitale.
Si tratta di sottoscrizione di capitale di rischio e di strumenti finanziari
ibridi (cioè che in caso di necessità l’emittente può trasformarli da debito in
capitale) da parte di ignari correntisti che vi investivano i risparmi di una
vita. Colpisce, anche in questo caso, l’assordante silenzio della Vigilanza.
I PROBLEMI
AUMENTANO. I revisori contabili (almeno loro) iniziano a mettere in risalto le
criticità della Popolare. Nella relazione al bilancio del 2017, il primo che
consolida le poste di Tercas, PwC riporta una sezione sugli “aspetti chiave
della revisione contabile”. In essa vengono fatte minuziose considerazioni sulla
valutazione dei crediti verso la clientela, recuperabilità delle imposte
anticipate, riduzione di valore degli avviamenti. La relazione scrive anche
dell’esplicita responsabilità degli amministratori per la valutazione
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. È un vero e proprio
campanello d’allarme. Probabilmente PwC lo fa anche per difendersi. Carmelo
Barbagallo, il capo della Vigilanza tanto solerte nell’estromettere Sabella
(“per conflitto di interessi”) che aveva ravvisato criticità nell’acquisizione
di Tercas, tace. Tace l’intera Banca d’Italia, guidata da Ignazio Visco, che
pure ha come unico compito quello della Vigilanza bancaria. Anzi alla fine del
2017 a Visco viene rinnovato dal governo Gentiloni il mandato della durata di
sei anni di Governatore della Banca d’Italia. Evidentemente la bravura non passa
inosservata. Banca d’Italia continua a non far pervenire segni di vita neanche
quando il bilancio 2018 della Popolare registra una perdita record di 420
milioni di euro e PwC nella sua relazione al bilancio scrive di “incertezza
significativa relativa alla continuità aziendale” e che “gli amministratori
ritengono di poter confermare la sussistenza della continuità aziendale”.
Seguono, come per il 2017, pagine intere relative alle “procedure di revisione
in risposta agli aspetti chiave”, in cui PwC elenca tutti i controlli effettuati
sulle poste contabili maggiormente critiche. Il revisore elenca i controlli
effettuati per difendersi nel caso di problemi, ritenuti evidentemente
imminenti. Infatti al revisore spettano i controlli, ma è la Vigilanza che deve
prendere decisioni sulla base di quegli stessi controlli. Infatti Banca d’Italia
ha dal 2015 il potere di rimuovere i vertici di BPB (art. 53-bis, comma 1, lett.
e) del Testo Unico Bancario). Questo potere può essere esercitato anche nei
confronti di esponenti che soddisfino i requisiti di idoneità previsti dalla
normativa (art. 26 del TUB), ma che evidentemente non sono dei validi
amministratori. Nel silenzio di Banca d’Italia De Bustis, che aveva lasciato BPB
nel 2015, incredibilmente vi ritorna alla fine del 2018 come amministratore
delegato. Carica che viene confermata nel luglio 2019. Nel frattempo il dissesto
della Popolare aveva attirato l’attenzione della Procura della Repubblica di
Bari che apre un fascicolo. Nel luglio 2019 il presidente Jacobini si dimette,
ma a sostituirlo è il nipote Gianvito Giannelli. Secondo l’audio pubblicato su
fanpage.it è proprio Giannelli che ancora il 10 dicembre 2019 (a pochi giorni
dal commissariamento della Popolare) tranquillizza dirigenti e dipendenti
spiegando che non c’è da temere il commissariamento perché “ci appoggia il mondo
politico, e ci appoggia anche la Vigilanza”. Ottimismo condiviso da De Bustis
che anche lui fatica a comprendere il non interventismo di Banca d’Italia.
Infatti interviene a quella stessa assemblea dicendo: “Bontà loro, e per ragioni
strategiche altissime, qualcuno ha deciso che la Banca debba sopravvivere”.
EPILOGO. Il 13
dicembre 2019 arriva infine quello che molti temevano: la BPB entra in una
irreversibile crisi di liquidità e pertanto viene commissariata da Banca
d’Italia con la nomina di Enrico Ajello e Antonio Blandini commissari
straordinari. Nel salvataggio interviene il Fondo interbancario di tutela dei
depositi per 1,17 miliardi di euro e Mediocredito Centrale (Mcc, di proprietà
del Ministero dell’Economia e Finanze attraverso Invitalia) per 430 milioni di
euro. Il buco provocato dalla Popolare di Bari ammonta quindi a 1,6 miliardi di
euro. Il Fitd, dopo aver ripianato le perdite e ricostruito il capitale, cederà
le azioni a Mcc al prezzo di un euro. Mcc avrà alla fine il 97% del capitale
mentre il 3% rimanente è stato assegnato agli attuali soci. Il 29 giugno 2020
l’assemblea straordinaria della Banca ha approvato l’aumento di capitale e la
sua trasformazione in SpA, probabilmente fin dall’inizio vero obiettivo
dell’operazione Tercas. Infatti in una SpA gli azionisti non possono opporsi
all’ingresso di nuovi investitori, e la Banca diventa quindi contendibile. Nel
giro di 18 mesi la ex-BPB, risanata e dotata di capitali freschi, si teme, sarà
pronta per essere consegnata ad un gruppo bancario dell’asse Toscana Nord-Ovest.
ANALOGIE TRA
BANCO DI NAPOLI, BANCA DI SICILIA E POPOLARE BARI. La fine del Banco di Napoli,
Banca di Sicilia e Banca Popolare di Bari presenta delle caratteristiche comuni
che possono essere riassunte qui di seguito:
Induzione da
parte di Banca d’Italia di una banca di medie dimensioni verso scelte
strategiche sbagliate (acquisizione di Sicilcassa per Banca di Sicilia e Tercas
per la Popolare di Bari mentre per il Banco di Napoli si passa direttamente al
punto successivo);
Azzeramento
del valore delle azioni di soci o azionisti;
Iniezione di
denaro pubblico (attraverso il Fitd, Mcc o Mef);
Svendita della
Banca meridionale ora risanata e ricapitalizzata ad un gruppo bancario dell’area
Toscana Nord-Ovest (Banco di Napoli a Bnl prima Banca Intesa poi, Banca di
Sicilia a Unicredit, Banca Popolare di Bari a Monte dei Paschi di Siena?).
CONSIDERAZIONI
FINALI. Notizie di questi giorni danno già adesso un’indicazione della strada
che la ex Popolare seguirà nei prossimi mesi ed anni. Infatti il 15 settembre
2020 l’azionista statale Mcc ha nominato il bolognese Giampiero Bergami
direttore generale. Bergami è stato fino all’agosto scorso vicedirettore di
Banca Monte dei Paschi di Siena e proprio nel 2021 lo Stato (rappresentato dal
Mef che ora ne detiene il 68%) dovrà uscire dal capitale della Banca senese,
secondo gli accordi dell’Italia con la Commissione Europea. È naturale quindi
pensare che la ex-Popolare, risanata e ricapitalizzata con soldi pubblici, e
cioè di tutti, sarà svenduta a Mps, una banca moribonda e dissestata,
caratterizzata da innumerevoli problemi di carattere gestionale, finanziario ed
esistenziale. A chi sta a cuore Bari, la Puglia ed il Sud Italia non può e non
deve rassegnarsi alla perdita di una Banca che è parte integrante del nostro
territorio, della nostra vita e del nostro successo. La ex-Popolare di Bari deve
avere la possibilità di restare indipendente e di contribuire al progresso
economico dei territori in cui opera. Stupiscono il silenzio del sindaco di Bari
Antonio Decaro, del presidente di regione Michele Emiliano, quasi che la Banca
Popolare di Bari non faccia parte della nostra terra, del nostro lavoro e delle
nostre aspirazioni. Vorrei che questo articolo abbia la più ampia risonanza
possibile e che tutti noi facessimo qualcosa, per esempio contattando i
parlamentari che ci rappresentano (di tutti i partiti e di tutti gli
schieramenti) che hanno il potere di bloccare l’ennesimo furto bancario ai danni
di una parte del Paese. Vorrei che a questa battaglia di civiltà si unissero i
nostri amici veneti, a cui hanno sottratto nel corso degli anni Banca
Antonveneta, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, secondo dinamiche già
viste in questa ed in altre sedi. Siamo in tanti ma non lo sappiamo.
·
A-Nazionalità ed
Anti-Italianità. Ecco chi ha ucciso la nostra Patria.
"Il vero uomo è martire": polemiche per il messaggio del 4
novembre. Marco Ugo Filisetti, direttore dell’Ufficio
regionale delle Marche, ha rivolto un pensiero agli studenti riprendendo un
pensiero del filosofo Giovanni Gentile. Gabriele Laganà, Giovedì 05/11/2020 su
Il Giornale. La scorsa primavera era finito al centro delle polemiche per aver
impedito, con una circolare, ai presidi di rilasciare interviste ai tempi delle
polemiche per la didattica a distanza. Sono passati diversi mesi e Marco Ugo
Filisetti, direttore dell’Ufficio regionale delle Marche, è di nuovo sotto i
riflettori. Il dottore, infatti, per celebrare la ricorrenza del 4 novembre,
Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, ha rivolto un
pensiero particolare ai suoi studenti. Rivolgendosi agli studenti delle scuole
marchigiane Filisetti ha preso a prestito anche le parole di Giovanni Gentile,
il filosofo e ministro dell’Istruzione ai tempi del Fascismo, contenute nel suo
"Sommario della pedagogia" incentrando il pensiero su patriottismo, coraggio e
sacrificio. "In questo giorno il nostro reverente pensiero va a tutti i figli
d’Italia che dettero la loro vita per la Patria, una gioventù che andò al fronte
e là vi rimase. Una gioventù lontana dai prudenti, dai pavidi, coloro che
scendono in strada a cose fatte per dire: "Io c’ero"", ha scritto Filisetti sul
documento dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. "Giovani che vollero
essere altro- ha aggiunto- non con le declamazioni, ma con le opere, con
l’esempio consapevoli che "Un uomo è vero uomo se è martire delle sue idee. Non
solo le confessa e le professa, ma le attesta, le prova e le realizza".
Combatterono per dare un senso alla vita, alla vita di tutti, comunque essi la
pensino". Un messaggio davvero particolare e d’altri tempi, questo di Filisetti,
che si conclude con il "PRESENTE", parola scritta rigorosamente in maiuscolo e
che è ricordata nel Sacrario di Redipuglia dove sono i resti di centomila
soldati italiani della Grande Guerra. "Per questo quello che siamo e saremo lo
dobbiamo anche a Loro e per questo ricordando i loro nomi sentiamo rispondere,
come nelle trincee della Grande Guerra all’appello serale del comandante:
PRESENTE!". Le parole cariche di amore per la Patria messe nero su bianco dal
direttore dell’Ufficio regionale delle Marche non sono passate
inosservate. Beatrice Brignone, segretaria nazionale di Possibile, ha chiesto
alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina di intervenire sul dirigente
regionale che "esalta nazionalismo e fascismo". "Ieri il dirigente scolastico
regionale delle Marche, Marco Ugo Filisetti, ha inviato a tutti gli studenti
della regione una comunicazione in cui elogia la guerra. Più esattamente lo
spirito del nazionalismo e del fascismo per parlare della giornata delle Forze
armate", ha affermato la Brignone. “Il documento- ha proseguito- oltre a essere
inviato alle scuole per studenti e docenti, è stato pubblicato anche sul sito
Usr Marche e lascia senza parole. La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina,
intervenga tempestivamente. Il contenuto di quella comunicazione è
inaccettabile". La segreteria della Flc Cgil Marche stigmatizza con forza le
affermazioni di Filisetti: "Nella nota non troviamo un passaggio sul ripudio
alla guerra sancito dall’art. 11 della nostra Costituzione, non un accenno al
differente ruolo svolto oggi dalle nostre forze armate, bensì una evocazione
della guerra come fabbricatrice di senso della vita". Per il sindacato il
dottore farebbe meglio, anziché citare il filosofo Gentile, a ricordare "questo
breve passaggio del libro "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di Erich
Maria Remarque: "Avevamo diciott’anni, e cominciavamo ad amare il mondo,
l’esistenza: ci hanno costretti a spararle contro".
Perché si
celebra il 4 novembre.
Il 4 novembre
è la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. In questo giorno, nel
1921, fu sepolto a Roma il milite ignoto. Matteo Carnieletto, Mercoledì
04/11/2020 su Il Giornale. La scena è ormai arcinota. Peppone, sapendo che don
Camillo lo sta ascoltando, comincia a sbraitare contro l'esercito e il Re, che
hanno mandato al massacro tanti giovani durante la Prima guerra mondiale:
"Reclute! Ascoltate la voce del vostro popolo! Andate nelle caserme perché così
vuole la barbara legge nemica dei lavoratori, ma dite chiaro e tondo a coloro
che tentano di armarvi per combattere i fratelli proletari del grande paese che
voi non combatterete! Dite che voi...". Don Camillo non ne può più. Sa che
Peppone ha combattuto in trincea e che, anche se forse malvolentieri, ha fatto
il suo dovere in battaglia. Vorrebbe far qualcosa, ma non sa cosa.
All'improvviso il colpo di genio: vede un altoparlante e, quasi senza rendersene
conto, fa partire L'inno del Piave. Bastano poche note per risvegliare i veri
sentimenti di Peppone che, con una manata, si attacca al microfono: "Dite a
coloro che ingannano il popolo, a coloro che diffamano il popolo, che i nostri
padri hanno difeso la patria dall'invasore allora e noi siamo pronti oggi a
tornare sul Carso e sul Monte Grappa dove abbiamo lasciato la meglio gioventù
italiana. Dovunque è Italia dappertutto è Monte Grappa quando il nemico si
affaccia ai confini sacri della Patria. Dite ai diffamatori del popolo italiano
che, se la patria chiamasse, i vostri padri, ai quali brillano sul petto le
medaglie al valore conquistate nelle pietraie insanguinate, giovani e vecchi si
ritroveranno fianco a fianco e combatteranno dovunque e contro chiunque nemico,
per l'indipendenza d'Italia e al solo scopo inseparabile del Re e della Patria".
E poco importa che il re non ci fosse ormai più. Per Peppone, che quella guerra
l'aveva vissuta, il 4 novembre era tutto questo. Erano i caduti, il Monte Grappa
da difendere ad ogni costo, ma soprattutto era il Piave, il fiume su cui gli
italiani, dopo la rovinosa ritirata di Caporetto, ottennero la vittoria che
cambiò il corso del conflitto. Lì si assistette a quello che Mario Silvestri,
autore di diversi libri sulla Prima guerra mondiale, definisce un vero e proprio
"mistero". I fanti reagirono con forza inaudita. Secondo Aldo Cazzullo, autore
de La guerra dei nostri nonni (Mondadori), il motivo è da ricercare nello
spirito di quegli uomini preoccupati più per ciò che avevano alle loro spalle -
famiglie e affetti - che per ciò che si trovavano davanti: "Non si combatteva
più in terra straniera, per conquistare montagne dal nome slavo, il Matajur e il
Kuk, per avanzare in campagne dove non si sentiva una parola in italiano, per
prendere città italianissime - Trento e Trieste - in cui però nessuno era mai
stato. Si combatteva la guerra di casa, per difendere una patria giovane, per
impedire che anche alle altre donne venisse fatto quello che stavano subendo le
friulane e le venete al di là del Piave e del Grappa. Una guerra che ai nostri
nonni, fanti contadini abituati a badare alla terra e alla famiglia, risultava
quasi naturale. Se non giusta, inevitabile". Forse i nostri nonni (e bisnonni)
non hanno mai letto Gilbert Keith Chesterton, ma di certo hanno messo in pratica
i suoi insegnamenti: "Un vero soldato non combatte perché ha davanti a sé
qualcosa che odia. Combatte perché ha dietro di sé qualcosa che ama". Questo fu
- ed è ancora oggi - il 4 novembre. Come ci spiega il colonnello Fabrizio
Giardini dell'Ufficio storico dell'Esercito italiano: "Non è facile immaginare
le indicibili sofferenze di coloro che hanno combattuto, per anni, sulle Alpi o
nelle trincee del Carso, lungo l’Isonzo o sul Piave, ma anche in Francia,
Albania, Macedonia e Palestina. In questa ricorrenza, è giusto e opportuno
ricordarne il sacrificio. Essi combatterono, caddero, o portarono per sempre il
segno delle atroci ferite sofferte in battaglia per essere all’altezza di un
giuramento prestato all’Italia e agli Italiani". L'Italia non si fece con il
Risorgimento, che fu un progetto realizzato da pochi, ma con la Prima guerra
mondiale. Fu quell'esperienza, drammatica e devastante, a unire il popolo
italiano che, proprio il 4 novembre del 1921, si trovò unito attorno a un figlio
comune: il "milite ignoto". "Il senso ed il valore di questo giuramento - ci
spiega il colonnello Giardini - è rimasto immutato nel tempo, per sottolineare e
rinnovare il profondo legame che unisce la realtà militare con quella della
collettività nazionale". Oggi come ieri.
Riprendiamoci l'Amor patrio: il valore più nobile di tutti.
Andrea Cionci
su Libero Quotidiano il 03 novembre 2020.
Andrea Cionci
Storico
dell'arte, giornalista e scrittore, si occupa di storia, archeologia e
religione. Cultore di opera lirica, ideatore del metodo “Mimerito” sperimentato
dal Miur e promotore del progetto di risonanza internazionale “Plinio”, è stato
reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha appena pubblicato il romanzo
"Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del sano e del vero – per quanto
scomodi - vive una relazione complicata con l'Italia che ama alla follia
sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore.
Ci hanno
rubato tutto: distrutta la Famiglia, eliminato Dio (almeno, quello nostro), la
Patria ormai è una parola proibita, al massimo rimpiazzata col suo freddo,
impersonale, corrispettivo al maschile: “il Paese”. Una parola che sa di
economia, di Pil, di parmigiano reggiano, un eufemismo fuorviante, un po’ come
chiamare “Genitore 2” la Mamma. I tre motori che hanno prodotto per noi
italiani (e per il mondo) quel fiotto interminabile di arte, cultura, eroismo,
sapienza, poesia, bellezza, produttività, valori morali, tradizione, che
conosciamo sono stati disattivati e portati allo sfasciacarrozze da chi ha
sempre avuto interesse a svendere l’Italia, a trance, al miglior offerente. Un
sabotaggio cominciato già negli anni ’60: un lavorìo disgregatore di piccole
termiti industriose che hanno fatto del tradimento continuativo e "sottotraccia"
la loro missione di vita nella politica, nella cultura, nell’arte,
nell’informazione, nella scuola, ovunque. Un processo che culmina oggi
visibilmente con i conati iconoclasti di chi vorrebbe eliminare le targhe
intitolate a re e generali, di chi imbratta i monumenti ai caduti, mette le
braghe alle statue classiche o stupra la lingua di Dante per “non turbare la
sensibilità” di questo o di quest’altro. A permettersi di denigrare le basi
della nostra CIVILTA’, un’armata aggressiva, sostenitrice di istanze che
promettono un ordine mondiale “nuovo” - ma nato già vecchio e muffito – e che
finora non hanno prodotto niente, se non diritti senza doveri e grottesche
censure, isterie che sanno solo distruggere, rimproverare, rimuovere,
lamentarsi, creare neologismi ridicoli come “matria”, “presidenta” o mettere
l’asterisco al posto delle desinenze su aggettivi e sostantivi. Inaudito che
nessuno ancora li abbia ammutoliti chiedendo loro: “Sì, quelli del Dio, Patria,
Famiglia, hanno anche fatto alcuni errori nella storia, ma voi cosa avete fatto,
cosa avete prodotto?”. Nulla. Ebbene, fra i tre valori fondativi della nostra
civiltà, possiamo dire – senza timore di blasfemia - che l’amore per la Patria
sia senz’altro il più nobile, per i motivi che illustreremo. Come è possibile,
infatti, non amare la propria famiglia? Per quanto i familiari possano essere
talvolta "difficili" e le responsabilità pesanti, i legami di sangue con i
propri genitori, figli, fratelli sono fortissimi, naturali e istintivi. Il
ritorno pratico e affettivo che una famiglia offre all’individuo è evidente:
protezione, mantenimento, calore umano, amore, educazione, esercizio della
sessualità coniugale, gioia della genitorialità, assistenza da anziani e il
prolungamento della propria vita nei figli. E Dio? Se da un lato non è così
palese la Sua esistenza - cosa che consente a molti di ignorarLo senza troppi
rimorsi – certamente, per chi vi crede, per quanti sacrifici possa comportare,
fornisce "in cambio" pace interiore, forza spirituale e, infine, la VITA ETERNA:
un premio incommensurabile. Invece la Patria no: amarla è la COSA PIU’
DIFFICILE, più rischiosa, più dura, col minore compenso. Almeno a chi indossa
un’uniforme, essa riconosce, al massimo, un grado, una decorazione, nei casi
peggiori una linda croce di pietra o pochi caratteri di bronzo sul monumentino
nella piazza del paese. Ai nostri soldati che vanno all’estero, qualcuno oggi si
permette di dire che lo fanno per soldi, come dei mercenari. Vediamo quanti, fra
questi critici, per gli stessi soldi, sarebbero capaci di mollare per sei mesi
la propria famiglia e rischiare tutti i giorni di saltare in aria su un ordigno
improvvisato o di essere colpiti da un cecchino. Tuttavia, amare la Patria non è
solo appannaggio dei militari, ma anche di tutti coloro che fanno il loro DOVERE
senza frignare continuamente, bravi cittadini che contribuiscono al bene
dell’Italia, onorando un valore reale come la propria famiglia, ma allo stesso
tempo spirituale come una religione, e che tuttavia richiede una consapevolezza,
una maturità da Uomini adulti per essere compreso. La Patria è, infatti, la
terra dei padri, il frutto di sacrifici enormi e di centinaia di migliaia di
vite, l’espressione della collettività nazionale in cui si riassumono i valori
e gli interessi dei suoi concittadini. Non è qualcosa di facile, di
immediatamente vicino come il fiato del proprio bambino o il soffio dello
Spirito nel proprio cuore. La Patria è popolata da individui sconosciuti, che in
alcuni casi sono perfino ignoranti, disonesti o poco apprezzabili. Quando la
Patria chiama, non è per gettarvi le braccia al collo come un figlio piccolo,
una madre, o una moglie, né per spalancarvi le porte dell'immortalità
ultraterrena: di solito è sempre per una "fregatura", per un'emergenza
sopravvivenziale. La Patria è laica e “anaffettiva” ed esige il più grande degli
sforzi, quello di subordinare la propria individualità al bene collettivo,
(mentre Dio e la Famiglia, al contrario, la esaltano al massimo). Primordiale
tribù allargata, la Patria chiede di fare il tuo dovere anche se non condividi
gli obiettivi che essa si è prefissata. L’amore per essa richiede quindi lo
SFORZO SUPREMO, comporta l’intelligenza razionale più alta, il più nobile dei
sentimenti e il più faticoso dei sacrifici, ben oltre qualsiasi ritorno
ego-individualistico dai propri familiari o a beneficio della propria anima. La
sua difesa “è sacro dovere del cittadino” recita l’art. 52 della Costituzione:
oggi l’unico ideale trascendente, ma oggettivo, palpabile, che può unire laici e
credenti, oltre che i nuovi italiani, è solo l’amore per la Patria.
Riprendiamocelo perché è il momento giusto.
Monte Bianco, cresce la tensione tra Italia e Francia: Macron
vuole la vetta. Macron in visita al Monte Bianco, sul
ghiacciaio della Mer de Glace, il 13 febbraio scorso. L'ultimo motivo di
attrito: due leggi a favore della biodiversità violano la sovranità italiana sul
proprio territorio. Di Maio protesta formalmente: "Forte disappunto". La
Repubblica il 21 ottobre 2020. Riguarda due misure di protezione del sito
naturale del Monte Bianco adottate dalla prefettura dell'Alta Savoia il primo
ottobre scorso il "forte disappunto" italiano espresso formalmente, su
istruzione del ministro Luigi Di Maio, dall'ambasciata di Parigi alle autorità
francesi. Il progetto era stato annunciato già il 13 febbraio dal presidente
francese Emmanuel Macron, durante la visita del ghiacciaio Mer de glace. Si
tratta di nuovi provvedimenti - in francese Aphn (arrêtés de protection habitats
naturels) - create dal ministero per la Transizione ecologica e che mirano a
"proteggere in modo specifico habitat naturali in quanto tali, indipendentemente
dalla presenza di specie protette da misure normative". Un modo per "garantire
una protezione efficace di alcuni ambienti rari che fino ad oggi non hanno
beneficiato di uno strumento legislativo adeguato". Il perimetro dell'area
protetta sul massiccio del Monte Bianco copre una superficie di 3mila 175 ettari
e crea due zone: una centrale (pari all'80 per cento del totale) riservata alla
pratica dell'alpinismo e dello scialpinismo, l'altra "di transizione",
accessibile a tutti, escursionisti ma anche semplici turisti. Ma proprio
nell'area centrale rientra anche la zona del ghiacciaio del Gigante, dove si
trovano il rifugio Torino e la stazione "Punta Helbronner" della funivia Skyway,
che parte da Courmayeur. Un territorio che l'Italia considera proprio. Le misure
francesi hanno l'obiettivo di evitare le "derive osservate", come "l'atterraggio
di un aereo" e di "un centinaio di parapendisti" sulla cima del Monte Bianco, ma
anche l'"installazione di una Jacuzzi" e "l'ascensione da parte di persone non
equipaggiate in modo sufficiente o mal preparate". Secondo l'Italia la linea di
confine del Monte Bianco - e più in generale del massiccio - passa sullo
spartiacque, mentre per la Francia sul Monte Bianco di Courmayeur, con il Monte
Bianco interamente nel proprio territorio. Nel giugno 2019 un'ordinanza dei
comuni francesi di Chamonix e Saint-Gervais aveva fatto divampare la polemica,
dato che aveva esteso nell'area contesa tra i due Stati il divieto di
atterraggio in parapendio su un perimetro di 600 metri attorno alla cima del
Monte Bianco. A fine 2017 Google maps aveva rivisto i confini dell'area (che
prima rispecchiavano la cartografia francese), delineando con linee tratteggiate
la zona contesa. Alcuni mesi prima c'era stata una riunione tra le autorità dei
due Stati durante la quale si era deciso che nessuno avrebbe intrapreso
iniziative unilaterali in quelle aree. Il 4 settembre 2015 era scoppiato un
'caso' diplomatico quando il sindaco di Chamonix (Francia) aveva fatto bloccare
con una transenna e dei lucchetti - poi rimossi da ignoti - l'accesso al
ghiacciaio del Gigante, dal rifugio Torino, sotto la stazione di arrivo della
funivia italiana Skyway, considerandolo nel proprio territorio. L'Italia fa
riferimento al Trattato fra Regno di Sardegna e Impero francese (Torino, 24
marzo 1860) e alla Convenzione di delimitazione tra Sardegna e Francia (Torino,
7 marzo 1861) in esecuzione dello stesso trattato. La cartografia francese
invece sposta il confine sul versante sud del massiccio per un'area di 82
ettari, rifacendosi a quelli sanciti con l'armistizio di Cherasco del 1796 dopo
la prima campagna Napoleonica in Italia ed entrati - dopo una decisione
unilaterale francese - sulle carte ufficiali a partire dal 1865.
"Ripristinare sovranità italiana". Esplode caso del Monte Bianco.
In una
nota il capodelegazione di Fdi, Carlo Fidanza, chiede che i vertici europei
intervengano sulla questione dei confini del Monte Bianco. Gabriele Laganà,
Martedì 20/10/2020 su Il Giornale. Nel passato l’annessione unilaterale
compiuta da uno Stato di un territorio, seppur poco esteso, avrebbe portato alla
guerra due Paesi. Oggi, per fortuna, la situazione è diversa. Le armi tacciono
mentre a divampare sono le polemiche. Nella Ue si è creata una frattura tra
Italia e Francia per la questione Monte Bianco. E le conseguenze possono essere
imprevedibili, soprattutto perché ora saranno coinvolte le istituzioni europee.
"Di fronte all’atto unilaterale delle autorità francesi che nelle loro
cartografie hanno annesso alla Francia la vetta del Monte Bianco e alcune aree
adiacenti, chiediamo che i vertici dell’Unione Europea intervengano. La vicenda
sollevata dal Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco
Lollobrigida, che ha correttamente richiamato il governo Conte a difendere la
sovranità del territorio italiano, non può lasciare inerti i vertici di
Consiglio e Commissione europea". È quanto dichiara in una nota il
capodelegazione di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza. Il tema è delicato e si
aggiunge alle tensioni tra il nostro Paese ed i cugini transalpini sul tema dei
migranti. La cima del Monte Bianco a chi appartiene? I confini tra Italia e
Francia nella zona del massiccio sono da tempo oggetto di una controversia
internazionale riguardante la stessa cima del monte e la zona del Colle del
Gigante - Punta Helbronner, di rilievo per l'Italia come punto di arrivo della
funivia proveniente da Courmayeur e come sito dello storico rifugio Torino.
Politica ed economica si intrecciano. Secondo un accordo del 1860, la sovranità
di Punta Helbronner era stata concessa al nostro Paese. Questo nonostante
storicamente essa appartenesse alla contea della Savoia passata alla Francia
nell'ambito dei trattati risalenti all'unità d'Italia. Ma ciò ai francesi non è
mai andata a genio. E così ora i comuni transalpini di Chamonix e St.
Gervais hanno unilateralmente modificato i propri confini, facendo ricadere il
rifugio Torino all'interno del territorio francese. La situazione è venuta alla
luce nel giugno del 2019, quando le autorità transalpine hanno vietato
l'atterraggio in parapendio in tutta la zona. A rendere pubblica la vicenda è
stato un articolo su Libero, in cui si fa presente come i francesi riscuotano
adesso tutti i proventi degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche
della zona. In sostanza, gli accordi del 1860 sono divenuti carta straccia. La
Francia unilateralmente si è annessa un pezzo di Val d'Aosta. L'attenzione su
quanto compiuto dai "cugini" d’oltralpe la si è dovuta solo dopo
un'interrogazione presentata dal deputato di Fdi, Francesco Lollobrigida. Nel
documento è stato chiesto al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri
in che modo si stava affrontando la vicende "per conoscere quali iniziative
intendessero intraprendere per tutelare l'interesse nazionale e la sovranità
dello Stato italiano nelle aree del Monte Bianco per supportare le istituzioni
territoriali coinvolte nella gestione dei problemi amministrativi ed economici
relativi alle attività turistiche, sportive ed alpinistiche che si svolgono in
quelle zone nevralgiche per l'accesso al massiccio e alla vetta del Monte
Bianco; per giungere alla definitiva risoluzione di un contenzioso diplomatico
che si trascina ormai da oltre 70 anni, durante i quali l'Italia ha sempre
subito le iniziative unilaterali ed arbitrarie delle autorità francesi". Lo
scorso 12 ottobre è stato il sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ivan Scalfarotto, a rispondere, a
nome dell'esecutivo: "Il governo tramite l'ambasciata a Parigi ha subito
proceduto a rappresentare formalmente e con fermezza alle autorità francesi, la
tradizionale posizione italiana riguardo ai confini". Ma Parigi si è fatta beffe
di noi. Per il governo transalpino quell'intesa del 1860 non rappresenta ad oggi
una base giuridica di rilievo e di conseguenza i provvedimenti dei comuni
francesi si inseriscono nel contesto di una disputa internazionale non ancora
risolta. La questione non può finire qui. Nel documento, il capodelegazione di
Fdi, Carlo Fidanza ha ricordato che "il rispetto delle sovranità territoriali
degli Stati membri, la cooperazione transfrontaliera e i rapporti di vicinato
sono tra i fondamenti dell’Unione e non possono essere violati unilateralmente
da uno Stato membro senza che l’Ue intervenga". L’esponente del partito della
Meloni ha garantito che "la delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento
Europeo ha indirizzato una lettera alla presidente della Commissione Ue Von der
Leyen e al presidente del Consiglio Michel". Mentre si aspetta Bruxelles, i
comuni francesi si tengono rifugio Torino e i soldi proventi delle attività
della zona. Un doppio smacco per l’Italia.
Ecco quali sono i territori che l’Italia rischia di perdere.
Mauro Indelicato e Sofia Dinolfo su Inside Over il 25
ottobre 2020. Dalla montagna al mare, dalle Alpi al Mediterraneo, il territorio
italiano è per eccellenza la maggiore espressione di un Paese adagiato tra due
entità non solo geografiche ma anche culturali e identitarie. Eppure, tanto
lungo le delimitazioni alpine quanto lungo quelle marine, esistono non pochi
problemi. I confini italiani in alcuni punti non sono ben definiti. È una
questione forse sottovalutata, ma concretamente reale e non secondaria: a quasi
160 anni dall’unità, sono diversi i fronti aperti con gli Stati vicini per la
delimitazione delle frontiere.
Il caso del Monte Bianco. Di recente ha fatto scalpore la vicenda
legata al rifugio Torino. Si tratta di un’importante struttura non lontana
da Punta Helbronner, nei pressi del Monte Bianco. La questione riguarda quindi i
confini tra Italia e Francia. Il 27 giugno del 2019 le autorità transalpine
hanno vietato il sorvolo in parapendio della zona, una circostanza che ha
iniziato a destare sospetti: perché i francesi hanno preso un provvedimento del
genere in un’area ricadente in territorio italiano? Molto semplice: poche
settimane prima i comuni di Chamonix e St. Gervais, ricadenti sul versante
francese, hanno unilateralmente esteso i propri confini anche su Punta
Helbronner. In tal modo è stata fatta propria la posizione storicamente
sostenuta da Parigi e cioè che il rifugio Torino ricade in territorio francese.
Nei mesi successivi un deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, ha
portato la questione in parlamento con un’interrogazione. Soltanto il 12 ottobre
è arrivata una prima risposta dalla Farnesina, secondo cui l’Italia si è opposta
a questa scelta unilaterale dei comuni francesi. In concreto però non sembrano
essere stati fatti passi per dirimere la controversia risalente addirittura
all’anno dell’unità italiana. In cambio infatti della Savoia, nel 1860 la
Francia ha lasciato sovranità a Roma su Punta Helbronner. Per gli italiani
quell’intesa è ancora valida, per i francesi invece no. E mentre la controversia
va avanti, i comuni transalpini intanto intascano i proventi degli impianti
sciistici della zona. Anche perché è proprio su Punta Helbronner che arriva la
funivia di collegamento con la località turistica valdostana di Courmayeur.
Il rifugio alpino. Lungo il confine tra l’Italia e la Svizzera vi
è una contesa fra le due Nazioni che ha a che vedere con la struttura
denominata Guide del Cervino. Si tratta di un rifugio, con annesso ristorante,
che si trova nel Plateau Rosa e capace di fruttare diversi milioni di Euro per
il turismo valdostano. La struttura è divenuta oggetto di rivendicazioni da
parte della Svizzera a causa dello scioglimento dei ghiacciai alpini e, in
particolar modo, del Valtournenche . Quest’ultimo si è ritirato di circa 230
metri. Il nocciolo della questione deriva dal regolamento dei confini nelle
Alpi, i quali vengono tracciati secondo “la direzione del verso delle acque”. Se
il verso segue il lato italiano, una determinata struttura viene considerata
appartenente all’Italia, se invece segue il lato svizzero, la stessa viene
considerata sotto sovranità svizzera. È proprio questo modo di regolare i
confini e l’arretramento del Valtournenche che ha fatto sorgere le pretese di
Berna sul rifugio. Secondo Alain Wicht, sovrintendente alle frontiere elvetiche
per Swisstopo, l’arretramento del ghiacciaio ha determinato un cambiamento nel
verso dello scorrimento delle acque nella zona del rifugio verso la Svizzera e
per tale motivo la struttura deve ritenersi appartenente al territorio elvetico.
A questa tesi si oppone l’Istituto Geografico militare di Firenze, secondo cui
il rifugio si trova senza dubbio in territorio italiano. Una commissione tecnica
adesso sta cercando di definire i confini ma le operazioni non sono del tutto
semplici. Berna è disposta a riconoscere la sovranità del rifugio all’Italia in
cambio di 650 metri quadrati di territorio, lo stesso in cui si trovano il
rifugio, il ristorante e la nuova ala della struttura in progetto. Ma da Roma è
arrivato il no.
La contesa con l’Algeria dell’Italia sulla Zee. Dal 21 marzo del
2018 v’è una questione che ha portato l’Italia e l’Algeria a trattare in merito
alla vicenda legata alla Zee, ovvero la Zona Economica Esclusiva. Quest’ultima è
regolamentata dalla convenzione di Montego Bay, un documento che funge da base
del diritto internazionale del mare e che la stabilisce entro le 200 miglia
nautiche dalla linea di base dello Stato costiero. In quest’area la Nazione
interessata esercita il diritto di gestione delle risorse naturali avendo anche
giurisdizione in materia di installazione e uso di strutture artificiali o
fissa, ricerca scientifica, protezione e conservazione dell’ambiente marino.
L’Italia non ha mai stabilito i confini della propria Zee e, nel 2018, l’Algeria
ha allargato i propri estendendoli fino alla Sardegna. Il caso sollevato dall’ex
presidente della Regione Sardegna, Mauro Pili, è arrivato in Parlamento. Tra
Algeri e Roma viene adesso portato avanti un dialogo diretto a risolvere le
rivendicazioni dell’Italia. Nel dicembre del 2019 è stato depositato alla Camera
un disegno di legge per istituire una Zee italiana. Prima firmataria è
stata Iolanda Di Stasio, deputata del M5S che ad InsideOver ad agosto ha
confermato il coinvolgimento trasversale da parte delle forze politiche: “La
proposta di legge sulla Zee – ha affermato Di Stasio – ha ricevuto la piena
approvazione da parte della Commissione esteri della Camera, con un appoggio
trasversale che ne valorizza ulteriormente l’importanza strategica per il Paese
e attendiamo dunque la calendarizzazione per il voto dell’Aula”.
Le controversie legate al trattato di Caen. Non è soltanto
l’attuale mancanza della Zee a dare grattacapi all’Italia sul fronte dei confini
marittimi. C’è un altro caso che riguarda ancora una volta i rapporti con i
cugini transalpini. Nel marzo 2015, nella cittadina francese di Caen, Roma e
Parigi hanno firmato un trattato con cui sono stati fissati i nuovi confini. In
particolare, in cambio di alcune secche tra la Corsica, Capraia e l’Isola
d’Elba, l’Italia ha ceduto alcune porzioni del mar di Sardegna e del mar Ligure.
In un primo momento la firma del trattato non ha avuto eco mediatica. La
situazione è cambiata nel gennaio 2016, quando il peschereccio italiano Mina è
stato fermato dai francesi nella zona denominata “Fossa del Cimitero”. Si tratta
di uno dei punti ceduti dall’Italia alla Francia: “È un tratto di mare molto
ricco dal punto di vista della pesca, con una vivace presenza proprio di
gamberoni rossi”, ha spiegato nel suo blog l’ammiraglio De Giorni alcuni mesi
dopo. Da qui le polemiche più importanti contro il trattato. Alcuni partiti, tra
cui Fratelli d’Italia, Lega e M5S, hanno accusato l’allora governo Renzi di aver
regalato tratti di mare molto pescosi alla Francia. Tuttavia la controversia è
ancora in corso: il parlamento italiano non ha mai ratificato il trattato di
Caen, che dunque ufficialmente non è in vigore. Le stesse autorità francesi,
dopo aver sequestrato il peschereccio Mina, hanno chiesto scusa visto che i
nuovi confini formalmente non esistono. La questione quindi non è stata risolta.
Ecco chi ha ucciso la nostra Patria.
Marco Gervasoni, 29 luglio 2020 su Nicolaporro.it. Può sembrare
assurdo evocare oggi l’interesse nazionale quando abbiamo un presidente del
Consiglio che a Bruxelles chiede soldi e invoca “pietà” agli olandesi in nome
dei “morti di Covid” (come se lo fossero stati sui campi di battaglia) oppure
quando il più inetto ministro dell’Interno della storia unitaria (non era facile
battere Alfano) fugge di fronte a immigrati tunisini con barboncino. Aveva forse
ragione il giurista Salvatore Satta, uno dei più grandi scrittori italiani del
Novecento, quando tra il 1944 e il 1945 in De profundis lamentò la “morte della
patria”? Però poi, nella prima repubblica, De
Gasperi, Fanfani, Andreotti, Cossiga, Craxi, l’interesse nazionale l’hanno
difeso. Anche per quello Tangentopoli fu organizzata, per distruggere una classe
politica che sapeva tutelare l’Italia, e far posto a una nuova politica
tecnocratica da un lato e post comunista dall’altro, che il senso della nazione
non l’avevano mai coltivato, e che videro nell’adesione alla Ue un modo per
sbarazzarsi finalmente della nostra nazione. Chi si oppose a questo
progetto, Silvio Berlusconi, fu perseguitato in tutti i modi. E alla fine fu
sconfitto. Eppure di interesse nazionale bisogna parlare perché senza nazioni
noi non esistiamo, essendo la nazione lo spazio in cui le persone possono agire
in comunità. E, come ha scritto il politologo Stephen Walt di recente su
“Foreign Policy”, non certo un organo nazionalista, il XXI secolo sarà più che
mai quello delle nazioni. Perciò bisogna assolutamente leggere il voluminoso
rapporto sull’interesse nazionale prodotto dalla Fondazione Fare Futuro (Italia
20.20. Rapporto sull’interesse nazionale, Roma, Fondazione Fare futuro, 25
euro). Perché il primo concreto e realistico pericolo è quello che sparisca non
solo la nazione ma con lei anche gli italiani, come scrive nella sua
introduzione il senatore Adolfo Urso. E crisi demografica da un lato e progetti
di grand replacement con gli immigrati dall’altro (come esplicitamente
teorizzato da un partito come più Europa favorevole alla sostituzione etnica) ci
dicono questa ipotesi tutt’altro che peregrina. Dal presidente dell’Istat Gian
Carlo Blangiardo all’ex ministro e ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, dal
direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, agli storici Giuseppe Parlato ed Ernesto
Galli della Loggia, dal giurista Alessandro Mangia al generale Carlo Jean fino
a Guido Crosetto, ognuno affronta, dal punto di vista delle proprie competenze e
esperienze questo tema; come salvare l’Italia? Senza nulla togliere ai numerosi
autori mi soffermo solo su gli interventi di due Giuli, Sapelli e Tremonti, Il
primo punta l’attenzione sulle ragioni del declino economico, di quella che
negli anni Ottanta era la terza economia europea. Secondo Sapelli, l’Italia è
crollata da un lato perché, attraverso un golpe tecnocratico e giudiziario, le
privatizzazioni hanno distrutto un sistema che, al di là degli eccessi, era
virtuoso. E poi perché, a cominciare dal cosiddetto divorzio tra Tesoro e Banca
Italia, nel 1981, è stato imposto all’Italia un’adesione alla integrazione
europea che non poteva non comprometterla. Volendo istituire un ideale tribunale
della storia, alla barra secondo noi dovrebbero andare Beniamino
Andreatta, Tommaso Padoa Schioppa e Carlo Azeglio Ciampi, in ordine di
responsabilità. Ma al di là dei singoli casi, è una fetta sempre più ampia di
classe politica e dirigente che, a partire dagli anni Settanta, comincia a non
sentirsi più come nazionale e di fatto ad agire consapevolmente o
inconsapevolmente a favore di altri paesi, soprattutto la Germania (a parte i
comunisti che lavoravano per l’Urss). Il grimaldello ideologico con cui
giustificare la sottomissione del paese fu la metafora del “vincolo esterno”,
teorizzata dal governatore della Banca d’Italia, Menichella ma poi diffusa
da Guido Carli, un personaggio troppo spesso monumentalizzato ma la cui
attività andrebbe valutata assai criticamente. L’a-nazionalità, se non proprio
l’anti italianità , di un pezzo di classe politica e dirigente è il tema
affrontato dall’altro Giulio, Tremonti che scrive delle diverse chiamate del
straniero in Italia, la più clamorosa quella del governo Monti grazie a un
presidente (post?) comunista come Napolitano. Oggi solo uno sprovveduto potrebbe
pensare che gli eredi di Berlinguer, mai sentitisi italiani, e quelli di
Andreatta, possano essere interessati a tutelare l’interesse nazionale, al di là
delle parole. Quanto ai grillini, meglio stendere un velo pietoso. Compito,
quello della difesa della nazione, che spetta perciò di diritto alle forze
sovraniste. Che siano in grado di farlo, è però questione tutta aperta e da
costruire: ma anche la lettura di questo volume potrebbe contribuire in parte a
riempirla. Marco Gervasoni, 29 luglio 2020
LA SOLITA ITALIOPOLI. (Ho scritto un saggio dedicato)
·
Ma quale latrina?
Dagospia il 14
febbraio 2020. Robot domestici che aiutano nelle faccende di casa; mani
artificiali che sostituiscono e hanno le stesse funzionalità di quelle naturali;
rover spaziali che sono in grado di muoversi su qualsiasi terreno, fino ad
arrivate alle macchine con le sembianze dei polpi per la pulizia dei fondali
marini. Sono le 100 storie italiane da sud a nord che parlano di tecnologie
pronte a migliorare la vita delle persone: innovazioni applicate alle attività
quotidiane, alla sanità, all’industria e alla ricerca. Un volto inedito del
nostro Paese che viene raccontato da Enel e Fondazione Symbola nel quarto
Rapporto sull’innovazione Made in Italy “100 Italian robotics and automation
stories”. Robot e automi fanno parte della vita di tutti i giorni, dalle
attività domestiche a quelle industriali, con numeri mondiali in forte crescita.
Basti pensare che il mercato ha raggiunto il valore di 16,5 miliardi di dollari
e solo nel 2018 sono state consegnate 422mila macchine, con un aumento del 6%
rispetto all’anno precedente. L’Italia è nel G7 della robotica piazzandosi in
sesta posizione per numero complessivo di robot industriali installati (69.142
unità nel 2018), preceduta da Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e
Germania. Una voce forte che il nostro Paese fa sentire anche per numero di
pubblicazioni scientifiche: sono infatti oltre 10mila, che la rendono sesta al
mondo nella ricerca di settore davanti a Francia, Canada, Corea del Sud e
Spagna. Un primato spesso poco pubblicizzato che rappresenta un fiore
all’occhiello italiano come dimostrano le 104mila imprese cresciute del 10% in
cinque anni, con 429mila addetti, diffuse in tutto il territorio. Milano guida
la classifica con circa 12mila aziende e 110mila addetti; seguono Roma con
11mila imprese e 63mila addetti, Napoli con 5mila imprese e 13mila addetti,
Torino con 5mila imprese e 25mila addetti e, con circa 2mila imprese tra
Brescia, Padova, Bari, Bologna, Firenze, Monza e Brianza, Bergamo e Salerno.
Vittorio Feltri sull'Italia: "Ma quale latrina? Non siamo
inferiori rispetto a nessuno, o quasi". Libero
Quotidiano il 26 Gennaio 2020. Percepire non significa conoscere. Ciononostante
si blatera quasi esclusivamente di temperatura percepita, che non è misurata dal
termometro, trattasi di sensazione. Lo stesso vale per la corruzione, anche
questa percepita. Si dice che l' Italia è marcia, piena di individui che danno e
ricevono mazzette, vivono di sotterfugi, non pagano le tasse e via sputtanando.
Per non parlare della delinquenza, la quale viene dipinta come un cancro che
divora il tessuto sociale. Tutte panzane che ci rovinano la reputazione
gratuitamente. La nostra Nazione è talmente sana da essere quella europea che
registra il minor numero, in rapporto alla popolazione, di reati. Nel 2019, dati
alla mano, dalle nostre parti le azioni delittuose hanno raggiunto il minimo
storico. La sicurezza non è mai totale in nessun luogo al mondo, però da noi
essa non costituisce una emergenza. Sono in costante calo gli omicidi (benché le
mafie non siano state sconfitte), le rapine e perfino i furti. Non sto
descrivendo la situazione del paradiso terrestre, tuttavia faccio notare che non
siamo all' ultimo posto nella classifica della civiltà, ma in vetta o quasi.
Dobbiamo smetterla di piangerci addosso e di autodenigrarci. Invece di percepire
ciò che non esiste dobbiamo esaminare le statistiche che, sui grandi numeri, non
sbagliano mai. La corruzione consiste in gran parte nel tentativo da parte della
gente non di strappare un favore, bensì il rispetto di un diritto. Se ho bisogno
di una Tac all' ospedale, l' impiegato mi comunica di tornare fra sei mesi. Per
accelerare le tempistiche, dunque, metto mano al portafogli e allungo al
funzionario 100 euro. Cosicché d' incanto ottengo l' appuntamento col medico che
mi riceverà la prossima settimana. Questo non è un episodio corruttivo, ma una
semplificazione nel mare della burocrazia più spietata e soffocante del globo. I
femminicidi sono sempre troppi, d' accordo, eppure inferiori alla media
continentale. Aumentano invece gli scandali negli ospizi, vecchi brutalizzati e
addirittura torturati, tuttavia nessuno se ne cura. Gli anziani possono essere
presi a calci nel culo impunemente, così i bambini negli asili dove non sono
ancora state installate le telecamere. Il nostro problema non è provocato dal
comportamento dei cittadini, piuttosto dalla politica incapace di proteggere le
persone oneste e di tutelarle con una legislazione idonea. Quanto alla
microcriminalità che turba la popolazione, giova ricordare che essa non è
combattuta efficacemente dalle forze dell' ordine perché queste ultime sono
frenate da disposizioni che proteggono i malviventi e demonizzano agenti e
militari allorché agiscono con vigore. In altri termini, c' è più comprensione
per i malfattori che non per chi li contrasta. La nostra patria non sarà l'
Eldorado però neppure la latrina che emerge dai racconti di una informazione che
distorce la realtà. E noi non saremo i migliori, ma quasi. Consoliamoci invece
di sentirci inferiori. Inferiori a chi? di Vittorio Feltri
·
L'Italia è federale
per natura.
L'Italia è federale per natura. È l'ora di prenderne atto.
L'unificazione forzata continua a fare danni. Carlo
Lottieri, Domenica 26/04/2020 su Il Giornale. Ci fu un tempo - non lontanissimo
- in cui una vera «questione Nord-Sud» ancora non esisteva. La storia musicale
della prima metà del Settecento, ad esempio, fu caratterizzata dal trionfo di
due scuole, quella veneziana e quella napoletana, che hanno dato un contributo
cruciale. Ascoltare i concerti di Antonio Vivaldi o le sonate di Domenico
Scarlatti significa entrare in una civiltà nella quale i molteplici colori
dell'Italia potevano esprimersi appieno. Vi era una comune koinè (perché scambi
e intrecci erano ricorrenti), ma al tempo stesso ognuno poteva essere se stesso.
Quando l'Italia fu conquistata dai Savoia e unificata anche da plebisciti
fasulli, oltre che da un processo di nazionalizzazione che culminerà nel
fascismo, essa è stata snaturata. Si è pure adottato un modello del tutto
astratto di «società decente», a cui ogni parte della penisola doveva
uniformarsi: anche se questo poteva comportare il dissolvimento di tratti
essenziali. All'indomani del 1861 il socialista Pierre-Joseph Proudhon rileverà
come quell'uniformità calata dall'alto stesse negando la realtà: soffocando il
diritto di ogni popolazione ad amministrarsi da sé. Aggiunse che l'Italia era
per sua natura federalista, e quindi variegata e plurale. Ovunque l'ideologia
nega le diversità: da noi è stato il misticismo statolatrico mazziniano di tanti
risorgimentali a portarci dentro una convivenza forzata che ha moltiplicato le
incomprensioni, le tensioni, le ingiustizie. Se è sempre una buona cosa che ogni
comunità sia di piccole dimensioni e si governi da sé, costretta a confrontarsi
con le altre e ad allearsi con quanti possono contribuire ad assicurare la
difesa, questo è ancor più vero per un'Italia che è stata segnata da una
lunghissima storia di autonomie. Molte delle popolazioni che hanno popolato la
penisola (dai greci ai celti, agli etruschi, ma anche le stesse popolazioni
germaniche) hanno sempre pensato la comunità entro una logica locale e, in
seguito, cittadina. E infatti l'Italia medievale fu una costellazione di comuni
con caratteristiche assai difformi. Se oggi torniamo a riflettere sul contrasto
Nord-Sud dobbiamo capire che esso esiste perché siamo stati cacciati a forza
dentro un'Italia malamente unificata, quasi una copia minore della Francia
prefettizia. Ma ora l'irruzione del virus ha obbligato a fare i conti con il
fatto che le epidemie colpiscono sempre in maniera assai diseguale le società,
anche se il Palazzo ha cercato di adottare soluzioni uniformi per problemi
diversi: come se Milano fosse nella medesima situazione dell'Umbria, come se la
Lucania fosse stata colpita quanto la Bergamasca. Il Covid-19 ha dunque finito
per ricordarci che esistono - ed è bene che sia così! - tante Italie disparate,
che per questa ragione hanno bisogno di trovare un assetto istituzionale che
conceda a ognuna di loro di dotarsi delle regole adeguate. L'attivismo dei
presidenti regionali e dei sindaci ha provato a interpretare questa necessità di
rispondere alle differenti domande di cura e intervento, tutela della salute e
necessità di ripartire. Lo stesso schema oppositivo, che contrappone il
Settentrione e il Mezzogiorno, lascia il tempo che trova. In effetti, esistono
vari Nord: il Tirolo che fa storia a sé, il Veneto erede della Serenissima e di
una tradizione politica più che millenaria, Trieste quale universo del tutto
peculiare, e via dicendo. E al tempo stesso ci sono molti Sud diversissimi e
talune realtà - certamente la Sardegna, probabilmente anche la Sicilia - che non
sono nemmeno riconducibili a quella dimensione, dato che le isole hanno sempre
specificità proprie. La volontà di edificare un'unica legislazione unitaria e un
potere sovrano sempre più invadente, nonostante l'esistenza di comunità così
dissimili e desiderose di essere libere, ha generato questa reciproca diffidenza
e tale fatica nel confrontarsi. Per superare questa situazione c'è allora
bisogno di ripensare tutto con coraggio. Vi è la necessità di un nuovo patto
costituente che veda protagonisti i territori: che lasci alle spalle la carta
attuale e ci restituisca un ordine istituzionale più plurale, differenziato,
rispettoso di tutti.
"È fallito il metodo ridistributivo. La strada giusta è
nell'autonomia". L'economista e filosofo disegna lo
scenario post-virus: "Rafforzare il tessuto produttivo". Luigi
Mascheroni, Domenica 26/04/2020 su Il Giornale. Lorenzo Infantino. Calabrese,
economista, filosofo, Lorenzo Infantino è professore di Filosofia delle Scienze
sociali alla LUISS di Roma e noto a livello internazionale per i suoi studi di
ispirazione liberale. Con lui abbiamo parlato della situazione che la pandemia
ha determinato nel Paese.
Professore, l'emergenza Coronavirus sta allargando ulteriormente
il fossato tra Nord e Sud? I primi giorni della quarantena da Milano a Palermo
tutti cantavano dai balconi l'Inno d'Italia. Ora il Sud vuole bloccare gli
arrivi dal Nord e il Nord dà al Sud del razzista...
«È noto che, perlomeno nella loro fase iniziale, fenomeni come
carestie, epidemie, terremoti determinano un'unificazione del corpo sociale,
poiché c'è in gioco la vita di ciascuno. È la stessa situazione creata
dall'esistenza di un nemico esterno. Ma è una situazione che non dura a lungo.
Nel momento in cui il pericolo allenta la sua minaccia, o in cui i vari gruppi
credono di potersi mettere in salvo autonomamente, le vecchie divisioni si
riaffermano. Anzi, vengono esasperate da quell'alterazione cognitiva che
accompagna sempre fenomeni del genere e che fa riemergere il tribalismo che c'è
in noi».
L'emergenza crea molti conflitti a livello politico e sociale.
Nord contro Sud, Stato contro Regioni, Regioni contro Regioni, sindaci contro
governatori... Siamo di nuovo al trionfo del «particulare»?
«Non porrei in tal modo la questione. Possiamo considerare la
crescita della civiltà come una lunga lotta contro le pulsioni più
pericolosamente avverse alla convivenza sociale. È una lotta che non consente
pause o distrazioni, perché non c'è nulla di acquisito una volta per sempre.
Condividiamo tutti la stessa condizione di fallibilità. E, per quanto grandi
possano essere le acquisizioni della scienza, la nostra ignoranza rimane sempre
infinita. Le vicende di questi giorni lo dimostrano ampiamente. Dobbiamo quindi
essere molto attenti. Quella della contrapposizione fra Nord e Sud è una via
che, una volta imboccata, può condurre solo a ulteriori divisioni e
frantumazioni o, come lei dice, al trionfo del particulare. I grandi maestri
delle scienze sociali ci hanno insegnato che gli uomini sono ovunque soggetti
alle stesse imperfezioni e alle stesse miserie. Ciò che li migliora o che rende
più produttivo il loro lavoro è l'adozione di norme di comportamento che
cambiano la gamma delle possibilità e delle impossibilità di ciascuno. Se il
divario fra le varie aree del Paese non è stato colmato dopo tanti anni di
interventismo, ciò è dovuto all'ostinazione con cui la classe politica e le sue
clientele hanno perseverato nella loro attività parossisticamente
redistributiva, che produce l'opposto di quel che promette».
Il virus, con le sue conseguenze sanitarie, economiche e sociali,
aumenterà la distanza tra Nord e Sud? E come?
«Bisogna pensare in termini diversi dal passato. Le logiche
redistributive non hanno fin qui consentito il recupero delle aree
economicamente meno sviluppate; e non lo faranno in futuro. Diversamente da quel
che viene talvolta rozzamente detto, non si tratta di un'incorreggibile e
genetica incapacità delle popolazioni meridionali. Un discorso del genere non è
accettabile da alcun punto di vista. Bisogna avere chiare le condizioni che
rendono possibile lo sviluppo economico. Occorre comprendere cioè che, nella
misura in cui le politiche redistributive impediscono la crescita
dell'imprenditorialità e del tessuto autenticamente produttivo, il problema non
potrà essere superato».
In tutto questo, mentre Nord-Sud e Stato-Regioni si fanno la
guerra, quale è il ruolo dell'Europa? Esce rafforzata o indebolita dalla
pandemia? C'è anche una guerra tra partigiani del Mes contro patrioti
dell'Eurobond.
«Penso che la discussione che riguarda l'Unione Europea risenta
del tribalismo che ha colpito il dibattito relativo alle questioni interne. Il
confronto ha avuto momenti assai poco gradevoli. È stato dominato dal
tatticismo, da assurde preclusioni (l'incomprensibile rifiuto del Mes) e da
esorbitanti pretese (l'immediata emissione di eurobond da parte un'Unione che
non ha potestà impositiva diretta). È mancato un rilevante coefficiente di
onestà intellettuale e, senza di ciò, non ci può essere quella passione civile
che dovrebbe prevalere in situazioni come quella di oggi. La burocrazia europea
non può piacere ad alcuno, se non a se stessa. Ma l'Europa sarà come noi
vorremo. Non dipende dagli altri; dipende esclusivamente da noi. Quella europea
rimane una grande idea. Il prezzo del suo fallimento produrrebbe una situazione
catastrofica, che trascinerebbe nella miseria più nera gli strati economicamente
più deboli. E contro ciò varrebbero assai poco le declamazioni di una classe
politica chiaramente inadeguata.
Commedia All'Italiana. Esistono ancora i Settentrionali?
Roberto Marino il 31 maggio 2020 su Il Quotidiano del Sud. I maligni dicono che
questa rivalità sia iniziata quando Vittorio Emanuele II e Garibaldi non avevano
neanche fatto in tempo a girare i cavalli dopo la storica stretta di mano a
Teano. È lì che è nato tutto: nordisti e sudisti, muro contro muro, fino a
finire a “polentoni” contro “terroni”. Per la verità sono stati loro a
cominciare: mille camicie rosse mandate allo sbaraglio, nascondendo la mano e le
ambizioni sabaude del grande Piemonte, non sono una cosa da niente. E gli
italiani? Ferite e lacerazioni non si risolvono con meno di due secoli. Il
servizio di leva, le fabbriche e la televisione ci hanno provato a creare un
popolo che avesse qualcosa in più in comune che la spartizione di una fettuccia
di terra a spigolo nel Mediterraneo. E se un minimo di condivisione della lingua
lo si deve alla Rai, il resto è rimasto più o meno com’era, pregiudizi,
discriminazioni e insulti compresi. Poi da 30 anni in qua, sono arrivati quelli
del Carroccio a rimestare le differenze e a scavare crepe, gettando sulla
Questione meridionale anche una patetica e inquietante ombra razzista. Ma è
teatro, solo teatro. Perché poi la Storia si prende le rivincite e rimette
sempre le cose a posto. «Si è sempre meridionali di qualcuno», dice il professor
Bellavista chiuso a lume di candela in ascensore con sciur Cazzaniga. E così 180
anni di pregiudizi incartati con la peggiore retorica padana, finiscono per
diventare anacronistici. A forza di prendersela con i terroni, l’identità
nordica è andata a farsi benedire. A Milano il cognome più diffuso sull’elenco
del telefono è Hua, non proprio meneghino; e nella francofona Valle d’Aosta
prevalgono quelli calabresi. Il mondo cambia sotto i nostri occhi e non aspetta
nessuno, neanche quelli dei prati di Pontida con le ampolle dell’acqua del Po.
Tra minacce di secessione, esibizioni di superiorità, presunzioni e ricchezze
cumulate nell’ingiustizia delle spartizioni dei bilanci statali, il Nord si è
ritrovato dentro l’incubo incredibile del coronavirus. I numeri sono dalla parte
loro, ma l’identità? Esistono ancora i settentrionali? Certo che ci sono, ma
sono minoranza. Quanti sono i torinesi, i milanesi, i veneziani, i genovesi di
sangue puro da generazioni e generazioni? Pochi, una comunità sopraffatta in
casa, malgrado tutte le misure e gli esorcismi per tenere a distanza gli
«africani dello Stivale». Il Nord ha vinto tutte le battaglie ma ha perso la
guerra con «gli inferiori». Ne sono consapevoli soprattutto i passeggeri e i
guidatori del Carroccio. Cinema, teatro, televisione, letteratura parlano più
dei vinti che dei vincitori. E così il riccone di provincia veneto o lombardo
deve sorbirsi gli effetti e i prodotti di una cultura bollata come minore,
insignificante, impalpabile. Rosicano, e come se rosicano. Gli alfieri della
Lega più volte hanno stuzzicato l’argomento: basta con il terrone Camilleri o De
Giovanni o Saviano. «Basta con queste storie che parlano una lingua che si fa
fatica a capire». Bisogna pure comprenderli, poverini. Ma è andata così. I vinti
si sono riscattati con i vincitori. Gli hanno lasciato le cifre del conto in
banca e delle carte di credito. I numeri delle statistiche economiche, il ruolo
di locomotiva dello sviluppo, i servizi più efficienti. L’agiatezza non sempre
produce idee culturali, soprattutto quando è finalizzata a un edonismo fine a se
stesso, senza neanche la spinta a chiedersi come e perché. Essere primi e
accomodati nel benessere non produce sempre voglia di capire, crescere,
raccontare. Il Nord è quasi sparito dalle storie, pur avendo i cinema, le
librerie, i teatri e gli indici di lettura migliori. Il vecchio Sud ha rimontato
il distacco sull’analfabetismo, ha saputo stringere i denti e imparare da chi ha
accolto i suoi figli con la valigia di cartone. Si sono integrati, hanno
orecchiato le cadenze e gli accenti. Fino a diventare una comunità che guarda al
resto del paese. qualche volta, dall’alto in basso. Negli stadi di Torino,
Bergamo, Verona, Brescia i cori contro i tifosi meridionali arrivano anche da
altri sudisti trapiantati al Nord. La voglia di identità fa questi scherzi. La
rivincita dei padani. Creare dai terroni i nuovi polentoni. Due Italie in una e
non più una in due. Quando scompariranno dialetti, tradizioni, differenze,
avremo forse gli «italiani», un Paese più omogeneo, ma chi ha detto che sarà
anche migliore?
L'Italia è finita di Pino Aprile.
Dopo lo straordinario successo di Terroni, Pino Aprile firma un libro infuocato,
che irrompe con forza nel dibattito politico. Autorevoli studi e indagini dicono
che, tra una manciata di anni, l'Italia, e forse l'Europa, non esisteranno più.
Almeno come le conosciamo ora. Si spezzeranno per il fallimento della loro
economia e non reggeranno alla spinta disgregatrice dei mercati finanziari.
D'altronde, già oggi l'Italia non è più la stessa: grandi aziende, grattacieli,
squadre di calcio appartengono a capitali stranieri. E unita, in realtà,
l'Italia non lo è mai stata. Piuttosto, è il risultato di un'operazione
scellerata di saccheggio e conquista, che ha distrutto il Sud. È questa la
crepa, mai sanata, che si allargherà fino a inghiottire tutto l'edificio
dell'Italia unita? O forse nelle tensioni e nelle divisioni gli italiani danno
il meglio e lo smembramento sarà la nostra salvezza?
“L’ITALIA E’ FINITA. E FORSE E’ MEGLIO COSI’”: NUOVE VERITA’ NEL
NUOVO LIBRO DI PINO APRILE. Gennaro De Crescenzo su neoborbonici.it. “L’ITALIA
E’ FINITA. E FORSE E’ MEGLIO COSI’”: NUOVE IMPORTANTI VERITA’ NEL NUOVO LIBRO DI
PINO APRILE. Pino Aprile analizza (da giornalista vero e spesso da storico vero)
i fatti del passato e del presente del Sud (e anche dell’Italia e del mondo) e
propone una sua soluzione dei problemi. “Tutto qui”, potremmo dire ma altro che
“tutto qui”, se pensiamo che quelle analisi e quelle soluzioni molto spesso
nessuno le ha fatte o prospettate e che si tratta (pur partendo dal passato) di
analisi e soluzioni nuove. Dico da sempre che nel mondo del meridionalismo si
dovrebbe parlare di epoca pre e post-terroni per quante persone, da quel lontano
2010, sono state sensibilizzate su temi spesso sconosciuti. Il successo di Pino
Aprile è in gran parte legato allo schema utilizzato nel suo best-seller, negli
altri libri sul tema (da “Giù al Sud” al recente e importante “Carnefici”) e nel
nuovo libro pubblicato qualche settimana fa: “L’Italia è finita. E forse è
meglio così”. Pino Aprile non ha “la” soluzione per risolvere i problemi del Sud
(si chiama “questione meridionale” e intere generazioni di politici e/o
meridionalisti non sono riusciti a risolverla). Pino cerca “una” soluzione e la
cerca alla luce di studi continui e di esperienze “sul campo”, nel confronto
quotidiano che ha con i suoi lettori sui social come con le centinaia di
conferenze in giro per l’Italia e per il resto del mondo (conosco poche persone
in grado di percorrere tanti chilometri all’anno come Pino). I "nemici" di
Aprile, allora (pochi, pochissimi , se rapportati agli incredibili numeri degli
"amici" raccolti in questi anni), o non leggono i libri di Aprile (un'occhiata
al web e alle copertine, un pizzico di pregiudizi, una buona dose di invidia o
un poco di antico antimeridionalismo e siamo pronti!) oppure sono distratti:
fanno evidentemente finta di lamentarsi per l'assenza delle fonti (eppure è
facile: le mette all'interno del testo e non nelle note!) solo per l'incapacità
di contrastarne le tesi (frutto in gran parte di ricerche personali o di quelle
fonti, accademici alternativi "in primis"). Fanno evidentemente finta di
contestare la validità di tante tesi senza entrare mai nel merito (spesso si
tratta di opinionisti più o meno famosi che non sanno neanche dove sia il Sud) e
senza mai proporre tesi alternative o, anzi, riproponendo tesi che hanno ridotto
il Sud come sappiamo in 150 anni di colonizzazione e di questioni meridionali
mai risolte e sempre più gravi con colpe che di certo non possono essere di Pino
Aprile (non ha mai curato neanche l’amministrazione del suo condominio e non ha
mai neanche cercato -pur avendo avuto non poche offerte- di diventare il
“leader” dell’ennesimo partito meridionalista o della corrente meridionalista di
qualche partito nazionale).
“Da un secolo e mezzo, i meridionalisti muoiono senza veder la
fine della questione meridionale, nata in Italia, con l'annessione violenza del
Regno delle Due Sicilie al regno sabaudo. L'Italia unita mi piace, ma alla pari;
e la questione meridionale mi dispiace più di quanto mi piaccia l'Italia
unita. Non voglio morire senza averne vista la fine (ho 68 anni e siamo longevi
in famiglia, fatevene una ragione). Per cui: o finisce la questione meridionale
o finisce l'Italia unita. E io ci voglio essere”. Qualcuno potrebbe mai
contestare questa affermazione a meno che non sia un ministro o il figlo di un
ministro italiano in carica o in “ex carica” dal 1860 ad oggi? Qualcuno potrebbe
mai dire che non è vero che dal Sud “prima dell’unità non emigrava nessuno e che
il Sud aveva i due terzi dei soldi di tutta Italia” o che in Italia esiste “una
parte che insulta e si ritiene superiore e una parte che viene insultata e non
reagisce più, perché dai e dai, si è convinta di esser inferiore”? E’ una
falsità scrivere che “in Italia esiste una parte in cui costruiscono sempre più
ospedali in cui accogliere malati costretti a emigrare, per curarsi e una parte
in cui chiudono sempre più ospedali, onde costringere i malati a emigrare per
curarsi; una parte in cui si pagano meno tasse e si hanno più servizi e una
parte in cui si pagano più tasse per avere meno servizi e scadenti”? A meno che
non siate direttori di nomina politica di un giornale o opinionisti più o meno
“ufficiali” (e loro “seguaci” ignavi, ignari o più o meno consapevoli) o
politici con responsabilità dirette o indirette (pure la passività è una colpa),
qualcuno in buona fede potrebbe mai definire falsa la tesi secondo la quale
“chiamare questo ‘un Paese’ è una presa in giro, una truffa che può durare solo
finché non lo si sa o si finge di non sapere”? Del resto gli studi (anche
internazionali) e i segnali (anche elettorali) che dimostrano la tesi di Aprile
(la fine dell’Italia) non sono affatto pochi e solo chi non vuole leggerli, per
pigrizia o per complicità, può far finta di nulla. Del resto la domanda è facile
e la risposta dovrebbe essere altrettanto facile (un sì o un no): “è vero o no
che la politica ‘unitaria’ ha scavato un solco quasi incolmabile fra le due
macro-regioni, per concentrare ricchezza e infrastrutture solo in una delle
due”? E’ vero o no che “l'Italia è il Paese occidentale che ha le più grandi
disuguaglianze”? Non perdete tempo a cercare e ad affibbiare a Pino Aprile le
definizioni più negative e (secondo voi) offensive (“terronico, terronista,
neoborbonico, nostalgico, secessionista” ecc. ecc.) e dimostrate, se potete, che
non è vero che “l’Italia ha il divario più duraturo del pianeta (per strade,
treni, scuole, investimenti, reddito, diritti, salute, vita media...)”. Non
accontentavi dei titoloni dettati dai governi di turno (“disoccupazione in calo,
crisi finita” ecc.). Non accontentavi neanche delle statistiche nazionali che
fanno di tutto per “coprire” i dati regionali e rassegnatevi all’idea che il Sud
Italia è la zona più povera d’Europa e, purtroppo, Pino Aprile ha ragione… E
sono in tanti, sempre di più, a porsi una domanda drammatica: “perché devo stare
con chi mi ha derubato, mi deruba, mi insulta e mi ricorda a ogni passo che non
mi vuole, dopo avermi costretto a unirmi a lui a mano armata?”. E qui non si
tratta di essere anti-italiani e di spingere verso eventuali secessioni: la
secessione è in atto da 150 anni e, come diciamo spesso, è in quella percentuale
drammatica che riguarda i nostri giovani meridionali (che hanno la metà dei
diritti, del lavoro, dei servizi, delle infrastrutture, delle occasioni e delle
speranze di quelli del resto dell’Italia e dell’Europa). Qui si tratta di
rendersi semplicemente conto di come sono andate le cose e di come continuano ad
andare con la consapevolezza che “gli italiani si sentivano ed erano tali più
quando, nel solco di storia, cultura e religione comuni, si ammiravano ed
emulavano, in concorrenza, a volte armata, per le loro ricche diversità”. Ancora
più chiara un’altra sintesi: “Il Paese si rompe, perché non lo si volle unire,
ma assimilare. L'operazione non è riuscita”. Ai limiti del mondo pirandelliano,
poi, è chi contesta ad Aprile (e magari ai neoborbonici) un dato inconfutabile:
“in tutti i Paesi ci sono zone più ricche e più povere e lo Stato spende in
queste ultime, più di quanto riceva”. E se “l’Italia è finita” è colpa di Pino
Aprile che ci ha scritto un libro oppure di una Lega (sempre e comunque) Nord
che governa da decenni e che nel suo statuto ha tra gli obiettivi la creazione
della Padania (ed è quasi riuscita a crearla con la complicità periodica degli
altri partiti)? E’ colpa di un libro o della prossima e bene avviata
“secessione” del Veneto (e poi di Lombardia ed Emilia Romagna) finalizzata a
distruggere quel patto di solidarietà nazionale a puri scopi economico-fiscali?
E’ anti-italiano Aprile o chi offende il Sud ogni giorno con i suoi giornali
(“Ci tocca mantenere un meridionale”, titolava Libero poche ore fa) o chi finge
di ignorare quello che le regioni del Nord stanno facendo (con successo e anche
in queste ore)? “Qual è il nuovo disegno del mondo? Quale il nostro posto,
quello dell'Italia?”. Quello che emerge da questo libro non è una certezza ma
una domanda, legittima, sacrosanta e che dovrebbe aprire dibattiti veri e
possibilmente democratici. E se la vita media al Sud è diminuita di 4 anni
rispetto al Nord (e a Napoli di 8) è colpa di Pino Aprile, dei meridionali che
decidono di morire prima o di chi ha governato questo Paese? “L'alternativa è
costruire un Paese veramente uno, ma il Nord non vuole e il Sud non ha più tempo
di aspettare. E non si capisce perché il derubato dovrebbe ancora fidarsi del
ladro” (e la frase dovrebbe campeggiare su strade e piazze del meridione
d’Italia). “L'ingegneria istituzionale non risolve da sola; è utile solo in
presenza di consapevolezza e volontà diffuse e condivise” è la risposta di
Aprile a chi invoca anche da queste parti macroregioni o altri assetti
istituzionali ed è una risposta che non possiamo non condividere sottolineando
anche un altro aspetto evidenziato nel libro: sotto la spinta “emotiva” delle
bandiere venete o lombarde qualcuno potrebbe pensare di “accettare la sfida” e
di chiedere la stessa “autonomia” ma potrebbe cadere nella ennesima trappola:
questo sistema oggettivamente nord-centrico, per continuare a “utilizzare” il
Sud, potrebbe concedergli “autonomia” ma mai una vera “indipendenza”... Del
resto è difficile per chiunque contestare il confronto tra i dati veicolati dai
soliti Giletti o Del Debbio o Feltri di turno e quelli reali (idem per le
questioni storiche con il supporto, magari, dei nuovi studi di accademici onesti
e coraggiosi come Daniele, Malanima, Fenoaltea o Tanzi). Del resto è difficile
minimizzare l’importanza di movimenti come quello neoborbonico (raccontato con i
recenti articoli di Limes) o dei tanti che si battono per la verità storica
diventando (lo ammise lo stesso Galli della Loggia tempo fa) “maggioritari” e
creando non poche inquietudini sui fronti accademico/ufficiali impegnati in
strenui e stressanti tour con convegni (tra di loro) per spiegare a se stessi e
ai loro poveri alunni chi è Pino Aprile o chi sono i neoborbonici (guardandosi
bene, ovviamente, dall’invitare sia il primo che i secondi). Non era facile
affrontare temi che Aprile aveva già affrontato arrivando con un messaggio forte
e chiaro sia ai lettori (magari post-terronici) “che sanno” e anche a quelli che
“non sanno” e Aprile lo ha fatto con grande abilità (il libro è articolato e
massiccio ma si legge con velocità e con piacere) guardando le cose da una
prospettiva diversa da quella utilizzata nei libri precedenti (anche solo un
occhio allo stile e ai contenuti dei finali dei capitoli vi fa capire perché
Pino Aprile ha il successo che in tanti non hanno). Questa volta, tra l’altro,
il Sud (dall’unità alle sue conseguenze passando per la Cassa per il Mezzogiorno
fino ai drammatici dati attuali ignorati dagli intellettuali ufficiali troppo
impegnati magari a combattere i “giorni della memoria“) non è l’unico
protagonista del libro insieme a tante analisi e a tante tesi sulla nuova Europa
e il nuovo mondo che stiamo vivendo e che forse vivremo. “L'Italia che proprio
non riesce a essere unita, parrebbe avere tutto da guadagnare, rompendosi.
Meglio, peggio? E che ne so: è una possibilità, è l'adeguamento al futuro e
potrebbe darci sorprese. Per il Sud, peggio dell'ultimo secolo e mezzo, e
soprattutto dei primi due decenni e degli ultimi due è difficile”. Una tesi, una
possibilità, una sfida, una scommessa… Chiamatela come volete ma se ancora amate
il Sud e, in fondo, l’Italia, non potete fare finta di non aver letto queste
parole e non potete non leggere questo libro. Gennaro De Crescenzo
·
Un paese di inventori.
Italia e
innovazione, richieste di brevetti in crescita più della media Ue.
I dati relativi al 2019. A livello globale, nessuno come Huawei. La Repubblica
il 15 Marzo 2020. Prima del coronavirus, perché ormai è chiaro che bisogna
dividere la nostra epoca tra una fase pre e post virus, l'Italia aveva
registrato una brillante performance per quel che riguarda l'innovazione. L'anno
scorso ha messo a segno il quinto anno consecutivo di crescita di richieste
di brevetti, in particolare nel settore dei trasporti e delle macchine utensili.
E' quanto rileva l'European patent Office secondo cui sono salite dell'1,2%,
sopra la media Ue dello 0,9%. Le 4456 domande inoltrate da società e inventori
italiani sono guidate da quelle della Lombardia che scala di una posizione (da
13esima a 12esima), la classifica delle regioni europee. Fra le società la
bolognese G.D. (sigarette) si è rivelata quella più attiva nella domanda
di brevetti presentati a Epo, seguita da Pirelli (46), Prysmian (46), Chiesi
Farmaceutici (42), Saipem (37), Leonardo (30), Istituto Italiano di Tecnologia
IIT (27), Ansaldo Energia (25), Brembo (20) e Telecom Italia (20). Fca, Cnh e
Stm non appaiono nella classifica perché domiciliate nei Paesi Bassi. A livello
globale, con 3524 domande, Huawei è stata in assoluto la società con il più alto
numero di richieste presentate a EPO nel 2019. Samsung si è posizionata al
secondo posto mentre LG è arrivata terza. Le due società coreane sono tallonate
dall'americana United Technologies e da Siemens, che, arrivata prima lo scorso
anno, nel 2019 si è posizionata al quinto posto. Nel complesso, European Patent
Office ha ricevuto richieste (che rappresentano un nuovo record assoluto) per
più di 181 000 brevetti nel 2019, con un aumento del 4% rispetto al 2018. Di
queste, solo il 45% delle domande era di provenienza dei 38 Paesi aderenti
all'EPO mentre il 55% arriva da altre aree. I primi 5 Paesi per numero di
richieste sono gli Stati Uniti (25% del totale), la Germania (15%), il Giappone
(12%), la Cina (7%) e la Francia (6%) (Fig.: L'aumento delle richieste lo scorso
anno è stato sostenuto soprattutto dalla crescita robusta della Cina, degli
Stati Uniti e della Corea del Sud. Altro trend inconfutabile sembra essere
l'ascesa delle richieste di brevetto nei settori della Comunicazione digitale e
del Computer Technology, che riflettono l'importanza in rapido aumento delle
tecnologie correlate alla trasformazione digitale.
·
Il Rapporto Italia 2020 dell'Eurispes e dell’Istat.
Indagine Eurispes: il 15,6% crede che la Shoah non sia mai
esistita, erano il 2,7% nel 2004.
Presentato il 'Rapporto Italia' 2020: diminuiti del 10% gli italiani favorevoli
allo Ius Soli e uno su due si sente sicuro nella propria città. Il presidente
Gian Maria Fara: "Si allarga la frattura tra il Sistema e il Paese, la politica
intervenga". La Repubblica il 30 gennaio 2020. Dal 2004 a oggi aumenta il numero
di chi pensa che la Shoah non sia mai avvenuta: erano solo il 2,7% oggi sono il
15,6%. Lo sostiene il 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes. Risultano in
aumento, sebbene in misura meno eclatante, anche coloro che ridimensionano la
portata della Shoah dall'11,1% al 16,1%. Secondo la maggioranza degli
italiani, recenti episodi di antisemitismo sono casi isolati, che non sono
indice di un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese (61,7%). Al tempo
stesso, il 60,6% ritiene che questi episodi siano la conseguenza di un diffuso
linguaggio basato su odio e razzismo. Per meno della metà del campione (47,5%)
gli atti di antisemitismo avvenuti anche in Italia sono il segnale di una
pericolosa recrudescenza del fenomeno. Per il 37,2%, invece, sono bravate messe
in atto per provocazione o per scherzo. Al campione dell'Eurispes è stato
chiesto quali affermazioni esprimono al meglio l'anima politica della
maggioranza degli italiani. Trova un "discreto consenso" l'affermazione secondo
cui "molti pensano che Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso
qualche sbaglio" (19,8%). Con percentuali di accordo vicine tra loro seguono
"gli italiani non sono fascisti ma amano le personalità forti" (14,3%), "siamo
un popolo prevalentemente di destra" (14,1%), "molti italiani sono fascisti"
(12,8%) e, infine, "ordine e disciplina sono valori molto amati dagli italiani"
(12,7%). Oltre un italiano su quattro (26,2%) non condivide nessuna delle
opinioni proposte.
Cittadinanza e immigrazione. Rispetto al 2010, sono diminuiti di oltre dieci
punti gli italiani favorevoli allo Ius soli (dal 60,3% al 50%) e sono aumentati
notevolmente i sostenitori più rigidi dello Ius sanguinis (dal 10,7% al 33,5%,
quasi 23 punti in più). In calo anche gli italiani che si augurano che venga
concessa la cittadinanza per chi è nato in Italia, purché educato in scuole
italiane (dal 21,3% al 16,5%). Emerge dallo studio che un quarto degli italiani
ha un rapporto negativo con gli immigrati e da uno su tre, vengono visti come
una minaccia all'identità nazionale. Cresce anche la convinzione che gli
stranieri tolgano lavoro agli italiani e per contrastare l'immigrazione
clandestina l'ipotesi prevalente è "aiutiamoli a casa loro". Quattro italiani su
dieci (40,3%) definiscono il proprio rapporto con gli immigrati "normale", quasi
uno su cinque (19,4%) parla di reciproca indifferenza, il 14,4% di reciproca
disponibilità, mentre un decimo trova gli immigrati ostili (10,1%), l'8,1% li
trova insopportabili, il 7,7% afferma di temerli. Secondo il 45,7% degli
italiani un atteggiamento di diffidenza nei confronti degli immigrati è
"giustificabile, ma solo in alcuni casi". Per quasi un quarto (23,8%) guardare
con diffidenza gli immigrati è "pericoloso", per il 17,1% (+6,7% rispetto al
2010) è "condivisibile", per il 13,4% è "riprovevole" (-4,3% rispetto al 2010).
Sicurezza. Il 53,2% degli italiani ritiene di vivere in una città abbastanza
(44,1%) e molto (9,1%) sicura; sul versante opposto, il 30,4% giudica la propria
città come poco (26,3%) e per niente sicura (4,1%). Il Rapporto Italia 2020
dell'Eurispes aggiunge che, anche se con un dato che si discosta solo in parte
dalle altre fasce d'età, sono soprattutto i giovanissimi (dai 18 ai 24 anni) a
segnalare un livello basso di sicurezza nella città in cui vivono
(complessivamente poco o per niente sicura per il 33,3%). Le Regioni del Centro
(34,6%) e del Sud Italia (35%) raccolgono il numero più elevato di cittadini che
ritengono di vivere in città non sicure. Al campione è stato chiesto se e come
sia cambiata negli ultimi due anni la paura di subire reati. Nella maggior parte
dei casi essa è rimasta invariata (68,5%), e dal confronto con le risposte
fornite alla stessa domanda nell'indagine del 2019, nel 2020 si evidenzia un
calo di quanti hanno visto aumentare la propria paura (dal 30% al 24,5%), in
favore di coloro i quali ritengono che sia rimasta invariata (+9,4% rispetto al
2019). Resta, comunque, considerevole la percentuale di italiani che mostrano la
convinzione del rischio di subire reati, dato che solo il 7% afferma che la
paura sia diminuita, in calo rispetto al 10,9% riscontrato nel 2019.
Le misure del governo. Tra le misure attuate o proposte dal Governo le più
criticate sono il reddito di cittadinanza con il 67,1% delle indicazioni
negative e la Sugar Tax (67,4%); anche la Flat Tax incontra la disapprovazione
della maggioranza (62,6%). Quota 100 è apprezzata da sei cittadini su dieci
(59,2%) e un numero simile si esprime positivamente sull'autonomia delle Regioni
(57,6%); conquista, anche se non in maniera netta, la tassa sulla plastica
(51%). Quanto alla condizione economiche delle famiglie sebbene ci siano "lievi"
segnali di ripresa la metà dei cittadini continua a 'polverizzare' i risparmi.
Secondo la maggioranza degli italiani la situazione negli ultimi 12 mesi è
rimasta stabile (37,9%), il 37,5% ha riscontrato invece un peggioramento netto o
parziale. Circa un cittadino su dieci (14,3%) nota un miglioramento. Nelle isole
il disagio di un'economia negativa - sostiene l'Eurispes - arriva al 72%, con
una distanza con le altre aree geografiche del Paese che arriva a segnare un
divario tra i 30 e oltre i 40 punti percentuali. Quasi la metà delle famiglie
(47,7%) è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese (+2,6%
rispetto al 2019); ma crescono seppur di poco quelle che riescono a risparmiare
(23,7%; +1,7%). Saldare la rata del mutuo rappresenta un ostacolo per il 34,1%
degli italiani (+1,4%). Far fronte alle spese mediche è un problema per il 22,3%
degli italiani (+1,2%). Almeno un italiano su dieci (11,9%) è caduto nelle
maglie dell'usura non potendo accedere al credito bancario:erano il 7,8% nel
2018 e il 10,1% nel 2019.
Le preoccupazioni degli italiani: disoccupazione, tasse e ambiente. Dopo la
disoccupazione (56%) e l'esosità delle tasse (39%), la tutela dell'ambiente è la
terza preoccupazione degli italiani (37%). Tuttavia, solo poco più della metà
(53%) acquista prodotti realizzati con materiali riciclati e solo uno su cinque
adotta abitualmente comportamenti sostenibili. E' il quadro che emerge dal
32esismo rapporto dell' Eurispes, in cui viene ricordato che l'Italia è il
maggiore produttore al mondo di beni di consumo di plastica: ogni anno 2,1
milioni di tonnellate di plastica vengono usati per imballaggi e il 76% di
questi per il settore food & beverage. Istat, tornano a calare gli occupati a
dicembre. Maxi calo per i posti fissi, record di precari. Più di un terzo degli
italiani (34,7%) è disposto a ridurre i consumi quotidiani per limitare il
riscaldamento terrestre (nel 2018 erano il 23%,); un altro terzo (33,2%) crede
possa servire se lo fanno in tanti tutti i giorni (41,1% nel 2018,); l'ultimo
terzo (32,1%) si divide tra chi crede sia un problema troppo grande da risolvere
attraverso i comportamenti dei singoli (17%; nel 2018 erano il 20,2%), chi è
poco disposto a cambiare le proprie abitudini (9,7%; nel 2018 erano il 10,1%) e
chi crede non serva a niente (5,4%; nel 2018 il 5,6%). Per ridurre i consumi
molti sono disposti a utilizzare lampadine a basso consumo (79,4%), ad
acquistare prodotti privi di imballaggio in plastica (74,4%), a ridurre l'uso
dell'auto privata (72,2%), a usare meno i condizionatori d'aria d'estate (71%),
e a consumare meno acqua quando ci si lava (70,1%). Meno apprezzata la
possibilità di rinunciare il più possibile ai viaggi in aereo (59,7%), insieme
all'acquisto di pannelli fotovoltaici per la propria casa (63,2%).
I
mezzi di comunicazione, la tv resta la più credibile. La Tv, anche se in calo,
rimane sempre il mezzo più credibile per gli italiani, mentre i social non
vengono considerati affidabili. La televisione, come mezzo per formarsi una
opinione di voto, perde dieci punti in 10 anni e che un quarto degli italiani
non si affida ai mezzi di informazione. Quelli che considerano ancora la
televisione il mezzo più attendibile sono il 64,6%; seguono giornali radio
(59,8%), quotidiani (55,3%), quotidiani online (51,1%), talk televisivi (42,4%),
forum o i blog (41,1%) e social network (35,4%). Quasi tre italiani su dieci
(28,6%) formano la propria opinione di voto sulla base delle informazioni che
apprendono in Tv (anche se nel 2008 il dato era al 38,3%); un quarto (24,6%) non
si basa su alcun mezzo, in quanto ha idee proprie. Pochi si affidano a Social
(12,2%), quotidiani (10,1%), quotidiani on line (8,5%), radio e comizi dei
candidati (5,2%). Ad influenzare maggiormente le scelte di voto sono i valori e
le opinioni personali (32,6%) seguono la propria situazione economica/lavorativa
(16,8%), la propria visione del futuro (14,8%), la situazione familiare (10,5%),
la tradizione familiare (9,6%) e l'opinione di parenti ed amici (8,8%). Si
allarga sempre più "la frattura tra Sistema e Paese" che "produce numerosi danni
anche sul piano economico e mette in discussione la stessa tenuta sociale". È
l'immagine delineata dal 32esimo 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes. Una
possibile via d'uscita la traccia il presidente dell'istituto Gian Maria Fara:
"È necessario che la politica possa contare su fondamenta rinnovate" e, quindi,
su una sua 'nuova' Costituzione. "Ci si confronta ormai - sostiene - con la
mancata crescita del Paese che è divenuta strutturale, con l'imbarbarimento del
clima del pubblico dibattito, con la sterile litigiosità che si rispecchia in un
sistema dei media il quale si nutre più di elementi distruttivi che costruttivi,
con l'inefficienza della Pubblica amministrazione, con i fenomeni endemici della
corruzione, con l'illegalità diffusa, con la sostanziale irresponsabilità della
classe dirigente". "I dati del rapporto Eurispes sono allarmanti. Dal 2004 a
oggi gli italiani che negano la Shoah sono cresciuti dal 2,7 al 15 per cento. Il
negazionismo continua a infangare la memoria di questa tragedia", ha commentato
il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri. "Dobbiamo fare di più affinché le
teorie negazioniste non trovino nuovo consenso. E' responsabilità di tutti noi
non sottovalutare questi dati".
Vecchio, ma soprattutto poco istruito. Il Paese fotografato
dall’Istat. su Il Dubbio il 15 dicembre 2020. Il
rapporto anziani-bambini è di cinque a uno. Il 50,1 della popolazione ha la
licenzia media, solo il 13,9% ha conseguito una laurea. L’Italia è un Paese
sempre più vecchio. La conferma arriva dai primi dati del censimento permanente
della popolazione diffusi dall’Istat. Tutte le classi di età sotto i 44 anni
vedono diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011 mentre aumentano
molto le persone dai 45 anni in su che passano dal 48,2% del 2011 al 53,5% del
2019. L’età media si è innalzata di due anni rispetto al 2011, da 43 a 45 anni.
La Campania, con 42 anni, è la regione con la popolazione più giovane, seguita
da Trentino Alto Adige (43 anni), Sicilia e Calabria (entrambe con 44 anni). La
Liguria si conferma la regione con l’età media più elevata (49 anni). Anche nel
1951 la Campania e la Liguria erano la regione più giovane e quella più vecchia
ma, per entrambe, l’età media risultava più bassa di 13-14 anni rispetto a
quella registrata nel 2019. Il progressivo invecchiamento della popolazione
italiana appare «ancora più evidente nel confronto con i censimenti passati»,
sottolinea l’Istat, spiegando che «il numero di anziani per bambino passa da
meno di uno nel 1951 a 5 nel 2019 (era 3,8 nel 2011)»: anche l’indice di
vecchiaia (dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con
meno di 15 anni) «è notevolmente aumentato, dal 33,5% del 1951 a quasi il 180%
del 2019 (148,7% nel 2001)». Il comune più giovane è Orta di Atella, in
provincia di Caserta, con una età media di 35,3 anni; quello più vecchio è
Fascia, in provincia di Genova, dove l’età media supera i 66 anni. «Ancora
l’anno non è finito ma una previsione fa pensare che quest’anno supereremo il
tetto dei 700.000 decessi complessivi, che è un valore preoccupante perché
l’ultima volta che siamo andati oltre questo numero è stato nel 1944, durante la
guerra», ha detto il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo nel corso di
Agorà su Rai 3.
Popolazione in calo, aumentano gli stranieri. Al 31 dicembre 2019
la popolazione censita in Italia ammonta a 59.641.488 residenti – circa 175 mila
persone in meno rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, pari a -0,3% – ma
risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011, quando si contarono
59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui). È quanto
merge dai primi dati del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni diffuse dall’Istat. Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono
nell’Italia meridionale e nelle isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano nell’Italia
centrale (+2%) e in entrambe le ripartizioni del Nord (+1,6% nell’Italia
Nord-orientale e +1,4% nell’Italia Nord-occidentale). Più del 50% dei residenti
è concentrato in cinque regioni, una per ogni ripartizione geografica: Lombardia
(16,8%), Veneto (8,2%), Lazio (9,7%), Campania (9,6%) e Sicilia (8,2%). Il
lievissimo incremento di popolazione residente in Italia rispetto a dieci anni
fa è da attribuire «esclusivamente alla componente straniera». Nel periodo
2011-2019 la popolazione di cittadinanza italiana è diminuita di circa 800 mila
unità (-1,5%) mentre i cittadini stranieri sono aumentati di circa un milione
(+25,1%), senza considerare che sono più di un milione le acquisizioni di
cittadinanza nel periodo 2012-2019 e che già al censimento del 2011 i cittadini
italiani per acquisizione erano quasi 700 mila. I cittadini stranieri risultano
in crescita in tutte le regioni della penisola, a eccezione della Valle d’Aosta,
mentre sono solo quattro le regioni in cui aumenta anche la popolazione
italiana: Lombardia, Lazio, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. La
popolazione residente diminuisce nei comuni con meno di 5 mila abitanti
(-520.843 individui rispetto al 2011) e aumenta in tutte le altre classi
dimensionali, soprattutto nei comuni tra i 50 mila e i 100 mila abitanti (+3,6%)
e in quelli con oltre 100 mila abitanti (+2,5%). Questa dinamica è dovuta
principalmente ai cittadini stranieri, la cui presenza aumenta in tutte le
classi di ampiezza demografica. Gli italiani invece diminuiscono in tutte le
classi di comuni, a eccezione di quella tra 50 mila e 100 mila abitanti La
struttura per genere della popolazione residente si caratterizza per una
maggiore presenza di donne. Nel 2019 le donne sono 30.591.392 – il 51,3% del
totale – e superano gli uomini di 1.541.296 unità. Il Comune italiano più grande
è Roma con 2,8 milioni di abitanti, quello più piccolo Morterone, in provincia
di Lecco, con 30 abitanti. È quanto emerge dai primi dati definitivi del
censimento della popolazione italiana rilasciati dall’Istat.
Lavoro e occupazione. In Italia tra la popolazione residente di
15 anni e più, le forze di lavoro ammontano al 52,5%, dal 50,8% del censimento
2011, mentre calano gli inattivi (47,5% da 49,2%). Gli occupati salgono al 45,6%
dal 45,0% del 2011 (23.662.471 da 23.017.840). La quota di disoccupati passa
invece dal 5,8% al 6,9%. Quote di occupati sopra la media nazionale (45,6%) si
rilevano nelle regioni del Nord e del Centro. Le percentuali più elevate sono
quelle del Trentino – Alto Adige (55,6%) e di Emilia-Romagna, Veneto e
Lombardia, con valori compresi tra il 51,7% e il 51,0%. Livelli più bassi si
registrano principalmente nel Mezzogiorno, soprattutto in Campania (37,3%),
Calabria (36,5%) e Sicilia (34,9%). Anche se di poco, aumenta anche la quota di
donne occupate. Se nel 2011 la componente femminile rappresentava il 41,8% degli
occupati (9.621.295), nel 2019 sale al 42,4%. La maggiore partecipazione delle
donne al mercato del lavoro è confermata dalla variazione intercorsa tra il 2011
e il 2019 che è stata per gli uomini pari a +1,7% (+233.895 unità) e per le
donne di +4,3% (+410.736). Permane però lo squilibrio di genere, confermato
anche dai livelli dei tassi di occupazione (37,4% contro 54,4% per gli uomini),
disoccupazione (15,1% contro 11,6%) e inattività (56,0% contro 38,5%).
Istruzione: 14 laureati ogni 100 persone. L’anno scorso sono
aumentate in Italia le persone in possesso di titoli di studio più elevati
rispetto a otto anni prima. In particolare, si contano quasi 36 diplomati (31
nel 2011) e 14 laureati (11 nel 2011) ogni 100 cento individui di 9 anni e più
mentre i dottori di ricerca passano da 164.621 a 232.833, con un incremento pari
a più del 40%. In particolare, i laureati e le persone che hanno conseguito un
diploma di alta formazione artistica musicale e coreutica di primo o secondo
livello rappresentano il 13,9% della popolazione di 9 anni e più. Il 35,6% dei
residenti ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica
professionale; il 29,5% la licenza di scuola media; il 16,0% quella di scuola
elementare. La restante quota di popolazione si distribuisce tra analfabeti e
alfabeti senza titolo di studio (4,6%) e dottori di ricerca, che possiedono il
grado di istruzione più elevato riconosciuto a livello internazionale (pari allo
0,4% della popolazione di 9 anni e più). Rispetto al 2011, diminuiscono, sia in
termini assoluti che percentuali, le persone che non hanno concluso con successo
un corso di studi (dal 6% al 4,6%) e quelle con al massimo la licenza di scuola
elementare (dal 20,7% al 16,0%) e di scuola media (dal 30,7% al 29,5%).
·
L'onore offeso di Nassirya.
L'onore
offeso di Nassirya.
4 Carabinieri
superstiti alla strage denunciano come siano state concesse onorificenze a chi
non ha avuto ruoli di rilievo e chi ha quesi perso la vita è stato considerato
poco e male. Fausto Biloslavo il 17 gennaio 2020 su Panorama. Medaglie mai
assegnate a chi le meritava, ma concesse ad altri soldati solo per aver fatto
niente di più del proprio dovere. Benefici prima riconosciuti e poi tolti da un
giorno all’altro. Promesse rimaste parole al vento. A 16 anni dalla strage di
Nassiriya le ferite sono ancora aperte. Quattro carabinieri - che per sempre
resteranno segnati dall’attacco kamikaze del 12 novembre 2003 - hanno inviato a
Panorama una lettera aperta, un vero «J’accuse». Ricordiamo prima di tutto
quell’evento tragico. La base Maestrale che ospita la sezione logistica della
Multinational specialized unit (Msu) a Nassiriya, 360 chilometri a sud-est di
Baghdad, viene colpita da un attacco terroristico. Un camion cisterna kamikaze
con 300 chili di esplosivo scoppia davanti all’edificio base presidiato dai
Carabinieri, forzando il cancello d’entrata e proseguendo la corsa sino alla
palazzina di tre piani che ospitava il dipartimento logistico italiano. Prendono
fuoco i mezzi militari parcheggiati nel cortile e anche il deposito munizioni:
feriti e morti ovunque. Il bilancio delle vittime è di 28 morti, di cui 19
italiani e 9 iracheni, ai quali si aggiungono 58 feriti. Coloro che hanno
scritto la lettera al nostro settimanale sottolineano che, subito dopo la
strage, «tutti si sono affrettati, politici, importanti cariche dello Stato e
generali, ad annunciare, (...), provvedimenti di promozione, medaglie e
onorificenze per il “ruolo” svolto e come riconoscenza per le gravi ferite
subite (…) Orbene, semplicemente nulla è accaduto!». L’appello è firmato da
Vittorio De Rasis, Paolo Di Giovanni, Cosimo Visconti e Antonio Altavilla,
quattro dei 19 feriti gravi dell’attacco. Per le vittime dell’attentato è stata
realizzata la Croce d’onore attribuita ai caduti e a chi ha un’invalidità
superiore all’80 per cento, come appunto tre dei quattro firmatari del
«J’accuse» inviato a Panorama. «Nulla agli altri, ma nel corso degli anni senza
destare attenzione sono state, invece, attribuite onorificenze e medaglie di
alto valore a militari che hanno preso parte alla missione Antica Babilonia
nelle varie fasi, ma anche ad alcuni presenti al momento dell’attentato del 12
novembre ancorché lievemente feriti o rimasti assolutamente indenni perché
distanti al momento dell’esplosione» lamentano i carabinieri in congedo. Di
Giovanni era nella palazzina al momento dell’esplosione, vicino al sottotenente
Giovanni Cavallaro, che è deceduto. «Ho perso la funzionalità del braccio
sinistro, una scheggia mi ha perforato il polmone e ho avuto un’emorragia
interna. Non dimenticherò mai la distruzione e il terribile silenzio che ho
trovato quando sono uscito dall’edificio» racconta a Panorama il brigadiere capo
in congedo. Sul sito del Quirinale si può leggere l’elenco delle onorificenze
concesse per la missione in Iraq. Ben 155 riguardano «An Nassiriya», ma quasi
tutte sono elargite per fatti accaduti dopo la strage. «La lettura delle
motivazioni è disarmante da parte di chi ha pagato con il sangue un contributo
altissimo, talvolta ridicole e irricevibile risulta il tentativo di esaltare
fatti o posizioni che chi ha operato sul territorio ben conosce e mai potrà
credere a una scenata immensa» scrivono i carabinieri feriti nell’attentato.
Così, medaglie al merito sono state concesse a chi portava «aiuti finalizzati
alla ricostruzione della provincia di Dhi Qar e ad alleviare le sofferenze della
popolazione locale» facendo semplicemente il proprio dovere «con generosa
dinamicità», ma non certo sotto il fuoco. Un altro decorato ha ricevuto la
medaglia al merito per la «grande capacità di coordinamento e controllo» dalla
sala operativa - non in prima linea - durante uno scontro ingaggiato da un
reparto della missione Antica Babilonia. I firmatari della protesta puntano il
dito contro le onorificenze ad alti gradi che hanno «trasformato normale
attività istituzionale in atto eroico». Al contrario, chi le ha concesse è
rimasto «silente davanti a un solo e unico atto eroico appurato anche dal
processo (per la strage di Nassiriya, ndr): quello del sacrificio del
carabiniere Andrea Filippa che nonostante fosse certo della sua morte, a
distanza di pochissimi metri dal camion (imbottito di esplosivo, ndr) in arrivo,
ha aperto il fuoco ed evitato il totale crollo della palazzina e quindi la morte
di tutti noi (…). Nessuno lo ha considerato per una medaglia al valor militare».
Il luogotenente in congedo dell’Arma, Vittorio De Rasis, non si separa mai dalla
foto che lo ritrae riverso sul cassone posteriore di un fuoristrada col volto
insanguinato. Gli iracheni lo stanno portando di corsa all’ospedale in gravi
condizioni. «Mi accade di rivivere l’incubo della strage almeno quattro, cinque
volte al mese» dice. «Vedo i caduti come Filippo Merlino, che dopo l’esplosione
mi si avvicina barcollando, ma non ce la farà. O l’amico Cosimo Visconti
gravissimo, che è sopravissuto». E il militare ricorda molto bene i colpi
sparati con l’arma in dotazione «da Andrea Filippa, che grazie alla sua reazione
ha fatto esplodere prima il camion». A questo carabiniere hanno dato la Croce
d’onore e la medaglia delle vittime del terrorismo, «che non sono paragonabili a
quella al valor militare» lamenta De Rasis. I familiari dei caduti chiedono
l’alta onorificenza per tutti. Nella lettera aperta a Panorama, i quattro
soldati sollevano il velo sulle operazioni «combat» della missione di pace in
Iraq, rimaste nascoste per motivi politici. «Situazioni di contrapposizione e
guerriglia con elementi ostili, tutti documentabili (…) anche con foto e video
che hanno lasciato morti e feriti a terra ma di cui non bisognava fare parola»
si legge nel testo. De Rasis ricorda quando con la sua squadra è andato a
liberare Enzo, un italiano legato ai servizi segreti che era stato arrestato
dalla milizia del partito sciita Dawa al Islamya. La lettera aperta elenca
ancora gli scontri maggiori, quasi tutti taciuti all’opinione pubblica. «Gli
innumerevoli conflitti a fuoco avuti dalle squadre dell’Unità di manovra
(acquartierata nella palazzina oggetto dell’attentato), l’attacco a diverse
unità presso la sede del comando di polizia locale con l’incendio del mezzo dei
carabinieri e del personale rumeno, la battaglia alla fabbrica del ghiaccio, la
liberazione di ostaggi (…) fino allo scontro per il pagamento delle pensioni». E
aggiunge un particolare scabroso sulla reazione degli iracheni: «Non possiamo
dimenticare quanti il 12 novembre subito dopo l’esplosione, nonostante il
persistere di un altissimo pericolo, si sono prodigati o solo hanno evitato di
sparare sulla popolazione che si era riversata nella base non soltanto per
aiutare ma anche per depredarla di tutto, comprese le armi dei colleghi ormai
deceduti». I quattro carabinieri gravemente feriti si chiedono «perché tutto
questo è stato cancellato? Perché solo alcuni sono stati insigniti dell’Ordine
militare e delle medaglie (…) pur non avendo compiuto azioni di rilievo?». E
dopo la memoria della strage, si riallacciano all’attualità: «Lo stesso
meccanismo utilizzato nell’erogazione di encomi a pioggia solo per alcuni ruoli
di “rilievo” è una prassi». Il riferimento è ai 130 encomi solenni, un record
assoluto, concessi dal precedente ministro delle Difesa, Elisabetta Trenta.
Roberta Pinotti, un’altra donna che ha guidato il dicastero, ne ha concessi solo
una trentina in quasi cinque anni. Per Trenta non è mancato l’encomio «last
minute» firmato il 5 settembre scorso, un attimo primo dell’arrivo del nuovo
ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Destinatario è il colonello Francesco
Greco, capo della Pubblica informazione e comunicazione, «per la preziosissima e
leale collaborazione assicurata ai vertici del dicastero».
Greco viene
citato dai feriti di Nassiriya nella seconda parte della loro lettera che parla
dei benefici previdenziali prima concessi e poi cancellati. «A oggi è sceso un
assordante silenzio, il colonnello Greco incaricato di seguire la cosa non
risponde più al telefono e nuove richieste inviate al neo ministro della Difesa
sono cadute nel vuoto» sottolineano i carabinieri. La beffa è chiara: «A un
certo punto il ministero della Difesa decide (...) di non erogare più le
pensioni privilegiate ai feriti, sostituendole con emolumenti privi di alcuni
benefici che hanno costretto alcuni militari a dover restituire le somme
percepite». Il governo Berlusconi le aveva concesse, ma poi nel 2010 le ha
revocate per chi veniva gestito dalla Difesa, tagliando cifre che variano da 300
a 600 euro mensili a seconda del grado e dell’anzianità di servizio. A
differenza dei feriti che sono di competenza dell’Inps. Nel 2018, «l’allora
ministro della Difesa Elisabetta Trenta, sollecitata dalla presidenza della
Repubblica, riceve alcuni militari a un tavolo tecnico per risolvere la
questione» scrivono ancora i carabinieri. Uno dei partecipanti è Di Giovanni:
«Dopo timide ammissioni di alcuni e risposte riluttanti di altri, si chiudono i
lavori con la promessa di mettere fine all’evidente amputazione di benefici». Il
tempo passa e il colonnello Greco viene indicato come referente, ma le promesse
non hanno seguito. Di Giovanni commenta amaro: «Non ci si può permettere di
prendere in giro chi ha pagato un prezzo sulla propria carne».
·
Toponomastica
Partigiana.
"Senso unico" a sinistra. Le strane vie intitolate e poi
quelle dimenticate. Omaggi a Iotti e Berlinguer,
Togliatti e Marx. Niente per Bucalossi, Craxi, Miglio, Pannella. Alberto
Giannoni, Mercoledì 26/08/2020 su Il Giornale. Perché Milano ricorda Ho Chi Minh
e Marx e dimentica Pietro Bucalossi che è stato un grande sindaco? Perché non
celebra anche il leader socialista Bettino Craxi, primo presidente del Consiglio
milanese, oltre al segretario comunista Enrico Berlinguer, piuttosto estraneo
alla città? E visto che a Palazzo Marino ambiscono alla parità di genere anche
nella toponomastica, perché non danno corso all'idea di un parco-giochi o di una
scuola col nome di Paola Bonzi, fondatrice del Centro per la vita della
Mangiagalli, sicuramente più legata alla città di Nilde Iotti, che sarà
omaggiata con un giardino al pari di Rosa Parks? Forse ci si è posti il problema
di una «par condicio» di genere, e magari anche di un'equilibrata gratificazione
delle tifoserie calcistiche cittadine, però la toponomastica politica resta
sbilanciata verso sinistra. Una mozione per Bucalossi era stata proposta da
Fabrizio De Pasquale (Fi) ma da allora è rimasta lettera morta. Così il primo
cittadino che ottenne il pareggio di bilancio, l'oncologo, il deputato
socialista-democratico aspetta invano, mentre altri personaggi riscuotono
attenzione e celebrazioni. «È arrivato il momento di un po' di pluralismo - dice
De Pasquale - le scelte di questa amministrazione sono a senso unico, pare che
se non si è stati nel Pci non si possa ambire a niente. E invece è il momento di
rendere omaggio alla grande tradizione repubblica e laica di Milano, e ci sono
altre grandi figure che meritano, penso a Bernardo Caprotti, che è stato un
grande imprenditore, ma penso che meritino un ricordo anche Cesare Romiti e
Franco Zeffirelli, legato alla storia della Scala. E anche Marco Pannella è una
figura importante, mentre per Craxi credo che purtroppo dovremo aspettare un
sindaco più coraggioso e meno dipendente dagli starnuti di Beppe Grillo». Sui
giardini Pannella - simbolicamente davanti a San Vittore - la giunta (compreso
il radicale Lorenzo Lipparini) ha pasticciato non poco, inducendo i militanti
dell'associazione Cazzavillan a procedere a una sorta di intitolazione
fai-da-te. E qualcosa del genere accadrà il 3 ottobre anche in corso di Porta
Ticinese, dove sorgeva la «Colonna infame». Parteciperà lo storico Gianluca
Margheriti. L'antefatto è che diversi esponenti della politica e della cultura
con una lettera al Comune (sottoscritta tra gli altri dall'ex sindaco Gabriele
Albertini, dall'ex ministro Claudio Martelli e dall'ex deputato Lorenzo Strik
Lievers) avevano chiesto due targhe: quella per Enzo Tortora sarà posta in via
dei Piatti nel giorno del compleanno del giornalista-presentatore e deputato
radicale (il 30 novembre), ma resta inascoltato l'appello per la targa dedicata
alla «Colonna» resa celebre grazie all'opera di Alessandro Manzoni, quella che
proprio Tortora volle accanto alle sue ceneri nell'edizione con prefazione di
Leonardo Sciascia, grande scrittore «illuminista» e garantista. E a proposito,
resta in sospeso anche l'omaggio a Sciascia, che pure l'assessore alla Cultura
Filippo Del Corno aveva approvato. E un sì dell'assessore era arrivato (invano?)
anche per la Brigata ebraica, che ebbe un ruolo cruciale nella Liberazione di
Milano. Insieme alla tradizione laica e socialista, resta insoddisfatta
l'aspirazione leghista per una via a Gianfranco Miglio, giurista, senatore,
teorico di una feconda riscoperta del federalismo. All'idea di un ricordo di
Miglio dette voce qualche anno fa Stefano Bruno Galli, oggi assessore regionale.
In passato, d'altra parte, molto dovette battagliare la Gioventù liberale per
ottenere una via dedicata a Giovanni Malagodi, prestigioso leader del Pli,
presidente a più riprese dell'Internazionale liberale e ministro degli Esteri:
alla fine ottenne solo un «passaggio», anche se centralissimo. Per passare dai
liberali alla destra, nel 2016 l'iscrizione al Famedio - col via libera
dell'allora presidente del Consiglio comunale, il «comunista Basilio Rizzo» - è
stata concessa al deputato missino Franco Servello. A lungo è stato purtroppo
volutamente «dimenticato» Sergio Ramelli, studente diciottenne che 45 anni fa fu
ucciso barbaramente, solo per il suo orientamento politico, mentre tornava a
casa col motorino. La attuale deputata Paola Frassinetti, allora assessore
provinciale alla Scuola, ha fatto porre una targa. «Ma è nascosta - ha spiegato
di recente - Io penso che Milano non possa non intitolare a Ramelli la sua
scuola». Nel 2005 a questa giovane vittima innocente dell'odio politico furono
intitolati dei giardini. E fu, quella di Albertini, una stagione in cui si
ottenne un certo bilanciamento delle intitolazioni, basti pensare ai giardini
per Montanelli, in corso Venezia, dove è stata collocata una statua del
giornalista, che di recente è stata presa di mira da vandali politici e
criticata anche da altri, a sinistra. No problem invece per la palazzina Liberty
intitolata a Dario Fo. Ci sono Comuni d'altra parte Comuni con vie Togliatti,
Lenin o Tito. Un gesto in grado di unire sarebbe riprendere in mano la proposta
di un omaggio a Paola Bonzi, grande figura della Milano operosa e che aiuta. La
aveva accolta con favore anche Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del Pd
(«Sarebbe bello ricordarla dedicandole un luogo simbolico, capace di unire»,
aveva detto). Va anche dato atto al sindaco Beppe Sala, di aver mostrato grande
attenzione per l'opera della fondatrice del Cav, che circa un anno fa è
scomparsa ed è stata iscritta al Famedio. Forse l'idea di un parco o di una
scuola merita di essere ripresa anche a Milano, come sta facendo Vanzaghello (un
asilo nido) e come è stato proposto anche a Bareggio.
·
Paese di indigenti
spendaccioni.
Economia. Crescita quasi zero, lavori malpagati, più debito:
il 2020 sarà un altro "anno bellissimo". Tutte le
previsioni delle istituzioni e dei centri di ricerca dipingono questo quadro per
la nostra economia nel 2020. C'è solo una buona notizia: l'incubo spread sembra
più lontano (almeno per ora). Vittorio Malagutti il 3 gennaio 2020 su
L'Espresso. Lenta, lentissima, praticamente ferma. L’economia italiana gira con
il motore al minimo e si prepara ad affrontare il secondo decennio degli anni
Duemila senza una chiara prospettiva di sviluppo, stretta tra guai vecchi e
nuove incognite. Insomma, si tira a campare. È questa, in estrema sintesi, la
diagnosi sul futuro prossimo del nostro Paese che emerge dalla lettura delle
previsioni sfornate nelle ultime settimane del 2019 dalle istituzioni
internazionali e dai centri di ricerca. Nei prossimi dodici mesi la crescita del
Pil si prospetta anemica come già nel 2019, l’anno che secondo un’infausta
battuta del premier Giuseppe Conte, sarebbe dovuto essere «bellissimo». Gli
analisti sono concordi nel sottolineare che la nostra economia continuerà a
risentire della frenata del resto d’Europa, a cominciare dalla Germania,
tradizionale mercato di sbocco di una fetta importante del nostro export. Il
grafico della produzione industriale, in ribasso ormai da mesi, difficilmente
invertirà la rotta, almeno nel breve termine. Intanto, non si vede la fine del
tunnel neppure sul fronte dei conti pubblici: nella migliore delle ipotesi il
debito subirà solo una minima limatura nel 2020, come pure nel 2021. La manovra
di bilancio appena varata dal governo, infatti, incide solo marginalmente sullo
stock accumulato negli anni, che ormai viaggia verso i 2.500 miliardi di euro. E
i tagli sono comunque inferiori ai nuovi interessi da pagare. C’è una notizia
buona, però, almeno una: l’allarme spread per il momento pare rientrato. È un
passo avanti, certo, se non fosse che tra novembre e dicembre le zuffe continue
dentro la maggioranza di governo hanno provocato nuovi ribassi delle quotazioni
dei Btp. Siamo ancora distanti dai livelli della scorsa primavera, quando il
differenziale di rendimento rispetto ai Bund tedeschi viaggiava verso i 300
punti. A metà dicembre però il tasso d’interesse offerto dai titoli di stato
greci a dieci anni ha superato al ribasso quello sulle emissioni italiane di
pari durata. Un fatto che conferma una volta di più la sfiducia dei grandi
investitori internazionali verso Roma, che ormai fatica a reggere il confronto
perfino con Atene, a lungo fanalino di coda della Ue. Rispetto al resto della
zona euro, l’azienda Italia resta molto più esposta ai venti di tempesta causati
da eventuali crisi sui mercati finanziari. E non potrebbe essere altrimenti
vista la montagna di pagherò che sovrasta il Paese. Il rischio di uno shock
globale appare tutt’altro che remoto. Negli ultimi anni, infatti, per effetto
soprattutto delle politiche espansive delle banche centrali, Bce in testa, non
ha mai smesso di crescere l’alta marea della liquidità, che ha tra l’altro
alimentato una lunga fase di rialzi nella maggior parte delle Borse, a
cominciare da Wall Street. Ecco perché sono sempre più numerosi gli economisti
che mettono in guardia il mondo politico sulle possibili conseguenze
dell’esplosione di questa bolla speculativa. Nella peggiore delle ipotesi
finirebbe per andare in scena lo stesso copione del 2008, con crolli a catena
sui listini azionari e obbligazionari. Lo sboom dei mercati potrebbe innescare
una nuova pesante recessione dell’economia reale. E come è già successo un
decennio fa, l’Italia si troverebbe in balìa delle onde. C’è un dato che ben
illustra la debolezza del sistema Paese ed è quello relativo all’andamento del
Pil, che tra il 2010 e il 2019 è aumentato solo dello 0,5 per cento. Come dire
che nell’arco degli ultimi dieci anni la nostra economia è rimasta ferma, mente
la Germania è cresciuta del 16 per cento circa, la Francia del 12 per cento e la
Spagna del 10.
LA CRESCITA CHE NON C’È. Per avere i conti definitivi del 2019
bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma le stime pubblicate di recente
lasciano poco spazio all’ottimismo e confermano che l’economia nazionale ha
continuato a viaggiare con il freno a mano tirato. Nei 12 mesi appena trascorsi
il Pil è cresciuto a un ritmo ancora inferiore rispetto al già deludente 2018,
che si era chiuso con una crescita dello 0,8 per cento per effetto soprattutto
della frenata del terzo e del quarto trimestre, in calo rispettivamente dello
0,2 e dello 0,1 per cento. Le analisi dei principali centri di ricerca,
dall’Istat a Bankitalia, sono pressoché unanimi nel fissare intorno allo 0,2 per
cento l’incremento del Pil nel 2019. Ci sono però i pessimisti, come il Fondo
monetario internazionale e il Centro studi della Confindustria, che hanno
misurato una crescita zero. Fin qui, in attesa del dato definitivo, i numeri per
l’anno scorso. Niente di esaltante, come abbiamo detto, ma se il peggio può
dirsi passato e nel breve termine non c’è il rischio di una recessione,
ancora non si vede nessuna reale inversione di tendenza. Nel 2020 il Pil
aumenterà infatti di un misero 0,6 per cento, secondo l’ultimo aggiornamento
delle previsioni del governo e quelle dell’Istat, ma la Commissione europea, per
esempio, vede un incremento ancora inferiore, non più dello 0,4 per cento.
Questo significa che l’Italia continuerà a perdere terreno rispetto al resto
della zona Euro, che nonostante la recente revisione al ribasso delle stime
formulate da Bruxelles, dovrebbe comunque far segnare una crescita dell’1,5 per
cento. In base a queste previsioni, le maggiori economie del continente
continueranno a viaggiare a velocità quasi doppia rispetto a quella di Roma: la
Germania, reduce dalla brusca frenata del 2019 (più 0,4 per cento), arriverebbe
all’1 per cento, alle spalle di Francia (1,3 per cento) e Spagna (1,5 per
cento). Come si spiega la calma piatta dell’economia italiana? Sul futuro
prossimo pesa soprattutto l’estrema incertezza del contesto internazionale a cui
vanno sommati anche i dubbi sulla durata del governo Conte bis. In altre parole
gli imprenditori navigano a vista e riducono gli investimenti perchè temono
possibili sviluppi negativi nel breve termine. I dati più recenti confermano del
resto che il rallentamento dell’economia globale si è già fatto sentire
pesantemente sul sistema delle imprese tricolori. A ottobre, secondo quanto
segnalato dall’Istat, la produzione industriale è diminuita per l’ottavo mese
consecutivo. Nei primi dieci mesi del 2019 l’indice ha fatto segnare un calo
dell’1,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E se si
guarda indietro ai numeri antecedenti la crisi esplosa con il crack finanziario
globale del 2008, si scopre che in poco più di un decennio è andato in fumo
addirittura un quinto della produzione industriale: il calo dal 2007 è stato
pari al 22 per cento. Al momento sembra quantomeno improbabile che l’azienda
Italia riesca a ripartire di slancio. Il contesto internazionale descritto dagli
analisti non è certo quello più adatto per trainare una eventuale ripresa. Dopo
molti e bassi, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si sono ridotte
nelle ultime settimane, ma restano per esempio le nubi nere sulla Germania,
costretta ad affrontare le crescenti difficoltà del settore automobilistico, a
cui sono legate a doppio filo decine di aziende dell’Italia del Nord. In
ottobre, secondo le statistiche della Commissione di Bruxelles, la produzione
tedesca era andata in rosso addirittura del 6,3 per cento su base annua. Con la
locomotiva di Berlino in grave difficoltà aumentano i guai anche per le
esportazioni nostrane. “L’export procede a strappi”, si legge nel rapporto
pubblicato a dicembre dal Centro studi della Confindustria. E un’analisi di
Banca Intesa segnala che nel complesso i distretti industriali italiani,
nonostante la fase di difficoltà dell’economia globale, nel 2019 hanno visto nel
complesso aumentare le loro vendite all’estero dell’1,9 per cento nei primi nove
mesi del 2019, con risultati d’eccellenza come la crescita del 50,6 per cento
nelle vendite oltrefrontiera di pelletteria e calzature prodotte nell’area di
Firenze. In definitiva, però, il contributo delle esportazioni alla crescita del
Pil sarà quasi nullo nel 2020, non superiore a un misero 0,1 per cento. È questa
la previsione del governo formulata nel Nadef, la Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza pubblicato in ottobre. Va meglio per quanto
riguarda la spesa delle famiglie, che secondo l’Istat dovrebbe crescere
quest’anno dello 0,6 per cento. C’è poco da festeggiare, però, visto che nel
2019 l’incremento era stato dello 0,8 per cento. Rallentano, e di molto, anche
gli investimenti che, secondo le previsioni di Banca d’Italia, nel 2020
aumenteranno nel complesso non oltre lo 0,4 per cento, a un ritmo quindi di
molto inferiore a quello registrato nell’anno appena concluso, quando la stessa
voce statistica aveva fatto registrare una crescita del 3,1 per cento.
PIÙ LAVORETTI PER TUTTI. Il 2018 si era chiuso con l’allora
vicepremier Luigi Di Maio che garantiva «nessun esubero» in Alitalia e
annunciava orgoglioso che il caso Ilva «aperto un decennio fa è stato chiuso in
soli tre mesi e mezzo» grazie al governo Cinque stelle-Lega. A un anno di
distanza da quelle incaute dichiarazioni, le due storie simbolo della crisi
industriale italiana sembrano ben lontane dall’ultimo capitolo e il governo che
prometteva «soluzioni di mercato» per entrambe ora è costretto ad ammettere che
il doppio salvataggio sarà impossibile senza l’intervento diretto dello Stato
nel capitale. Nel frattempo, al ministero del Lavoro si accumulano i dossier
sulle aziende in grave difficoltà: sono 149, una dozzina in più rispetto a un
anno fa, con oltre 200 mila dipendenti che rischiano il posto di lavoro. I
numeri fin qui citati non autorizzano grande ottimismo, almeno nel breve
termine, eppure gli analisti sono concordi nel prevedere un calo della
disoccupazione nei prossimi due anni. Nulla di eclatante: secondo le stime della
Banca d’Italia, la percentuale dei senza lavoro che a gennaio del 2019 fa
viaggiava intorno al 10,5 per cento e già nel settembre scorso (ultimo dato
disponibile) si era attestata intorno al 10 per cento, nel 2020 dovrebbe calare
ancora fino al 9,7 per cento per arrivare al 9,4 per cento nel 2022. Anche la
percentuale degli occupati, storicamente molto più bassa nel nostro paese
rispetto alla media dell’Unione europea, continua ad aumentare, tanto che il
ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in una recente intervista a “La
Repubblica” ha dichiarato che il governo punta nel 2020 a raggiungere un tasso
di occupazione del 60 per cento. Un traguardo che appare ormai a portata di
mano: l’ultimo dato rilevato dall’Istat (settembre 2019) era pari al 59,4, in
netta crescita rispetto al 58,6 per cento di un anno prima. Difficile non
notare, a questo punto, che l’incremento nel numero dei posti di lavoro avviene
in una fase di stagnazione del Pil. In sostanza, il Paese ha smesso di crescere
ma aumentano le occasioni di impiego. In realtà, spiegano gli analisti, c’è
stata una «diminuzione dell’intensità dell’occupazione». In parole povere
significa che un gran numero di rapporti a tempo pieno è stato sostituito da
impieghi part time. E questi ultimi, come spiegano Ivana Fellini e Roberto
Reyneri in un articolo per “lavoce.info”, rappresentano una scelta di ripiego da
parte di lavoratori che non sono riusciti a trovare un’occupazione a tempo
pieno. «La forte diffusione del part time involontario – scrivono i due studiosi
– è un ulteriore segnale della grave debolezza della domanda di lavoro». È vero
quindi, come certificano le statistiche, che l’occupazione è aumentata ma buona
parte di questa crescita si spiega con quelli che vengono di solito qualificati
come “lavoretti”: contratti spesso malpagati da poche ore al giorno o della
durata di qualche mese in corso d’anno. Nulla lascia pensare che questa
tendenza, consolidata nel periodo della grande gelata dell’economia dopo il
2008, verrà in qualche modo corretta nel breve termine. In altre parole la
“quota 60” annunciata dal ministro Gualtieri forse verrà raggiunta, ma il
mercato del lavoro cresce soprattutto grazie agli impieghi part time.
ALLA ROULETTE DELLO SPREAD. Le buone intenzioni non bastano per
tagliare il colossale debito pubblico che incombe sul sistema Italia. Il governo
Conte bis nelle scorse settimane ha messo nero su bianco il suo piano: nel 2020
il rapporto tra debito e Pil dovrebbe calare di mezzo punto rispetto al 2019, da
135,7 al 135,2 per cento, per poi scendere ancora al 133,4 nel 2021. Dopo anni
di promesse non mantenute è però comprensibile che i nuovi impegni di Roma
vengano presi con le molle dai partner dell’Unione europea. E infatti è proprio
Bruxelles a disegnare un quadro ben più pessimistico sul futuro dei nostri conti
pubblici. Nel documento del novembre scorso dedicato alle prospettive economiche
dell’Italia si legge che «il debito sembra destinato ad aumentare nei prossimi
anni». Tradotto in numeri significa che secondo gli analisti della Commissione
il rapporto con il Pil arriverà al 136,8 per cento nel 2020 e al 137,4 per cento
nel 2021. In base a questi dati quindi, sembra destinata ad allargarsi la
distanza che ci separa dalla media dei paesi della zona Euro che nel 2020,
secondo le stime di Bruxelles, avranno un indebitamento pari all’85,1 del Pil,
in diminuzione rispetto all’86,4 per cento del 2019. Nel gran mare delle
incognite per i prossimi anni c’è però almeno una buona notizia. Per effetto
del calo dei rendimenti dei titoli di stato, nel triennio fino al 2022 il
governo può contare su risparmi per 15 miliardi rispetto a quanto previsto nella
primavera del 2019. A patto, ovviamente, che ipotetici futuri scossoni sul
fronte politico non inneschino rialzi dei tassi con relativa fiammata dello
spread. La minore spesa alla voce interessi sui Btp può trasformarsi in un
tesoretto che potrebbe essere utilizzato per finanziare misure destinate a
rilanciare la crescita. È difficile però che il calo degli oneri sui titoli di
stato sia sufficiente per dare un taglio al rapporto tra debito e Pil.
Quest’ultimo infatti aumenta in misura di molto inferiore al tasso d’interesse,
pari al 2,58 per cento nel 2019, pagato in media dalle casse pubbliche sui
propri debiti. Gli addetti ai lavori parlano di effetto snow ball, palla di
neve. E se l’Italia non riprendere a crescere a un ritmo ben più sostenuto di
quel misero 0,5 previsto nel 2020, la palla di neve rischia di trasformarsi in
una valanga.
Sandro Iacometti per “Libero Quotidiano” il 5 gennaio 2020. I
dati sul fisco e sulla povertà parlano chiaro: l'Italia è un Paese di indigenti.
Le ultime rilevazioni dell' Istat e della Caritas individuano in 1,8 milioni le
famiglie in condizioni di povertà, vale a dire 5 milioni di individui. I nuclei
che sono a un passo dal baratro (la povertà relativa) salgono a 3 milioni, quasi
9 milioni di persone. Ancora peggio va sul fronte dei redditi. Su 60 milioni di
italiani, circa 20 neanche presentano la dichiarazione al fisco, non avendo
nulla da segnalare. Altri 10 milioni compilano il 730, ma guadagnano così poco
che, tra detrazioni e deduzioni, scivolano inevitabilmente nella fascia degli
incapienti, quelli che non devono versare neanche un euro di imposte. A parte i
dati che non collimano (30 milioni senza reddito e solo 9 milioni di poveri), la
vera sorpresa si presenta ogni qualvolta ci sia all' orizzonte un' occasione di
svago, di acquisto o di festeggiamento comandato. E' qui che, misteriosamente, i
portafogli si aprono e i quattrini fuoriescono a iosa, senza più tracce di
miseria o di privazione. Certo, sappiamo bene dai tempi di Trilussa che se il
mio vicino va in vacanza alle Maldive e io resto a casa, per gli statistici ce
la siamo spassata entrambi. Ma l' affollamento dei negozi e i numeri snocciolati
dalle associazioni di categoria sotto le feste indicano, con tutto il rispetto
per chi la fame la soffre davvero, che i conti non tornano. Prendiamo le
rilevazioni di Swg Confesercenti: per il black friday, evento legato al giorno
del ringraziamento americano e caduto, quest' anno, il 27 novembre, gli italiani
attirati dagli sconti hanno speso 107 euro a testa. Per doni e pacchi di Natale
sono usciti dalle tasche altri 272 euro. Per i saldi che scattano già da oggi in
alcune regioni la previsione è di 168 euro. In tutto fa 547 euro. Non una cifra
da capogiro, intendiamoci, ma pur sempre una somma superiore ai 522 euro che in
media percepiscono i destinatari del reddito di cittadinanza per far tirare
avanti una famiglia per 30 giorni. E non è tutto, perché ai quei 547 euro di
acquisti in regali e prodotti di consumo vanno aggiunti i soldi per pranzi e
cene di Natale e Capodanno (140 euro per la prima ricorrenza 94 euro per la
seconda, ci dice Coldiretti) e, soprattutto, quelli usati per i viaggi, le
immancabili vacanze. Tra settimane bianche, soggiorni brevi e week end lunghi,
gli italiani, che hanno prenotato, secondo Assoturismo, l' 83% dei posti
disponibili, hanno speso, ha calcolato Federalberghi, la bellezza di 13
miliardi: 771 a testa per il Natale, 648 il Capodanno. Findomestic, infine, ci
spiega che a gennaio è salita del 2,1% la propensione all' acquisto per tutti i
comparti, dai viaggi, alle auto fino agli elettrodomestici. Da dove spunta il
denaro? Dove sono finiti gli indigenti? Una consistente quota di chi spende e
spande fa parte di quella che il sociologo Luca Ricolfi chiama la società
signorile di massa, che fa carte false, s' indebita e compra a rate pur di
partecipare ai riti collettivi delle festività. Un' altra buona fetta di
italiani che sperpera attinge al proprio ingente patrimonio, che ammonta
complessivamente, come sappiamo, a circa 10mila miliardi di euro, il più alto
del Continente. Infine, in barba ai poveri veri, ci sono quelli che piangono
miseria, truccano gli Isee e intascano i bonus, ma si tengono sotto il materasso
(o in qualche banca svizzera) una parte di quei 109 miliardi di tasse non
versate all' erario.
SOLITA LADRONIA. (Ho scritto un saggio dedicato)
·
Tutti dentro…
Alessandra Severini per “Leggo” il 3 luglio 2020. Appalti
bloccati, costi alle stelle e rischio corruzione sempre dietro l’angolo. La
relazione annuale alla Camera dei Deputati sull’attività svolta dall’Anac nel
2019 offre un quadro allarmante e a tratti sconcertante. Da un lato la Banca
dati nazionale dei contratti pubblici ha registrato più di 60mila procedure
connesse all’emergenza sanitaria, per una spesa complessiva di oltre 3 miliardi.
I soli dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) hanno
ricoperto la gran parte del budget e solo il 3% delle risorse è stato utilizzato
per i tamponi. Tra le criticità evidenziate nella relazione, «l’abnorme
lievitazione dei prezzi e la forte variabilità degli stessi sul territorio
nazionale». Grave anche la situazione degli appalti, bloccati dall’arrivo del
virus. Se nel 2019 il valore complessivo degli appalti pubblici si è attestato a
170 miliardi, in crescita del 23%, l’emergenza Covid ha cambiato completamento
lo scenario. Nel primo quadrimestre 2020 gli appalti sono scesi del 24% per
numero e del 33% in valore, pari a 18,6 miliardi in meno. Ma il Covid, come ogni
situazione emergenziale, rischia di spalancare autostrade al fenomeno già molto
diffuso della corruzione. E il quadro fatto dal presidente dell’Authority,
Francesco Merloni è grave. Perché il vizietto italico che tanti danni produce
all’economia e all’efficienza è polverizzato e multiforme e spesso si manifesta
anche per pochi spiccioli. «Il valore della tangente è di frequente molto basso
e sempre di più ha forme diverse dalla classica dazione di denaro, come
l’assunzione di amici e parenti». Ci si vende per duemila o tremila euro, a
volte anche solo per 50 o 100 euro. E alcuni casi sono addirittura grotteschi:
in cambio del “favore” si ottiene una riparazione all’auto, un trasporto mobili.
O addirittura, come ha ricordato Merloni, «in un caso segnalato quest’anno, in
cambio di un’informazione riservata è stato persino offerto un abbacchio». Il
presidente ha avvertito poi sul rischio di una deregulation che allenti i
vincoli sull’assegnazione degli appalti e le norme anticorruzione al fine di far
ripartire l’economia. «Non è togliendo le regole che il sistema funziona
meglio».
Gianmarco Oberto per leggo.it il 3 luglio 2020. Mariolino Chiesa
scoprì suo malgrado - con i finanzieri che bussavano alla porta - che i mazzi di
banconote (sette milioni delle vecchie lire) non vanno giù per il water.
Un’amara scoperta datata 1992 che ha dato il via a Mani Pulite, fatto venire giù
la Prima Repubblica e costretto i mazzettari a cambiare strategia. Anche perché
nelle procure ormai faceva scuola il metodo del giudice Falcone contro la mafia,
«segui i soldi». Ma è più difficile per gli inquirenti tracciare l’aiutino, la
spintarella, il favore, l’inveterata pratica italiana dello scambio, quello che
già i latini chiamavano do ut des. I quattro capponi di Renzo per ingraziarsi
l’avvocato nei Promessi Sposi oggi sono una ristrutturazione, un posto per il
figlio, un incarico all’amante. Magari una vacanza. Maestro è stato Formigoni.
«Sfido chiunque a provare che io abbia preso un solo euro» diceva quando è
partita l’inchiesta Maugeri. Vero, i soldi non c’erano. Ma l’ex governatore,
condannato in via definitiva per corruzione, ha ricevuto benefit di lusso per
6,5 milioni di euro fra yacht, vacanze e la comproprietà di una villona in
Sardegna. Erano tempi di vacche grasse. Adesso - lo dice l’Anac - ti puoi
mettere in tasca un funzionario pubblico con 50 o 100 euro. Perfino inviandogli
un abbacchio. Fa scuola Checco Zalone, funzionario della Provincia nel film Quo
vado: un timbro su una pratica in cambio di una quaglia. «Sarà mica corruzione?»
chiede il cittadino. E lui ci spiega che no, non lo è. «Ma è frollata questa
quaglia?». E tutti a ridere. Nel Paese c’è la percezione che il problema non sia
poi così rilevante. E invece lo è. L’anno scorso l’Italia era 51ª nella
classifica mondiale dei Paesi più corrotti, a pari (de)merito con il Rwanda.
A Palazzo Chigi rubano persino il disinfettante.
Il Corriere del Giorno il 30 Giugno 2020. A pochi passi dal
salone dove si tiene il Consiglio dei ministri, accanto a un flacone di
disinfettante per le mani, è apparso un cartello imbarazzante : “È vietato
riempire contenitori personali dal dispenser”. Non si può stare tranquilli
neanche a Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove
rubano il disinfettante per le mani come racconta un articolo del quotidiano il
Messaggero. A pochi passi dal salone dove si tiene il Consiglio dei
Ministri all’interno di Palazzo Chigi, accanto a un flacone di disinfettante per
le mani c’è un cartello su cui è scritto: ”è vietato riempire contenitori
personali dal dispenser”. Nei palazzi ministeriali romani gli
impiegati incredibilmente sono costretti a tenere nei cassetti i rotoli di carta
igienica, in quanto quella fornita dalla pubblica amministrazione non resiste
nei bagni per più di qualche ora: chi la porta via? Fa un certo effetto
apprendere che nel cuore delle istituzioni qualcuno possa rubare gel
igienizzante, che non rimane un caso isolato, considerato che le cronache
parlamentari racconta che nella vicina Camera dei Deputati, già ai primi tempi
dell’epidemia, era sparita l’Amuchina dalle toilette.
Da “il Fatto Quotidiano” il 5 gennaio 2020. Il 2020 sarà un anno
importante per le inchieste che hanno coinvolto o anche solo sfiorato la
politica italiana. Si conoscerà l' esito di molti processi e pure di parecchie
indagini. Da Matteo Salvini a Luca Lotti, tanti politici si ritrovano a dover
affrontare qualche grana giudiziaria. In casa Lega ce ne se sono diverse da
risolvere. Per il leader del Carroccio ed ex ministro, per esempio, si attende
la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere al Senato per il
caso Gregoretti (la vicenda riguarda 131 migranti trattenuti per cinque giorni a
bordo della nave della Guardia Costiera).
Non solo. Quest' anno si saprà anche l' esito di un' altra
inchiesta in cui Salvini è indagato per abuso d' ufficio, quella che riguarda
alcuni voli di Stato. Nel suo stesso partito si contano altri indagati, come l'
ex sottosegretario Armando Siri accusato di corruzione.
Quello che verrà potrebbe non essere un anno spensierato anche
per alcuni renziani. Luca Lotti (rimasto nel Pd dopo la scissione di Matteo
Renzi, per fondare Italia Viva) deve affrontare un processo per favoreggiamento
a Roma.
A Firenze c' è l' inchiesta sulla Fondazione Open. Qui la Procura
ha indagato il suo ex presidente Alberto Bianchi per traffico di influenze e
finanziamento illecito. Nei mesi scorsi sono stati anche perquisiti alcuni
finanziatori della Open (non indagati). E poi ci sono diversi altri procedimenti
in cui, seppure i politici non sono indagati, hanno svelato interessanti
retroscena. Come l' inchiesta di Perugia sul Csm o quella sull' Air Force di
Renzi.
Lo scandalo Consip. Dal 15 gennaio, Luca Lotti & C. a processo
per favoreggiamento. Inizierà il prossimo 15 gennaio il processo a Luca Lotti,
ex ministro dello Sport, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e
fedelissimo di Matteo Renzi (anche se con la scissione è rimasto nel Pd). È
imputato di favoreggiamento nell' ambito del filone dell' indagine "Consip" che
riguarda chi spifferò all' ex amministratore delegato della Centrale acquisti,
Luigi Marroni, l' esistenza di un' inchiesta napoletana sulla società che
gestisce gran parte dei maggiori appalti pubblici. Con Lotti a processo ci sono
finiti anche l' ex comandante generale dell' Arma dei Carabinieri Tullio Del
Sette (accusato di rivelazione di segreto) e l' ex comandante della Legione
Toscana, Emanuele Saltalamacchia, imputato di favoreggiamento. A processo anche
l' ex presidente della fiorentina Publiacqua, Filippo Vannoni, anche questi
accusato di favoreggiamento. Tutti gli imputati hanno sempre respinto le accuse.
L' aereo di Stato e la fondazione. Le inchieste sull' Air Force
Renzi e sui fondi & favori del caso Open. Proseguono da mesi gli accertamenti
della Finanza sugli accordi sottoscritti per l' Airbus A340-500 , preso in
leasing dalla compagnia Etihad ai tempi del governo di Matteo Renzi per
effettuare voli di Stato al servizio di Palazzo Chigi. La Procura di
Civitavecchia ha un fascicolo aperto sul crac di Alitalia ed è nell' ambito di
questa inchiesta che sono stati delegati gli approfondimenti. L' ex premier
Renzi non è stato sfiorato dalle indagini dei pm di Civitavecchia. Come pure non
è sotto inchiesta a Firenze dove invece alcuni suoi fedelissimi sono finiti
indagati nel fascicolo che riguarda la Open: l' ex presidente della Fondazione
Alberto Bianchi è accusato di traffico di influenze e finanziamento illecito.
Quest' ultimo reato è contestato anche a Marco Carrai, che nella Open è stato
membro del Cda. Al centro dell' inchiesta c' è una consulenza affidata allo
studio legale Bianchi nel 2016 dalla Toto Costruzioni. Per i pm nascondeva un
finanziamento.
Finanziamento illecito ai partiti Bonifazi (Iv) e Centemero
(Lega), i due tesorieri sotto accusa. Il tesoriere della Lega, Giulio Centemero,
rischia il processo. E come lui anche l' ex tesoriere del Pd Francesco Bonifazi
(ora in Italia Viva). I pm di Roma nei mesi scorsi hanno chiuso l' indagine sui
flussi di denaro partiti dall' imprenditore Luca Parnasi e indirizzati, secondo
le accuse, alla politica. Finanziamento illecito è il reato contestato. Per
quanto riguarda il leghista al centro dell' inchiesta, c' è un finanziamento da
250 mila euro erogato tra il 2015 e il 2016 dalla Immobiliare Pentapigna srl (in
passato riconducibile a Parnasi) alla "Più voci", onlus di area leghista. La
Procura è convinta che la "Più Voci" sia "riconducibile alla Lega Nord quale sua
diretta emanazione e comunque costituente una sua articolazione". Per Bonifazi
invece l' indagine riguarda 150 mila euro pagati dalla Immobiliare Pentapigna
Srl a cavallo delle scorse elezioni politiche per uno studio di ricerca: per i
pm la ricerca era un modo per camuffare il contributo economico.
Ipotesi di abuso e sequestro Salvini nei guai per i voli di Stato
e i migranti sulla nave Gregoretti Matteo Salvini ha qualche grana giudiziaria
da risolvere. La prima riguarda il "caso Gregoretti", la nave della Guardia
costiera italiana sulla quale nel luglio scorso 131 migranti sono stati
trattenuti per cinque giorni. L' allora ministro è finito indagato per sequestro
aggravato di persona e il 20 dicembre 2019 il Tribunale dei ministri di Catania
ha chiesto il processo e inviato gli atti alla Giunta per l' autorizzazione a
procedere al Senato, che ancora non decide. C' è un fascicolo sull' ex
vicepremier anche in un altro Tribunale dei ministri, quello di Roma. Qui
Salvini è indagato per abuso d' ufficio nell' ambito di un' inchiesta su alcuni
voli di Stato utilizzati quando era ministro. La Procura di Roma, dopo aver
ricevuto il fascicolo dalla Corte dei conti, lo ha iscritto nel registro degli
indagati come atto "dovuto" e ha trasmesso le carte al Tribunale dei ministri.
La vicenda riguarda alcune trasferte su velivoli di Polizia e Vigili del fuoco.
Alcuni voli sono avvenuti su un Piaggio P-180, noto come "la Ferrari dei cieli".
Il denaro del Carroccio Dalla caccia ai 49 milioni all'
associazione Maroni. L'inchiesta sui 49 milioni della Lega che devono essere
restituiti allo Stato pare vicina a una svolta. I pm genovesi Francesco Pinto e
Paola Calleri, insieme con la Guardia di Finanza, a dicembre hanno sentito
almeno due testimoni. Il nuovo filone riguarda i 450 mila euro (secondo l'
accusa parte del denaro proveniente dalla truffa ai danni del Parlamento) che
dalle casse della Lega sarebbero andati all' associazione Maroni Presidente e da
qui a due tipografie lombarde cui sarebbe stato commissionato materiale
elettorale che, a detta dei pm, non sarebbe stato realizzato. Alla fine, il
denaro sarebbe tornato nelle casse del Carroccio. Movimenti effettuati in
diverse tranche dal 2013 all' aprile 2018, quindi già durante la segreteria di
Matteo Salvini. Finora sul fascicolo degli indagati, con l' ipotesi di
riciclaggio, è iscritto solo Stefano Bruno Galli (in foto), già ai vertici dell'
associazione Maroni Presidente e oggi assessore della giunta regionale lombarda
di Attilio Fontana.
L' hotel Metropol. L' ex portavoce del leader della Lega e gli
affari con i russi. Il cosiddetto "caso Moscopoli" è esploso nel giugno scorso.
Corruzione internazionale è il reato per il quale indaga la Procura di Milano
che ha aperto un fascicolo sulla base di alcuni articoli pubblicati su L'
Espresso. Al centro c' è l' incontro nell' hotel Metropol di Mosca del 18
ottobre 2018. Presente Gianluca Savoini, all' epoca portavoce di Salvini per le
questioni russe. Al tavolo sei persone, tre italiani (oltre a Savoini, l'
avvocato Gianluca Meranda e il manager Francesco Vannucci) e tre russi. Si
discute di un carico di 1,5 miliardi di dollari dal quale fare uscire 65 milioni
per la Lega e per finanziare le elezioni europee del maggio scorso. Il tutto
registrato in un audio il cui autore ad oggi è ancora ignoto. Così a luglio
scattano le perquisizioni e i sequestri a carico dei tre indagati (Savoini,
Meranda, Vannucci). I pm cercano dunque la prova dell' accordo. Eni non è
coinvolta.
I rapporti con Arata e San Marino. Siri, i 30 mila euro promessi
e il mutuo senza garanzie. Tra i leghisti finiti sotto inchiesta c' è anche il
senatore Armando Siri. L' ex sottosegretario è indagato a Roma per corruzione
per aver tentato di promuovere provvedimenti per favorire l' ex parlamentare
forzista Paolo Arata in cambio di 30 mila euro, dati o promessi. A prova di ciò
per i pm c' è un' intercettazione fra Arata e il figlio in cui si parla della
"somma di denaro pattuita a favore di Siri per la sua attività di sollecitazione
dell' approvazione di norme che l' avrebbero favorito". L' indagine romana è
ancora in corso. Ma Siri è finito sotto inchiesta anche a Milano: in questo caso
i pm contestano l' autoriciclaggio a causa di un prestito ottenuto - secondo i
pm senza le dovute garanzie - da un istituto bancario di San Marino. Per quanto
riguarda l' indagine milanese, la Giunta per le autorizzazioni del Senato ha
dato il via libera ai magistrati per poter sequestrare due pc e sms, email e
altri contenuti del cellulare di un collaboratore di Siri.
Csm: i giochi svelati dal trojan Le nomine dei procuratori capo
suggerite da toghe e politici. Durante l' estate del 2019 Palazzo dei
Marescialli si è trovato sull' orlo dello scioglimento: un' indagine della
Procura di Perugia ha scatenato un terremoto nel Consiglio superiore della
Magistratura (Csm). Tutto è nato da alcune accuse mosse contro Luca Palamara, l'
ex presidente dell' Anm, ex Csm, pm di Roma sospeso, finito sotto inchiesta per
corruzione per alcune utilità, come soggiorni all' estero, pagati da un
imprenditore. In questo fascicolo nessun politico è indagato, ma il trojan
installato sul cellulare di Palamara ha svelato lo scenario della politica al
tavolo con le toghe per discutere delle nomine dei futuri capi delle Procure.
Viene fuori così un incontro notturno tra 5 togati del Csm, poi dimissionari e
due parlamentari: Cosimo Ferri, ora a Italia Viva, magistrato in aspettativa e
Luca Lotti, deputato Pd: per la nomina a procuratore di Roma volevano puntare
sul pg di Firenze Marcello Viola (a sua insaputa). Ferri e Lotti non sono
indagati.
Torino in bilico Appendino, il debito da 5 milioni e la tragedia
di piazza San Carlo. La sindaca di Torino Chiara Appendino si prepara ad
affrontare due processi importanti col rito abbreviato. Il 6 febbraio i pm
Enrica Gabetta e Marco Gianoglio terranno la requisitoria nel processo sul caso
Ream, in merito all' iscrizione a bilancio di un vecchio debito da 5 milioni di
euro. La sindaca è indagata per falso in atto pubblico e abuso d' ufficio in
concorso con l' assessore al Bilancio Sergio Rolando, il direttore finanziario
della città Paolo Lubbia e l' ex capo di gabinetto, Paolo Giordana. In caso di
condanna per abuso, Appendino rischierebbe la sospensione in base alla legge
Severino. Il 21 febbraio, poi, la sindaca e altri quattro imputati affronteranno
il processo, sempre in abbreviato, per gli incidenti di piazza San Carlo del 3
giugno 2017: il pm Vincenzo Pacileo li accusa di disastro, lesioni e duplice
omicidio colposo (per le morti di Erika Pioletti e Marisa Amato).
La passione dell' urbanistica De Luca in aula per gli illeciti di
piazza della Libertà a Salerno. Per dirla con le parole dei Figli delle
Chiancarelle, la pagina social che da quasi un decennio satireggia il
deluchismo, il processo sui presunti illeciti nella realizzazione di piazza
della Libertà a Salerno, l' ultima e residuale pendenza penale del governatore
dem della Campania, Vincenzo De Luca, "va avanti alla velocità di un pachiderma
zoppo". È iniziato il 9 marzo 2018, per reati risalenti al 2010-12, e colleziona
ritardi e rinvii de plano. Gli imputati sono 26 tra amministratori comunali,
funzionari pubblici e imprenditori accusati a vario titolo di falso, turbativa
d' asta, peculato e false fatturazioni. De Luca è coinvolto da ex sindaco di
Salerno che volle ridisegnare l' urbanistica della città, fino a stravolgere il
lungomare con il Crescent - per il quale è stato assolto da un' accusa di abuso
d' ufficio - e la sottostante piazza della Libertà. L' imputazione per falso di
De Luca comunque non è a rischio legge Severino: resterebbe in carica anche in
caso di condanna.
·
I Furbetti del Cartellino.
Accusato di
assenteismo, il giudice lo reintegra.
E avrà anche 34 mila euro. Pubblicato martedì, 04 febbraio 2020 da Corriere.it.
Era stato licenziato per assenteismo, ma è stato reintegrato su ordine del
giudice del lavoro, che ha imposto al Comune di Trieste anche il pagamento di
34.500 euro di stipendi arretrati. La vicenda è riportata da «Il Piccolo» e
riguarda un dipendente comunale del capoluogo giuliano. Nel 2018 il lavoratore
viene sorpreso mentre si allontana dal posto di lavoro senza aver timbrato il
cartellino. Comincia dunque una serie di controlli, al termine dei quali da
parte del Comune gli vengono imputate oltre dieci ore di «assenza
ingiustificata». Da qui il provvedimento. Diversa la decisione della
magistratura che rileva l’assenza di recidive tali da giustificare il
licenziamento. L’uomo è stato quindi reintegrato in servizio con una sanzione
sospensiva. Ieri il Consiglio comunale di Trieste ha approvato l’esborso sotto
forma di debito fuori bilancio.
Il vigile
di Sanremo che timbrava in mutande assolto dal giudice.
Pubblicato
lunedì, 20 gennaio 2020 su Corriere.it il Claudio Del Frate. Era divenuto il
simbolo dei «furbetti del cartellino». Dopo il blitz del 2015 il comune ligure
aveva licenziato 32 dipendenti. L’assoluzione motivata con il cosiddetto «tempo
tuta». Era divenuto suo malgrado il simbolo dei «furbetti del cartellino», la
sua immagine aveva fatto il giro del web e delle tv. Ma oggi il vigile di
Sanremo sorpreso a timbrare il cartellino in mutande è stato assolto dal gup
della cittadina ligure Paolo Luppi. «Il fatto non sussiste» ha decretato il
magistrato per il «vigile in mutande» e altri nove imputati. nella medesima
udienza 16 persone sono state rinviate a giudizio e altrettante sono uscite dal
processo con un patteggiamento. Il blitz era scattato il 22 ottobre 2015 :
vennero eseguite 43 misure cautelare e il comune di Sanremo licenziò in tronco
32 degli indagati. Alberto Muraglia, questo il nome del vigile, era il
responsabile dei controlli al mercato ortofrutticolo ed era finito agli arresti
domiciliari. Le immagini della Guardia di Finanza lo mostravano mentre
strisciava il badge in «deshabillé» o faceva compiere l’operazione di timbratura
alla figlia. «Ma il nostro appartamento è proprio dentro il mercato, abbiamo la
spiegazione per tutti gli episodi contestati» aveva detto la moglie del vigile
interpellata dai cronisti dopo che il caso era esploso. «Mi è capitato di
smontare dal servizio, arrivare a casa e ricordarmi di non ave timbrato. Per
evitare di rivestirmi sono andato a strisciare il badge in pigiama» aveva detto
il vigile nel corso di un interrogatorio. A gennaio del 2016 Muraglia aveva poi
ricevuto la lettera di licenziamento del municipio; attraverso il suo avvocato
aveva presentato ricorso al giudice del lavoro e nel frattempo aveva aperto una
bottega per la riparazione di elettrodomestici nel centro della città.
A.Pasq. per il
“Corriere della Sera” il 21 gennaio 2020. Quel giorno timbrò il cartellino in
mutande. Fu immortalato da una telecamera del Comune e l' immagine diventò il
simbolo di un certo mondo, pigro e lavativo, della pubblica amministrazione: i
furbetti del cartellino. Era il 2015 e Alberto Muraglia, oggi cinquantottenne,
faceva il vigile a Sanremo come responsabile dei controlli al mercato
ortofrutticolo. Fu licenziato e con lui ne licenziarono altri 31, tutti
dipendenti del Comune ligure, tutti indagati nell' ambito di un'inchiesta che il
22 ottobre 2015 portò a un blitz senza precedenti: 35 arresti, ai domiciliari,
altri 8 dipendenti con l'obbligo di firma, accusati di falso ideologico e truffa
ai danni dello Stato. Un terremoto giudiziario e amministrativo, del quale
Muraglia diventò l' icona. Ieri, la sorpresa: il giudice per l' udienza
preliminare di Imperia, Paolo Luppi, ha assolto tutti gli imputati, dieci, che
avevano scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Fra questi c'era
Muraglia. Per il gup «il fatto non sussiste», cioè assoluzione piena. L' ex
vigile si è commosso: «Sapevo di non aver fatto nulla di male ma sentirsi dire
dal giudice che sei innocente è un' altra cosa. È la fine di un incubo, sono
stati quattro anni di tortura mediatica...». Va detto che il giudice ha anche
disposto 16 rinvii a giudizio e chiuso 16 patteggiamenti e che dunque l'
indagine del pm Maria Paola Marrali e della Guardia di Finanza non era campata
per aria. Fra chi ha patteggiato c' è l' ex messo notificatore del Comune, un'
ex impiegata dell' ufficio anagrafe, un ex ausiliario del servizio notifiche, un
ex istruttore amministrativo elettorale e l' ex perito agrario dei Lavori
pubblici che, secondo la Finanza, timbrava, usciva e andava a vogare. Tutti,
naturalmente, licenziati. Ma perché è stato assolto Muraglia, «beccato» in
mutande a timbrare? In attesa delle motivazioni della sentenza (entro 90 giorni)
è il suo avvocato, Alessandro Moroni, a dare una spiegazione: «Semplicemente per
il fatto che lui abitava nello stabile del mercato dove c' era la timbratrice.
Essere in abiti borghesi conta poco, perché la vestizione della divisa è
considerata orario di lavoro e quindi successiva alla timbratura». Muraglia si
svegliava alle 5.30 per aprire i cancelli del mercato e prendeva servizio alle 6
e, visto che abitava lì, talvolta passava alla macchinetta che marcava la
presenza mentre si cambiava, dice. Gli veniva contestato pure di aver mandato
anche la figlia a timbrare. «Perché talvolta dimenticava di strisciare il badge
o si attardava a chiudere le pratiche e allora lo faceva lei». Comunque sia,
assolto. Dopo essere stato licenziato e sfrattato, l' ex vigile ha deciso di
cambiare lavoro. «Potevo sprofondare o rimboccarmi le maniche e ho scelto la
seconda», dice ora. Si è messo a fare l'«aggiustatutto», aprendosi un negozietto
che pare funzioni alla grande. Sistema frigoriferi, cucine, elettrodomestici in
genere. E ora che farà? «Vorrei tornare alla mia vecchia occupazione», ha detto.
C' è una causa in piedi davanti al giudice del lavoro, nella quale lui chiede il
reintegro. L' assoluzione giocherà a suo favore. «Non c' è una trasposizione
automatica del procedimento penale in quello civile ma è chiaro che si tratta di
una gran bella notizia anche per questo fronte», ha spiegato l' avvocato Luigi
Zoboli che lo assiste nel civile. E la Procura cosa dice? «Io dico che l'
indagine della Guardia di Finanza e del pm Marrali è stata condotta con grande
serietà. Hanno profuso un impegno investigativo davvero notevole. Vorrei
comunque ricordare che ci sono anche 16 patteggiamenti e 16 rinvii a giudizio,
cosa che depone per la consistenza dell' impianto accusatorio. Quanto agli
abbreviati, aspettiamo di vedere le motivazioni e decideremo il da farsi, anche
perché su queste posizioni vi erano prove che la Procura ha considerato
importanti e di spessore». Sembra comunque scontata l' impugnazione. Dei dieci
assolti, sette erano stati licenziati. Anche per loro, dunque, si potrebbero
riaprire le porte del Comune di Sanremo.
Alberto Muraglia il furbetto del cartellino: un farabutto
innocente, giornalisti e magistrati chiedano scusa.
Piero Sansonetti il 21 Gennaio 2020 su Il Riformista. Sapete mica chi è Alberto
Muraglia? È quel farabutto che fu fotografato in mutande mentre timbrava il
cartellino, e la sua foto era stata distribuita a tutti i giornali e alle Tv, ed
era stato indicato unanimemente al ludibrio pubblico come malfattore,
profittatore, prosciugatore di risorse pubbliche che si cuccava il suo stipendio
da più di mille euro gabbando i cittadini e fingendo di lavorare. Timbrava in
mutande, capito? E poi tornava a casa a dormire, magari! Il furbetto del
cartellino. L’hanno beccato, se Dio vuole. Inchiodato dalla Procura di
Sanremo nel corso di un’operazione brillantissima che consistette in due atti:
una retata all’alba con 43 arresti – tutti piccoli impiegati – e poi la
distribuzione di foto e filmati di ogni genere alla stampa e alle Tv. L’immagine
di quel mascalzone di Alberto Muraglia è stata portata persino sul palco
del festival di Sanremo. È giusto così: i manigoldi vanno esposti alla gogna,
così imparano! Beh, ieri la vicenda di Alberto Muraglia, professione vigile
(all’epoca dei fatti, ora “piccololavorettista” per sbarcare il lunario) ha
preso una strana piega. Si è arrivati al processo (ma che bisogno c’era di fare
un processo quando la colpa era così evidentemente e la gogna così giustamente
in azione?) e in processo l’avvocato di Muraglia ha potuto finalmente parlare e
spiegare che Muraglia abitava nello stesso edificio che ospitava il mercato (il
suo appartamento era dentro il mercato) che doveva sorvegliare (era quello il
suo lavoro) e che, per contratto, il tempo per mettersi la tuta da lavoro faceva
parte del suo orario di lavoro, e lui talvolta, di conseguenza, prendeva
servizio appena uscito dal suo appartamento e prima ancora di mettere la tuta.
Cioè, ha spiegato che non aveva commesso nessuna irregolarità, e che visto che
le telecamere lo avevano controllato per un anno intero, a sua insaputa – e solo
quattro volte, peraltro, lo avevano sorpreso vestito un po’ discinto, alle 5 di
mattina – invece di arrestarlo magari bastava chiedergli spiegazioni. E, forse,
sarebbe stato giusto anche chiedergli spiegazioni prima di licenziarlo in tronco
dal Comune insieme a 31 suoi colleghi di lavoro. Il Giudice dell’udienza
preliminare lo ha ascoltato, ha guardato le carte, i filmati, ha sentito i
testimoni e poi ha pronunciato quella parolina che tanto fa inorridire
giornalisti e Tv: as-sol-to. Capite? Il giudice ha detto che è innocente.
Mammamia. E ora? Sono passati quasi cinque anni dalla retata e dallo scandalo.
In quell’inverno del 2015 decine di trasmissioni televisive furono dedicate a
Muraglia e ai suoi fratelli. La gogna ebbe grandi onori. Se andavi a una
trasmissione Tv e provavi a mettere qualche dubbio, ti sommergevano di insulti,
ti dicevano che eri peggio di loro. Chissà se i “gognisti” di allora adesso se
lo ricordano. Sui giornali andò su tutte le prime pagine. Andrà in prima
l’assoluzione? Mi sa di no. E non è neanche detto che il Muraglia sia riassunto.
Lui per cinque anni è rimasto disoccupato, ha provato a cavarsela facendo
lavoretti saltuari (un po’ elettricista, un po’ idraulico, un po’ riparatore
generico) ma la gente lo guardava storto. Ha subito cinque anni di umiliazioni.
Nessuno lo risarcirà. Speriamo almeno che lo riassumono, e gli diano gli
arretrati. Che giornalisti e magistrati chiedano scusa e provino a riabilitarlo
è molto improbabile. Giornalisti e magistrati, lo sapete quanto me, spesso sono
canaglie.
Marco Menduni
per “la Stampa” il 21 gennaio 2020. Dall'altra parte della strada gli amici lo
applaudono e gridano: «Assolto, assolto!». Lui muove entrambe le mani con il
palmo in basso, come dire: calma, devo prima capire se è davvero finita. Alberto
Muraglia sta sull' uscio della bottega di aggiustatutto, il mestiere con cui si
è reinventato la vita, piena di stufe, forni, televisori: «Ci so fare, sistemo
ogni cosa, sono ripartito da qui». Non ci sarà ancora da alzare i calici, ma
Muraglia ha il volto disteso. Il vigile in mutande, protagonista della clamorosa
inchiesta sui furbetti del cartellino al Comune di Sanremo nel 2014, è stato
assolto: «Perché il fatto non sussiste. E lo stesso anche per un' accusa di
corruzione che era venuta fuori durante l' inchiesta». Difficile crederci, dopo
che quell' immagine sbracata davanti alla macchina timbratrice era diventata l'
emblema dell' Italia degli assenteisti, di chi ruba lo stipendio e mette nel
sacco i lavoratori onesti. L' allora presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva
esclamato: «Questa è gente da licenziare in 48 ore, è una questione di dignità».
Muraglia, che
effetto le ha fatto impersona l' emblema dell' Italia che non va, che truffa e
non lavora, con l' aggravante di una foto così poco dignitosa? «Sono stati
quattro anni di tortura mediatica, di fronte alla quale si può reagire in due
modi. Abbattendosi e sprofondando. Oppure reagire non dico con divertimento ma
con serenità e ironia. Ho scelto la seconda, lo dovevo alla mia famiglia, ai
miei figli. Non potevo farmi vedere distrutto».
Ha sostenuto
dall' inizio dell' inchiesta di esser convinto dell' assoluzione.
«Io credo
nella giustizia e ho sempre creduto di essere nel giusto e di non aver fatto
nulla di male. La conferma ora è arrivata, anche se è stata dura. Una cosa mi ha
disturbato su tutte, quasi nessuno ha mai avuto l' onestà mentale di far la
domanda giusta: quelle timbrature erano fatte prima o dopo l' orario di
servizio? Rispondo io: tutte prima, non ho mai rubato nulla».
Sì, ma le
mutande, quelle maledette mutande riproposte mille e mille volte dai giornali e
dalle tv, che senso avevano?
«Le cose vanno
contestualizzate. Non ero un pazzo che andava a timbrare così nella sede del
Comune, a Palazzo Bellevue. Io ero il custode del mercato. La macchinetta era in
un corridoio davanti al mio appartamento, la usavo quando la struttura era
ancora chiusa, ero io ad aprirla. Praticamente un contesto privato».
Però non era
ancora pronto per lavorare...
«No: è stato
dimostrato che indossare la divisa rientra nell' orario di lavoro. A volte mi
sono dimenticato di timbrare quando già avevo iniziato a metterla, allora sono
corso mezzo svestito a convalidare il badge. Il Comune ha guadagnato qualche
secondo di lavoro, non l' ha perso e questo il giudice l' ha compreso. Al limite
potrei aver fatto una mezza scorrettezza amministrativa, ma proprio al limite.
Roba da un giorno di sospensione disciplinare».
Cosa è
accaduto nella sua vita?
«Quello che
succede quando uno viene licenziato, non ha più un lavoro e nemmeno l' alloggio
di servizio. Però non sono crollato e mi sono rimboccato le maniche. Un parente
mi ha offerto in comodato gratuito un appartamentino e questa bottega: mi ha
salvato la vita. Oggi ho tantissimi clienti, lavoro per 200 condomini. Capisco
l' impatto determinato dall' inchiesta e dalla foto: ma la gente di Sanremo mi
conosceva, mi ha sempre stimato, mi è stata vicina. Sin dall' inizio sapeva qual
era la verità».
In città è
sempre andato a testa alta?
«Sempre. Vado
persino al mercato, dove lavoravo, a far la spesa. Sono stato 18 anni lì, ho
fatto anche parecchie multe agli operatori. Se avessi avuto la coscienza sporca
non mi sarei fatto più vedere. Mi avrebbero detto: mi ha multato e poi lo str...
eri tu? Invece no: mi hanno espresso tutti la loro solidarietà».
Adesso rivuole
il suo posto di lavoro?
«Il ricorso l'
ho già fatto. Ho portato 40 testimoni, ne hanno già ascoltati 22 e la prossima
udienza sarà ad aprile. Io sono stato messo alla porta sulla scorta delle sole
accuse.
Ora che c' è
una sentenza di assoluzione, credo valga qualcosa».
Sua moglie
Adriana?
«Mia moglie è
sempre accanto a me. Non ha mai avuto il minimo dubbio, visto che vivevamo anche
insieme e sa tutto quel che è accaduto. Finire il lavoro, tornare a casa e
trovarla è la vera gioia, il tesoro della mia vita».
E con lei si
riparte...
«Dopo la
sentenza, il mio cellulare sarà squillato 100 volte. Mi vogliono ospite in tutte
le trasmissioni tv. Non ci penso nemmeno. Vorrei che dopo tanto tempo sulla mia
vita calasse il silenzio, che tornasse la normalità. Intanto stasera vado a cena
con Adriana».
Per Gramellini contano più le immagini delle sentenze.
Angela Azzaro il 22 Gennaio 2020 su Il Riformista. Massimo
Gramellini per contestare l’assoluzione del vigile accusato di essere
un furbetto del cartellino, nella sua rubrica fissa sulla prima pagina
del Corriere della sera, invoca il potere delle immagini. Poiché c’è un video
che immortala il signore in mutande mentre timbra – è il suo ragionamento – chi
se ne frega delle prove, delle carte processuali, della difesa e della decisione
del giudice. Il video è lì a dimostrare i fatti. Il giornalista, che pure la
televisione non solo la guarda ma la fa, dovrebbe sapere meglio di chiunque
altro che le immagini non hanno mai e poi mai uno statuto di verità. Ci credono
solo i più sprovveduti, i creduloni, quelli che basta vedere una cosa in tv per
ritenere che sia oggettiva, reale, inconfutabile. Ma così non è. Basterebbe
chiedere al critico televisivo del Corriere della sera, Aldo Grasso, per capire
come stanno le cose. Le immagini da sole non bastano. Va ricostruito il
contesto, il prima e il dopo di ciò che viene inquadrato, va compreso quale sia
il punto di vista con cui si osserva quella realtà e nel caso che quelle
immagini vengano montate sapere chi l’ha fatto e perché. Le immagini non sono
mai neutre, oggettive, ma sono sempre l’affermazione di una soggettività: nel
caso specifico quelle delle forze dell’ordine che non solo le hanno filmate ma
le hanno anche diffuse. Così come una intercettazione non dovrebbe bastare per
mandare una persona in galera, ma spesso purtroppo basta e avanza, così una
immagine da sola è spesso solo un indizio, a volte non costituisce neanche una
prova. Le telecamere hanno però un altro potere di cui questa volta si è
abbondantemente abusato: sono un veicolo incredibile per incitare le persone al
linciaggio, per mettere le persone alla gogna. E così è stato fatto con il
vigile poi assolto. La scena con lui che timbra in mutande è diventata l’emblema
delle persone che fregano lo Stato, dei corrotti, furbetti, ladri, insomma la
peggiore specie che possa vivere sulla terra. Il signor Alberto Muraglia dal
2015 ha vissuto anni terribili: lui e la sua famiglia additati, presi in giro,
insultati, senza nessuna pietà. Gramellini invece di rivendicare quelle
immagini, avrebbe dovuto chiedere scusa. Avrebbe dovuto dire: caro signor
Muraglia, ci siamo sbagliati. Non solo perché lei è innocente, ma perché nessuno
merita di essere trattato in quel modo. Essere sbattuti così su tutte le tv e i
giornali d’Italia non è informazione, non è giustizia. È la legge del taglione,
è la vendetta eseguita attraverso i nuovi mezzi di informazione. Ci scusi caro
signor Muraglia, abbiamo sbagliato, le abbiamo rovinato la vita e d’ora in poi
saremo molto più attenti per evitare queste forme di linciaggio. Invece no,
Gramellini, ha protestato come un credulone qualsiasi, come
un Savonarola qualsiasi.
Furbetti
del cartellino a Sanremo, assolti il vigile che timbrava in mutande e altri
nove: "Torturato mediaticamente".
Clamorosa
decisione del giudice per le udienze preliminari. Alberto Muraglia: "Ho dovuto
cambiare vita, questi anni nessuno me li restituirà mai". Marco Lignana, Matteo
Macor e Marco Preve il 20 gennaio 2020 su La Repubblica. L'allora premier Matteo
Renzi di fronte alla foto del vigile in mutande accusato di assenteismo disse:
"Questa è gente da licenziare in 48 ore. E' una questione di dignità". Ma
quattro anni dopo quello stesso vigile, simbolo di mala amministrazione è stato
assolto. Infatti, dieci imputati fra i 42 coinvolti nell'indagine sui "furbetti
del cartellino" di Sanremo sono stati assolti oggi dal giudice per le udienze
preliminari Paolo Luppi perché "il fatto non sussiste". La clamorosa decisione
riguarda anche Alberto Muraglia, ex vigile del mercato annonario, ripreso dalle
telecamere mentre timbrava il cartellino in slip. Quell'immagine era divenuta il
simbolo di tutta l'inchiesta, che il 22 ottobre 2015 aveva portato ad arresti e
altre misure per oltre 50 persone. Muraglia e gli altri nove assolti hanno
scelto il rito abbreviato. Ecco le prime parole di Alberto Muraglia dopo
l'assoluzione: «È un sollievo ma non una sorpresa: ne vengo da quattro anni e
mezzo di tortura mediatica per colpe che non ho mai avuto, e l'ho sempre
sostenuto. Sono stato costretto a cambiare vita, reinventarmi un lavoro,
sopportare e far sopportare ingiustamente alla mia famiglia il peso di
derisioni, mancanze di rispetto, difficoltà. Questi anni nessuno me li
restituirà mai, ma ora voglio solo voltare pagina. Timbrare in mutande mi ha
trasformato mio malgrado in un simbolo, ho peccato di malcostume, forse di
scorrettezza amministrativa, ma non di certo di truffa allo Stato. E finalmente
è stata riconosciuta la verità». Nei mesi scorsi altri 16 imputati avevano
deciso di patteggiare pene comprese fra 8 mesi e 1 anno e 7 mesi. Mentre altri
16, proprio oggi, sono stati rinviati a giudizio. L'inchiesta sui furbetti di
Sanremo era stato uno dei casi di cronaca che all'epoca aveva fatto discutere
per mesi. Sia per le modalità del blitz di finanza e procura, con il Comune di
fatto occupato e bloccato per i sequestri di documentazione. Poi per il numero
di dipendenti coinvolti e l'apparente diffusione di abitudini fra il personale
senza che vi fosse un controllo gerarchico effettivo. Nelle settimane successive
su indicazione del sindaco Biancheri il segretario generale aveva avviato
procedimenti disciplinari interni che si erano conclusi con numerose sanzioni
e alcuni licenziamenti. La vicenda dei furbetti del cartellino aveva suscitato
anche un forte dibattito politico. L'allora premier Renzi era stato molto
chiaro:" Norme più semplici e soprattutto più efficaci per punire chi timbra e
abbandona il posto di lavoro: "Se io ti becco a timbrare il cartellino e te ne
vai, entro 48 te ne vai a casa, sospendendoti, e poi 30 giorni per chiudere il
procedimento. Ci sono tutte le procedure e le garanzie, ma quando a Sanremo vedi
quello che timbra in mutande non è un optional il licenziamento. Questa è gente
da licenziare entro 48 ore. È una foto terribile, è una questione di dignità e
rispetto verso chi si alza la mattina e mette la sveglia presto per andare a
lavorare". Ora con l'assoluzione - ma la procura presenterà sicuramente ricorso
- per Muraglia ed altri potrebbero aprirsi le strade per una richiesta di
reintegro. Molto dipenderà dalle motivazioni.
Sanremo, il
vigile in mutande dopo l'assoluzione: “Rivoglio il mio lavoro”.
Le Iene News il 20 gennaio 2020. L’ex vigile diventato virale per aver beggiato
in mutande rivuole il suo posto in Comune, dopo esser stato assolto. Con Filippo
Roma vi abbiamo parlato della clamorosa inchiesta sui "furbetti dei cartellini"
che beggiavano irregolarmente. “Dopo aver vissuto questa tortura, rivoglio il
mio posto in Comune”. È questa l’appello che l’ex vigile di Sanremo ha lanciato
dal quotidiano La Stampa, dopo essere stato assolto nel procedimento contro i
presunti “furbetti del cartellino”. L’uomo era stato pizzicato a beggiare in
mutande e le sue immagini avevano fatto il giro del Paese come simbolo
dell’assenteismo e del poco rispetto verso la pubblica amministrazione: il
tribunale però gli ha dato ragione. La motivazione è che il vigile si era
dimenticato di vestire la divisa prima di beggiare ed era uscito appunto in
mutande per andare alla timbratrice situata vicino al suo alloggio. Ora che è
stato assolto, l’uomo si spiega: “Al limite potrei avere fatto un mezza
scorrettezza amministrativa, roba da un giorno di sospensione disciplinare”. E
adesso chiede rispetto: “Sono stati quattro anni di tortura mediatica. Ho scelto
di reagire con ironia, lo dovevo alla mia famiglia. Non potevo farmi vedere
distrutto”, ha detto l’ex vigile, che si rifiuta di parlare anche in
televisione. “Non ci penso nemmeno, voglio che torni la normalità. Intanto
stasera vado a cena con Adriana, mia moglie”. Adesso che le acque si sono
calmate, vuole tornare al lavoro perché sicuro di non aver fatto nulla di male:
“Il ricorso per riottenere il mio posto l’ho già fatto. Ho portato 40 testimoni,
22 sono stati assolti”. La prossima udienza sarà ad aprile 2020.
L’inchiesta sui presunti furbetti del cartellino aveva scatenato molte
polemiche. “Questa è gente da licenziare entro 48 ore” aveva detto Matteo Renzi,
ai tempi presidente del Consiglio. “È una foto terribile, è una questione di
dignità e rispetto verso chi si alza la mattina e mette la sveglia presto per
andare a lavorare". Nonostante questo sospiro di sollievo, l’ex dipendente non
sembra ancora essere sereno: “Vorrei che sulla mia vita calasse il silenzio”.
Sanremo,
assolto il vigile che timbrava il cartellino in mutande.
Le Iene News il 20 gennaio 2020. L’impiegato comunale di Sanremo era diventato
famoso perché beccato dalla Finanza a timbrare in mutande. Con Filippo Roma vi
abbiamo mostrato come molti altri “furbetti del cartellino” se la spassavano
senza beggiare regolarmente. Il vigile urbano di Sanremo diventato famoso per le
immagini della Guardia di Finanza del 2015 che lo riprendevano mentre timbrava
in mutande è stato assolto perché “il fatto non sussiste”. “Mi è capitato di
smontare dal servizio, arrivare a casa e ricordarmi di non avere timbrato. Per
evitare di rivestirmi sono andato a strisciare il badge in pigiama” aveva detto
il vigile, che nel gennaio del 2016 ha ricevuto la lettera di licenziamento.
L’inchiesta aveva scatenato molte polemiche. “Questa è gente da licenziare entro
48 ore” aveva detto Matteo Renzi, ai tempi presidente del Consiglio. “È una foto
terribile, è una questione di dignità e rispetto verso chi si alza la mattina e
mette la sveglia presto per andare a lavorare". La motivazione dell’assoluzione
da parte dal gup di Sanremo Paolo Luppi è che il vigile si era dimenticato di
vestire la divisa prima di beggiare ed era uscito appunto in mutande per andare
alla timbratrice situata vicino al suo alloggio. Nella stessa udienza 16 persone
sono state rinviate a giudizio e altrettante sono uscite dal processo con un
patteggiamento. Il blitz della Guardia di finanza contro l’assenteismo era
partito nel 2015 e, dopo l’inchiesta, il comune di Sanremo aveva licenziato 32
dipendenti. Nonostante tre anni fa sia stato approvato il decreto
anti-fannulloni, molti furbetti del cartellino continuano purtroppo a “beggiare”
irregolarmente. Noi ce ne siamo occupati con Filippo Roma nel servizio che
vedete qui sopra. Abbiamo beccato durante l’orario di lavoro, al Policlinico
Umberto I di Roma, chi andava a fare shopping, chi andava dal parrucchiere o
semplicemente passava il tempo con i colleghi al bar. Sempre senza timbrare
l’uscita. C’era poi chi beggiava, anche per un suo collega, ma poi spariva da
lavoro.
Assenteismo
pubblico: a Taranto si condanna, in Liguria si proscioglie...Il
Corriere del Giorno. Il vigile urbano Alberto Muraglia lavorava per il Comune di
Sanremo. Per il sostituto procuratore Grazia Pradella “L’impianto accusatorio
vede una sostanziale conferma in sedici patteggiamenti e altrettanti rinvii a
giudizio. Ricordate il “‘vigile in mutande” che all’interno del Comune di
Sanremo timbrava il cartellino e se ne tornava a casa ? Si chiama Alberto
Muraglia e durante l’udienza preliminare è stato assolto con rito abbreviato.
Era finito sotto processo a seguito inchiesta nell’indagine della Guardia di
Finanza sui “furbetti” del cartellino. Matteo Renzi all’epoca dei fatti era
Presidente del Consiglio, guardando la foto del vigile in mutande accusato di
assenteismo disse: “Questa è gente da licenziare in 48 ore. E’ una questione di
dignità“. Invece quattro anni dopo quello stesso vigile, simbolo di mala
amministrazione per tutti, non lo è stato per il giudice per le udienze
preliminari Paolo Luppi che ha assolto 10 imputati dei 42
coinvolti nell’indagine sui “furbetti del cartellino” di Sanremo perché “il
fatto non sussiste“. L’inchiesta della Guardia di Finanza sui furbetti di
Sanremo era diventato uno dei casi di cronaca che all’epoca aveva fatto
discutere per mesi, proprio a partire dal vigile che timbrava il cartellino in
mutande ma anche per l’imponenza del blitz delle Fiamme Gialle del 22 ottobre
2015 disposto dalla Procura con cui vennero eseguite 43 misure cautelare e
il Comune di Sanremo licenziò in tronco 32 degli indagati. Nelle settimane
successive su indicazione del sindaco Biancheri il segretario generale aveva
avviato procedimenti disciplinari interni che si erano conclusi con numerose
sanzioni e alcuni licenziamenti. Adesso con l’assoluzione – a fronte della quale
la Procura presenterà ricorso – per Muraglia ed altri furbetti del cartellino
potrebbero aprirsi le strade per una richiesta di reintegro. Ma molto dipenderà
dalle motivazioni.
Lo stesso
procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e altrettanti
patteggiamenti. Tra le accuse quella di truffa ai danni dello Stato. Per il
sostituto procuratore Grazia Pradella “L’impianto accusatorio vede una
sostanziale conferma in sedici patteggiamenti e altrettanti rinvii a giudizio.
Per quanto riguarda gli abbreviati leggeremo con attenzione le motivazioni e
decideremo il da farsi anche perché su queste posizioni vi erano prove che la
Procura ha considerato importanti e di spessore. Valuteremo con estrema serietà,
così come con estrema serietà sono state considerate le prove fotografiche e
documentali”. La data di inizio del processo, per chi ha invece scelto il rito
ordinario, è stata fissata al prossimo 8 giugno. “Una decisione assolutamente
corretta e in linea con le risultanze del procedimento, per cui non mi stupisce
affatto”, ha dichiarato Alessandro Mager, uno degli avvocati del collegio
difensivo. Per l’avvocato Alessandro Moroni invece ”è il momento di spegnere i
riflettori e lasciare che questa vicenda torni a essere come tutti gli altri
processi. Il vaglio di questi filmati ha detto che erano innocenti”.
·
Gli italiani
onesti. Quelli che chiamano ladri gli altri.
Dagospia il 17 settembre 2020. CHE IMBARAZZO PER LA PIÙ ALTA
ISTITUZIONE GIUDIZIARIA - LA CORTE COSTITUZIONALE ELEGGE MARIO MORELLI
PRESIDENTE. VOLETE RIDERE? SARÀ IN CARICA SOLO 3 MESI. GIÀ, PERCHÉ IN QUELLA
BOLLA FEUDALE CHE E' LA CONSULTA VIGE LA TRADIZIONE CHE UN GIRO SULLO SCRANNO
PIÙ ALTO (COI RELATIVI BENEFIT ECONOMICI E TITOLI) NON SI NEGA A NESSUNO PRIMA
DELLA FINE DEL MANDATO. E COSÌ SI LAVORA A SINGHIOZZO TRA UN PRESIDENTE E
L'ALTRO, SENZA UN MINIMO DI VISIONE A LUNGO TERMINE. UNA VERA SCHIFEZZA
SPACCIATA PER ''SERENITA' E INDIPENDENZA''.
(ANSA il 17 settembre 2020) - Nessuno strappo alla tradizione.
Chiamati a eleggere il loro presidente i giudici costituzionali hanno scelto il
collega che da più tempo siede alla Consulta, seguendo ancora una volta il
criterio dell'anzianità: si tratta di Mario Morelli, il giudice che in
Cassazione aveva firmato la sentenza sul caso di Eluana Englaro, dal 2018 vice
presidente della Corte Costituzionale. Il successore di Marta Cartabia però
potrà resterà in carica solo tre mesi. Il 12 dicembre prossimo scadrà infatti il
suo mandato di 9 anni di giudice costituzionale, dove è giunto nel 2011 eletto
dai magistrati della Cassazione. E proprio sul nodo della presidenza breve la
Corte si è divisa. L'elezione è passata a maggioranza e solo alla seconda
votazione (alla prima non si è raggiunto il quorum richiesto), con 9 voti a
favore. Cinque sono andati invece a Giancarlo Coraggio e uno a Giuliano Amato,
che avrebbero potuto assicurare una guida certamente più lunga alla Consulta.
Tutti e due sono stati nominati vicepresidenti da Morelli, che intende
accentuare la "collegialità" della Corte come antidoto alle "criticità" della
presidenza breve, come ha spiegato il neo presidente nella tradizionale
conferenza stampa. "In 3 mesi non si può fare quanto in 3 anni" , ma il
principio dell'anzianità , che è stato sempre seguito dalla Corte costituzionale
nella scelta del presidente (e da cui si è deviato solo in 4 casi ) "assicura
serenità e indipendenza", ha detto Morelli, affrontando esplicitamente il tema e
spiegando che da tempo alla Consulta convive un'altra "linea di pensiero" che
vede nella presidenza breve problemi per la funzionalità della Corte. La partita
vera sulla presidenza si è giocata tra lui e Coraggio, che "al 99,9% sarà il
prossimo presidente" : "abbiamo rappresentato le due opzioni di fondo, ma
rimanendo amici come prima. Siamo completamente d'accordo, lavoreremo insieme",
ha assicurato Morelli. La storia della Consulta ha comunque visto già diverse
presidenze brevi: anche Giuliano Vassalli, Giovanni Conso, Giuseppe Tesauro,
Giovanni Maria Flick sono stati al vertice della Corte costituzionale per poco
più di tre mesi. E ancora meno tempo (1 mese e 14 giorni) Vincenzo Caianiello.
Il neo-presidente non si è sottratto a nessuna domanda dei giornalisti. Il
taglio degli eletti? "è una riforma che incide sulla Costituzione in maniera
relativa e va completata con provvedimenti che con sequenza diacronica devono
seguire" . Non ha detto se voterà si o no al referendum ma ha ammesso che "c'è
un mezzo pieno e un mezzo vuoto" in ognuna delle due posizioni. Quanto ai
principi a cui deve ispirarsi la nuova legge elettorale "sono quelli già fissati
dalla Costituzione, che hanno orientato le decisioni della Corte". Romano, 79
anni anni, sposato, con due figlie, Morelli ha diviso la sua carriera di giudice
tra la Cassazione e la Consulta, dove prima di essere eletto giudice è stato per
30 anni assistente di studio, partecipando all'istruttoria del processo
Lockheed. Alcune sue teorie hanno fatto breccia nella giurisprudenza
costituzionale: come la possibilità di estendere la garanzia di inviolabilità ai
nuovi diritti. "C'è una classe di diritti che dobbiamo far rispettare che non
nascono dall'alto ma sono richiesti dalla coscienza sociale", ha ribadito in
conferenza stampa, confermando che su questo tema le porte della Corte sono
aperte.
Edmondo Rho per espresso.repubblica.it il 3 settembre 2020. A
Ferragosto ha fatto molto scandalo il bonus Covid per le partite Iva riscosso da
3 parlamentari (due leghisti e un pentastellato) su 945 eletti: certo,
scandaloso, ma in questo caso la percentuale di “furbetti” è davvero bassa.
Strano invece sia spesso ignorata la cosiddetta “doppia pensione” cui hanno
diritto parlamentari e consiglieri regionali che, essendo lavoratori dipendenti,
dopo l’elezione si mettono in aspettativa dal loro impiego: un tema che,
evidentemente, riguarda molte più persone. Sia chiaro: la “doppia pensione” dei
parlamentari, esiste da mezzo secolo, ovvero dall’approvazione della legge n.
300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori. Il cui articolo 31 (mai abrogato)
prevede la tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti in aspettativa per
alcuni incarichi politici, con la conservazione del posto di lavoro e il
versamento dei contributi figurativi per avere poi la pensione. A partire dal
2000 c’è stata una variante: i parlamentari e i consiglieri regionali devono
pagare la loro quota di contributi (il 9,19 per cento a carico dei lavoratori)
per avere diritto a quelli figurativi (che sono pari al doppio) a carico
dell’ente previdenziale, cioè a spese della collettività. La norma voleva
tutelare, giustamente, chi lascia il proprio lavoro per entrare in un’assemblea
politica elettiva. Ma l’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori si aggiunge al
vitalizio, istituito fin dal 1956 per deputati e senatori, che non è,
giuridicamente, una pensione. E nulla è cambiato dal 2012, quando per i vitalizi
dei nuovi eletti alla Camera e al Senato si è modificato il sistema di calcolo,
passando dal metodo retributivo a quello contributivo. «Quella che oggi si
chiama pensione contributiva dei parlamentari ha una funzione di garanzia del
ruolo particolare che ricopre chi è eletto in Parlamento, come previsto dalla
Costituzione», dice Antonello Falomi, presidente dell’Associazione ex
parlamentari. Quindi la pensione da eletto si assomma a quella da lavoratore
dipendente? «Sì, ed è una giusta incentivazione dello Stato a svolgere
un’attività pubblica», sostiene Falomi. Ma questa norma può essere rivista?
«Secondo me i parlamentari durante il loro mandato dovrebbero versare i
contributi all’Inps o alla cassa professionale cui sono iscritti, e avere le
stesse regole e gli stessi trattamenti di tutti gli altri lavoratori», dice
Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil. Anche l’esperto previdenziale
Giuliano Cazzola (ex parlamentare e, prima ancora, per quasi trent’anni
dirigente della Cgil, fino al 1993) sostiene che «avere una doppia pensione non
è illegittimo, I contributi figurativi a carico della collettività sono una
valutazione della legge del 1970 che a suo tempo riconosceva una funzione
sociale, e oggi può essere rivista». Però va anche detto che Cazzola già nel
2010, quand’era deputato, aveva proposto che i parlamentari venissero iscritti
alla gestione separata dell’Inps: un’idea caduta nel vuoto. Secondo Cazzola,
«oggi i veri privilegiati, più che i parlamentari, sono i sindacalisti, gli
unici che hanno mantenuto inalterate le regole dello Statuto dei lavoratori di
50 anni fa: per il dipendente in aspettativa, il sindacato non versa l’intera
contribuzione sociale, che è considerata figurativa e quindi a carico di noi
tutti». Mentre, come detto, parlamentari e consiglieri regionali devono pagare
la quota di contributi a carico dei lavoratori. Inoltre, l’ex parlamentare ed ex
sindacalista Cgil aggiunge un particolare importante: questa regola più
favorevole vale per tutti i «sindacati considerati rappresentativi, perché
firmatari dei contratti collettivi applicati in azienda. Si spiega così il
proliferare di sigle sindacali nei settori del pubblico impiego e dei servizi:
conquistare un “posto a tavola” (dove si stipulano i contratti) significa poi
aver accesso al “tesoretto” del distacco o dell’aspettativa a favore dei loro
attivisti».
Pietro Senaldi e la scuola: "Professori con i certificati per
non andare al lavoro? Sospendeteli tutti". Libero
Quotidiano il 29 agosto 2020. Mancano pochi giorni al 14 settembre e la
riapertura delle scuole è ancora un caos. "C'è la triste notizia - spiega Pietro
Senaldi - che circa 200mila professori hanno prodotto certificati medici che
consentono loro di non presentarsi a scuola". Il motivo? "Condizioni precarie di
salute - prosegue il direttore di Libero -, insomma, stanno a casa per non
prendere il coronavirus". Per Senaldi la paura è legittima, però "i professori
dovrebbero pensare anche ai loro studenti e al compito che hanno". In sostanza,
"se gli infermieri si comportassero come loro, noi saremmo a terra e non saremmo
ancora usciti dall'emergenza". E così sarebbe il caso per il direttore che
questi professori vengano sospesi dal pagamento, "tanto non sarebbe una sciagura
per la scuola, visto che questi professori hanno ben poco da insegnare agli
studenti".
L'alibi
perfetto per chi predica una finta etica. Nell’Italia dei furbi la mafia serve a
far sentire migliori: basta non essere mafiosi, l’onestà non importa.
Gioacchino Criaco su Il Riformista il 16 Agosto 2020. E sia chiaro, la mafia fa
schifo, è una montagna di merda. E, senza utilizzare ma o però, alla fine c’è
una generale tendenza alla assoluzione o autoassoluzione, come a dire che,
tranne i mafiosi, si è tutti sullo stesso piano, poiché in settant’anni
la Repubblica più che un popolo, una coesione di cittadini, ha creato una
società unità dalla complicità. Decenni di cattivi insegnamenti in cui le vie
traverse sono diventate le strade giuste per raggiungere una sistemazione, e i
trucchi e le furberie gli elementi essenziali al vivere bene o sopravvivere: una
società che parte dalla raccomandazione per raggiungere la corruzione. Ed è
chiaro che se si porta in piazza l’etica o la morale, il refrain della
stragrande maggioranza onesta, diventa un’enorme balla. E sia chiaro, la mafia
fa schifo, è una montagna di merda, senza ma o però. La mafia c’è, pian piano
diventa l’ultima frontiera, il confine fra il bene e il male che consente al
resto di rimanere in piedi. Non è bella gente quella che si becca il bonus dei
600 euro, ma pian piano si vedrà che oltre ai politici se lo sono beccati
migliaia di professionisti agiati, di norma abbienti che non sono alla fame. La
società italiana è ormai adagiata sulla forzatura delle regole, regole che di
norma sono forgiate per incoraggiare il superamento della vergogna, quasi fosse
una prospettiva sociale. Tutti quelli che hanno gridato all’onestà nel passato,
poi si sono contati fra i disonesti, e tutti quelli che hanno linciato, lanciato
monetine, poi, strette nel pugno, avevano monete che non gli appartenevano. E la
mafia è un orrido a cui non si devono accostare alibi, esiste per dimostrare
fino a dove la cattiva coscienza, o l’incoscienza, possa portare il cuore umano,
esiste per stabilire il confine fra l’assoluzione, l’autoassoluzione, e la
condanna eterna. In Italia finché la mafia avrà vita, tanti potranno continuare
a sentirsi migliori, perfino buoni, per il solo fatto di non essere mafiosi,
lasciando perdere il discorso dell’onestà.
Coinvolti Lega, 5 Stelle e Italia Viva.
Chi sono i deputati che hanno chiesto il bonus da 600 euro.
“Coinvolti oltre 2mila politici minori”. Redazione su Il Riformista il 9 Agosto
2020. Non sono ancora noti i nomi ma sarebbero tre deputati della Lega, uno del
Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva i parlamentari che hanno chiesto
all’Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000 previsto dai decreti
Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva in
difficoltà durante la crisi del coronavirus. A denunciare l’accaduto, così come
riporta Repubblica, la direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e
Trasparenza dell’Inps, organo creato da Pasquale Tridico per individuare le
truffe. In realtà, non c’è nulla di illegale nel comportamento dei cinque
deputati e del conduttore televisivo. Solo una questione di opportunità in un
momento così delicato per il Paese. Uno schiaffo alla miseria di chi durante
l’emergenza coronavirus ha avuto serie difficoltà ad arrivare a fine mese. Loro
invece potevano contare su stipendi di migliaia di euro (per la precisione
12.439) oltre ai rimborsi per il soggiorno a Roma per la loro attività politica.
OLTRE 2MILA POLITICI COINVOLTI – Ma non è tutto. Nella vicenda –
così come rivela sempre Repubblica -sarebbero coinvolti addirittura duemila
persone tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e
sindaci. Numerose le condanne da tutti gli schieramenti politici. Anche il
presidente della Camera Roberto Fico condanna senza mezzi termini il
comportamento dei cinque deputati: “E’ una vergogna che cinque parlamentari
abbiano usufruito del bonus per le partite iva. Questi deputati chiedano scusa e
restituiscano quanto percepito. E’ una questione di dignità e di opportunità.
Perché, in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli obblighi morali, al
di là di quelli giuridici. E’ necessario ricordarlo sempre”.
DI MAIO: “ESCANO ALLO SCOPERTO, SI DIMETTANO” – Il primo a
intervenire sulla vicenda, via Facebook, è stato il ministro degli Esteri Luigi
Di Maio scrive: “Oggi La Repubblica parla di 5 parlamentari, di 5 poveri
furbetti che durante la pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta
allo Stato per avere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e
alle partite Iva in difficoltà. Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila
euro netti di stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi
di cui già godono. È vergognoso. È davvero indecente. Questa pandemia ha fatto
danni economici senza precedenti. Ci sono state persone che hanno perso il
lavoro, aziende che hanno visto il proprio fatturato scendere in maniera
drastica, attività che hanno chiuso senza più riaprire. E questi 5 personaggi
invece di rispondere al popolo che li ha eletti hanno ben pensato di
approfittarne. I nomi di queste 5 persone sono coperti dalla legge sulla
privacy. Bene, siano loro allora ad avere il coraggio di uscire allo scoperto.
Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano, se in corpo
gli è rimasto ancora un briciolo di pudore. Non importa di quale forza politica
siano espressione. Mi auguro che anche le altre forze politiche la vedano come
noi”.
BELLANOVA: NON HANNO SERVITO I CITTADINI – “Leggo che cinque
parlamentari della Repubblica avrebbero percepito i 600 euro di bonus partita
Iva Chiunque siano, a qualunque partito e schieramento appartengono, se hanno un
minimo di dignità possono fare solo una cosa per sanare questa brutta vicenda:
dimettersi. Devono farlo perché evidentemente non sono stati in grado di servire
i cittadini che rappresentano e il Paese con onore e lealtà, tanto più in un
momento come questo”. Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche
agricole Teresa Bellanova, di Italia viva.
SALVINI – “Chiunque siano, immediata sospensione”. Lo dice il
leader della Lega Matteo Salvini a proposito dei parlamentari che avrebbero
incassato il bonus Inps.
Annalisa Cuzzocrea e Giovanna Vitale per Repubblica.it il 10
agosto 2020. I nomi ancora non si conoscono, ma appartengono a tre diversi
partiti i "furbetti" del bonus Covid. Come svelato da Repubblica, cinque
deputati hanno chiesto all'Inps il bonus da 600 euro mensili poi elevato a 1000
previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi
e partite Iva in difficoltà durante la crisi del coronavirus. Segnalazione che è
arrivata direttamente dalla direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e
Trasparenza dell'Inps, una struttura creata ad hoc dal presidente Pasquale
Tridico con l'obiettivo di individuare i truffatori. Dalle prime indagini
sarebbe emerso che i cinque di Montecitorio sarebbero tre deputati della Lega,
uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Inoltre, nella vicenda
sarebbero coinvolti addirittura duemila persone tra assessori regionali,
consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. A intervenire sul caso
con durezza è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che scrive su Facebook:
"Oggi la Repubblica parla di 5 Parlamentari, di 5 poveri furbetti che durante la
pandemia hanno avuto il coraggio di avanzare richiesta allo Stato per avere il
bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite iva in
difficoltà. Evidentemente non gli bastavano i quasi 13mila euro netti di
stipendio al mese, non gli bastavano tutti i benefit e privilegi di cui già
godono. È vergognoso. È davvero indecente". Poi aggiunge: "Questa pandemia ha
fatto danni economici senza precedenti. Ci sono state persone che hanno perso il
lavoro, aziende che hanno visto il proprio fatturato scendere in maniera
drastica, attività che hanno chiuso senza più riaprire. E questi 5 personaggi
invece di rispondere al popolo che li ha eletti hanno ben pensato di
approfittarne - prosegue Di Maio - i nomi di queste 5 persone sono coperti dalla
legge sulla privacy. Bene, siano loro ad avere il coraggio di uscire allo
scoperto. Chiedano scusa agli italiani, restituiscano i soldi e si dimettano, se
in corpo gli è rimasto ancora un briciolo di pudore. Non importa di quale forza
politica siano espressione. Mi auguro che anche le altre forze politiche la
vedano come noi". Anche il presidente della Camera Roberto Fico condanna senza
mezzi termini il comportamento dei cinque furbetti: "E' una vergogna che cinque
parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite iva. Questi deputati
chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. E' una questione di dignità e
di opportunità. Perché, in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli
obblighi morali, al di là di quelli giuridici. E' necessario ricordarlo sempre".
Di identico parere è anche la viceministra cinquestelle dell'Economia Laura
Castelli: "Se questa notizia fosse confermata, sarebbe molto grave - afferma su
Facebook - Vorrebbe dire che a Montecitorio non c'è il senso della misura.
Quando abbiamo pensato a questi provvedimenti, li abbiamo scritti per aiutare
chi davvero stava soffrendo, chi si era ritrovato di colpa in difficoltà, chi ne
aveva bisogno davvero. Col Movimento 5 Stelle abbiamo sempre combattuto gli
sprechi e non credo appartenga ai principi 'onorevolì quello di richiedere il
bonus partita Iva per chi di sicuro non fa fatica ad arrivare a fine mese ma ha
avuto la fortuna di ricevere il proprio stipendio regolarmente anche durante la
pandemia. Un gesto davvero inopportuno". E si augura che "si intervenga presto
per capire chi ne ha fatto richiesta". Sulla stessa linea anche Licia Ronzulli,
vicepresidente di Forza Italia al Senato, che afferma: "Se confermato, questo
sarebbe semplicemente uno scandalo. E' inaccettabile che mentre le famiglie non
sapevano come fare la spesa e molte attività chiudevano, qualcuno, con lo
stipendio garantito, senza avere accusato perdite, abbia pensato di
approfittarsi dell'emergenza Covid togliendo soldi a chi ne aveva realmente
diritto e, soprattutto, bisogno. Ci aspettiamo un sussulto di dignità: i
deputati di cui parla l'Inps chiedano scusa e, se li hanno presi, restituiscano
immediatamente i soldi. Diversamente non si lamentino se i cittadini hanno
sempre meno fiducia nella politica e si ingrossano le file dell'astensione e dei
voti di protesta". Più diretto il leader della Lega, Matteo Salvini, che oltre a
condannare il comportamento dei deputati, accusa l'Inps. "Che un parlamentare
chieda i 600 euro destinati alle partite Iva in difficoltà è una vergogna. Che
un decreto del governo lo permetta è una vergogna - attacca Salvini - ma che
l'Inps abbia dato quei soldi è una vergogna". E aggiunge: "Chiunque siano i
deputati, procedere con l'immediata sospensione". A chiedere dimissioni
immediate, a prescindere dal partito a cui appartengono, a la ministra
dell'Agricoltura e esponente di Italia Viva (partito a cui apparterebbe uno dei
"furbetti"), Teresa Bellanova. "Chiunque siano, a qualunque partito e
schieramento appartengono- sostiene su Facebook - se hanno un minimo di dignità
possono fare solo una cosa per sanare questa brutta vicenda: dimettersi. Devono
farlo perche' evidentemente non sono stati in grado di servire i cittadini che
rappresentano ed il Paese con onore e lealta', tanto piu' in un momento come
questo". Definisce la vicenda "uno squallore" la leader di Fratelli d'Italia,
Giorgia Meloni. "Una brutta storia di deputati avidi e governo incompetente -
afferma - sulla quale pretendiamo massima chiarezza. Intanto, visto che l'Inps
non fa i nomi per questione di privacy, invito ogni parlamentare a dichiarare
'#Bonus Inps io no!'. In modo che i nomi emergano lo stesso, per esclusione".
Anche il vicepresidente del Pd alla Camera Michele Bordo condanna il
comportamento dei 5 deputati, definendolo "inqualificabile". E aggiunge: "Spero
che restituiscano subito i soldi o che il presidente Roberto Fico trovi
immediatamente la maniera per porre rimedio a questa ingiustizia, che è uno
schiaffo enorme nei confronti di chi ha realmente bisogno, specie dopo
l'emergenza sanitaria. Questa vicenda dimostra che ha ragione il Pd quando
afferma che sono sbagliati i contributi a pioggia senza nessun meccanismo di
selezione". "Posso dire che è una vera vergogna?" scrive su Facebook il
segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Mentre il capogruppo dem alla Camera
Graziano Delrio aggiunge: "Non possono essere ammessi comportamenti simili da
parte di eletti in Parlamento, soprattutto dinanzi alle difficoltà e alle
sofferenze vissute da così tanti italiani in questi mesi. Restituiscano subito
gli importi e chiedano scusa al Paese". Il portavoce di Leu, Federico Fornero,
chiede chiarezza sulla vicenda. "È giusto - dice - che gli italiani conoscano i
l nomi dei cinque parlamentari e chi si è comportato in questo modo deve
assumersi le proprie responsabilità, incominciando con il restituire subito i
soldi. Si faccia dunque chiarezza sulla vicenda e la si faccia subito".
Gian Antonio Stella per “il Corriere della Sera” il 10 agosto
2020. Neanche l'immenso onorevole diccì Giovanni Alterio, che un giorno si
mangiò alla buvette 24 panini e 5 crocchette di riso innaffiati da bottiglie
d'acqua e limonata, era mai stato così ingordo. Come hanno osato cinque
parlamentari, nei giorni più difficili della pandemia, chiedere (loro!) il bonus
di 600 euro? Una schifezza. Da trattare col sarcastico dono che il verde Stefano
Apuzzo riservò allora a quel deputato insaziabile: «Un sacchetto di ghiande per
placare il vorace appetito». Ma c'è di più: a fare la domanda sarebbero stati
anche circa duemila politici locali. Va da sé: è scoppiato un putiferio. E
parallelamente un coro di censure. Da Nicola Zingaretti («Posso dire solo che è
una vergogna?») a Giorgia Meloni («Una brutta storia di deputati avidi e governo
incompetente sulla quale pretendiamo massima chiarezza»), da Roberto Fico
(«Questi deputati chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. È una
questione di dignità e di opportunità. Perché, in quanto rappresentanti del
popolo, abbiamo degli obblighi morali, al di là di quelli giuridici») a Teresa
Bellanova («Chiunque siano, a qualunque partito e schieramento appartengono, se
hanno un minimo di dignità possono fare solo una cosa per sanare questa brutta
vicenda: dimettersi»), da Mariastella Gelmini («Quei fondi erano per persone in
grave difficoltà, chi ne ha approfittato dovrebbe immediatamente autodenunciarsi
e restituire subito i soldi») a Luigi Di Maio («È davvero indecente. I nomi sono
coperti dalla legge sulla privacy. Bene, siano loro allora ad avere il coraggio
di uscire allo scoperto») a tanti e tanti altri.
Tutti scandalizzati. Per non dire di Matteo Salvini: «Che un
parlamentare chieda i 600 euro destinati alle partite Iva in difficoltà è una
vergogna. Che un decreto del governo lo permetta è una vergogna. Che l'Inps (che
non ha ancora pagato la cassa integrazione a migliaia di lavoratori) abbia dato
quei soldi è una vergogna. In qualunque Paese al mondo, tutti costoro si
dimetterebbero».
Cesello finale: «Chiunque siano, immediata sospensione». Dove il
«chiunque siano» dice tutto: tre parlamentari su cinque (gli altri due coperti
da un'idea insensata della privacy pare appartengano al Movimento 5 Stelle e ad
Italia viva) sarebbero infatti della Lega. Una legnata in più, in caso di
conferma, a poco più di un mese dalle elezioni regionali, sulla groppa di un
partito già inguaiato per il riaccendersi delle polemiche interne sui 49 milioni
di euro da risarcire e lo scandalo sulle forniture alla regione Lombardia da
parte dell'impresa proprietà della moglie e del cognato del governatore Attilio
Fontana.
Sia chiaro: non è la prima volta, e probabilmente non sarà
l'ultima, che la politica sia accusata di insaziabilità. Basti ricordare il caso
di Luigi Lusi, il tesoriere della Margherita del quale Filippo Ceccarelli nel
libro Invano racconta che, «posseduto da un demone ingordo e spendaccione» per
un totale di tredici milioni, non resisteva agli «spaghetti con il caviale
presso uno dei migliori ristoranti della città politica, Carmelo alla Rosetta:
raccontavano i camerieri che al momento di scolare e condire la pasta, Lusi si
recava in cucina e qui, come in un rito solenne, con una bilancina misurava la
quantità di caviale. Comunque erano 180 euro a piatto». Per non dire di tante
inchieste sui rimborsi elettorali nei quali ci fu chi infilò di tutto: dalla
bottiglia di vino da 112 euro al materasso ad acqua, dalla parrucchiera ai
sensori elettronici per l'auto della moglie o del cugino. Quello che più
offende, questa volta, e solleva una nuova ondata di indignazione, è la
piccineria taccagna e miserabile di chi si è precipitato a raschiare quei 600
euro, di fatto sottratti a chi ne aveva più bisogno, in un momento tragico per
il Paese. Quello della spaventosa conta quotidiana di morti, degli appelli a
tutto il mondo per trovare respiratori per quanti si spegnevano affamati
d'ossigeno, delle sale di rianimazione stracolme, dei medici che se ne andavano
a due, tre, quattro al giorno, dei camion militari che partivano appena faceva
buio per portare centinaia di bare verso cimiteri lontani per la cremazione...
Nulla può giustificare l'avidità di chi in momenti come quelli ha fatto il
furbo. Tanto più che, stando alle rivelazioni che sgocciolano tra l'imbarazzo e
la collera dai vertici e dagli ispettori dell'Inps, dicevamo, sarebbero in
totale un paio di migliaia i politici nazionali, regionali, comunali, ad aver
cercato di avere una fetta di quella torta. Su tutti, imperdonabili, quei cinque
anonimi segnalati dalla struttura di Pasquale Tridico, il presidente
dell'istituto di previdenza che il 20 aprile aveva parlato di «4,4 milioni di
domande per il bonus da 600 euro» dei quali «pagati 3,5 milioni». A maggior
ragione perché l'accusa ai cinque parlamentari è stata giustamente accompagnata
dal confronto con i redditi mediamente percepiti da deputati e senatori: «uno
stipendio netto da 12.439 euro». Numeri ricavati dai siti ufficiali di
Montecitorio e Palazzo Madama. Che, come ha ricordato recentemente
truenumbers.it , certificano come un parlamentare «può arrivare a guadagnare
oltre 17.625 euro lordi al mese se è senatore e o 18.735 euro lordi se è
deputato». Il tutto a dispetto della stizzita comunicazione ufficiale con cui
l'ufficio stampa del Parlamento il 3 gennaio 2012, otto anni fa, rispondeva non
ai «soliti giornalisti criticoni» ma al rapporto della Commissione che, guidata
da Enrico Giovannini, aveva comparato stipendi, diarie e indennità dei
parlamentari europei con quelli di deputati e senatori nostrani: le indennità
«sono pari mediamente a 5.000 euro. La cifra di 11.283,28 euro mensili è
riferita infatti al lordo. Il netto risulta inferiore rispetto a quello
percepito dai componenti di altri Parlamenti presi a riferimento». Certo,
cinquemila senza tutte le altre voci. Chiarì tutto, nel giugno di due anni dopo,
una comparsata al programma «L'aria che tira» di Giancarlo Galan, deciso a
dimostrare, a dispetto delle polemiche e delle tesi dei magistrati che l'avevano
incastrato per il Mose, di esser in grado benissimo di pagare il mutuo
stratosferico della villa in cui viveva. Mostrò a Myrta Merlino la sua busta
paga: «Tanto a questo punto è meglio essere considerato "casta" che non ladro».
Fatti i conti, con la «diaria parte variabile, diaria parte fissa, rimborso
forfettario, rimborso spese accessorie, rimborso semestrale, spese telefoniche,
rimborso spese esercizio mandato» si arrivava «a 18 mila euro». Prova provata
che i famosi tagli radicali sono nel tempo evaporati...
IL BONUS DEL DISONORE. Sebastiano
Messina per “la Repubblica” il 10 agosto 2020. Un parlamentare che non si
accontenta dei 13 mila euro che incassa ogni mese ma scrocca allo Stato i 600
euro destinati a salvare dalla miseria le partite Iva messe in ginocchio dal
coronavirus non commette un illecito ma perde quell'onore che una volta
giustificava il titolo di "onorevole". E dunque, ancor prima che si conoscessero
i nomi dei cinque deputati o senatori che sono stati scoperti dalla centrale
antifrode dell'Inps - tre leghisti, un grillino e un renziano - si è abbattuta
su di loro l'onda di un'indignazione trasversale che in un altro Paese europeo
li spingerebbe all'unica via d'uscita possibile: la restituzione, le scuse e le
dimissioni immediate. Ma poiché in Italia la democrazia troppo spesso diventa
commedia, siamo rassegnati a un finale all'italiana, perché in fondo aveva
ragione Longanesi quando diceva che sulla nostra bandiera nazionale dovrebbe
esserci una grande scritta: «Tengo famiglia». E infatti pare che non siano stati
solo quei cinque parlamentari a fare i furbetti, ma più di 2000 politici locali,
tra assessori e consiglieri regionali e comunali, sindaci e persino presidenti
di Regione, una fetta non piccola di quella classe politica che anche durante la
pandemia ha regolarmente ricevuto uno stipendio che nelle Regioni supera i 6000
euro. E allora capiamo che c'è una questione ancora più imbarazzante, ancora più
allarmante, di quella degli onorevoli scrocconi, ed è la norma che ha permesso
tutto questo, ovvero l'articolo 27 del decreto legge "Cura Italia". Che
prevedeva un unico requisito, per l'erogazione dell'indennità di 600 euro a
tutti i titolari di partita Iva e ai lavoratori Co.co.co: che non fossero
pensionati. Limiti di reddito, zero. Chi l'ha scritta questa norma, i cui abusi
oggi indignano così violentemente i Di Maio e tutti i pentastellati? L'hanno
scritta loro, perché sono grillini il ministro dello Sviluppo economico
Patuanelli, il ministro del Lavoro Catalfo, il viceministro dell'Economia
Castelli e il presidente del Consiglio Conte. E l'hanno scritta con lo stesso
inchiostro con cui fu stilata la legge sul reddito di cittadinanza, quando
l'Inps ebbe solo cinque giorni di tempo per vagliare un milione di domande, e
così in mezzo a quelle di tanti italiani realmente bisognosi si infilarono
camorristi, spacciatori ed evasori fiscali. L'hanno scritta con la stessa fretta
con cui sono stati erogati bonus a pioggia, a cominciare da quello per bici e
monopattini, senza distinguere tra disoccupati e milionari. Lo scandaloso caso
dei parlamentari che chiedono la mancia non è dunque solo un nuovo episodio
dell'ingordigia della casta, ma è innanzitutto l'indizio della totale
inadeguatezza di una classe politica populista che continua ad alimentare nel
suo elettorato l'illusione che lo Stato possa distribuire redditi e bonus senza
creare sviluppo e lavoro. Eppure sappiamo già che il principale effetto di
questa immorale vicenda sarà quello di rafforzare il già solido sentimento
anti-casta. E chi ci ha costruito sopra la sua fortuna politica - il Movimento 5
Stelle - certo la userà spudoratamente per la campagna per il taglio dei
parlamentari. Cercando di farci dimenticare che oggi in Italia il vero problema
non è il numero dei politici, ma la loro capacità di governare questo Paese.
Alessandro Sallusti per “il Giornale” il 10 agosto 2020.
Quattordicimila euro al mese, più varie prebende, senza lavorare in generale e
certamente durante il periodo di lockdown non bastavano a cinque deputati che,
si scopre, hanno fatto domanda di accedere ai sussidi - poche centinaia di euro
al mese - previsti dai decreti emergenza Covid per chi era rimasto senza lavoro
e stipendio. Lo rivela l'Inps, che getta il sasso ma ritira la mano. I furbetti
del Covid sono infatti per ora senza nome, anche se non credo che rimarranno
anonimi a lungo. Probabilmente i cinque non hanno commesso alcun reato - magari
nella vita privata sono professionisti che in quei mesi non hanno fatturato - e
questo già la dice lunga su come siano pensate e scritte le leggi di questi
incapaci, perché permettere che agli aiuti possa accedere gente che comunque
guadagna dieci volte lo stipendio medio di un italiano è scandaloso oltre che
immorale. Accattoni è la giusta definizione di questi signori o signore che
siano. Tra i tanti modi di fare soldi attraverso la politica, questo mi sembra
il più meschino. Per prendere una tangente ci vuole coraggio e talento, un
talento criminale ma pur sempre talento. Sottrarre risorse ai bisognosi quando
si è con il sedere ben al caldo è semplicemente stupido e vigliacco. Sarà a
norma di legge, ma mi ricorda tanto quell'infermiere di un reparto di
rianimazione Covid che sottrasse il bancomat a un ricoverato e prelevò tremila
euro. Attenzione, l'Inps non è uno spettatore neutro della partita politica. È
un attore al servizio del governo, che per di più nel film Covid ha recitato una
pessima parte, dando prova di non essere all'altezza del ruolo, per esempio
nell'erogazione della cassa integrazione. Possibile quindi che la decisione di
rendere noto il misfatto faccia parte di un regolamento di conti che poco ha a
che fare con la morale, e il fatto che Di Maio sia stato il più lesto a saltare
sullo scandalo è un indizio in tal senso. Ciò nulla toglie alla gravità di ciò
che è successo. Consiglio agli interessati di uscire allo scoperto, non sperino
di cavarsela con semplici e patetiche scuse o arzigogolate spiegazioni. Gente
così, chiunque sia, non può stare in Parlamento un giorno in più.
Le confessioni dei politici "Bonus preso, processateci..."
Alcuni consiglieri rivendicano la richiesta dell'assegno per le partite Iva. E
spiegano così i motivi della loro scelta. Federico Garau, Lunedì 10/08/2020 su
Il Giornale. Non si placa la bufera sul bonus di 600 euro messo a punto dal
governo per auitare i titolari di partita Iva in difficoltà e percepito anche
da alcuni membri del parlamento e rappresentanti locali della politica. Mentre
prosegue la "caccia" ai nomi dei 5 deputati che avrebbero usufruito
dell'ammortizzatore sociale, un altro consigliere comunale ha deciso di seguire
l'esempio di Anita Pirovano, consigliera del comune di Milano, e di
autodenunciarsi.
Rispondendo al post pubblicato su Facebok della rappresentante
di "Milano progressista", Jacopo Zannini, consigliere per il comune di Trento
appartente al gruppo "L'Altra Trento a Sinistra" ha dichiarato: "Grazie Anita
Pirovano. Sono in Consiglio comunale a Trento e anche io non vivo di sola
politica, pago l'affitto ogni mese e per marzo e aprile sono rimasto senza
lavoro e ho chiesto come te i 600 euro visto che con i gettoni di presenza non
sarei arrivato a fine mese... ed è giusto rivendicarlo". Un intervento, quello
di Zannini, che ha ricevuto la comprensione di un utente, che ha
commentato: "Jacopo è diversa la tua situazione da quanto credo di aver
capito". "Certo molto diversa ma lo dico per evitare di fare demagogia", è stata
la replica del consigliere di Trento.
Intervistata da "Radio Capital", la stessa Anita Pirovano ha
ancora una volta ribadito quanto affermato nel suo post lasciato sui social. "Io
faccio il consigliere comunale, non il parlamentare né il consigliere regionale
o l'assessore regionale. Quello che viene percepito in termini di riconoscimento
economico è sostanzialmente diverso. A differenza dei parlamentari e dei
consiglieri regionali noi non prendiamo un'indennità, ma dei gettoni di
presenza. Guadagno ben sotto i trentamila euro lordi, visto che devolvo una
parte dei gettoni da consigliere. Se avessero messo un tetto Isee per accedere a
questo ammortizzatore, come avrebbero dovuto, avrei potuto beneficiarne. Ho
esplicitato la mia situazione non per giustificare i cinque parlamentari, ma per
rendere ancora più esplicito che hanno fatto una cosa assurda, sbagliata", ha
spiegato, come riportato da "LaPresse". La sua condizione, così come quella dei
colleghi, non è dunque equiparabile a quella dei parlamentari. "Bisogna spiegare
ai cittadini che non tutta la politica è lo stesso, che fare il parlamentare è
diversissimo dal fare il consigliere comunale. Io ho rivendicato quello che ho
fatto, non ho problemi etici a dimostrare le mie ragioni. Spero che anche loro,
che avranno più difficoltà a trovare giustificazioni etiche, escano allo
scoperto e chiedano scusa agli italiano. Dovrebbero dimettersi perché hanno
sbagliato lavoro", ha aggiunto la Pirovano. Alla domanda se anche lei sarebbe
ora disposta a dimettersi, la consigliera ha poi replicato: "In generale non
prendo ordini, ma ci rifletterei. Magari più se me lo chiedessero i miei
elettori. Al momento le reazioni al mio post su facebook sono di ringraziamento,
c'è chi mi dice grazie per aver fatto vedere che la politica è soprattutto
servizio e non guadagno". Pirovano si dice pronta al confronto anche se le
venisse richiesto di restituire il bonus, ed è certa di non aver commesso alcun
errore:"Non ho sbagliato, lavoro da psicologa ed è la mia attività principale, e
avendo avuto come tutti una situazione di difficoltà in questi mesi ho chiesto
di accedere a una misura che esisteva. Se fossi stata ricca non lo avrei
chiesto", ha concluso.
Ad unirsi al coro anche un consigliere comunale di
Ancona, Francesco Rubini, che risponde duramente alle critiche: "Ho 29 anni,
sono un giovane avvocato precario con una partita Iva aperta nel 2019 e faccio
il consigliere comunale nel comune di Ancona dove percepisco gettoni di presenza
(niente stipendio, indennità, rimborsi, benefit etc, etc) per una media di
600/700 euro al mese. Ho chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per i liberi
professionisti perché, malgrado una laurea magistrale, un titolo da avvocato,
una nobile professione e un ruolo istituzionale in un capoluogo, sono ancora
costretto a barcamenarmi per avere un reddito mensile decente", ha dichiarato,
come riportato da "LaPresse". Poi, la provocazione: "Adesso, cari populisti da
strapazzo, odiatori di professione, leoni da tastiera e buffoni vari, venite a
prendermi per processarmi in pubblica piazza nella vostra ridicola guerra contro
'i politici ladri'. Vi aspetto a braccia aperte".
Ad aggiungersi alla lista anche il consigliere regionale di Forza
Italia Franco Mattiussi, che ha rivelato di aver richiesto il medesimo
bonus. "Ho utilizzato quei soldi anche per far quadrare conti che comunque
dovevano essere saldati. Perché nonostante tutto fosse fermo, bollette
continuavano ad arrivare. Quindi, calma. Sangue freddo e razionalità. Che
puntare il dito è fin troppo facile. Vedere la luna un'altra cosa", ha detto il
noto albergatore sulla sua pagina Facebook. "Capisco la semplicità
dell'antipolitica. Capisco il caldo e, forse, una certa rabbia sociale, che
taluni aiutano a montare. Magari non troppo giustificata da foto balneari", ha
proseguito Mattiussi. "Capisco il richiamo alla morale. Ma fatico a vederne una
definizione compiuta in questo tempo. I parlamentari così come Sindaci e
consiglieri regionali vari ed eventuali che hanno richiesto il bonus Inps non
hanno rubato nulla, ma hanno esercitato un loro diritto. Hanno, in un certo
senso, profittato di una norma che lo consentiva. L'avere partita iva presuppone
l'esistenza di un lavoro autonomo parallelo alla figura politica ricoperta".
Mattiussi, che gestisce varie strutture (tra cui, come ricordato dal Corriere
Veneto, l'hotel ristorante Patriarchi di Aquileia, la trattoria albergo Ai
Cjastinars a Villa Vicentina, l'albergo Aquila Nera ed il bar Cjapitul entrambi
ancora ad Aquileia), avrebbe utilizzato il bonus "immettendolo nella casse
aziendali". Il profilo di Mattiussi è stato tempestato di messaggi di utenti
indignati: "Vergognati", "Gente senza vergogna in questa come probabilmente in
altre occasioni", "Non ti voterò più", "Provo nausea nei tuoi confronti" "6300
euro lordi mesi, 2400 netti esentasse, 17400 lordi e le servivano 600 euro?".
Una reazione che ha spinto l'albergatore a replicare. "Sto leggendo commenti
alcuni civili ed alcuni meno relativi alla mia ammissione. Ho scelto, come
sempre, la trasparenza. Ma qui sta nascendo un paradosso: se la mia azienda
causa lockdown ha una perdita d'incassi prossima ai 300000 euro e lo Stato - cui
regolarmente pago le tasse- mi riconosce 600euro in due mensilità non c'è nulla
da giustificare. Anzi", ha spiegato il consigliere di Forza Italia certo del
fatto suo.
Le prime confessioni hanno fatto uscire allo scoperto altri
politici. "In quei mesi di lockdown il mutuo per la casa, il fitto per lo studio
legale, la rata per l'auto, le bollette per i consumi non hanno avuto alcuna
sospensione... E allora voglio essere trasparente fino all'inverosimile: ho
chiesto e ottenuto, così come 142.000 avvocati in Italia, il bonus
professionisti legato al Covid-19 semplicemente perché ne avevo diritto e ne
avevo bisogno", ha spiegato su Facebook il consigliere comunale di Lamezia Terme
Rosario Piccioni, che era stato in corsa anche per la poltrona di sindaco. "600
euro per il mese di marzo e 600 euro per il mese di aprile. E non me
ne vergogno: perché di professione faccio l'avvocato e non il politico". Una
motivazione che oramai ha contagiato quanti hanno richiesto il bonus. "E lo
sanno tutti che anche la giustizia, così come tanti settori, nei mesi di marzo e
aprile è stata completamente paralizzata e noi avvocati non abbiamo lavorato:
non abbiamo svolto cause e non abbiamo potuto ricevere clienti", ha concluso.
"Apprendo da internet che sindaci e consiglieri comunali che
hanno richiesto i 600 euro all'INPS debbano essere considerati dei 'furbetti'",
esordisce invece il sindaco di Solbiate con Cagno (Como). "Bene, per grande
trasparenza non aspetto che qualcuno trafughi notizie, nè che l'INPS renda noti
i nomi, ma preferisco dire subito che, pur essendo sindaco di un piccolo comune,
ho chiesto il bonus da 600 euro come libero professionista. E non l'ho fatto per
rubare qualcosa, ma per un semplice e chiaro motivo: dopo l'ultima fattura del
26 febbraio, a marzo, aprile e maggio ho fatturato ZERO con la mia partita iva",
ha spiegato il primo cittadino. "Chi vuole vedere la mia situazione finanziaria,
ha la mia massima disponibilità. Ho ben poco da nascondere. Chiudo molto
rapidamente: se qualcuno mi dimostrerà che ho realmente sbagliato (come molti, a
quanto pare), ben disponibile a restituire, ma fino a quel ma fino a quel
momento evitiamo di fare come sempre di tutta un'erba un fascio", ha aggiunto
Federico Broggi.
I “furbetti” del bonus sono solo cinque su mille parlamentari,
ma il populismo vince. Il Dubbio il 10 agosto 2020. La
furia propagandista cavalca il referendum di settembre sul taglio dei deputati.
Ma i cinque non hanno trasgredito alcuna legge: si sono avvalsi di una norma che
li favoriva. In Parlamento e aree limitrofe è caccia grossa. Fuori i nomi dei
cinque “furbetti”, come sono stati ribattezzati senza spreco di fantasia i 5
onorevoli, tre della Lega, uno del M5S e uno di Iv che hanno chiesto il bonus
autonomi di 600 euro nonostante godano di uno stipendio che non si può definire
da fame. Il più imbarazzato è Salvini: con tre dei suoi nella listaccia la croce
dal dorso non gliela toglie nessuno. Di Maio invece si frega le mani.
Quell’unico reprobo pentastellato non offusca l’occasione propagandistica d’oro
e diamanti in vista del referendum sul taglio dei parlamentari. Quei cinque
insaziabili sono la prova provata della nefandezza parlamentare. Il loro
affronto alla miseria grida vendetta e quale occasione migliore per coglierla di
un referendum il cui senso compiutamente antiparlamentare non sfugge a nessuno
proprio dietro l’angolo. Le dimissioni, se mai i partiti di appartenenza
riusciranno a strapparle ed è ben poco probabile, non laveranno l’onta, le
bordate propagandistiche resteranno ad alzo zero. Non che siano davvero
giustificate però. I cinque non hanno trasgredito alcuna legge: si sono avvalsi
di una norma che li favoriva. Può non essere corretto e certamente non lo è ma
nulla di più. Al contrario, la percentuale dovrebbe suonare quasi rassicurante.
Cinque parlamentari su circa mille, ciascuno dei quali avrebbe avuto tutto il
diritto di avanzare la sua brava richiesta di bonus, sono lo 0,5%. Tenendo conto
del vertiginoso abbassamento del livello medio dei parlamentari nell’ultimo
quindicennio, dovuto proprio alla perdita di ruolo del Parlamento stesso, non è
neppure una percentuale da strapparsi i capelli. Il problema serio dovrebbe
riguardare una tendenza che il caso Montecitorio indica e che al di fuori del
Parlamento ha dimensioni ben più massicce. Se quei parlamentari, e sembrerebbe
un paio di migliaia di consiglieri comunali e regionali, hanno potuto chiedere
il bonus è perché il governo aveva deciso di lasciare le maglie molto larghe,
senza condizioni controlli o filtri di alcun genere. Disfunzioni a parte, il
bonus doveva essere erogato a tutti. Su una altra voce “di ristoro” però la
scelta è stata opposta: il reddito di emergenza, destinato ai più poveri e ai
più penalizzati dalla crisi, è stato ridotto all’osso, 400 euro una tantum
raddoppiati per le famiglie molto numerose, e soprattutto le condizioni per
accedervi sono state fissate con tanta rigorosità da tagliare fuori buona parte
della platea. Alla fine il rde è arrivato solo a un terzo della platea
inizialmente prevista. In questo caso non si tratta della furbizia di un numero
insignificante di deputati e neppure di una distrazione: al contrario una parte
della maggioranza aveva segnalato e protestato per i criteri opposti con i quali
il governo guardava agli autonomi da un lato e ai precari dall’altro. Del resto,
proprio mentre tagliava (di oltre due terzi) il fondo previsto per il reddito
d’emergenza il governo allargava gli sgravi fiscali a tutte le aziende, incluse
quelle che nella crisi non hanno perso o hanno guadagnato. Non è infine un
mistero che molte aziende si siano avvalse della cassa integrazione continuando
a far lavorare da casa i dipendenti e limitandosi a risparmiare sugli stipendi.
Lo scandaletto di Montecitorio è solo la schiuma sulla cresta di un’onda
gigantesca. Al di là della palese ingiustizia, la decisione del governo di
muoversi in questa direzione è allarmante, in vista delle scelte da compiersi
con il Recovery Fund europeo, perché conferma due tendenze esiziali. La prima,
non certo limitata all’Italia, è il miraggio di raggiungere un’impossibile
quadratura del cerchio: la speranza di mantenere basso il costo del lavoro,
altissime le diseguaglianze sociali e tuttavia rilanciare la domanda interna. La
logica della iniqua ripartizione delle risorse nel dl emergenziali del governo
Conte è evidente. Inutile dare soldi a chi ne ha pochissimi, perché comunque non
spenderebbe e l’investimento sarebbe a fondo perduto in termini di aumento della
domanda interna. Molto meglio sostenere il ceto medio e quello medio alto
auspicando che consumino, spendano e riportino in alto la domanda interna. Non
ha mai funzionato e non funzionerà neppure stavolta: senza quell’intervento
drastico sulle diseguaglianze sociali che peraltro la Commissione europea stessa
invoca a gran voce non ci sarà vera ripresa della domanda interna e dunque del
Pil. La seconda tendenza è invece essenzialmente italiana. Consiste in una
politica industriale ridotta a sovvenzionare le aziende, senza alcuna visione
strategica e senza alcun ruolo oltre l’assecondare l’eterna tendenza del
capitalismo italiano a farsi assistere.
Società civile assolta e politici alla gogna: il populismo
all’italiana. Paolo Delgado su Il Dubbio il 13 agosto
2020. La Lega ha sospeso i deputati Murelli e Dara perchè sono tra quelli che
hanno incassato i bonus. Ma nessuno si scandalizza delle centinaia di notai che
hanno preso i 600 euro nonostante gli incassi da favola. Alla fine l’Inps
comunicherà a una folla assetata di severa punizione i nomi dei tre reprobi che,
pur godendo dello stipendio di parlamentari, hanno chiesto e ottenuto a
differenza di altri due colleghi a cui è stato negato, il bonus di 600 euro
mensili, passati poi a mille tondi. Intanto la Lega ha sospeso i deputati
Murelli e Dara perchè sono tra quelli che hanno incassato i bonus. Pur se del
tutto legittima la richiesta non è stata precisamente un bel gesto e un certo
grado di indignazione è in questo caso giustificato. Negli ultimi tre giorni,
però, si è prodotto nel Paese un clima che è andato ben oltre i confini della
comprensibile e legittima indignazione. Una sorta di caccia alle streghe che
dallo sparuto drappello di parlamentari si è allargato ai consiglieri comunali,
senza tener conto della spesso enorme differenza di stipendi. Il particolare è
considerato secondario dal momento che sempre di politici si tratta e che si
portino a casa un gettone da mille euro o una busta paga da 12mila che spesso
lievita poi intorno ai 18mila, cosa cambia? Ci sono state autodenunce, impegni a
espiare evitando la ricandidatura, messe all’indice, cancellazioni preventive
dalle future liste. Come se nulla fosse è stato chiesto a voce stridula di
ignorare la Costituzione costringendo i 3 deputati a restituire il maltolto (
che in realtà non è tale, almeno a termini di legge) con norma retroattiva. Si è
invocata una impossibile costrizione alle dimissioni. Complice la campagna
referendaria sulla riforma costituzionale, i 5S non hanno esitato a sbandierare
l’efferato delitto come prova della turpitudine del Parlamento, svelando così il
carattere compiutamente antiparlamentare sia della riforma che del correlato
referendum. E’ indicativo che a questa furia, non solo popolare ma altrettanto
diffusa tra i politici e i giornalisti, nei confronti dei deputati e consiglieri
comunali o regionali non si sia accompagnato nessuna reazione scandalizzata a
proposito delle altre categorie. Le notizie fatte filtrare in maniera opaca e
poco accettabile dall’Inps parlavano di 5 deputati e di un noto conduttore
televisivo. Nessuno ne ha reclamato il nome. Nessuno se l’è presa, pur sapendo
che in linea di massima gli emolumenti dei “noti conduttori” vanno ben oltre
quelli dei parlamentari, per non parlare dei consiglieri comunali. E’ noto da
mesi, pur se mai ufficialmente quantificato, che nelle categorie professionali
la percentuale di quanti che hanno battuto cassa invocando un bonus del quale
non avevano bisogno va ben oltre quella, in realtà molto esigua riscontrata fra
i parlamentari. In fondo a chiedere quei 600 euro sono stati in 5 su mille, pari
appunto allo 0,5%, percentuale che scende, considerando quelli che il bonus lo
hanno effettivamente incassato, allo 0,3%. Corre voce che tra i notai ad
avanzare la quella richiesta siano stati in centinaia. Tenendo conto del fatto
che i notai sono una professione a numero chiuso, sono in tutto 5.115, e che di
conseguenza si tratta anche di quella più lucrosa, il dato dovrebbe suscitare
quantomeno un qualche disappunto. E’ poi il segreto di Pulcinella che molte
aziende abbiano usufruito della cassa integrazione, ma senza ritenersi di
conseguenza obbligate a non far lavorare i dipendenti cassintegrati. Un bel
risparmio, lo si riconosca. La stessa giustificazione accampata dalla
viceministra Castelli per spiegare la totale assenza di condizioni nella
distribuzione del bonus, “Dovevamo fare presto”, non è stata confutata quasi da
nessuno ricordando alla viceministra che nel caso del reddito di emergenza non è
stata avvertita alcuna esigenza di fare presto e le condizioni sono state
pensate freddamente per impedire a molti degli aventi diritto di incassare quei
400 euro una tantum. Nessuno o quasi se l’è presa a male di fronte a quest’onda
gigantesca sulla cresta della quale figurano come trascurabile schiuma quei
cinque deputati. Nessuno ha reclamato chiarimenti, invocato punizioni esemplari,
puntato l’indice. E’ il frutto di un decennio e oltre nel quale i politici sono
stati descritti come una combriccola di inutili mangiapane a tradimento, ceto
parassitario nella migliore delle ipotesi, corrotto e venefico nella peggiore.
Se un notaio chiede e ottiene il bonus, la cosa appare certamente disdicevole ma
si ferma lì. Se a fare la stessa cosa è un politico la colpa si somma a quella
di essere, appunto, un politico. Diventa la goccia che fa traboccare il vaso, il
particolare lercio che getta una luce acquitrinosa su tutto il resto,
l’occasione per cogliere una a lungo attesa vendetta. Difficile immaginare una
temperie politica più infida e pericolosa.
Clima da monetine. Bonus ai
deputati, tutti si inchinano al moralismo di Travaglio e dei suoi ragazzi. Piero
Sansonetti su Il Riformista il 12 Agosto 2020. Sta tornando il clima del 1993.
L’anno delle monetine a Craxi, assediato dai militanti del Pds e del Msi; l’anno
del popolo dei fax che faceva e disfaceva le leggi, e dei neofascisti che
circondavano il parlamento gridando “arrendetevi”, e dei leghisti che in aula
a Montecitorio facevano dondolare un cappio, ridenti, contenti, furenti. Sta
tornando quel clima lì. La parola d’ordine è: “Prendete il Palazzo”. C’è anche
il referendum alle porte. Diventerà un plebiscito. Cosa vogliono quelli del sì
al referendum? Vogliono ridimensionare il parlamento e indicare il
parlamentarismo come il male oscuro della nazione. Da battere, spazzare via. C’è
qualcosa di meglio, per sostenere questa campagna, della scoperta che tre
deputati e un po’ di consiglieri regionali hanno chiesto e ottenuto i seicento
euro di sostegno previsti per i lavoratori poveri a partita Iva? A lanciare la
campagna è stata l’Inps. Guidata da questo Pasquale Tridico, credo che sia un
uomo legato ai 5 stelle e che ai 5 stelle, probabilmente, ha voluto fare un
piacere. Loro lo hanno accolto con entusiasmo il regalo. Anche se tra i felloni
c’è uno di loro. Che problema è? Lo espellono e via. Voi conoscete la linea
politica dei 5 Stelle? La linea è l’antipolitica, cioè la guerra alla democrazia
parlamentare. Il loro capo, che poi è ancora Grillo, questo ha in testa e non
molto di più. Su questo punta tutto. Ed ecco l’Inps che viola la riservatezza e
il suo ruolo istituzionale e si getta in politica a menar cazzotti e raduna
subito un bel gruppetto di picchiatori: da Di Maio a Travaglio, che promuove una
raccolta di firme sul Fatto: “Fuori i nomi”. 20 mila firme in dieci minuti.
Sembrano quei film americani quando la gente del linciaggio circonda la casetta
dello sceriffo e vuole che gli consegni i negri per scannarli. Viene la pelle
d’oca a vedere queste scene, siamo nell’Italia di Manzoni, di Gramsci e De
Gasperi, di Moro e Craxi, di Sciascia e di Calvino e di Enzo Tortora, e siamo
nel 2020. Ma vincono loro, i ragazzi di Travaglio. Tutti si inchinano al loro
moralismo e alla nuova inquisizione. Pure i leghisti, che ci stanno dentro fino
al collo. Ma non reagiscono, hanno paura. Tutti hanno paura,
da Zaia a Zingaretti. I leader dei partiti tacciono o vanno appresso a Di Maio e
Travaglio. È peggio del ’93.
P.S. Ho visto che molti dei politici che hanno preso
il bonus hanno dichiarato di aver dato tutto ai poveri. Probabilmente ai
migranti. Vedrai, vedrai che anche stavolta è colpa loro…
Scalpita il Tribunale etico supremo.
Bonusopoli, l’ennesima legge fatta male da chi ora chiede
punizioni impossibili. Alberto Cisterna su Il Riformista l'11 Agosto 2020.
l bonus Iva percepito da parlamentari, amministratori e quant’altro a pelle è
una schifezza. Non si tratta di essere populisti, né demagoghi. Con migliaia e
migliaia di partite Iva nei guai per colpa della pandemia, che il denaro
pubblico finisca nelle tasche di chi non ne ha alcuna necessità fa risuonare
ancora una volta i rintocchi delle campane a morto per la casta. Una casta che,
in questi mesi, aveva tentato invero di rialzare il capo accreditando l’idea di
saper governare in qualche modo il Paese, sia pure con miliardi e miliardi di
elargizioni a pioggia distribuiti a destra e a manca. Con un’operazione, del
tutto consapevole a prima vista, che puntava a sostituire la demagogia
dell’antipolitica con un populismo economico di stampo peronista e
vocazionalmente bancarottiere. Ci sono settori ormai ampi dell’establishment che
non vedono di buon occhio questo tentativo corposo di riconquistare una
centralità della politica. Tacciata un giorno sì e l’altro pure di incompetenza
e incapacità, la “razza padrona” della classe dirigente italiana ha visto, dopo
anni di stenti e austerità finanziarie, dispiegarsi innanzi ai propri occhi
un’occasione straordinaria e irripetibile, quella di dispensare denari a pioggia
a chiunque e in qualunque direzione senza dover tener conto di vincoli e
reprimende eurocomunitarie. L’epidemia sanitaria ha inoculato nel corpo
malaticcio e malfermo della politica italiana l’illusione di poter riconquistare
consenso e prestigio mettendo a libro paga un’intera nazione in tutte le sue più
minute articolazioni. Ciò posto non è un caso che, in queste ore, a lanciare
fuoco e fiamme contro i furbetti del bonus siano proprio coloro i quali questa
perfida e pericolosa onda dell’attacco al palazzo d’inverno del potere politico
in Italia l’hanno inventata anni or sono, traendone benefici enormi, e non solo
in termini di mera notorietà. C’è chi proprio non tollera che la politica abbia
un consenso. La precarietà del governare è divenuta il modo d’essere del potere
politico nazionale e da questa condizione di subalternità c’è chi trae vantaggi
enormi a spese della collettività. Comprendere lo scenario complessivo entro cui
anche questa polemica agostana si dipana e arroventa non impedisce che possa
causare fastidio il fatto che – da ogni parte – anziché fare ammenda per
l’ennesima legge mal scritta e mal gestita, si voglia supplire alla piena
legittimità delle elargizioni del bonus a qualche “immeritevole” con reprimende
morali, stucchevoli quanto insopportabili. È il destino triste e oscuro cui il
Paese si è consegnato da un paio di decenni: non conta che le norme siano
rispettate e che le regole non siano state infrante. Perché esiste una superiore
legge morale, amministrata da solerti Savonarola, in base alla quale si
stabilisce, di volta in volta ossia per capita, che ciò che pur è del tutto
legale deve essere o può essere giudicato come immorale se scrutato sotto i
riflettori di una più alta etica pubblica. Spiace citare per l’ennesima volta il
compianto professor Sgubbi (Diritto penale totale Punire senza legge, senza
verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019), ma anche questa volta la sua
analisi coglie nel segno: punire senza legge, ecco la spaventosa involuzione del
principio di legalità e di libertà che il nostro Paese conosce da troppo tempo e
cui tributa un prezzo enorme. È un’involuzione tragica che, ad esempio, dissuade
chiunque dall’investire in Italia, che rende le indagini penali un torneo
dall’esito imprevedibile, che attanaglia le libertà fondamentali, quelle
economiche in primo luogo. Se il principio cardine delle democrazie liberali è
quello per cui tutto ciò che non è vietato deve intendersi come consentito,
il Tribunale supremo etico – che ha afferrato per la gola un popolo e che
vorrebbe soggiogarlo – si pone sopra e oltre la legge e la Costituzione e si
arroga il diritto di poter affermare, a propria discrezione, che ciò che è
legale può essere immorale. Poco importa che un legislatore distratto e inetto,
o anche solo liberale, abbia concesso varchi e aperto così la via anche a
qualche mascalzone, tanto “superior stabat lupus” e, squadernando i codicilli di
questa morale immanente e mai codificata, i sacerdoti dell’etica pubblica
troveranno quale peccato sia stato commesso e quale infrazione debba essere
portata al pubblico ludibrio. In queste ore è un coro unanime: fuori i nomi dei
profittatori. Certo, perché senza i nomi la gogna morale non è perfetta, senza i
nomi tutto si ridurrebbe a dover ammettere che la legge è stata scritta in modo
imperfetto e che tutto, alla fine, è legittimo, ossia ciò che davvero dovrebbe
contare in una democrazia delle regole. In questi decenni il Tribunale supremo
etico e le sue inflessibili vestali hanno sedato ogni horror vacui e colmato
ogni interstizio a danno delle libertà individuali, minacciandole costantemente
con reprimende morali distruttive e irreversibili. Un Paese così viene preso in
ostaggio e tanto più il denaro pubblico scorre a fiumi verso i sudditi
bisognosi, tanto più si accresce la possibilità di stigmatizzare questo o quel
percettore, ieri per il reddito di cittadinanza, oggi per il bonus Iva, domani
casomai per l’ecoincentivo di migliaia di euro che spetta anche per acquistare
auto da nababbi. Si confeziona la regola giuridica e, poi, si copre ogni fuga e
ogni crepa con la malta cementizia della morale, casomai la legge non fosse
precisa, il Tribunale supremo è lì pronto a intervenire. «Punire senza legge» è
la più temibile deviazione che Filippo Sgubbi addebitava alla giustizia penale
italiana dell’ultimo decennio, perché la vedeva protesa in modo preoccupante a
elaborare giudizi morali e, poi, a cercare nelle pieghe del sistema il precetto
da applicare. Ma quel sistema penale, così facendo, non si è ridotto ad altro
che a funzionare come il braccio operativo – aggressivo e temuto – di una più
grave e radicale deviazione dai valori liberali che tengono insieme una
democrazia matura. L’assalto al principio di legalità e di libertà è la più
pericolosa eversione democratica che sia in atto da tempo nel Paese e troppo
pochi sono coloro i quali tentano di costruire argini e approntare aree con cui
contenere e dare sfogo alla piena moralista.
Bonusopoli, assist dell’Inps a Di Maio: politici alla gogna
per 20 euro a seduta. Giulio Seminara su Il Riformista
l'11 Agosto 2020. La caccia ai “furbetti del bonus”, le accuse indiscriminate
dell’Inps, Luigi Di Maio contro il diritto alla privacy, la folla inferocita e
l’ennesimo enorme e confuso processo sommario alla “casta politica”: alla
vigilia del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari ecco il nostro
incubo populista di una notte di mezza estate. Andata in ferie la politica,
puntualissimo il giallo da sdraio. Ancora ignari di come verranno spesi i 209
miliardi del Recovery Fund, ci siamo lanciati alla ricerca dei cinque -nel
frattempo diventati tre- parlamentari italiani che durante il lockdown hanno
richiesto e poi ottenuto i bonus di 600 euro mensili garantiti dal decreto Cura
Italia ai lavoratori autonomi e alle partite Iva colpite dalla crisi sanitaria.
Non ci sarebbe molto da aggiungere: se alcuni rappresentanti delle istituzioni,
pagati circa 12000 euro al mese, sfruttano un bonus del governo pensato per i
disgraziati che hanno perso clienti, botteghe e stipendio a causa
del Coronavirus, non commettono necessariamente un illecito ma una sgradevole
furbata e un atto politicamente balordo. Se confermata la liceità della
sgradevole iniziativa, questi parlamentari sarebbero semplicemente da non
ricandidare, certamente non da rinchiudere in carcere. Ma lo scandalo, lanciato
da Repubblica e basato sull’inchiesta della direzione centrale Antifrode,
Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps, l’organo anti-truffe creato da Pasquale
Tridico, sta provocando un autentico tsunami di populismo e antipolitica. Anche
perché l’Inps, con il suo documento-inchiesta ha creato un immenso e caotico
calderone di “furbetti del bonus”, avendo inserito non solo i cinque -diventati
tre- parlamentari fantasma ma circa 2000 politici nostrani, tutti “colpevoli” di
aver richiesto il bonus di 600 euro garantito dal decreto Cura Italia. Ci sono,
non citati, governatori di regione, sindaci, assessori locali, consiglieri
regionali e comunali. Così in un Paese che non è diventato migliore a causa
del Covid, semmai più povero e frustrato, è sorta subito “Bonusopoli”, una
specie di Tangentopoli senza neanche magistrati e l’ombra di un reato, ma con
simili furie e giustizialismi anti-casta. Sui social mancano solo i forconi, e
se la frustrazione contro la furbizia di un deputato, rappresentante del popolo
ben pagato, è almeno comprensibile, la crociata contro i consiglieri e assessori
comunali appare quantomeno fuori fuoco. Come si fa a stigmatizzare la richiesta
del bonus da parte di amministratori locali, possibilmente di piccoli comuni,
che a seduta prendono 20 euro lordi di diaria? E siamo certi che i consiglieri
delle grandi città siano davvero resi ricchi dalla politica o comunque siano
avulsi da bisogni o problemi economici? Intanto è partita la caccia ai politici.
Logorata da questa strana inquisizione estiva, la consigliera comunale di
Milano Anita Pirovano è uscita allo scoperto, facendo coming out: «Sarei
coinvolta nello scandalo dei furbetti del bonus e mi autodenuncio. Non vivo di
politica perché non voglio e non potrei». La donna, laureata in Psicologia,
svolge “lavori e consulenze per scuole e università”. Su Facebook ha spiegato di
avere “un reddito annuo dignitoso e nulla di più” e un “mutuo”. La consigliera
ha chiarito che “l’impegno a Palazzo Marino” non le garantisce né “un’indennità
né i contributi Inps”. È probabilmente la verità ma i commenti in rete sono
stati spietati, nell’apoteosi di un populismo feroce che non guarda in faccia
nessuno e non sa distinguere tra parlamentari e consiglieri locali, persone
benestanti e persone normali, se non addirittura economicamente precarie. Un
altro aspetto controverso è stato l’equivoco tra i dati dell’Inps, spiattellati
dai giornali, e le informazioni in possesso tra i partiti. Così Ettore Rosato,
coordinatore nazionale di Italia Viva, è stato costretto a chiamare il direttore
dell’Inps Pasquale Tridico per farsi “rassicurare” sul fatto che tra i
parlamentari furbetti non ci sono esponenti renziani, dopo un giorno e mezzo di
tam-tam e condanne a mezzo social sul “parlamentare renziano ladro e infame”.
D’altronde l’ “Indovina chi” sui “furbetti del bonus” ha sì eccitato il
dibattito pubblico e scosso i partiti, ma è avvinto da un alone di mistero
alla Agatha Christie. E l’Inps, vincolata al rispetto della privacy ma donatrice
di scoop ai giornali e di processi alla piazza, avrebbe svolto un “servizio
pubblico barbaro”, secondo lo stesso Rosato. Intanto prosegue la sarabanda
dell’indignazione dei leader, con Nicola Zingaretti che urla “vergogna”, Giorgia
Meloni che invita i parlamentari a definirsi estranei allo scandalo su twitter
(come se poi i colpevoli non potessero twittare falsità) e Luigi Di Maio che
invoca “dimissioni immediate” e “iniziative parlamentari” per scoprire
l’identità dei parlamentari furbetti, contestando di fatto il diritto alla
privacy. L’ex capo politico del Movimento 5 stelle non ha rinunciato a fare da
gran cassa alla rabbia d’agosto, attaccando su Facebook i “2000 politici che
hanno richiesto il bonus”. Per lui sono già tutti colpevoli. Anche se il reato
non esiste e tra loro ci saranno sicuramente molti amministratori locali che
fanno politica per passione, rimettendoci solo tempo e soldi. Per Di Maio i loro
nomi devono essere “resi pubblici”. Una specie di messa alla gogna. Secondo i
rumors, i tre ignoti “parlamentari furbetti del bonus” sarebbero due leghisti e
un pentastellato. Nella Lega serpeggia l’imbarazzo per questi due esponenti
ancora misteriosi ma già incandescenti. Pare che qualcuno avrebbe parlato di
“disguido con il commercialista”, intanto Salvini tuona “sospensione immediata”.
Ma in realtà con “Bonusopoli” sotto accusa è tutta la classe politica, dal
parlamentare al consigliere comunale. Un pessimo momento prima del referendum
confermativo sul taglio dei parlamentari di settembre. Ormai una triste
formalità.
Bonus a deputati e politici, nessun reato ma solo una legge
scritta con i piedi. Piero Sansonetti su Il Riformista
l'11 Agosto 2020. S’è aperta la caccia. E s’è aperta la gara a chi riesce a
pronunciare la frase più indignata. Partecipano più o meno tutti. Sia i partiti
accusati di essere coinvolti sia quelli che pare siano fuori. Lo scandalo sono
quei 600 euro di bonus per le partite Iva in difficoltà che secondo
l‘Inps sarebbero stati percepiti da cinque parlamentari e da un conduttore
televisivo. Impossibile conoscere i nomi, però si conoscono i partiti di
appartenenza. Nessun reo confesso, per ora, anche perché il clima è quello del
linciaggio. Meloni, Salvini e Di Maio più di tutti, ma gli altri a ruota. Nessun
leader di partito ha invitato alla calma e ad aspettare almeno di sapere meglio
cosa sia successo. Le indiscrezioni dicono che i cinque deputati sarebbero tre
della Lega, un 5 Stelle e un renziano. Però ieri sera si è sparsa la voce che i
5 reprobi in realtà siano 3 e che non ci sia nessun renziano. Dopodiché siccome
l’Inps ha spiegato che ci sono poi altri 2000 politici tra governatori,
assessori e consiglieri comunali, l’orgia dei moralisti si è allargata ancor di
più. Tra urla di dolore e richieste di fucilazione. Nessuno ha fatto notare che
c’è una bella differenza tra un deputato, che ha uno stipendio di 12/13 mila
euro al mese, e un consigliere comunale di un piccolo paese, che probabilmente
alla fine del mese porta a casa un centinaio di euro e magari del sussidio ha
bisogno davvero, molto più di un professionista romano o milanese. Il clima però
è quello: addosso, addosso. E se qualcuno fa notare che non c’è nessun reato, e
che la norma era fatta così (coi piedi, probabilmente) peggio ancora. Ti
spiegano che non è il reato che conta ma la moralità. E invocano il tribunale
dell’etica, dei giusti, dei savonarola, di Dio. Qualcuno ha il coraggio di
opporsi e di chiedere un po’ di ragionevolezza? Improbabile. Anche perché si è
aperta la campagna elettorale per il referendum contro il Parlamento.
Perché i politici del bonus di 600 euro devono indignare di
più degli altri che non ne avevano bisogno. Notizie.it
il 10/08/2020. I deputati che hanno ricevuto il bonus durante il lockdown
indignano di più rispetto agli altri perché a un politico è giusto chiedere
qualcosa in più. Passata la buriana dell’indignazione popolare, quella che per
una domenica intera ci ha tenuto appesi allo scandalo dei cinque deputati col
bonus da 600 euro, devono essersi detti, i professionisti del “ma anche”, che
occorreva intervenire per riportare al centro una bilancia sbilanciata solo sul
piatto della politica. E dunque la nuova mise en place del lunedì, dopo la
domenica delle vesti stracciate, ha una nuova narrazione: accanirsi contro i
cinque deputati non va del tutto bene.
L’indignazione contro i deputati del bonus. Intendiamoci: un po’
sì. Ma con juicio, come diceva quello, ché alla fine così fan tutti. Pretenderne
i nomi pare che sia diventato ormai un oltraggio giacobino a un certo
liberalismo che usa la privacy alla bisogna, solo quando, in genere, è pro domo
sua. C’è perfino chi tira in ballo la quisquilia della cifra, 600 euro appunto,
che certo devono apparire come poca cosa a un Paese che manda giù sprechi e
incompiute da Guinness World Record. E così il piatto sbilanciato sulla
responsabilità della politica – forse sarebbe meglio dire dei politici –
riportato al centro da questa sofisticata operazione di rilettura, viene quasi a
un tratto a tornare a inclinarsi e questa volta verso quegli (im)prenditori – e
perfino un conduttore televisivo pare – che hanno osato anche loro l’oltraggio
del bonus garantito per legge. Si dice: e allora di questi cosa dovremmo fare,
visto che sono – pare – migliaia, dunque ben più dei cinque ascari
dell’emiciclo? Fuori i nomi anche di questi affamatori del popolo, dato che
sempre di denari pubblici si tratta. Qui dunque la condanna, che per i cinque
deputati era degrado giacobino, diventa in un batter di ciglia consentita per
tutti i furboni che alla tetta dell’Inps hanno succhiato, sebbene in modo del
tutto legittimo. Loro sì che fanno schifo, sarebbe l’assunto. E allora la
domanda è: i soldi pubblici per l’emergenza Covid sono per tutti uguali? E
ancora: il sussidio pubblico può valere, in un momento come questo, allo stesso
modo per chi la cosa pubblica l’amministra in nome del popolo – da cui peraltro
riceve il consenso e, in senso più lato, anche una più che dignitosa
remunerazione – rispetto a chi ne ha fatto legittima richiesta, ma non ha su di
sé la responsabilità dell’investitura popolare?
Ai politici è giusto chiedere qualcosa in più. Io credo che al
dibattito impazzito di questi giorni sia mancato un distinguo necessario. Spostando
il baricentro dalla politica alla “società civile”, che ha ugualmente
approfittato di una legge dalle maglie troppo larghe, si perde di vista un punto
cruciale. Ovvero che gli eletti hanno un dovere morale in più rispetto agli
altri. La politica, ovvero la forma più alta di “carità”, per citare Paolo VI,
non deve forse più di altri porsi il problema della giustizia, intesa in senso
largo? Non tutto ciò che è legale è giusto. Si tratta di soldi pubblici sia per
gli imprenditori che hanno beneficiato del bonus, sia per i politici. E questo è
vero. Aggiungo anche che del denaro pubblico occorre avere rispetto sempre, a
prescindere dalle cariche e dai ruoli. Tuttavia a un politico è giusto chiedere
qualcosa in più, non fosse altro che per quella forma altissima che è
l’esercizio della rappresentanza delegata. Se ti delego a scegliere per mio
conto tu – a tua volta – non puoi non avvertirne la responsabilità. Ecco
perché i cinque deputati del bonus indignano di più rispetto a chi, non eletto e
dunque sgravato dal dovere della rappresentanza, abbia ottenuto ugualmente i 600
euro, che pure paghiamo tutti noi. Il principio di responsabilità individuale è
ancora un esercizio ostile, pare, in questo Paese. Dell’etica poi non dico
neanche.
Bonus Iva, l’Inps grillina al servizio degli anticasta: ma in
229 votarono per quella legge. Deborah Bergamini su Il
Riformista il 12 Agosto 2020. E così anche l’Inps è diventata populista.
Inesorabile, il destino che accomuna tutta l’Italia verso una strada lastricata
di stupidità, conduce gli enti statali verso ciò che è già toccato alla
politica, e che l’ha distrutta. Oggi l’Inps, domani, chessò, l’Agenzia delle
Entrate o la Consob un’Autority saranno autorizzate ad abbandonare la terzietà
cui sono tenuti e diventare strumento di chi governa, in questo caso del partito
anti-casta, il 5 Stelle, che sul tam-tam dell’odio sociale ha costruito la
propria fortuna senza fare altrettanto per l’Italia. Non si potrà mai dire
abbastanza quanto i deputati che hanno chiesto i 600 euro post-CoVid siano stati
indecenti (sono tre, forse cinque, non trenta, non trecento, lo 0,4 per cento
del contingente parlamentare), ma va anche ricordato che lo hanno fatto sulla
base di una legge votata dai 229 deputati che nei giorni
del lockdown rappresentavano la maggioranza parlamentare a trazione 5 Stelle
e Pd, e che forse non si sono resi conto di cosa stavano votando. Anche per loro
allora dovrebbe valere il principio della sospensione o delle dimissioni. E
certamente non è stato detto abbastanza quanto sia stato grave il comportamento
dell’Inps e del suo presidente Tridico, non nuovo a campagne populiste e di
sicuro non ostile a Di Maio. Quel lancio il sasso e ritiro la mano, quelle
informazioni disponibili da maggio e vincolate da privacy ma tirate fuori a un
mese dal compimento del referendum che deve decidere se si devono tagliare i
parlamentari o no, ci dicono molto della fine che sta facendo la macchina dello
Stato. Ricapitoliamo rapidamente: Conte in fase Covid il 17 marzo vara un
decreto che prevede il famoso bonus da 600 euro per le partite Iva. Per fretta,
non si fanno differenziazioni fra i beneficiari. Ne avranno diritto tutti, anche
i redditi alti. È un errore, ma tant’è. Con il Parlamento dimezzato, in quel
periodo, e con i tempi strettissimi, sul decreto viene posta la fiducia. Decreto
approvato, presenti al voto alla Camera 354 (su 630), favorevoli 229, contrari
123. E così chiunque può fare richiesta per quei soldi, anche i parlamentari,
che non hanno quindi compiuto alcun reato, dato che la scarsità di intelligenza
non è ancora perseguibile. Ma chi salta col sangue agli occhi sulla ennesima
vergogna della casta? Il capo del partito di maggioranza al governo, cioè quello
che ha fatto la legge (così come ha fatto il reddito di cittadinanza finito a
mafiosi e criminali vari), Luigi Di Maio. E sulla base di cosa? Di informazioni
coperte da privacy che gli vengono fornite dal capo dell’ente previdenziale di
Stato, nominato col benestare dei 5 Stelle. Il quale di fatto a questo punto ha
in mano, conoscendone l’identità, i destini dei tre o cinque eletti dal popolo
percettori di bonus, i quali, non dichiarandosi (e ne hanno il diritto)
consentono che il discredito colpisca indiscriminatamente tutta la “categoria”.
Ma è una cosa normale? Ed è normale che dobbiamo credere che solo Tridico
conosca questi nomi? E se qualcuno un giorno, con la scusa della privacy,
dicesse che tra i percettori di questo bonus ci sono anche una decina di
grillini? Suggerimento per Conte: meglio concludere al più presto questa
pantomima e convocare un Consiglio dei ministri per modificare con decreto la
legge incriminata. Basta un attimo e i nomi escono legalmente: i titolari di
cariche elettive per questioni attinenti a retribuzioni, emolumenti,
corrispettivi pubblici di ogni ordine e grado non possono beneficiare della
legge sulla privacy. Una riga e tutto si sistema. Conte ne fa tanti di dpcm e
di Consigli dei ministri, può farne uno sulla trasparenza cui lui e i 5 Stelle
che lo hanno espresso tanto inneggiano. Oppure può farsi dare i nomi dall’Inps
tramite il Ministero del Lavoro (vigilante e controllante) e diffonderli
assumendosene la responsabilità. Non può consentire, invece, che si continui a
giocare sul filo del non detto lasciando sulla graticola il Parlamento a un mese
da un referendum fondamentale per il futuro della democrazia. Altrimenti questo
sarà solo il primo episodio di una lunga serie in cui l’organo rappresentativo
del popolo italiano si ritroverà in mano a enti dello Stato che potranno
disporne secondo necessità del momento o interessi di chi in quel momento
governa. E cioè da controllore di chi governa si troverà invece controllato da
chi governa.
Bonus Covid, la Lega chiede a tutti i parlamentari di non
parlare con i giornalisti. Il Corriere del Giorno l'11
Agosto 2020. I deputati sono delle figure pubbliche e quelli in questione hanno
chiesto di beneficiare di un contributo pubblico. La richiesta del bonus Covid,
da parte di un parlamentare, non svela alcun dato sensibile. Quindi la loro
condotta non è protetta dalle norme sulla privacy I due leghisti fortemente
sospettati sono Dara e Murelli alla Camera per la prima volta nel 2018. «Se
hanno preso soldi vanno sospesi». Ed ancora una volta Zaia è lontano da Salvini…
Tramontate le speranze di «confessione spontanea», cioè di autodenuncia da parte
degli interessati, nella Lega si mastica amaro: due dei tre parlamentari che
hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid sono leghisti Andrea Dara ed Elena
Murello , il terzo è un deputato del M5S . Il contributo è stato richiesto anche
un altro leghista e un renziano, ma non l’hanno ottenuto. L’on. Andrea Dara, 45
anni, mantovano, è un imprenditore che produce calze a Castiglione delle
Stiviere, mentre l’ On. Elena Murello, 45 anni, di Piacenza è una consulente in
finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione. “Lasciate che chiamino…
non rispondete al telefono”. è l’invito rivolto a tutti i parlamentari leghisti,
cioè di abbassare le saracinesche e non parlare con i giornalisti. Riccardo
Molinari, il capogruppo alla Camera, ribadisce che “se qualcuno ha preso un
bonus verrà sospeso, anche se quei soldi sono stati dati in beneficenza“. Il
riferimento e molto chiaro alla posizione personale di Ubaldo Bocci, consigliere
comunale leghista di Firenze che ha appunto dichiarato di aver ricevuto il bonus
Covid , ma di aver devoluto la somma in opere buone. Il caso dei consiglieri
comunali è assolutamente diverso e molto lontano da quello dei parlamentari
anche per la differenza sostanziale tra le retribuzioni. Ma è sempre Molinari il
capogruppo leghista alla Camera a non darsi pace per quel sospetto emerso non
appena il caso era deflagrato. Infatti nella Lega i nomi dei percettori di bonus
con stipendio da oltre 12 mila euro al mese, circolano eccome. Esiste il forte
sospetto che la vicenda dei 600 euro per i parlamentari che ogni mese ne
guadagnano 20 volte tanto in realtà altro non sia una strategia di distrazione
di massa: “non vorrei che fosse un modo per insabbiare e far dimenticare le
responsabilità di Conte per la mancata chiusura di Nembro e Alzano lombardo
nonostante il parere del Comitato tecnico scientifico“. I parlamentari
della Lega, nel frattempo, si preparano a una serrata campagna per dimostrare
che il presidente del Consiglio, “abbia mentito” sulla gestione governativa
dell’emergenza Covid.
Il Governatore uscente del Veneto Luca Zaia, con molto rigore
chiede invece ai candidati al consiglio regionale di firmare, prima che le liste
siano depositate la settimana prossima, una dichiarazione sul “non aver ricevuto
contributi pubblici”. Anche perché realmente non esiste una questione di
privacy. I deputati che hanno chiesto il bonus Covid non possono farsi scudo
delle norme a protezione della riservatezza. In altre parole, non possono
invocare la privacy per chiedere che il loro nome resti segreto.
L’ Autorità Garante della Privacy i cui nuovi componenti si sono
insediati il 28 luglio 2020 – a soli tre giorni di distanza dalla diffusione
della notizia dei parlamentari “furbetti” ha finalmente adottato una posizione
ufficiale sulla questione. “La privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati
relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non
possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale
dell’interessato”, dice il Garante della privacy. “Ciò vale, a maggior ragione
rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le
aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più
incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti”
prosegue il Garante in una nota. Il Garante contestualmente ha reso
noto che “sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita
dall’Inps rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al
riguardo diffuse”. I deputati sono delle figure pubbliche e quelli in questione
hanno chiesto di beneficiare di un contributo pubblico. La richiesta del bonus
Covid, da parte di un parlamentare, non svela alcun dato sensibile. Quindi la
loro condotta non è protetta dalle norme sulla privacy. Prevale, in questo caso,
il diritto dell’opinione pubblica e dei giornali a conoscere che cosa è
successo. Prevale la trasparenza sulla riservatezza. La stessa valutazione può
essere applicata anche per gli amministratori locali, che pure sono figure
pubbliche. Solo che ci si potrebbe trovare dinnanzi ad una sostanziale
differenza. Un amministratore locale non riceve il robusto stipendio dei
deputati, e quindi potrebbe versare in condizioni di difficoltà economica.
Chiedere il bonus Covid, il tal caso caso, può essere non solo comprensibile, ma
persino giustificato. Sarebbe improprio pubblicare il nome di un consigliere
comunale equiparando la sua posizione a quella del parlamentare. Ma il silenzio
dell’Inps, in questa situazione non è solo equivoco…ma persino imbarazzante,
L’Istituto per la previdenza non ha il diritto di negare i nomi dei deputati
beneficiari del bonus . Il Codice della Trasparenza – cioè la legge 33 del 2013
– indica e stabilisce all’articolo 26 che “le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati”.
Quindi prevale su tutto l’obbligo di trasparenza sui vantaggi che
personalità pubbliche come sono appunti i deputati ricevono dalla Pubblica
Amministrazione (cioè l’Inps) . C’è anche un consigliere regionale
piemontese, Diego Sarno, esponente del Partito Democratico nello scandalo del
contributo da 600 euro ai politici. Ex assessore di Nichelino, è alla sua prima
consigliatura a Palazzo Lascaris, ed è social media manager della propria
agenzia di comunicazione. Anche nel suo caso guarda caso….a suo dire si sarebbe
trattato di un errore di superficialità: «Li ho dati tutti in beneficenza Covid
appena me ne sono accorto» ma non fornisce alcuna prova di quello che dice. Ed
aggiunge: «Sapendo adesso che posso restituirli all’Inps, farò anche lì il
bonifico di 1200 euro». Ma non li aveva dati in beneficenza? Sarno quando
capisce che sta rischiando grosso, e confessa: «Ciao a tutti sono qui
per raccontarvi della questione 600 euro Inps e di come sono andati i fatti per
quanto mi riguarda. Ho deciso di scrivere perché come sanno le persone che mi
conoscono, quando sbaglio sono il primo ad ammetterlo, come anche in questo
caso. Un errore però di sottovalutazione e non una volontà da “furbetto” a cui
ho cercato di rimediare subito, più avanti capirete il perché». scrive in un
lungo post su Facebook.
Poi, arriva la sua spiegazione poco credibile: “La mia compagna
fa questo di lavoro e da sempre gestisce la contabilità riguardante la mia
attività professionale. Durante il lockdown, per provare diverse procedure ha
usato la sua partita Iva e anche la mia (avendone due tipologie diverse) così da
essere pronta per assolvere senza errori e con una maggiore velocità le molte
procedure gestite per i clienti dello studio nel quale lavora. Quando è uscito
il bonus per gli autonomi, come sempre, ha usato la mia partita iva per provare
la procedura e nella contemporaneità di altre dei clienti ha concluso anche la
mia per errore“.
Bonus 600 euro, l'Inps non risponde.
A quattro mesi dall'avvio delle domande sono migliaia i cittadini
senza liquidazione che cercano di avere chiarimenti. Ma l'istituto tace e invita
ad avere pazienza. Ecco le loro storie. Sara Dellabella il 12 agosto 2020 su
L'Espresso. C'è chi ha avuto il bonus, chi lo ha ottenuto indebitamente e molti
che attendono ancora che l'Inps batta un colpo. Anche chi scrive in verità. Lo
scorso 22 luglio, abbiamo chiesto all'Ufficio presieduto da Pasquale Tridico
quante fossero le domande per il bonus da 600 euro, accolte, ma ancora non
liquidate. La risposta non è mai arrivata e ci è stato detto di inviare i codici
fiscali dei richiedenti (qualora ne avessimo) affinché l'istituto potesse
effettuare una verifica. Ovviamente non è il nostro mestiere questo, ma abbiamo
inviato una segnalazione specifica alla quale non è seguita alcuna risposta.
Così eccoci qui, nella stessa situazione che migliaia di cittadini denunciano da
mesi oramai: Inps non risponde e cerca di prendere tempo. Marta ha 33 anni ed è
un agente immobiliare. Il 2 aprile ha presentato l'istanza per il bonus partita
Iva da 600 euro e nonostante la sua domanda risulti accolta, e abbia ricevuto
una risposta scritta da “Inps risponde” che assicurava “alla prima elaborazione
centralizzata dei pagamenti sarà effettuato” ancora non ha visto un euro sul
conto. A rinfrancare un po' la situazione è arrivato il bonus dei mille, ma dei
600 euro di marzo e aprile ancora nessuna traccia. «Ho chiamato decine di volte
il call center, alcune volte mi hanno risposto di avere pazienza, altre di
cambiare la modalità di pagamento, insomma una perdita di tempo e uno stress
perché quei soldi per me giovane partita Iva servivano sul serio. Senza contare
che a un certo punto mi hanno detto che avevo l'indirizzo di residenza
sbagliato, peccato che nel frattempo proprio lì mi siano arrivate tasse e pin
dispositivo. Insomma quando l'Inps mi ha voluto trovare, c'è riuscito
benissimo». Come lei, tanti, strozzati dalla crisi, dal Covid e da una pubblica
amministrazione che al di là dei proclami si mostra reticente. Molti, senza una
risposta certa dall'Inps, hanno deciso di confrontarsi in un gruppo Facebook dal
titolo “ Inps Bonus in attesa di esito ” per scambiarsi suggerimenti. Lucio da
Padova racconta in un post del 30 luglio “L'11 giugno ho presentato la domanda
bonus 600 categoria intermittenti , ancora oggi in attesa di esito. Sono stato
anche all'Inps di persona circa due settimane orsono e mi avevano detto che nel
giro di una settimana sarebbe stata accolta e poi pagata in altri 9-10 giorni
(probabilmente è la risposta standard che danno per farti stare calmo). Ad oggi
però ripeto tutto fermo. Qualcuno sa niente su date o cosa hanno intenzione di
fare? Ah e aggiungo che io non ho visto un euro di niente, né di cassa
integrazione né di bonus né di nulla mentre è stato pagato il bonus a persone
che girano in BMW”. Come a voler confermare quello che è trapelato qualche
giorno fa dall'Ufficio stampa dell'Inps, che il bonus oltre che a 3 parlamentari
è andato anche a quelle categorie che probabilmente per soglie di reddito non ne
avrebbero avuto bisogno. Ma accanto alle storie degli abusi, ci sono quelle di
chi pur di sopravvivere in questi mesi ha chiesto aiuto ad amici e parenti,
ritrovandosi indebitati. Sono tutte storie legate da un comune
denominatore: l'impossibilità di avere una risposta certa dall'Inps. Chi ha la
domanda accolta, non fa che aprire forsennatamente l'app della banca, sperando
di trovare l'agognato accredito, chi non smette di chiamare il call center dove
però le risposte sono evasive e allora qualcuno segnala nei post gli indirizzi
mail dei funzionari Inps, invitando a rivolgersi direttamente a loro. A tutti
viene chiesto di avere pazienza, ma la pazienza ad un certo punto finisce. Mirko
è un lavoratore dello spettacolo. Ha 44 anni, vive a Reggio Emilia, di
professione dj. Lui ha ottenuto il bonus di marzo, ma poi basta. Ha atteso
perché la normativa e la tv ha detto che chi aveva già ricevuto il bonus avrebbe
avuto l'accredito automatico. "Ho aspettato, certo che quei 1200 euro sarebbero
arrivati, così non mi sono fatto problemi a chiedere dei piccoli prestiti. Ma i
giorni passavano e niente. Alla fine mi hanno detto che non avevo diritto
neppure a quello di marzo, ma ho dovuto lottare per avere una risposta. Solo che
io ho bisogno di quei soldi e nessuno si è degnato di avvertire". In questo caso
una dirigente dell'Inps territoriale mi ha consigliato di interrompere in
maniera retroattiva il contratto, cosa che per legge non si può fare. C'è
dell'omertà da parte degli uffici, non sai neppure a chi scrivere". Insomma,
dietro ai numeri del successo del bonus si nascondono tante storie di
inefficienza della pubblica amministrazione, soprattutto per quei cittadini che
avendo la domanda accolta non hanno ancora ricevuto l'accredito. Dopo la
figuraccia del sito Inps che il primo aprile è andato in tilt mostrando i dati
sensibili di decine di utenti, secondo il Presidente Tridico, ascoltato lo
scorso 20 aprile in commissione Lavoro alla Camera, l'operazione bonus è stato
un successo. «Sono state presentate 4,4 milioni di domande, di cui 3,5 milioni
andate in pagamento. - ha spiegato - Altre 900mila, al momento, sarebbero in
istruttoria, mentre quelle rifiutate sono 400mila: in quest'ultimo caso
mancavano i requisiti necessari». Peccato che a quattro mesi dall'avvio delle
domande ci sia chi ancora è in attesa della liquidazione di una domanda accolta,
chi in istruttoria e chi semplicemente di una risposta chiara da parte di Inps.
Intanto i debiti crescono e anche le difficoltà di chi non ha ancora ripreso a
lavorare.
Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera” il 12 agosto 2020.
«Che cosa? Un caso montato di proposito, un modo per lanciare il referendum sul
taglio dei parlamentari? Non solo non è vero. Ma chi lo dice, chi lo scrive, ne
dovrà rispondere in tribunale. Ne va della mia dignità». Chi in queste ore è
riuscito a parlare con il presidente dell'Inps Pasquale Tridico si è trovato
davanti una persona a dir poco furiosa. Arrivati al terzo giorno un po' di
polvere si è posata, e nel caso dei deputati col bonus prende sempre più quota
la seconda domanda. Non solo perché quei tre deputati, nel pieno rispetto della
legge, abbiano chiesto un bonus pensato per chi era in difficoltà. Ma anche
perché il caso sia esploso solo adesso, quando manca meno di un mese al
referendum sul taglio del numero dei parlamentari, che per di più farà da traino
al voto in sette Regioni. Tridico nega che si tratti di un'operazione politica.
«Chi dice queste cose dovrebbe anche dimostrarlo, invece di sparare accuse nel
vuoto». Nega, soprattutto, che dietro ci sia la sua mano, e minaccia querele.
Assicura che se il Parlamento lo chiamerà a riferire, cosa più che probabile,
«darò lì tutte le spiegazioni». Eppure nel palazzo, a destra come a sinistra,
sono in tanti a chiedere le sue dimissioni. Che il presidente dell'Inps sia
organico al Movimento 5 Stelle nessuno lo può negare. Calabrese, 45 anni tra un
mese, professore di Politica economica all'università di Roma Tre, Tridico era
stato indicato come ministro del Lavoro nella squadra di governo che Luigi Di
Maio aveva presentato prima delle elezioni di due anni fa. La stessa in cui
Giuseppe Conte doveva essere solo ministro della Pubblica amministrazione, per
capirsi. Poi le cose sono andate come sono andate. E lui è stato in qualche modo
«risarcito» con la presidenza dell'Inps, forse la macchina più potente di tutta
la pubblica amministrazione italiana. «Ma un conto è la politica, un conto sono
le istituzioni», dice lui a chi ci ha parlato. Le zone d'ombra, tuttavia,
restano. L'inchiesta interna per capire come il caso sia uscito, pur in assenza
di irregolarità, va avanti. La freddezza con il direttore generale Gabriella Di
Michele cresce. Tutti vogliono capire come mai il responsabile dell'unità
antifrode dell'Inps, Antonello Crudo, lo abbia informato a maggio dei duemila
politici che avevano chiesto il bonus, in base a una serie di controlli mirati
vista la loro diversa posizione previdenziale. Ma, anche se la conclusione
dell'Antifrode era che la frode non ci fosse, quell'elenco è rimasto in qualche
cassetto e poco più di due mesi dopo ha fatto esplodere il caso. Tridico
continua a negare, a minacciare querele. Resta il fatto che negli ultimi mesi i
rapporti fra lui e il Movimento 5 Stelle si erano raffreddati. Parecchio. La
gestione delle pratiche della cassa integrazione aveva fatto perdere la pazienza
al premier Giuseppe Conte e all'ex capo politico del Movimento Luigi Di Maio. I
numeri erano oggettivamente insostenibili per una macchina tarata per il tempo
di pace, non per l'economia di guerra dell'era Covid. Ma quando il governo ha
cominciato a studiare la riforma degli ammortizzatori sociali, una delle ipotesi
sul tavolo è stata quella di creare una nuova agenzia per la cassa integrazione.
Togliendo a Tridico, in prospettiva, una brutta gatta da pelare, ma anche una
bella fetta di potere. C'era un rapporto politico da recuperare? Lui continua a
negare. E ricorda che il suo motto è «forte con i forti, generoso con i deboli».
Ma forse un pezzo della spiegazione di come sono andate le cose potrebbe essere
proprio qui.
L’assalto al parlamento è guidato dall’Inps: i politici non
hanno diritto all’anonimato fiscale, nemmeno quelli che guadagnano poco.
Giulio Seminara su Il Riformista il 12 Agosto 2020. Un colpo
al cerchio e un colpo alla botte. A quattro giorni dall’esplosione
di “Bonusopoli” e di caccia feroce agli “onorevoli furbetti”, il Garante per la
Privacy è sceso in campo, fornendo un assist alla furia populista del M5s e un
altro a Matteo Renzi, critico sui metodi tenuti dall’Inps diretta da Pasquale
Tridico. Ieri l’Autorità, la cui governance è stata rinnovata lo scorso 28
luglio, ha fatto cadere l’alibi della privacy: i parlamentari che hanno
usufruito del bonus di minimo 600 euro garantito dal decreto Cura Italia negli
scorsi mesi non hanno diritto all’anonimato. Il Garante ha dichiarato che «la
privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del
contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in
particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato».
Tradotto: gli onorevoli, poiché non poveri, non hanno diritto all’anonimato in
materia fiscale. Viene meno uno scudo per i cinque parlamentari che nei mesi
del lockdown hanno richiesto il bonus teoricamente destinato ai lavoratori
autonomi e alle partite Iva logorate dall’emergenza sanitaria. Il Garante
squarcia con nettezza il velo intorno ai deputati, per i quali «a causa della
funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono,
anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione
patrimoniale cui sono soggetti». Come questa direttiva, già suggerita
dall’Anac, possa conciliarsi con la Costituzione, sarà tema del cenone di
Ferragosto. Insieme ai dubbi sul fatto che il mancato diritto alla privacy
potrebbe valere anche per i consiglieri regionali e tutti gli amministratori
locali. Ma come si possono equiparare le condizioni economiche di un
parlamentare, mediamente pagato 12.000 euro al mese, a quelle di un consigliere
comunale o un assessore di una piccola città, pagato 20 euro lordi di diaria?
Inoltre non si capisce perché chiedere conto della richiesta di accesso al bonus
da parte dei numerosi cittadini impegnati nelle istituzioni locali e
contemporaneamente lavoratori e titolari d’azienda. In questi giorni stiamo
registrando l’enfasi giustizialista con la quale si pretendono i nomi degli
amministratori locali, spesso in debito con la politica attiva, “colpevoli” di
aver usufruito di un aiuto statale, come tutti gli altri cittadini. Con lo
spettro della pubblica gogna sullo sfondo. Ipotizziamo il caso di un consigliere
comunale di un piccolo comune, stipendiato duecento-trecento euro al mese per la
sua attività istituzionale e lavoratore autonomo. Lui ha richiesto e ottenuto il
bonus dei 600 euro per arginare la sopraggiunta difficoltà economica provocata
dall’emergenza Coronavirus. Cosa gli succederebbe se il suo nome venisse
improvvisamente diffuso nei bar del paese e sui social, possibilmente dai suoi
avversari politici, come fruitore del bonus? Probabilmente passerebbe come
autore di un’infamia e politico corrotto, quando in realtà ha semplicemente
sfruttato un aiuto statale in un momento di crisi. Il Garante dovrebbe pensare
anche alla loro di privacy. Certamente non ci pensa Luigi Di Maio, che ieri ha
accolto l’intervento dell’Autorità con entusiasmo: «Adesso non ci sono più
scuse. Anche il garante della privacy ha detto che non ci sono ostacoli alla
diffusione dei nomi dei deputati che hanno richiesto il bonus di 600 euro
malgrado i loro stipendi da 13mila euro netti al mese. È giusto che gli italiani
sappiano chi sono, che ne conoscano i volti, i nomi e i cognomi». L’ex capo
politico del Movimento 5 stelle dice, con un certo ironico coraggio, che non si
tratta di “gogna mediatica” o di “propaganda”, ma solo di “giustizia” e
“trasparenza”. Ma il Garante ha dichiarato anche altro, annunciando una
istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’Inps rispetto al trattamento
dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse».
Sotto “indagine” quindi il dico-non dico dell’Ente previdenziale italiano, fino
a ieri vincolato alla privacy ma dalla quale è partita, sotto forma di scoop
giornalistico, “Bonusopoli”, con annessa caccia all’uomo e ondata di
anti-politica. Sarà contento Matteo Renzi che ha chiesto le dimissioni del
direttore dell’Inps Pasquale Tridico, per «il clima populista di caccia alle
streghe che l’Inps ha instaurato, basato anche sulle notizie false, come quelle
su Italia Viva che quei soldi non li ha mai presi». L’ex premier ha accusato
Tridico anche di aver dimostrato “incompetenza” su “cassa integrazione e partite
Iva”. Intanto prosegue la caccia ai tre parlamentari che il bonus l’avrebbero
intascato. Stando ai rumors, si tratterebbe di due leghisti e un pentastellato.
I sospettati in casa Lega sarebbero Andrea Dara ed Elena Murelli, da giorni
irreperibili. D’altronde l’ordine di scuderia in via Bellerio pare essere “non
rispondete al telefono, nascondetevi”. Parole meno solenni delle “sospensioni
immediate” promesse da Matteo Salvini appena l’altro ieri. Intanto Luca
Zaia, governatore uscente del Veneto, ricandidato stra-favorito alle regionali
di settembre e soprattutto rivale interno di Salvini, ha decretato la messa al
bando dalle liste dei tre consiglieri regionali leghisti coinvolti in
“Bonusopoli”. Si tratterebbe di Gianluca Forcolin, vicepresidente della
regione, Riccardo Barbisan e Alessandro Montagnoli. Non sono tre pesci piccoli
nella lega veneta e non hanno commesso alcun reato. Ma l’ambizioso Zaia ha
deciso di strizzare l’occhio al clima giustizialista. E così “Bonusopoli”
diventa anche uno strumento di campagna elettorale. In attesa del referendum di
settembre sul taglio del parlamentari.
Bonus ai deputati, boomerang su Tridico: era vietato, perché
l’Inps non ha vigilato? Giuliano Cazzola su Il
Riformista il 13 Agosto 2020. Sullo scandalo tartufesco del bonus per le partite
Iva è in corso una vera e propria caccia alla volpe. Mute di giornalisti –
quelli che si sono “fatti un nome” con la denuncia delle malefatte della Casta,
accumulando diritti d’autore grazie a saggi contro le “sanguisughe”, i
“vampiri”, saltabeccando da “affittopoli”, ai “vitalizi” e alle “pensioni
d’oro” ed erigendosi a fondatori di un’etica che prescinde da ogni principio
dello stato di diritto – seguono da giorni ininterrottamente le tracce dei
parlamentari, prima, dei membri delle assemblee elettive periferiche, poi, che
hanno presentato la domanda per ottenere (con esito positivo) il bonus una
tantum da 600 euro riservato, a marzo, alle partite Iva (i “nuovi dannati della
terra” secondo la mistica sindacale sul c.d. precariato). Contro i “soliti
sospetti”, i partiti annunciano sanzioni, pretendono autocertificazioni,
minacciano l’esclusione dalle liste elettorali. E soprattutto è già predisposta
una gogna mediatica al pari di quella attivata in altre circostanze. Certo, non
si può sostenere che i nuovi “furbetti” abbiano fatto una figura da encomio.
Almeno i “vecchi marpioni” intrallazzavano per avere una casa in affitto a equo
canone dagli enti previdenziali o chiedevano di fare, dopo un’onorata carriera
nella burocrazia dei partiti, un “giro” in Parlamento per assicurarsi, col
vitalizio, una vecchiaia tranquilla. Quelli di oggi, più che appartenere a una
Casta, sembrano essere degli assistiti dalla Caritas. Ma “dove sta il beef”,
chiedeva un candidato alla presidenza degli Usa? In uno stato di diritto può
esistere un divario tra etica e legalità? Certo, il concetto di legalità non ha
un valore assoluto: anche una feroce dittatura – come quelle che i popoli hanno
subito, nel “secolo breve”– adotta delle norme vincolanti che i cittadini sono
tenuti a seguire e i giudici ad applicare. È una problematica, questa, che viene
in evidenza nel film Vincitori e vinti di Stanley Kramer dedicato a una sessione
“minore” del Processo di Norimberga. Un insigne magistrato tedesco (interpretato
da Burt Lancaster) viene sottoposto a procedimento dal tribunale internazionale
e condannato per aver applicato le leggi sul razzismo. Rivolgendosi al
presidente americano (Spencer Tracy) gli chiede quando a suo parere un giudice
può rifiutarsi di applicare il diritto positivo; la risposta che riceve è la
seguente: «Quando si accorge di condannare un innocente». Ma in un regime
democratico e in uno stato di diritto esiste un tribunale anche per le leggi. E
se un provvedimento legislativo è formulato male non è certo per responsabilità
di chi se ne avvale. Per ottenere l’una tantum di 600 euro non erano previste
prove di mezzi. I soli limiti preclusivi fissati riguardavano la percezione di
trattamenti pensionistici o il possesso di altre posizioni previdenziali, ad
eccezione dell’iscrizione alla Gestione separata (Inps). E tali limiti dovevano
essere noti ai parlamentari e agli amministratori locali, per i quali è
certamente più impegnativo il principio del “ignorantia legis non excusat”.
Infatti, l’articolo 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni
speciali dell’Ago) del decreto cura Italia stabilisce al comma 1 che: «Ai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione
della Gestione separata… è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a
600 euro». Come è trapelato sui media, alcune indagini svolte dalla Direzione
centrale antifrode, anticorruzione e trasparenza dell’Inps – organo creato dal
direttore Pasquale Tridico per individuare e scoraggiare eventuali truffe ai
danni dell’ente di previdenza sociale – nel prendere in esame le domande di
bonus pervenute, hanno evidenziato che, a richiedere bonus per autonomi e
partite Iva, sono stati anche alcuni parlamentari e circa 2mila amministratori
locali come presidenti di regione, consiglieri regionali e comunali e qualche
sindaco. “Dalli ai magna/magna”, sono insorte le vestali dell’opinione pubblica!
Però – ahimè – il problema esiste: non è di carattere etico ma giuridico; come
si conviene in uno stato di diritto. La Circolare Inps n. 49 del 30 marzo u.s.
ha chiarito che le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni
dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria
(AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli
enti di previdenza c.d. privatizzati dei liberi professionisti, nonché con la
c.d. Ape sociale e con l’assegno ordinario di invalidità. Al dunque, oltre a
percepire già un trattamento previdenziale/assistenziale il criterio
discriminante stabilisce che i beneficiari “non siano iscritti, al momento della
presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, a
esclusione della Gestione separata”. E i parlamentari sono iscritti a un regime
che è divenuto forzatamente pensionistico, per essere come tutti i cittadini.
Verrebbe da chiedersi se in proposito non esista una “culpa in vigilando” da
parte dell’Inps. La questione più seria, tuttavia, non riguarda l’ammontare del
reddito dei richiedenti. Il dibattito si è già infilato su questo binario morto.
Brutti e cattivi, secondo la gazzetta della gogna, sarebbero solo i parlamentari
e i consiglieri regionali a causa delle robuste indennità percepite; mentre i
consiglieri comunali si devono accontentare di striminziti gettoni di presenza.
Proprio come si intitolava una commedia di Dario Fo: Settimo: ruba un po’ meno.
Ma perché impelagarsi in questioni giuridiche (sussisteva o meno il diritto?)
quando è molto più conveniente presentare all’opinione pubblica l’evergreen di
un biasimo morale?
La difesa in commissione Lavoro della Camera, Bonusopoli,
Audizione di Tridico: “Non sono stato io a dare i nomi. L’Inps ha seguito la
legge”. Redazione su Il Riformista il 14 Agosto 2020.
“Non sono stato io a dare la notizia dei furbetti”. Così Pasquale Tridico,
Presidente dell’Inps, in videoconferenza, in audizione davanti alla commissione
Lavoro della Camera chiarisce tutti i nodi oscuri della vicenda che ha indignato
l’Italia. “I nomi dei politici che hanno preso il bonus non li abbiamo dati –
continua – Sono usciti perché si sono autodenunciati”. Tridico è stato chiamato
a chiarire tutti i punti oscuri sulla vicenda dei bonus da 600 euro erogati ai
politici. In particolare chiarisce i delicati punti in merito alla modalità di
richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle
categorie di destinatari di tale bonus nonché sulle relative attività di
monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell’Istituto. E ricostruisce la
vicenda: “Il direttore di Repubblica Maurizio Molinari il 7 agosto mi ha
informato del fatto che il suo giornale aveva la notizia che 5 deputati avevano
chiesto il bonus 600 euro. Mi ha chiesto i nomi, ma i nomi non li sa nessuno.
Non sono stato io a far trapelare la notizia ed è in corso un’indagine interna
sul caso. Questa notizia non è uscita in modo più assoluto dal sottoscritto”.
“Quando abbiamo appreso della notizia”, relativa ai bonus, “a fine maggio, il
sottoscritto ne ha parlato al Cda dell’istituto”, continua. “Rimando al mittente
ogni accusa verso di me e verso i miei dirigenti e funzionari, di un’azione
manipolata, architettata da me e dalle strutture, che sono autonome e il cui
lavoro è stato esemplare”, e aggiunge che i dirigenti e i funzionari “hanno dato
lacrime e sangue per far fronte alle esigenze, abbiamo anche dormito nelle sedi
per dare risposte”. Risponde alle accuse: “La procedura costruita
dall’amministrazione si basa sulla legge, basandosi sui nostri archivi, si
attinge alla presenza o meno di altri fondi previdenziali obbligatori”.
Ricapitola quelle delicate ore in cui scoppiò l’emergenza e fu disposto il bonus
con il decreto Cura Italia con cui il governo ha messo a disposizione 10
miliardi per dare un risposta veloce a chi ne aveva bisogno. “Erano momenti
convulsi – dice – l’Istituto ha risposto in maniera efficace, in 15 giorni,
predisponendo una misura che non esisteva e lo ha elargito, come da impegno
chiesto dal governo e dal presidente del Consiglio” in tempi rapidi, “così al 15
aprile sono stati elargiti 2,7 milioni di bonus e poi nei giorni successivi,
fino a 4 milioni”. E spiega il perchè a mesi di distanza sono stati fatti i
controlli che hanno portato alla scoperta dei bonus ai parlamentari. “L’estrema
semplificazione dei requisiti di accesso alla misura” del bonus per gli autonomi
previsto dal Cura Italia “rischiava di essere appetibile a chi fa delle frodi la
sua missione. La direzione centrale Antifrode ha attivato così un controllo
parallelo, diverso a seconda della prestazione ma uguale come output. L’attività
ha consentito di individuare oltre 3mila matricole aziendali evitando
elargizioni non dovute”. Si tratta di controlli postumi che sono ancora in corso
“e prima di pensare ad eventuali addebiti ci dobbiamo pensare ancora”, dice il
presidente dell’Inps, che si giustifica dicendo: “In epoca di Covid l’esigenza
era pagare, non controllare”. “Sono stati attinti dagli open data del ministero
dell’Interno i dati degli amministratori locali e dei parlamentari (che hanno
forme di previdenza differenti) e sono stati incrociati con quelli di chi ha
chiesto i bonus”. “Gli ammortizzatori sociali non avevano le informazioni di
primo livello sui politici nazionali e locali, si è dovuto andare per forza a un
controllo di secondo livello”, aggiunge. “Nei giorni scorsi ho ordinato un audit
interno per capire se le notizie sono state trafugate dall’interno dell’Istituto
verso Repubblica. L’Istituto non ha dato i nomi, l’Inps garantisce la privacy”.
Schedature di massa. Se Tridico si mette a fare Borrelli:
perchè ha reso noto fatti coperti da privacy? Tiziana
Maiolo su Il Riformista il 12 Agosto 2020. Se il Parlamento avesse residenza
a Milano, dove c’è la Procura della repubblica più occhiuta e vorace d’Italia,
il fascicolo sui bonus da seicento euro percepiti da qualche deputato o senatore
sarebbe già aperto sulla scrivania di un coraggioso sostituto. E non è escluso
che il fattaccio stia per accadere, visto che sarebbero 2000 complessivamente
gli esponenti politici ad aver fruito dell’aiuto di Stato, sparsi un po’ in
tutta Italia, tra consigli comunali e regionali. E se ancora non è intervenuta
la magistratura, qualcosa di molto simile è accaduto all’interno dell’Inps.
Tanto che stiamo assistendo alla più colossale schedatura di massa della
politica ad opera di un organismo burocratico e lottizzato, dall’era
democristiana fino a quella grillina. Per ricordare qualche cosa di simile,
occorre riandare con la memoria ai fatti di Tangentopoli. Tridico come Borrelli?
Non si capisce proprio a quale titolo la “Direzione centrale antifrode,
anticorruzione e trasparenza” dell’Inps, un organismo voluto e istituito dal
presidente Pasquale Tridico, abbia eseguito una ricerca sui pubblici
amministratori, incrociando dati sensibili e verificando quanti di loro avessero
fatto richiesta per ottenere il bonus. E infine, fatto ancora pià grave, una
volta appurato che nessuno di loro aveva commesso un reato o attuato una frode,
non abbia archiviato la pratica, ma abbia reso pubblica una (finta) notizia
coperta da rigoroso diritto alla privacy. Tra l’altro, non prevedendo il
provvedimento del governo sul bonus alcun limite di reddito per aver diritto a
riscuotere i seicento euro, qual è il motivo di questo polverone, se non lo
sputtanamento del Parlamento e dell’intera classe politica? Il presidente
grillino Tridico dovrà ben dare una spiegazione, soprattutto perché, secondo
quanto scritto dal Corriere della sera, la notizia risale a metà maggio, quando
la direttrice della Direzione antifrode dell’Inps avrebbe avvertito il
presidente dell’esistenza delle domande dei politici. Tre mesi dopo viene fatta
scoppiare la bomba, scatenando sanguinosi processi di piazza, con sentenze già
scritte, all’interno degli stessi partiti, con una caccia alle streghe da far
impallidire quelle del Seicento. Purtroppo quel che sta succedendo in questi
giorni dà la misura della pochezza di gran parte della classe politica che i
partiti hanno portato in questo Parlamento, e anche nelle amministrazioni
locali. Nessuno che rivendichi la nobiltà della politica o l’orgoglio di stare
nelle istituzioni a rappresentare il popolo italiano. Tutti lì a farsi fare
l’esame del sangue da quattro burocrati di partito miracolati da pochi clic
sulla piattaforma Rousseau. Consiglieri comunali costretti all’autodafè e a
spifferare pateticamente i propri redditi annui. E anche le voci più critiche su
questa colossale gogna si sentono in dovere di premettere che comunque è una
vergogna e che vogliamo sapere i nomi dei reprobi. Ma a che cosa serve sapere i
nomi, dal momento che nelle pratiche Inps non c’era nulla di irregolare? A farci
sentire più virtuosi perché noi non l’avremmo mai fatto? A dire che è immorale
essere avidi e volere tutto fino all’ultima briciola, soprattutto quando si ha,
come i parlamentari, già una buona entrata? E quando avremo impiccato al palo
più alto due o tre poveretti di cui nessuno vuol sentire le ragioni, perché
quando si alzano le forche le sentenze di morte sono già scritte, non avremo
comunque scritto una bella pagina di storia repubblicana. Per almeno due motivi.
Il primo, perché avremo semplicemente scoperto (o confermato) il fatto che
abbiamo mandato in Parlamento rappresentanti selezionati con il criterio di
uno-vale-uno, cioè persone prive di competenze e anche di rigorosi principi. E
poi che, quando si svalutano gli organi rappresentativi fino al punto di
attribuire agli enti burocratici come l’Inps il controllo della moralità dei
politici, vuol dire che siamo molto vicini alla volontà di distruggerlo, il
Parlamento, non solo di ridurre il numero dei suoi componenti. E tra poco saremo
chiamati a un referendum molto delicato il cui risultato non avrà solo a che
fare con un problema di sforbiciate. Ricordiamocelo.
Tridico non
si dimette, smitraglia cifre inutili e si difende: “Non sono stato io”, ma
l’Unità Antifrode l’ha creata lui.
Angela Nocioni su Il Riformista il 15 Agosto 2020. Ad infilzare Pasquale
Tridico, nervoso e sudaticcio mentre fa su e giù scomodissimo sulla sua sedia
come fosse un cavallino a dondolo, basterebbe l’aria di sorridente pietà con
cui Renata Polverini, in collegamento da remoto coi capelli svolazzanti, butta
là: «Nooo nooooo, ma io gli credo quando dice che non è stato lui». L’audizione
del presidente dell’Inps alla Commissione lavoro della Camera, un’accidentata
perfomance via streaming alla vigilia di Ferragosto, non è stata alla fine il
fuoco di fila di domande incalzanti che le opposizioni avevano promesso. Forza
Italia e Fratelli d’Italia le sue dimissioni comunque l’hanno chieste. Hanno
tentato, invano, di fargli spiegare il come e il perché della fuga di notizie su
dati sensibili. Tridico alza le mani: non sono stato io. Giura che i nomi dei
tre parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus Iva da 600 euro – notizia
nota all’Inps da più di due mesi e uscita adesso, a ridosso del referendum sul
taglio dei parlamentari voluto dai Cinque stelle grazie ai quali lui ha avuto la
nomina – non sono venuti fuori dall’Inps. E da chi, allora, visto che le liste
dei richiedenti sospetti sono state stilate dall’Unità antifrode dell’Inps,
misteriosa creatura creata su sua richiesta? «Le notizie sui bonus non sono
state certo diffuse dall’Istituto. Respingo tutte le accuse di manipolazione,
accuse fantasiose mosse per motivi che mi sfuggono. I controlli sono stati fatti
per verificare l’effettivo diritto a ottenere il bonus» dice lui agitando le
braccia come uno che affoga. Per Tridico l’audizione inizia male. È talmente
sottosopra che non riesce a usare la webcam. Per lunghissimi minuti
l’inquadratura fissa un innocente Sergio Mattarella incorniciato alla parete
accanto al tricolore, mentre in un angolino sinistro sul fondo dello schermo si
vede la fronte accaldata del presidente dell’Inps, capelli color mogano
appiccicati in testa, che con voce affannata smitraglia una serie di numeri
letti di corsa: «Abbiamo pagato 2,7 milioni di bonus entro il 15 aprile, abbiamo
dormito letteralmente nelle stanze dell’Istituto». «Partite Ive (sic)» di qua,
«vi spiego un attimo» di là. Confonde il ministero del Lavoro con quello
degli Esteri, sembra non potercela proprio fare il professore. Alla fine una ne
imbrocca. «Per avere diritto al bonus — dice Tridico — il richiedente non deve
essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. Sulla base di questa
norma l’Unità antifrode ha mandato una prima tranche di circa 40 mila soggetti
che alla data risultavano iscritti a un’altra forma di previdenza». Gli viene in
soccorso Guglielmo Epifani (Leu), l’unico che sembra averci capito qualcosa. Gli
chiede perché non s’è occupato subito della questione dei differenti sistemi di
previdenza, che riguardano necessariamente anche i parlamentari. Cita Cazzola.
Caritatevole, gli spiega anche che tutto mondo è paese, che in Germania a un
certo punto si sono accorti che per chiedere un rimborso da 1000 euro poteva
bastare possedere un cavallo. Tridico, finalmente sollevato: «Il cavallo –
esulta – il cavallo!». Rincuorato, s’allarga. Chiede di «guardare la luna e non
il dito», di non inchiodarlo a questa storia della manina rea d’aver fatto
uscire la notizia sui duemila politici con bonus – senza distinzione tra
deputati, consiglieri regionali e consiglieri comunali da pochi euro a seduta –
proprio adesso che serve a Di Maio. Sulla schedatura di persone che non hanno
compiuto né reati né frodi (comunque sputtanate) si difende così: «Nel periodo
del Covid l’esigenza era pagare subito e controllare dopo». I seicento euro
erano appetibili per chi froda» e per questo le «verifiche sono ancora in
corso». Più che il processo implacabile annunciato alla vigilia, l’audizione via
web di Tridico ieri è stata una carrellata di un campionario di varia umanità in
piena estate. L’apparizione fugace di un nerd tra gli alberi con lanternine
appese ai rami. La deputata Tiziana Ciprini, Cinque stelle eletta in Umbria, che
si presenta con bretelline, rossettone e occhi bistrati, genere Moira Orfei a
fine serata. La piddina Deborah Serracchiani, in grave difficoltà col computer,
che ricorda a Tridico come da presidente di Commissione le corra purtroppo
l’obbligo di pretendere da lui i nomi di quei due parlamentari sfuggiti per ora
alla gogna perché hanno chiesto il bonus, sì, ma senza ottenerlo. Cos’è che
vuole la Serracchiani? Il nome del renziano? Non lo dice, ma non molla. Tridico
prende tempo. Fa il vago anche sul se davvero un vicepresidente della Camera
(Rosato di Italia viva?) gli ha chiesto riservatamente se nel suo gruppo c’è
qualcuno con una richiesta bonus non dichiarata. «Questo riguarda la sfera
personale e non interessa». Si nasconde dietro l’attesa d’autorizzazione a
parlare da parte del garante per la privacy. Spiega d’aver ricevuto il 7 agosto
la telefonata del direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che gli diceva di
avere un’informazione e gli chiedeva i nomi dei parlamentari. Giura di non
averli dati, sottolinea che il titolone sul quotidiano è uscito solo il 9.
Da Repubblica gli arriva un salvagente mentre l’audizione è ancora in corso.
Dicono che la notizia l’hanno avuta d’altra fonte, che ovviamente tengono
riservata. Lui smitraglia un’altra serie di cifre abbastanza inutili e alla fine
tira un sospirone di sollievo. Si butta all’indietro sullo schienale e riavvia
il ciuffo, esausto. «Fiuuuuuu», si sente proprio. Il microfono non perdona.
Maurizio
Belpietro per ''la Verità'' il 15 agosto 2020. Non rivela i parlamentari che
hanno chiesto (senza averlo) il bonus Iva. Non dice il motivo di ricerche ad hoc
sugli onorevoli. E glissa sulla chiamata con il renziano Rosato: l'operazione
distrazione di massa è realizzata. Che la vicenda del bonus ai parlamentari
potesse essere usata come un' arma di distrazione di massa lo abbiamo sospettato
subito. Gli onorevoli approfittatori certo non hanno scusanti. Ma in un Paese
dove c' è chi ruba a mani basse, i cialtroni che arraffano 600 euro non sono
certo una notizia da tenere alta sulle prime pagine per giorni e giorni. A meno
che non ci sia chi ha interesse a gonfiare il fatto, magari per far dimenticare
altro e, soprattutto, per distogliere l' attenzione da faccende più
imbarazzanti. Dicevamo che il sospetto di un caso gonfiato ad arte ci era venuto
fin dall' inizio, ma ieri l' audizione del presidente dell' Inps, il professor
Pasquale Tridico, un uomo fortemente voluto ai vertici dell' ente previdenziale
dai grillini, ci ha tolto ogni dubbio. Il numero uno dell' istituto, tra
balbettii e difficoltà di collegamento, ha risposto alla commissione
parlamentare presieduta da Debora Serracchiani chiarendo alcune cose. La prima è
una conferma di ciò che avevamo riferito, ovvero che l' Inps sapeva degli
onorevoli con il bonus da quasi tre mesi. Il servizio antifrode dell' ente aveva
infatti segnalato la cosa addirittura dalla fine di maggio. Tuttavia, Tridico ha
negato di essere stato lui a spifferare il caso a Repubblica, il primo
quotidiano che ha rivelato la notizia. Il professore giura di non averne parlato
con anima viva, ma soprattutto con i giornalisti. Però ammette di aver riferito
la cosa al consiglio di amministrazione dell' istituto. Perché una vicenda che
non ha a che fare con le frodi (in base alla legge anche gli onorevoli hanno
diritto al bonus) sia stata messa all' ordine del giorno del consiglio di
amministrazione di un colosso previdenziale qual è l' Inps è però un mistero. Se
l' erogazione del sussidio rispondeva ai criteri di legge, anche se inopportuna,
perché Tridico ha sentito il bisogno di raccontare tutto ai consiglieri? Anche i
bambini sanno che parlare in un cda è come parlare con l' Ansa, cioè come fare
un dispaccio d' agenzia: per quanto sia richiesta la riservatezza su ciò che si
discute in consiglio, era facile prevedere che la notizia sarebbe rimasta
segreta qualche settimana, non molto di più. Possibile che il presidente dell'
Inps sia così ingenuo da non sapere che per mantenere riservato un fatto è
meglio evitare di parlarne? Se riferisci una notizia a due dozzine di persone,
il minimo che ti possa capitare è che dopo un mese lo sappiano tutti. C' è poi
un altro fatto che emerge dopo l' audizione di Tridico, e cioè che l' indagine
interna dell' Inps non aveva nessun reale motivo per essere fatta. Il presidente
non è infatti riuscito a spiegare come mai il suo staff sia andato a caccia di
parlamentari, spulciando i nomi dei beneficiari alla ricerca di qualche
onorevole. Non essendo illegale ma solo moralmente censurabile, perché l' ente
ha voluto verificare la richiesta di deputati e senatori? Tridico respinge l'
idea di un dossieraggio, minacciando querele e nega che ci sia qualche
collegamento con il referendum caro ai grillini sulla legge per ridurre il
numero di eletti in Parlamento. Tuttavia la coincidenza è assai curiosa.
Soprattutto è sorprendente che siano usciti i nomi di due leghisti e di un
grillino, ma siano stati coperti quelli di un onorevole del Pd e di un altro di
Italia viva. La scusa è che i primi tre hanno effettivamente incassato i 600
euro, mentre gli altri due si sarebbero visti respingere la domanda. Una
giustificazione fragile, perché se di furbi si tratta, che siano riusciti a
riscuotere o meno fa poca differenza. Tridico dice che non può fare i nomi di
chi non ha percepito per ragioni di privacy, ma la privacy evidentemente
funziona a giorni alterni. Se telefona Ettore Rosato, di Italia viva e
vicepresidente della Camera, il leader dell' Inps non si nasconde dietro la
legge della riservatezza, se invece a bussare alla sua porta sono altri,
giornalisti compresi, il riserbo è assoluto. Alla fine delle deboli spiegazioni,
una cosa ci pare chiara. Grazie al caso dei tre parlamentari con il sussidio di
povertà, dei ritardi e degli errori dell' istituto previdenziale non si parla
più. Non fanno quasi notizia nemmeno gli avvisi di garanzia a mezzo governo per
la gestione dell' emergenza. Le chiusure in ritardo, il lockdown esteso a tutta
Italia, le mascherine che non si trovano, i banchi della Azzolina, i soldi che
non arrivano: tutto è stato improvvisamente accantonato per dare visibilità ai
maramaldi del bonus. L' operazione di distrazione di massa, grazie alla
complicità degli organi di informazione, ha funzionato.
Mario Giordano per “la Verità” il 19 agosto 2020. Ma perché quei
nomi non interessano più nessuno? Siamo andati avanti per giorni e giorni, un
coro d'indignazione infinita, sembrava non esistesse null'altro al mondo: tutti
volevano conoscere l'identità dei disonorevoli furboni, i mentecatti del
coronavirus, quelli che in piena emergenza si preoccupavano di mettere in tasca
il bonus da 600 euro. E, a dire il vero, a noi la curiosità non è passata.
Infatti siamo ancora qui, sempre risoluti, non ci muoviamo di un millimetro e
chiediamo al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico(lo), di comunicare
ufficialmente la lista degli zozzoni. Ci teniamo da matti. Lo vogliamo proprio
sapere. Come dieci giorni fa. Anzi un po' di più. Però, ecco, il fatto è che
siamo rimasti soli. O quasi. A tutti gli altri sembra non importare più nulla.
Furboni dell'Inps? Parlamentari? 600 euro? Non pervenuti. Sfogli le pagine dei
giornali, al massimo c'è una breve. Titoloni in prima? Spariti. Le trasmissioni
tv? Tacciono. La politica? Latita. Ma come? Da quei nomi non dipendeva la
dignità della nostra democrazia? Non era fondamentale conoscerli per poter
difendere la nostra Repubblica? Noi, scusate, continuiamo a pensarla così. E ci
insospettisce non poco che gli altri abbiano cambiato idea. Eppure quei nomi
l'Inps non li ha mai resi noti. Formalmente Tridico(lo) si trincera dietro il
rimpallo all'italiana: prima manca la richiesta in carta bollata, poi manca il
parere del Garante, poi arriva il parere del Garante ma non è ancora
sufficiente, ci vuole un approfondimento, ma anche l'approfondimento non è
abbastanza approfondito. Risultato: la melina. È vero che tre nomi sono saltati
fuori (quello di Elena Murelli e Andrea Dara della Lega e di Marco Rizzone dei 5
stelle) ma perché li hanno fatti i rispettivi partiti. Dall'istituto nessuna
comunicazione ufficiale. Tutto resta segreto. Così come restano segreti i nomi
dei 2.000 amministratori locali che hanno fatto la medesima furbata. E così come
restano segreti, ed è ancor più grave, i nomi degli altri due parlamentari (uno
del Pd e uno di Italia viva, a quanto pare) che a prendere il bonus ci hanno
provato. Senza riuscirci, il che è quasi un'aggravante. Ecco: noi, di tutto ciò,
non ci diamo pace. Continuiamo a chiederci: perché all'improvviso a nessuno
interessa più conoscere quella lista nera? Hanno forse smesso di colpo di essere
mentecatti, accattoni, meschini, parassiti e tutto il resto? Non meritano più di
ricevere l'appropriata dose di insulti? E perché di due di quei cinque
parlamentari non si è mai fatto il nome, neppure per sbaglio? Il fatto che non
abbiano incassato la somma, chiaramente, è irrilevante. Lo scandalo di tutta la
vicenda, infatti, non è il danno erariale, ma l'atteggiamento di chi, eletto per
difendere gli italiani, difende invece soltanto i suoi interessi. È l'arroganza
di non si preoccupa di chiedere i 600 euro per gli italiani che ne hanno
bisogno, ma di chiederli per sé (insieme ai 12.000 euro di stipendio
assicurati). Il fatto che i quattrini arrivino realmente o no cambia poco: è
l'atto di chiederli che squalifica il parlamentare. E che dunque deve essere
censurato. Ma per essere censurato deve essere conosciuto. Ora, lo ripetiamo,
noi non abbiamo cambiato idea: continuiamo fermamente a ripetere #fuoriinomi,
anche se l'hashtag non è più in tendenza. Continuiamo a volere sapere chi sono
quei due che hanno chiesto il bonus e la cui identità non è mai stata rivelata.
Continuiamo a volere avere la conferma ufficiale dall'Inps dei tre nomi usciti
dalle segreterie dei partiti, e vorremmo pure sapere se per caso ce ne sono
degli altri. E, già che ci siamo, ci piacerebbe fosse chiarito anche qualche
altro mistero di corollario. Per esempio: come mai Tridico(lo) parlò al telefono
con il vicepresidente della Camera Ettore Rosato per escludere la presenza di
parlamentari di Italia viva tra coloro che avevano ricevuto il bonus? «Questione
personale», ha detto il presidente dell'Inps. Ma è una spiegazione che non sta
in piedi: il presidente dell'Inps parla con il vicepresidente della Camera di
contributi pubblici ricevuti da parlamentari, ed è una «questione personale»
come la briscola al bar di due pensionati? Ma vi pare?Ora il problema è: perché
su tutti questi dubbi è calato improvvisamente il silenzio? Non riusciamo a
farcene una ragione. Fino a qualche giorno fa era un garrire di editoriali, un
fiorir di elzeviri, il trionfo dell'indignazione. Ora, nulla, silenzio. I
giornaloni, tutti presi a bastonare il nuovo nemico - cioè il giovane che va in
discoteca - si sono distratti. La commissione Lavoro della Camera, tutta presa a
far dimenticare la figuraccia tecnologica della presidente Debora Serracchiani
nell'ultima riunione balneare, marca visita. E poi si sa, i parlamentari sono in
vacanza: in questo momento più che degli scrocconi sono preoccupati dagli
ombrelloni. Le uniche informazioni che vogliono con urgenza sono quelle sul
bonus pedalò. E così ci sembra di essere rimasti un po' soli: di tanti che
strepitavano non è rimasto molto.Per carità, non ci permettiamo di sindacare le
scelte altrui. Ognuno si indigna per quel che vuole. Può essere anche che un
giorno uno è assatanato per sapere i nomi dei furbetti del bonus e il giorno
dopo, anche se quei nomi non sono stati fatti, se ne dimentica. Succede. Solo
che, così, ci torna in mente un dubbio che abbiamo sollevato fin dall'inizio. E
cioè che questo polverone sui parlamentari mentecatti sia stato sollevato ad
arte, un giorno non a caso di agosto, per sviare l'attenzione dai guai di Conte,
del governo e dell'Inps. Ricordate? Quando è scoppiato lo scandalo tutti
parlavano delle bugie del premier sulla zona rossa. Argomento uscito di scena.
Così come sono passati in secondo piano la vicenda Autostrade (irrisolta), i
pasticci con gli immigrati, i ritardi nel pagamento alle imprese. Puff: tutto
svanito. In un attimo. La cortina fumogena si è alzata, ed è rimasta lì, giusto
il tempo necessario a scatenare il nuovo allarmismo contro il pericolo mortale
della discoteca, che ha assorbito l'attenzione generale. Serviva dare un'altra
bottarella alla Lega? Fatto. Serviva scavallare il Ferragosto senza troppi
danni? Fatto. A chi importa tutto il resto? A nessuno. Peraltro uno dei due
parlamentari sospetti potrebbe pure essere del Pd. Svelare il nome? E perché
mai? Nicola Zingaretti che tuonava vergogna ora tace. E nessuno gliene chiede
conto. Maurizio Belpietro, giovedì 13 agosto, scriveva: «Usano i ladri di polli
per distrarci dalle loro bugie». E mai una volta che la realtà ci dia la
soddisfazione di smentire i nostri sospetti.
(ANSA il 20 agosto 2020) - "Dopo aver ascoltato e verificato la
posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della
sospensione per la senatrice Marzia Casolati". Lo rende noto il capogruppo della
Lega al Senato, Massimiliano Romeo. La senatrice ha percepito il contributo di
1500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriale
costrette alla chiusura per il lockdown. "Anche se non è stato commesso alcun
illecito - precisa Romeo - e il contributo è stato già da tempo completamente
restituito, non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio.
Il provvedimento è stato già accettato e condiviso dalla diretta interessata".
Inps, Lega: Sospesi Murelli e Dara, inopportuno aver preso
bonus. (LaPresse il 12 agosto 2020) - "Dopo aver
ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento
della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara". Lo rende noto il
capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Entrambi i deputati hanno
percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva. “Pur
non avendo violato alcuna legge - dice Molinari - è inopportuno che parlamentari
abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso
con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. E’ comunque
incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo versato ai lavoratori che
aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in
difficoltà. In qualsiasi altro paese i parlamentari sarebbero stati sospesi ma
il presidente dell’INPS sarebbe stato licenziato”.
Lega sospende due deputati: "Murelli e Dara con i 600 euro".
I parlamentari sospesi sono Elena Murelli e Andrea
Dara. Il 14 agosto in commissione Lavoro della Camera avverrà l'audizione del
presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Gabriele Laganà, Mercoledì 12/08/2020 su
Il Giornale. Le voci circolate nelle scorse ore sono state confermate. Sono due
i deputati della Lega che hanno incassato il bonus da 600 euro messo a
disposizione per i titolari di partite Iva nell’ambito delle misure per
contrastare la crisi economica provocata dal coronavirus. Si tratta di Elena
Murelli e Andrea Dara. La Lega, una volta resa pubblica la notizia, ha deciso di
sospendere i parlamentari. "Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive
posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena
Murelli e Andrea Dara". Lo rende noto il capogruppo della Lega alla
Camera Riccardo Molinari. "Pur non avendo violato alcuna legge – ha affermato
ancora Molinari - è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e
per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il
provvedimento della sospensione". Il capogruppo leghista alla Camera allo steso
tempo ha lanciato un affondo contro l’istituto previdenziale: "È comunque
incredibile che i vertici dell'Inps non abbiamo versato ai lavoratori che
aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in
difficoltà. In qualsiasi altro Paese i parlamentari sarebbero stati sospesi ma
il presidente dell'Inps sarebbe stato licenziato". Nel frattempo continua il
dibattito parlamentare: la sede in cui verrà affrontato il caso
del bonus richiesto dai deputati sarà il Parlamento quando il prossimo 14
agosto, in commissione Lavoro della Camera, avverrà l'audizione in
videoconferenza del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. In quella sede i
deputati potranno interpellare Tridico ponendogli domande sull'erogazione dei
bonus. A meno di clamorose novità, potrebbe essere possibile conoscere anche i
nomi degli altri parlamentari beneficiari dei 600 euro. A confermarlo è il
presidente della Camera, Roberto Fico, che ha spiegato che i deputati potranno
porre "tutte le domande necessarie per fare definitivamente chiarezza su quanto
accaduto". "L'ho ripetuto in questi giorni: i parlamentari che avrebbero chiesto
e ottenuto il contributo destinato a professionisti e lavoratori in difficoltà
– ha ribadito Fico- dovrebbero scusarsi e restituire quanto percepito. È una
questione di opportunità, dignità e rispetto, nonché di consapevolezza del ruolo
che si ricopre". Mentre la Lega ha subito agito per "punire" i deputati che
hanno richiesto il bonus, come ha appreso l'Adnkronos da fonti parlamentari
sarebbero una quarantina gli esponenti del M5s che non hanno ancora firmato
l'autorizzazione per consentire l'accesso ai dati Inps, una operazione di
trasparenza proposta proprio dai vertici pentastellati.
Da “Avvenire” il 13 agosto 2020. Un piccolo imprenditore del
tessile e una consulente di finanziamenti europei, entrambi con un reddito
dichiarato oltre i 100mila euro. Ecco chi sono i due deputati leghisti col
bonus: Andrea Dara, 41 anni di Mantova, ed Elena Murelli, 45 anni di Piacenza.
Il loro nome circolava da giorni, senza che dagli interessati giungessero
smentite o ammissioni. È una nota del capogruppo della Lega Riccardo Molinari,
che ne comunica la sospensione, a dare la conferma: sì, sono Dara e Murelli due
dei tre parlamentari (il terzo sarebbe un 5 stelle) che hanno chiesto e ottenuto
il bonus da 600 euro riconosciuto dal governo alle partite Iva per far fronte
all'emergenza Coronavirus. Andrea Dara, nato a Castel Goffredo in provincia di
Mantova il 7 gennaio 1979, è un piccolo imprenditore nel settore tessile e
abbigliamento. Eletto nella circoscrizione Lombardia 4 nelle file della Lega,
nel 2019 ha dichiarato - come si legge nella dichiarazione consegnata alla
Camera - redditi per 109.324 euro. È stato consigliere comunale a Castiglione
delle Stiviere (dove possiede anche otto immobili, sempre secondo la sua
dichiarazione dei redditi) dal 2007 al 2011, poi vicesindaco nel 2016 fino alla
sua elezione alla Camera. Elena Murelli ha compiuto da poco 45 anni (è nata il
29 luglio 1975). Con una laurea in Economia e commercio e un master in gestione
dell'economia di rete, alterna l'attività di consulente in finanziamenti europei
a quella di docente a contratto all'Università Cattolica della sua città,
Piacenza. Nella Lega dal 2001, politicamente si divide tra il Consiglio comunale
di Podenzano, nella pianura piacentina, e lo scranno alla Camera (dal 2018). Lo
scorso anno ha dichiarato un reddito totale di 106.309 euro, nel 2018 di circa
62mila. Tra i provvedimenti che ha proposto da prima firmataria spicca uno sulle
modifiche alla struttura organizzativa di Inps e Inail e un altro per modificare
il decreto del 2019 sull'esclusione dei condannati per gravi delitti dal
beneficio del reddito di cittadinanza.
Estratto dall'articolo di Marco Cremonesi per il "Corriere della
Sera" il 13 agosto 2020. Dara avrebbe spiegato al partito che la richiesta di
bonus sarebbe stata fatta dalla madre, che con lui gestisce l’azienda di cui è
titolare al 60%: “Comprendo la scelta del partito, mi assumo la responsabilità
di quanto accaduto, anche se non sono stato direttamente io”. Insomma: “Non
cerco giustificazioni”. Secondo quanto si racconta, la madre del deputato
sarebbe distrutta dalla propria leggerezza: la richiesta di bonus, Dara
l’avrebbe scoperta quando il partito, per invogliare i deputati
all’autodenuncia, aveva consigliato di controllare semmai che la richiesta fosse
stata presentata dai commercialisti.
Bonusopoli, a chiederlo molti leghisti: Dara si scusa “L’ha
chiesto mamma”, sospeso con Murelli. Redazione su Il
Riformista il 13 Agosto 2020. Il clima continua a essere teso sulla vicenda dei
bonus da 600 euro chiesti dai politici. Il Garante della privacy ha aperto
un’Istruttoria sull’Inps e domani Tridico sarà alla Camera per rivelare i nomi
di chi ha chiesto e ottenuto il bonus. In realtà dei tre deputati incriminati
manca solo un nome, quello del del grillino. Gli altri due sono i deputati
leghisti Elena Murelli e Andrea Dara che, come promesso da Salvini, sono stati
sospesi dal partito.
ANDREA DORA – Andrea Dara ha provato a difendersi attribuendo la
colpa alla mamma. Sarebbe stata lei a fare materialmente la richiesta di bonus a
sua insaputa. Con lui infatti gestisce l’azienda di cui è titolare al 60%:
“Comprendo la scelta del partito, mi assumo la responsabilità di quanto
accaduto, anche se non sono stato direttamente io”. Insomma: “Non cerco
giustificazioni”, ha detto al Corriere della Sera. Dara avrebbe scoperto di aver
ottenuto il bonus solo quando il partito, per invogliare i deputati
all’autodenuncia, aveva consigliato di controllare semmai che la richiesta fosse
stata presentata dai commercialisti.
ELENA MURELLI – Anche Elena Murelli si è scusata con il partito.
Ma la piazza non l’ha affatto perdonata: sui social gira un video di un suo
intervento alla camera proprio sui bonus. “Abbiamo accettato l’elemosina dei 600
euro”, aveva detto in aula alla Camera lo scorso 23 luglio, in occasione della
votazione sull’istituzione della giornata della memoria delle vittime del Covid.
“Siccome stiamo uscendo da questa situazione di emergenza allora importate il
Covid”, aveva anche detto nel corso del suo intervento in aula riferendosi
all’arrivo di migranti sulle coste italiane.
I CONSIGLIERI – Poi ci sono i 2mila consiglieri che hanno chiesto
il bonus e che uno alla volta si stanno dichiarando e annunciando la penitenza.
Tra loro una vastissima parte è composta da persone che fanno politica quasi per
volontariato, ricevendo poco più che un rimborso. Ma ci sono anche ad esempio i
consiglieri regionali che possono arrivare anche a 12mila euro al mese di
stipendio. Tra questi ci sarebbe una prevalenza di leghisti, come dichiarato da
Repubblica. Dei nove finora individuati, infatti, sette sono della Lega
distribuiti in quattro Regioni. Uno è del Pd e uno di Forza Italia. Matteo
Salvini è stato chiaro: “Chiunque ha preso il bonus sia sospeso e in caso di
elezioni imminenti non ricandidato”.
I LEGHISTI – I leghisti sono così ripartiti: tre in Veneto, due
in Piemonte, uno in Emilia Romagna e uno in Liguria. Resta in dubbio il
consigliere regionale lombardo della Val Brembana Alex Galizzi, che al Corriere
di Bergamo dice di non ricordarsi né di aver chiesto il bonus né di averlo preso
(mentre gli altri colleghi lombardi del Carroccio negano). In Veneto ad aver
preso il bonus sono Riccardo Barbisan, Alessandro Montagnoli e il vicepresidente
della Regione Gianluca Forcolin. Tutti e tre fedelissimi del governatore Luca
Zaia, in corsa per le regionali di settembre e lanciatissimo nei sondaggi.
Lorenzo Fontana, commissario della Lega in Veneto, ha confermato l’orientamento
del partito, cioè di non mettere in lista chi ha chiesto il bonus. Forcolin,
intervistato oggi da Repubblica, si difende: “Io cacciato dalle liste e Fontana
ancora al posto suo in Lombardia?”.
Da corriere.it il 13 agosto 2020. Elena Murelli è una dei tre
deputati ad aver richiesto e ottenuto proprio il bonus da 600 euro per le
partite Iva e autonomi. Eletta alla Camera alle politiche del 2018, Elena
Murelli, una dei due deputati (l’altro è Andrea Dara), della Lega sospesa dal
partito per aver percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di
partita Iva. Emiliana di Piacenza, 45 anni, aderisce al partito nel 2001. Sette
anni più tardi viene eletta al consiglio comunale di Podenzano. Poco più di due
anni fa l’ingresso a Montecitorio. Laureata in Economia e commercio, consegue un
Master of management in the Network Economy, ed è - si legge sul suo profilo sul
sito della Camera - consulente in finanziamenti Europei per la ricerca e
l’innovazione. È componente della commissione Lavoro, che venerdì prossimo, a
mezzogiorno, svolgerà l’audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico,
proprio sulle modalità di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei
lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonché sulle
relative attività di monitoraggio, vigilanza e controllo.
Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera” il 13 agosto 2020.
Nella Lega c'è chi la chiama la «strada di mezzo»: i parlamentari che hanno
preso il bonus Covid sono stati sospesi, i consiglieri regionali non saranno
ricandidati. Matteo Salvini, ieri mattina, lo aveva anticipato ad Agorà Estate e
in serata è arrivato l'annuncio del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari: i
deputati Elena Murelli e Andrea Dara sono sospesi dal partito. Luca Zaia si era
riservato di ascoltare i suoi tre consiglieri regionali che hanno chiesto il
bonus. In serata, il messaggio è trapelato nitido dallo staff del governatore:
Montagnoli e Barbisan sono fuori. Un solo, lieve dubbio riguarda il vice di
Zaia, Gianluca Forcolin, che pare abbia cercato di fermare l'iter della domanda.
Ma è molto dura anche per lui. Difficile escludere che nella decisione della
Lega non abbia pesato la notizia che il presidente dell'Inps Pasquale Tridico,
domani a mezzogiorno, sarà ascoltato dalla commissione Lavoro (giusto quella di
cui Elena Murelli è capogruppo per la Lega): se i nomi fossero usciti in quella
sede sarebbe stato, come minimo, poco simpatico. Andrea Dara, anche il suo nome
circolava da giorni, per il partito è stata una sorpresa. Nessuno che non lo
descriva come «bravissima persona», nessuno che non se ne sia uscito con un «ma
dai...» quando i nomi hanno cominciato a circolare. 41 anni, imprenditore
tessile di Castel Goffredo nel mantovano, ha una fabbrica che produce calze a
Castiglione delle Stiviere, la Manifattura Mara, e un percorso tipico nella
Lega: consigliere comunale a Castiglione, provinciale a Mantova, poi
vicesindaco. Fino all'elezione alla Camera nel 2018. L'anno scorso ha denunciato
redditi per 109.324 euro. Al partito, avrebbe spiegato che la richiesta di bonus
sarebbe stata fatta dalla madre, che con lui gestisce l'azienda di cui è
titolare al 60%: «Comprendo la scelta del partito, mi assumo la responsabilità
di quanto accaduto, anche se non sono stato direttamente io». Insomma: «Non
cerco giustificazioni». Secondo quanto si racconta, la madre del deputato
sarebbe distrutta dalla propria leggerezza: la richiesta di bonus, Dara
l'avrebbe scoperta quando il partito, per invogliare i deputati
all'autodenuncia, aveva consigliato di controllare semmai che la richiesta fosse
stata presentata dai commercialisti. Mentre la 45enne Elena Murelli da
Podenzano, nel piacentino, è stata docente a contratto all'università Cattolica
ed è leghista dal 2001. Nel 2009 esordisce nel consiglio comunale del suo paese,
di cui è tuttora consigliera, prima di approdare a Montecitorio nel 2018. Sul
sito della Camera si definisce «consulente in finanziamenti europei per la
ricerca e l'innovazione». Reddito dichiarato: 106.309 euro. Era assurta alle
cronache per un intervento in Aula «non sereno» (definizione sua): «Siccome
stiamo uscendo dalla situazione di emergenza e non sapete come mantenere la
poltrona, allora importate il Covid» con l'immigrazione. Anche Murelli si
sarebbe scusata per il danno arrecato al partito. È la strada di mezzo: di
espulsi non ce ne sono stati. Però, in Veneto si mastica amaro: «I deputati se
la sono cavata con un buffetto. La sospensione, cosa è? Nemmeno esiste... Ai
consiglieri regionali, invece, è stata stroncata la carriera politica». Certo
che la campagna elettorale dei tre consiglieri sarebbe stata impervia.
Inps: Zaia, Forcolin mi ha annunciato le dimissioni.
(ANSA il 13 agosto 2020) "Il vicepresidente della giunta
regionale del Veneto Gianluca Forcolin mi ha annunciato le sue dimissioni e non
si ricandiderà nella Lega". Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia in
relazione ai tre casi veneti di richiesta del bonus autonomi. (ANSA).
Estratto dell’articolo di Enrico Ferro per “la Repubblica” il 13
agosto 2020. «Mettiamo in chiaro una cosa, io non sono furbetto. E poi, scusate:
il governatore della Lombardia è ancora al suo posto e io vengo cacciato dalle
liste per una pratica inevasa?». Gianluca Forcolin, 51 anni, di San Donà di
Piave (Venezia), diploma di Ragioneria, 27 anni nella Lega Nord, è assessore al
Bilancio e vicepresidente della Regione Veneto. (…)
Questa domanda per il bonus l' ha fatta o no?
«I soci dello studio in cui lavoro fecero la domanda ma non
avevamo i requisiti, quindi la pratica è rimasta inevasa. Io non sono neanche
presente negli elenchi dell' Inps». (…)
E qual è il punto allora?
«Tutti i politici che hanno comprato il monopattino con gli
incentivi, o che richiedono il bonus auto, o il bonus facciata, tutti questi si
devono dimettere. Se me ne vado io se ne devono andare anche tutti loro». (…)
Luca Zaia l' ha sentito?
«Certo, ci siamo sentiti e ho spiegato tutto. Vediamo come evolve
la situazione. Certo, essere buttato via in questo modo per una simile banalità
mi sembra davvero assurdo». (…)
Alberto Mattioli per “la Stampa” il 13 agosto 2020. E il furbetto
dove lo metto? Almeno in Veneto, la Lega non sembra proprio monolitica nei
confronti dei tre consiglieri regionali rei confessi del bonus da 600 euro. La
loro sorte sembrava segnata: sospensione in attesa di peggio e, soprattutto,
niente ricandidatura alle regionali prossime venture. Ma Luca Zaia ha spiazzato
tutti. Massimo rigore, certo, «siamo stati chiari, sono stato l'unico a livello
nazionale a fare una verifica fra i miei consiglieri». Anzi, Zaia era stato il
primo, in casa Lega, precedendo anche Salvini, a lanciare un "#metoo al
contrario" contro i furbetti. Però ieri a Conegliano, colpo di scena, Zaia ha
spiegato che invece la decisione non è scontata, almeno per uno dei tre: «Mi
riservo di incontrarli personalmente, poi deciderò. E voglio anche ricordare
che le situazioni sono diverse: da un lato abbiamo il caso di due consiglieri
che hanno fatto richiesta del bonus e poi lo hanno elargito in beneficenza,
dall'altro il caso del terzo consigliere che dice che la domanda è stata fatta
direttamente dallo studio professionale di cui è socio di minoranza, ma quando
l'Inps ha chiesto ulteriore documentazione nessuno l'ha mai presentata. Quindi
la domanda non esiste. Bisogna ricordare che non stiamo parlando di qualcosa di
illegale, bensì di una questione di opportunità». Insomma, per Riccardo Barbisan
e Alessandro Montagnoli, quelli del primo caso, non ci sarà clemenza («quei due
non hanno speranza, carriera finita», chiosa un leghista veneto); per Gianluca
Forcolin, assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione, il verdetto è
ancora sospeso. Zaia, dicono, vorrebbe salvarlo: è stato il suo braccio destro
per cinque anni (mentre Salvini, raccontano, non l'avrebbe molto in simpatia) e
a pochi giorni dalla presentazione delle liste e dell'inizio della campagna
elettorale bisogna essere cauti. Ma dall'altra parte c'è una pubblica opinione
scatenata, i social ribollono di invettive, e lo stesso governatore deve
mostrarsi coerente con le sue prese di posizione. «Alla fine lo sacrificherà»,
prevede un leghista di lungo corso e ben informato, ma dopo aver fatto il bel
gesto di ascoltarne l'autodifesa. Dal canto suo, Forcolin ci spera e spiega la
sua posizione: «Non ho mai incassato il bonus e anzi ho bloccato la richiesta
prima che partisse», e poi fa autocritica alla veneta: «Che mona che sono
stato». Però questa incertezza non è in sintonia con la posizione ufficiale del
partito. Il segretario del Veneto e vice di Salvini, Lorenzo Fontana, resta
fedele alla linea: «La posizione della Lega è che non verranno messi in lista»,
quindi nessuna apertura. E infatti proprio ieri sono stati sospesi i due
deputati furbetti e anche un consigliere in Trentino. Di certo, una decisione va
presa e anche in fretta, perché le liste per le regionali devono essere
presentate entro il 21. Ma anche nella Lega, e non solo in quella veneta, la
ricandidatura di un furbetto, anche se il meno colpevole, non sarebbe presa
molto bene. Il partito si sente sotto assedio anche più di quanto non sia ed è
un fatto che quest' ultimo scandalo lo stia colpendo più di altri. Proprio sulle
liste è in corso un'altra discussione tutta interna al partito. Il problema è
che nella scontatissima riconferma di Zaia, che i sondaggi danno al 70%, la
lista del governatore prenderà molti più voti di quella della Lega. Successe già
cinque anni fa, con la lista Zaia al 23 e quella della Lega al 17, ma il 20
settembre prossimo il risultato potrebbe essere ancora più pesante. Per questo
Salvini ha imposto che chi ha fatto l'assessore o il capogruppo debba
ricandidarsi nella lista leghista e non in quella del governatore (che del resto
è fatta tutta di leghisti, per qualche esponente della società civile c'è posto
in una terza lista, detta "degli amministratori"). Paradossalmente, Zaia è
d'accordo. Il popolarissimo governatore non ha il problema di vincere, ma di non
stravincere, almeno questo derby interno: rinfocolerebbe un dualismo con Salvini
che esiste nei fatti, ma che Zaia non ha alcuna voglia di cavalcare. Per la
stessa ragione, raccontano dalle segrete stanze della Lega veneta, tutta la
campagna elettorale del presidente verrà fatta sotto il simbolo della Lega. E
anzi Zaia starebbe dicendo a tutti i suoi fedelissimi di votare e far votare il
Carroccio.
Da iltempo.it il 13 agosto 2020. Sarebbe il deputato Marco
Rizzone il parlamentare del Movimento 5 stelle "colpevole" di aver incassato il
bonus di 600 euro destinato dal governo alle partite Iva in difficoltà per la
crisi da Coronavirus. Lo si apprende da una nota del capo reggente del M5s Vito
Crimi, che scrive: «In Relazione alla vicenda del bonus da 600 euro, destinato
a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito il deputato
Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri chiedendone la sospensione immediata e
massima severità nella sanzione». Domani, intanto, in parlamento andrà in scena
l'audizione sul caso del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che sarà
trasmessa in diretta sulla web tv della Camera.
Marco Rizzone: chi è il 5 Stelle che ha intascato il bonus da
600 euro. Nato nel 1983, è laureato in economia e
commercio ed è un imprenditore del settore turistico. Crimi: "Deferito al
Collegio dei probiviri". Angelo Scarano, Giovedì 13/08/2020 su Il Giornale. E
alla fine arrivò anche il nome del grillino. Dopo la sospensione dei due
deputati leghisti, Murelli e Dara, arriva anche il terzo nome dei furbetti che
hanno preso il bonus Partite Iva. È il pentatstellato Marco Rizzone. Ad
annunciare il nome del pentastaellato che ha incassato l'assegno da 600 euro è
stato il capo politico del Movimento, Vito Crimi: "In relazione alla vicenda del
bonus da 600 euro, destinato a partite Iva, lavoratori autonomi e
professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei probiviri
chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione".
L'annuncio di fatto arriva a poche ore dall'audizione del presidente dell'Inps,
Pasquale Tridico in Commissione Lavoro. Proprio domani il numero uno
dell'Istituto di Previdenza Sociale dirà i nomi dei 5 furbetti che hanno
incassato il bonus. Ricordiamo che 3 lo hanno ricevuto mentre altri due hanno
fatto richiesta. Insomma anche i grillini si scoprono casta. Sono finiti i tempi
del moralismo politico e gli attacchi al Palazzo. Anche tra i pentastellati c'è
chi ha cercato di riempirsi le tasche nonostante lo stipendio da parlamentare.
Marco Rizzone è stato eletto nel collegio uninominale di Genova San Fruttuoso.
Nato nel 1983 , è laureato in economia e commercio ed è un imprenditore del
settore turistico. A Montecitorio fa parte della commissione attività
produttive. Amico di Luigi Di Maio, su facebook in questi mesi ha raccontato la
sua attività politica in questi mesi di emergenza Covid. Un post appare curioso
alla luce dei fatti di oggi e risale a qualche mese fa quando è stato varato il
reddito di emergenza: "I beneficiari di questa misura, fortemente voluta dal
MoVimento 5 Stelle, sono i nuclei familiari (composti anche da una sola persona)
con #ISEE inferiore a 15 mila euro, che potranno ricevere per un bimestre un
importo compreso tra 400 e 800 euro mensili". Sul bonus Partite Iva non ha
scritto nulla perché probabilmente aveva già studiato bene le regole...Adesso
dovrà fare i conti con il suo Movimento che sempre più sta perdendo la matrice
anti-Casta. I Cinque Stelle infatti proprio in questi giorni stanno cambiando
pelle diventando partito. Il voto su Rousseau molto probabilmente metterà la
parola fine al divieto del doppio mandato e soprattutto spianerà la strada ad
alleanze anche su base locale. Il gesto di Rizzone (non l'unico ad aver
incassato nel mondo politico il bonus partite Iva) è il segno di come il Palazzo
abbia radicalmente cambiato i penstastellati. Adesso vogliono mettere le mani
sui bonus pur avendo il portafoglio pieno da parlamentari. Crollano dunque gli
ultimi baluardi del finto moralismo grillino. E probabilmente il tramonto dei
Cinque Stelle e la trasformazione in Casta è solo all'inizio...
Inps, Rizzone (M5S): Ci metto la faccia e prendo mie
responsabilità. (LaPresse il 14 agosto 2020) - "Eccomi
qua, sono pronto a metterci la faccia e ad assumermi le mie responsabilità, ma
anche a mettervi in guardia da chi vi sta gettando fumo negli occhi". Così il
deputato M5S sospeso, Marco Rizzone, su Facebook. "Voglio fare una premessa: pur
non avendo materialmente richiesto io quanto previsto dalla legge per la mia
categoria di partita iva, non incolperò (come hanno fatto altri) il mio
commercialista dicendo che in automatico, sulla scia di altri assistiti, ha
inoltrato la richiesta anche per me. Ne riconosco l’inopportunità e, consapevole
che in ogni caso la responsabilità ultima è solo mia, sono pronto ad assumermela
tutta e fino in fondo, come ho sempre fatto", aggiunge. "Però ora vi assicuro
che pretenderò che si vada fino in fondo su una serie di altre “questioni
morali” anche più serie di questa “leggerezza” e che forse sarebbe il caso di
affrontare nel rispetto di chi ci ha eletti (e chi mi conosce sa che non
demordo)", dice ancora.
Inps, Rizzone (M5S): Non sono disonesto, tiro al piccione mi
disgusta. (LaPresse il 14 agosto 2020) - "Di essere dipinto come un disonesto,
un infame o un ladro però non lo accetto, tantomeno da chi con la sua noncuranza
ha consentito a migliaia di partite iva ben più facoltose di me di richiedere
legittimamente il medesimo bonus". Così il deputato M5S sospeso, Marco Rizzone,
su facebook. "A me questo tiro al piccione - ve lo devo dire - disgusta
parecchio. E sapete perché? Perché significa non farsi il minimo scrupolo nel
mettere alla gogna una persona pur di gettar fumo negli occhi di voi cittadini,
illudervi che la colpa sia di chi in base a una legge dello Stato ottiene un
contributo previsto per la sua categoria e non di chi quella legge è incapace di
scriverla in modo che non vi siano eventuali distorsioni", aggiunge.
Inps, Rizzone (M5S): Comodo cavalcare rabbia in vista referendum.
(LaPresse il 14 agosto 2020) - "È comodo puntare il dito contro qualcuno per
nascondere le proprie mancanze. Ma è ancor più comodo (nonché molto triste)
cavalcare la rabbia delle persone per provare a riprendersi un po’ di consenso
in vista del referendum sul taglio dei parlamentari o delle elezioni
regionali...". Così il deputato M5S sospeso, Marco Rizzone, su facebook.
Inps, Rizzone: Fatto nulla di illecito, decreto è scritto male.
(LaPresse il 14 agosto 2020) - "Qui on è stato fatto nulla di illecito, nulla di
illegittimo. Tutto a norma di legge: un decreto scritto palesemente male (vuoi
per la fretta - giustificabile -, vuoi per l’incapacità di alcuni soggetti - non
giustificabile), un decreto su cui in Parlamento nessuno dei colleghi
“moralizzatori” è intervenuto per apportare modifiche che evitassero che
l’indennizzo fosse dato “a pioggia” a prescindere dal reddito (perché tanto
ormai basta fare propaganda più che buone leggi)...". Così il deputato M5S
sospeso, Marco Rizzone, su facebook.
Inps, Rizzone (M5S): Ci metto la faccia e prendo mie
responsabilità. (LaPresse il 14 agosto 2020) - "Concludo rivolgendomi a tutti
quegli italiani che si sono sentiti in qualche modo delusi da me: non sono come
mi hanno dipinto e lo dimostrerò battendomi perché la grande farsa portata
avanti da tempo da alcuni soggetti politici finisca presto, nel vostro interesse
e nell’interesse del Paese tutto, perché chi pensa di ingannare il popolo con la
caccia alle streghe e il populismo facile non ha capito che i cittadini sono più
svegli di quanto si pensi. Goccia dopo goccia il vaso trabocca...e se è un vaso
di Pandora - prima o poi - qualcuno lo dovrà aprire".
Bonus Inps, Rizzone (M5S): «Non sono né ladro né infame. Da
deputato ho restituito 40mila euro». Silvia Morosi il
15/8/2020 su Il Corriere della Sera. Il deputato grillino sulla vicenda dei 600
euro: «Fumo negli occhi, io ci metto la faccia». E lancia la sfida: «Perché non
pubblichiamo, come già fanno in 17 stati europei, i nomi di chi ha veramente
rubato risorse allo Stato evadendo le tasse?». «Sono pronto a metterci la faccia
e ad assumermi le mie responsabilità, ma devo anche mettervi in guardia da chi
vi sta gettando fumo negli occhi». Il deputato M5s Marco Rizzone rompe il
silenzio e interviene sulla vicenda del bonus da 600 euro richiesto all’Inps che
lo vede tra i protagonisti. «Se avessi voluto intascarmi dei soldi non mi sarei
tagliato più di 40mila euro del mio stipendio da parlamentare», precisa in un
video pubblicato sulla sua pagina Facebook. «È comodo — aggiunge il deputato
genovese — puntare il dito contro qualcuno per nascondere le proprie mancanze.
Ma è ancor più comodo, ma molto triste, cavalcare la rabbia delle persone per
provare a riprendersi un po’ di consenso, magari in vista del referendum sul
taglio dei parlamentari o delle elezioni regionali».
«Un decreto scritto palesemente male». «Questo tiro al piccione a
me disgusta perché significa non farsi il minimo scrupolo nel mettere alla gogna
una persona pur di gettare fumo negli occhi dei cittadini», ha aggiunto. Per il
parlamentare deferito ai probiviri del Movimento è tutta colpa «di un decreto
scritto palesemente male». «Di essere dipinto come un disonesto, un infame o un
ladro non lo accetto. Qui non è stato fatto nulla di illecito, nulla di
illegittimo», conclude, lanciando una sfida ai colleghi parlamentari e allo
stesso Garante della Privacy «che sull’onda del populismo più becero hanno
chiesto di fare i nomi dei parlamentari che hanno ottenuto (ripeto lecitamente)
il bonus. Perché non pubblichiamo, come già fanno in 17 Stati europei, i nomi di
chi ha veramente rubato risorse allo Stato evadendo le tasse?».
Giuseppe Alberto Falci per corriere.it il 14 agosto 2020. Da
qualche giorno Marco Rizzone si era inabissato. Pochi lo avevano sentito e quei
pochi avevano notato qualcosa di strano. «Non era più lo stesso», conferma un
grillino. Come se volesse nascondere qualcosa. E allora non è un caso se il suo
profilo facebook, solitamente aggiornato più di una volta al dì, sia fermo a sei
giorni fa. Ma la prova che fosse lui il grillino che aveva richiesto e ottenuto
il bonus destinato a partita Iva e lavoratori autonomi, i vertici l’hanno avuta
quando si sono accorti che solo due parlamentari non avevano sottoscritto la
liberatoria sulla privacy. E uno di loro era proprio “Marco”, classe ‘83,
genovese come Beppe Grillo, non un’attivista della prima ora, ma uno di quelli
che ha dovuto gareggiare nel collegio uninominale “Liguria-04” con un leghista
come Edoardo Rixi. La sera del 4 marzo del 2018 Rizzone vince per un soffio. Un
risultato, forse, inaspettato. «È uno di quei ragazzi si è ritrovato per caso
parlamentare», racconta un viceministro 5 Stelle. Alle 21 una nota del capo
politico Vito Crimi dà la notizia: «In relazione alla vicenda del bonus da 600
euro, destinato a partite Iva, lavoratori autonomi e professionisti, ho deferito
il deputato Marco Rizzone al Collegio dei probiviri chiedendo la sospensione
immediata e massima severità nella sanzione». Un minuto dopo nelle chat dei
parlamentari si susseguono messaggi di stupore. «Sono sconvolto. Ditemi che non
è vero», si lascia andare un deputato che ha conosciuto in questi due anni
Rizzone, giorno dopo giorno. D’altro canto, quando varca l’ingresso di
Montecitorio si fa notare per il suo carattere, ma anche per le sue intemerate
«mai tenere, ma comunque costruttive». «Polemizzava sulle rendicontazioni.
Poneva questioni del tipo: “Dove vanno i soldi? Da chi vengono gestite?”»,
raccontano. Nel frattempo questo 37 enne di Genova, laureato in economia, con un
dottorato alla prestigiosa Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, amministratore
unico di una start up “Zonzo Fox” che si occupa di tecnologia e dunque titolare
di partita Iva, non versava più nulla al Movimento. Le sue rendicontazioni sono
ferme al novembre del 2019. Non si può definire né vicino a Di Maio, né vicino a
Crimi, né a Fico. Fatto sta che il terzo parlamentare che avrebbe ricevuto il
bonus, assieme ai due leghisti Elena Murello e Andrea Dara, lo scorso 1 aprile
scriveva su Faceboook : «Bastano cinque minuti per richiedere i 600 euro di
bonus Covid per partite Iva e lavoratori autonomi». E poi spiegava per filo e
per segno la procedura: «È velocissimo. In pochi semplici passaggi ti verrà
chiesto di inserire numero di telefono, email e Iban del conto su cui
accreditare la somma». Esattamente la procedura seguita da lui, il promotore
dell’alleanza giallorossa in Liguria, il tessitore del laboratorio della sua
Regione. Perché Rizzone si è messo in testa di unire Pd e Cinquestelle con a
capo della coalizione Ferruccio Sansa. «È stato lui a trattare con Andrea
Orlando», spiegano. Adesso, però, se la dovrà vedere con i probiviri. Ma prima,
sottolinea un collega, «dovrà spiegare la ragione di questa furbata».
"Chiesta sospensione". Bonus ai
deputati, è Marco Rizzone (M5S) l’ultimo parlamentare ad averlo intascato.
Redazione su Il Riformista il 13 Agosto 2020. “In relazione alla vicenda del
bonus da 600 euro, destinato a partite IVA, lavoratori autonomi e
professionisti, ho deferito il deputato Marco Rizzone al Collegio dei Probiviri
chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione”. Lo
dichiara in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Rizzone
si aggiunge ai due deputati della Lega, Elena Murelli e Andrea Dara, sospesi
ieri così come annunciato dal capogruppo della Lega alla Camera Riccardo
Molinari. “Pur non avendo violato alcuna legge – dice Molinari –
è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa
ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento
della sospensione. E’ comunque incredibile che i vertici dell’Inps non abbiamo
versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece
versato a chi non era in difficoltà. In qualsiasi altro paese i parlamentari
sarebbero stati sospesi ma il presidente dell’Inps sarebbe stato licenziato”.
Da iltempo.it il 13 agosto 2020. Sergio Pirozzi è infuriato
perché è venuta allo scoperto la storia dei 600 euro che lo vedono coinvolto. E
a Il Tempo come aveva detto al Fatto quotidiano ha dichiarato che “il terremoto
ha distrutto ha distrutto il negozio, ci siamo rialzati, poi è arrivato il
Covid. Mia moglie rischiava di chiudere e ha chiesto il bonus”. Va aggiunto che
il negozio è proprietà di una S.a.s. intestata a moglie e marito. Nei giorni
scorsi l’ex sindaco di Amatrice aveva così commentato su Facebook la vicenda
riguardante i parlamentari che hanno chiesto il bonus all’Inps: Una brutta
storia, che fotografa bene la distanza che c’è oggi tra una certa politica e le
persone comuni. Io spero che questi 5 vigliacchi, di qualunque partito siano, si
dimettano e chiedano scusa agli Italiani e ai loro sacrifici. Sarebbe doveroso.
Al centro ci sono sempre le persone: se uno è una brava persona lo è da
cittadino e da uomo o donna delle Istituzioni. È questo che fa la differenza.
Sempre”.
Monica Rubino per repubblica.it il 13 agosto 2020. Oltre ai tre
deputati che hanno incassato il bonus Inps destinato alle partite Iva durante
l'emergenza coronavirus - i due leghisti Dara e Murelli e un grillino il cui
nome verrà rivelato domani - e gli altri due onorevoli di Iv e Lega a cui è
stata rifiutata la domanda, ci sono anche circa 2mila amministratori locali che
hanno chiesto e ottenuto il sussidio. La stragrande maggioranza sono sindaci e
consiglieri comunali di piccoli comuni, sui quali non si può gettare addosso la
croce perché la loro attività politica è quasi volontariato. Meno
giustificabili, invece, sono i consiglieri regionali con le loro indennità
mediamente sugli 8mila euro al mese, ma che possono superare anche i 12mila. Tra
questi ultimi si nota una prevalenza della Lega e il leader Matteo Salvini
conferma che non saranno ricandidati nelle regioni prossime alle elezioni. Dei
dieci finora individuati, infatti, otto sono del Carroccio distribuiti in cinque
Regioni. Uno è del Pd, l'altro di Forza Italia. I leghisti sono così ripartiti:
tre in Veneto, due in Piemonte, uno in Emilia Romagna, uno in Liguria e uno in
Lombardia. Quest'ultimo è Alex Galizzi, che ha ammesso di aver intascato l'aiuto
anche se si è giustificato dicendo: "Non lo ricordavo". Il consigliere dem è
piemontese, mentre quello forzista è friulano.
Gli otto della Lega. In Veneto ad aver preso il bonus sono
Riccardo Barbisan, Alessandro Montagnoli e il vicepresidente della Regione
Gianluca Forcolin. Tutti e tre fedelissimi del governatore Luca Zaia, in corsa
per le regionali di settembre e lanciatissimo nei sondaggi. Salvini oggi
ribadisce da Forte dei Marmi: "Abbiamo già deciso, Zaia l'ho sentito, non
saranno ricandidati". E torna ad attaccare il presidente Inps Pasquale Tridico:
"Non ha pagato Cig, cosa aspetta a dimettersi?". Ma il vice di Zaia Forcolin,
intervistato oggi da Repubblica, si è difeso: "Io cacciato dalle liste e Fontana
ancora al posto suo in Lombardia?". Tuttavia, dopo un colloquio con Zaia, tutti
e tre alla fine hanno rinunciato alla candidatura, evitando la pubblica
"decapitazione". In Piemonte i due consiglieri del Carroccio percettori del
bonus sono Matteo Gagliasso, 27 anni compiuti da poche settimane, di Alba, e
Claudio Leone 53 anni, di Rivarolo Canavese. Tutti e due sono stati eletti per
la prima volta in Consiglio regionale un anno fa in coincidenza con la vittoria
del centrodestra che ha portato al governo della Regione Alberto Cirio. Sia
Leone sia Gagliasso sono entrambi detentori di partita Iva. Hanno già restituito
gli importi all'Inps, ma la restituzione non li ha salvati dalla sospensione dal
partito, decisa oggi. In Emilia Romagna il leghista sotto accusa è Stefano
Bargi, 31enne di Sassuolo. Assieme ad altri due soci è proprietario di un locale
a Maranello, il Beer Stop, ed è iscritto a un'associazione di categoria che ad
aprile ha fatto la richiesta di bonus per tutti e tre. Il bonus gli è arrivato
ad aprile e a maggio e ha investito quei soldi per riavviare il locale colpito
dallo stop dovuto al lockdown. In mattinata Matteo Rancan, capogruppo leghista
in Regione ha annunciato la sua "sospensione dal partito". In Liguria il
consigliere regionale uscente Alessandro Puggioni, 51 anni di Rapallo, si è
autodenunciato e ha deciso di autosospendersi dalla Lega, partito in cui milita
dal 1995. Puggioni si è "auto-sospeso" e ha annunciato di volere rinunciare
alla candidatura alle regionali di settembre. In Lombardia, come accennato, Alex
Galizzi, consigliere regionale della Val Brembana e titolare della Brembo
informatica, ha ricevuto il bonus assieme a un socio. Ma nel difendersi critica
la legge: "Me ne ero dimenticato. Bastava mettere un limite sul reddito
dell'anno precedente e non ci sarebbero stati problemi".
Il consigliere piemontese del Pd. In Piemonte il consigliere dem
Diego Sarno dà la colpa alla compagna e parla di "un errore di
sottovalutazione". In un post su Facebook scrive: "La mia compagna fa questo di
lavoro da sempre gestisce la contabilità riguardante la mia attività
professionale. Durante il lockdown, per provare diverse procedure ha usato la
sua partita Iva e anche la mia (avendone due tipologie diverse) così da essere
pronta per assolvere senza errori e con una maggiore velocità le molte procedure
gestite per i clienti dello studio nel quale lavora". Una semplice "prova" per
testare il funzionamento del sistema e il procedimento. Prova, però, finita
male. Per "espiare" la sua colpa, Sarno annuncia che devolverà sei mesi di
stipendio ai lavoratori danneggiati dal coronavirus.
Il consigliere-albergatore di Forza Italia. In Friuli Venezia
Giulia Franco Mattiussi, 62 anni, albergatore e consigliere regionale di Forza
Italia (è vicecapogruppo azzurro), ha confermato in un lungo post su Fb di aver
incassato il bonus per due volte, utilizzando i soldi "per pagare le bollette"
nei suoi due alberghi-ristoranti che per il lockdown "hanno accumulato perdite
pari a 300mila euro. Anche lui affida la sua difesa a Facebook: "I parlamentari
così come Sindaci e consiglieri regionali vari ed eventuali - che hanno
richiesto il bonus Inps non hanno rubato nulla" ma soltanto "hanno esercitato un
loro diritto. Hanno, in un certo senso, profittato di una norma che lo
consentiva. L'avere partita Iva presuppone l'esistenza di un lavoro autonomo
parallelo alla figura politica ricoperta".
Il caso di Sergio Pirozzi (Fdi) nel Lazio. Nel Lazio spunta il
nome del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sergio Pirozzi, ex sindaco
di Amatrice ai tempi del terremoto, eletto nel consiglio del Lazio come
indipendente di centrodestra e passato a gennaio 2020 con Fdi. Il suo ufficio
stampa smentisce e spiega che il sussidio è stato chiesto dalla moglie
commerciante di Pirozzi, la quale è titolare di un'edicola ad Amatrice. Poi è lo
stesso Pirozzi che si difende in prima persona: "Non ho beneficiato del bonus
richiesto da mia moglie Teresa autonomamente per mandare avanti la piccola
edicola che gestisce ad Amatrice. Né avrei potuto impedire che effettuasse una
legittima richiesta per far sopravvivere la sua attività". E annuncia querele
contro chiunque tenti di mettere la posizione di sua moglie "sullo stesso piano
di quella dei politici eletti che, in via diretta hanno approfittato delle gravi
lacune che di questa legge, fatto che ho apertamente e pubblicamente condannato
fin dal primo momento in cui è emersa la vicenda". Su Facebook, infatti, Pirozzi
tre giorni fa aveva scritto: "Una brutta storia, che fotografa bene la distanza
che c'è oggi tra una certa politica e le persone comuni. io spero che questi 5
vigliacchi, di qualunque partito siano, si dimettano e chiedano scusa agli
italiani e ai loro sacrifici. Sarebbe doveroso. Al centro ci sono sempre le
persone: se uno è una brava persona lo è da cittadino e da uomo o donna delle
Istituzioni. + questo che fa la differenza. Sempre".
Da stylo24.it il 13 agosto 2020. Il suo nome è comparso nelle
ultime righe di un articolo del Corriere della sera. Ingiustamente sospettata di
aver incassato i 600 euro del bonus Covid e per questo additata all'opinione
pubblica nazionale. Michela Rostan, parlamentare di Italia viva – partito a sua
volta indicato nella prima fase come coinvolto nello scandalo sul sussidio e poi
scagionato del tutto – in questa intervista a Stylo24 annuncia la possibilità di
portare l'Istituto nazionale di previdenza, presieduto da Pasquale Tridico, in
tribunale per la fuga di notizie (false) che hanno rischiato di disintegrarne la
reputazione.
Onorevole Michela Rostan, si è letto il suo nome sul Corriere
della sera rispetto alla vicenda del Bonus Covid ai parlamentari, lei ha subito
smentito con fermezza.
«Come ho detto al giornalista e come
ho ribadito alle agenzie non ho mai chiesto il Bonus Covid per i lavoratori
autonomi e considero una indecenza il fatto che chi non avesse bisogno ne abbia
fatto richiesta e lo abbia ottenuto. Ho messo a disposizione tutti i miei dati
personali, chi vuole può controllare. Chiedo però anche all’Inps di fare
chiarezza. Considero una barbarie questa caccia alle streghe, alimentata
evidentemente da qualcuno. Istituzioni e mass media dovrebbero avere un sussulto
di dignità e comportarsi in maniera più responsabile. Potrebbero anche arrivare,
a questo punto, all’indirizzo dell’Inps e di alcuni giornali delle richieste di
risarcimento dei danni, visto che è stata lesa l’onorabilità di chi, come me, è
stato tirato in causa senza alcun motivo. Nel mio caso, devolverei tutto proprio
ai lavoratori autonomi e alle giovani Partite Iva in difficoltà».
Qualcuno ha legato questa fuga di notizie a una manovra, a cui
non sarebbe estraneo il vertice dell'Inps, per fomentare una nuova ondata di
populismo anti-casta in vista del referendum sul taglio dei parlamentari. È
d'accordo? Qual è la sua posizione sul referendum?
«Non so cosa ci sia dietro questa
vicenda. Certamente è grave che un parlamentare chieda un sussidio nato come
sostegno al reddito per chi era in difficoltà durante la pandemia. Com’è grave
che lo abbiano chiesto, e ottenuto, anche altre categorie professionali che non
avevano questa necessità. Fermo restando la necessità di rispondere dei propri
comportamenti, forse anche il meccanismo stesso di quel bonus era sbagliato, non
avendo previsto neppure un’autocertificazione sul reddito. Di sicuro questa
polemica ridà fiato al populismo contro le istituzioni e questo potrebbe aiutare
il fronte del Sì nel referendum di settembre, che appare oggettivamente in ombra
anche perché il tema non è così cruciale per le sorti del Paese. Io penso che il
taglio dei parlamentari non debba essere un tabù, si può lavorare anche con meno
rappresentanti dei cittadini. Ma quel taglio andava inserito in un progetto
complessivo di riforma delle istituzioni, tipo il bicameralismo perfetto, e
della legge elettorale. Tutto questo non è stato fatto».
Fino a che punto si può fare politica con l'antipolitica?
«C’è un brutto clima, sicuramente.
Si discute sempre meno dei temi, delle soluzioni, delle questioni aperte nel
Paese, mentre si rincorrono slogan, questioni secondarie, propagande di odio e
di qualunquismo che rischia di erodere il tessuto democratico. Il rischio è per
tutti».
Italia viva e il suo leader, Matteo Renzi, hanno un dna
politico fatto di garantismo: quanto è difficile essere garantisti in un mondo
politico in cui il sospetto diventa l'anticamera della verità?
«Giustizialismo è la somma della
cattiva giustizia con il cattivo giornalismo. Vengono distrutte le reputazioni
delle persone, a volte, senza che ci sia non dico una condanna di primo grado ma
neppure un rinvio a giudizio. Le carte dell'accusa sono le sole che interessano
ai giornali, i quali rinunciano a qualunque approfondimento critico sul lavoro
degli inquirenti, non seguono i procedimenti, non danno voce alla difesa, si
dimenticano di udienze e processi e siglano sentenze a mezzo stampa senza
neppure sentire il dovere di ascoltare la voce dell'accusato. In questo
tritacarne ci può finire chiunque. È un dramma democratico, che chiama in causa
molti attori. Dovremmo, come ho già detto, avere un sussulto di dignità e
responsabilità, ciascuno per la propria funzione. A rischiare è la democrazia
nel suo insieme. Giustizialismo è la somma della cattiva giustizia con il
cattivo giornalismo. Vengono distrutte le reputazioni delle persone, a volte,
senza che ci sia non dico una condanna di primo grado ma neppure un rinvio a
giudizio. Le carte dell’accusa sono le sole che interessano ai giornali, i quali
rinunciano a qualunque approfondimento critico sul lavoro degli inquirenti, non
seguono i procedimenti, non danno voce alla difesa, si dimenticano di udienze e
processi e siglano sentenze a mezzo stampa senza neppure sentire il dovere di
ascoltare la voce dell’accusato. In questo tritacarne ci può finire chiunque. È
un dramma democratico, che chiama in causa molti attori. Dovremmo, come ho già
detto, avere un sussulto di dignità e responsabilità, ciascuno per la propria
funzione. A rischiare è la democrazia nel suo insieme».
Bonus in beneficenza, la generosità non si dimostra con i
soldi degli altri. Notizie.it il 12/08/2020. Chi
sostiene di aver preso i 600 euro di bonus per darli in beneficenza si è
arrogato il diritto, che dovrebbe essere unicamente dello Stato, di stabilire la
priorità delle persone da aiutare. Dopo lo scandalo dei parlamentari e dei
consiglieri regionali e comunali che hanno richiesto il bonus pur non avendone
evidentemente bisogno, anche se diritto, molti di loro si stanno giustificando
sostenendo di averli presi per poi darli in beneficenza. In realtà già durante
il lockdown e immediatamente dopo avevo sentito molti fra amici e conoscenti
che, avendone anche loro diritto benché non bisogno, avevano detto di voler
richiedere (non so se poi lo abbiano fatto) il bonus per darlo in beneficenza.
Sentendosi come dei novelli Robin Hood, hanno pensato di “togliere” (purtroppo
non si può dire “rubare”, perché appunto ne avevano diritto) allo Stato per dare
ai poveri. Senza, però, rendersi conto che così facendo stavano comunque
sottraendo risorse a chi ne aveva bisogno: se costoro non avessero chiesto il
sussidio, lo Stato avrebbe avuto ad esempio maggiori fondi a disposizione per
poter riconoscere una cifra più alta quale sussidio. E proprio sull’iniquità
della cifra stabilita dal Governo hanno tuonato a gran voce i partiti da cui
provengono alcuni dei politici che hanno richiesto e ottenuto il bonus. Ma
soprattutto i politici arraffoni non si sono resi conto che, così facendo, sì
stavano arrogando il diritto, che invece dovrebbe essere unicamente dello Stato,
di stabilire la priorità delle persone da aiutare. Se necessitassero di maggiore
sostegno i liberi professionisti o i dipendenti, i disoccupati o gli occupati
sarebbe dovuta essere, infatti, una scelta effettuata in base a un’analisi di
priorità e non del sentimento personale dei singoli individui, che possono
sentirsi, per diverse ragioni, più vicini a una categoria piuttosto che a
un’altra. Vicinanza che, peraltro, potrebbe poi tramutarsi in bacino di voti,
visto che ciascun politico attinge il proprio consenso elettorale soprattutto
dagli ambienti, professionali e sociali, che gli sono più vicini e di cui
promette di farsi portavoce. E allora, più che beneficenza, sarebbe propaganda.
Ma la beneficenza, così come la propaganda, si fa con i soldi propri, non certo
quelli degli altri, a maggior ragione se gli altri sono i cittadini che
bisognerebbe rappresentare. Ovviamente costoro dovranno ora dimostrare di aver
effettivamente effettuato i bonifici e di averlo fatto ben prima del sorgere
dello scandalo, altrimenti sarà facile pensare che si tratti soltanto di un
escamotage per uscire dall’imbarazzo di essere stati sgamati con la mano nella
marmellata. Mentre lo Stato dovrà mostrarsi capace di stabilire meglio in che
modo distribuire i soldi ai propri cittadini, altrimenti finirà per legittimare
chi si sente impropriamente in diritto di stabilire una propria, personalissima,
classifica dei bisognosi. Perché, se c’è qualcosa che questo scandalo ha
dimostrato, è indubbiamente quanto i soldi siano stati distribuiti male, con
l’obiettivo di non scontentare nessuno, ma scontentando tutti.
Cumula pensione d’oro e stipendio statale: storia di un
consigliere grillino del Csm. Paolo Comi su Il
Riformista il 12 Agosto 2020. I grillini e Marco Travaglio sono furiosi nei
confronti dei politici che hanno ricevuto, dopo averne fatto domanda, il bonus
da 600 euro. Degli “accattoni” che hanno “arraffato” con la scusa
del Covid-19 la somma destinata a chi era in difficoltà, ha dichiarato ieri nel
suo editoriale il direttore del Fatto. Pur non avendo violato nessuna norma se
non quella “dell’etica e della decenza”, ha aggiunto Travaglio, questi
personaggi devono comunque essere “cacciati” dal Parlamento in quanto persone
“senza cuore, buon senso e buon gusto”. Nessuno da quelle parti, tutto preso
dalla rinnovata foga anticasta, ricorda cosa accadde nella scorsa consiliatura
del Csm allorquando un laico grillino, utilizzando le leggi previste, pressoché
raddoppiò dall’oggi al domani il proprio emolumento mensile. Questa la storia.
Il consigliere in questione era un docente universitario di ruolo. I grillini, a
cui spettava di indicare al Parlamento un nome per il Csm, lo avevano scelto per
quell’incarico con il sistema del voto online. Appena varcata la soglia
di Palazzo dei Marescialli, il neo consigliere venne collocato dal suo ateneo in
posizione di “fuori ruolo”, percependo lo stipendio da docente a cui sommava le
indennità per i componenti dell’Organo di autogoverno della magistratura. La
legge sul funzionamento del Csm prevede, infatti, per membri eletti dal
Parlamento che siano dipendenti della Pubblica amministrazione, un doppio
binario: rimane “a carico dell’Amministrazione di appartenenza l’onere inerente
il trattamento di cui risultino già provvisti” e “a carico dell’Amministrazione
della giustizia l’eccedenza spettante in quanto consiglieri del Csm”. Durante la
consiliatura, il professore grillino decise di andare in pensione, con ben sette
anni di anticipo rispetto all’età prevista per i docenti universitari fissata a
70anni, in quanto aveva maturato l’anzianità contributiva necessaria. Il Csm,
allora, iniziò a versargli per intero l’assegno spettante per i consiglieri,
pari a quello di un parlamentare. Assegno a cui l’ex professore “sommava”,
quindi, la pensione dell’università. Al Csm pare non valere la norma secondo cui
chi è titolare di una pensione, se vuole svolgere incarichi per la pubblica
amministrazione, deve farlo gratuitamente. Il caso sollevò, all’epoca, accese
discussioni al Csm. In una seduta di Plenum il laico Antonio Leone, già vice
presidente della Camera, chiese se questo “cumulo”, per di più da parte di chi
era stato eletto da un movimento che lottava contro i “privilegi”, fosse
ammesso. Erano anni quelli in cui i grillini, con il loro capo politico Luigi Di
Maio, stavano combattendo la battaglia della vita contro le “pensioni d’oro” e
le “maxi retribuzioni”. Gli allora vertici di piazza Indipendenza risposero che
era stato formulato un quesito all’Inps e che era tutto perfettamente
“regolare”. Nessuna violazione. Il caso, evidentemente, sarà sfuggito a
Travaglio e ai grillini oggi tanto indignati.
Il populismo è diventato l’ideologia unica. Scandalo bonus,
l’Inps usata a fini politici è la vera corruzione.
Piero Sansonetti su Il Riformista il 14 Agosto 2020. Ma ora dovete beccare
quelli dei monopattini. Sennò è sleale. Mi spiego meglio. Siamo tutti d’accordo,
mi pare, su una cosa: che quei deputati e quei consiglieri regionali che hanno
preso il bonus previsto per i lavoratori a partita Iva sono dei veri felloni. Fa
bene il Fatto Quotidiano, unico giornale che ha davvero la spina dorsale (da
quando non si stampa più il Popolo d’Italia) a raccogliere le firme per chiedere
che il governo tiri fuori i nomi e li esponga in piazza. Giusto? Però… Però non
ha torto neppure Forcolin. Chi è Forcolin? Fino a ieri era il vicepresidente
del Veneto, ma ora si è dimesso perché è finito nel pantano di questo
scandalo. Zaia, il Presidente, leghista come lui, gli ha detto che non lo
ricandiderà alle prossime elezioni e ora Forcolin, che è ancora giovane, rischia
di vedere distrutta una carriera politica che poteva diventare radiosa:
distrutta per 600 euro che ha dovuto oltretutto dividere con altri cinque o sei
soci della sua piccola azienda. A lui saranno andati si è no 100 euro una
tantum, e Forcolin è uno che guadagna circa 8000 euro al mese per l’incarico in
regione più i profitti della sua azienda ora sussidiata col bonus. Può un
cristiano, perlopiù di successo, andare in rovina per cento miserrimi euro? Beh,
Forcolin comunque ha ragione a rilanciare. Dice: scusate, ma perché ve la
prendete tutti con noi che abbiamo preso questo bonus Iva e non ve la prendete
coi deputati e i senatori (pare soprattutto 5 Stelle) che hanno preso il bonus
monopattino, e il bonus bicicletta, e il bonus automobile e soprattutto (lì si
tratta di decine e decine di migliaia di euro) il bonus ristrutturazione?
Secondo voi un deputato che guadagna 12 o 13 mila euro al mese ha bisogno
dell’aiuto dello Stato per comprarsi un monopattino? O per ristrutturare casa? È
vero anche che la legge lo consente, e quindi perché mai se un deputato volesse
comprarsi un monopattino non dovrebbe prendere il bonus? La risposta è unanime:
per ragioni morali. O il moralismo si ferma a Forcolin o alla Elena Murelli,
deputata della Lega che oltretutto in un recente intervento alla Camera definì
“mancia” quei poveri 600 euro? A me hanno spiegato che la legge permetteva ai
deputati di prendere il bonus ma siccome i deputati hanno un buono stipendio e
non hanno bisogno di aiuti, la legge morale (credo quella di Kant, che è dentro
di noi) impone di non prenderli. E perciò vanno messi alla gogna i deputati e i
consiglieri regionali che lo hanno preso o anche solo chiesto. Benissimo. Ma
forse i deputati hanno bisogno del bonus per comprare un monopattino? O per
comprarsi una bici, o per ristrutturare casa e mettere i pannelli solari sotto
il cielo stellato (che è sopra di noi…)? Dunque, se le cose stanno così, ci
aspettiamo che Il Fatto riprenda la raccolta delle firme e chieda che sia fatta
una indagine per accertare chi sono e quanti sono i deputati che hanno
approfittato dei vari bonus. E poi i governatori, e poi i consiglieri regionali
e via via… Fino ad ottenere una catena di dimissioni dal Parlamento e dalle
regioni. Centinaia, centinaia, centinaia. Usciamo dallo scherzo. Ma poi non è
uno scherzo perché gli argomenti di Forcolin sono ragionevolissimi. Oggi
il presidente dell’Inps Tridico risponderà alla Camera dei deputati che gli
chiederanno, immagino, non solo i nomi ma perché è stata violata la privacy
visto che non c’era stata nessuna frode e nessun tentativo di frode. L’Inps
forse è diventato un ente morale che detta le norme di comportamento coerenti
con l’Etica di Stato e poi provvede ad applicarle e a indicare al ludibrio
pubblico i trasgressori? Oppure l’Inps, essendo caduto in mano ai 5 Stelle,
segue disciplinatamente la politica dei 5 Stelle e dunque piega la sua vocazione
di previdenza e di assistenza in missione giustizialista? Non è mica un problema
formale. Noi stiamo assistendo in questi anni a un uso di pezzi di Stato – in
primo luogo, ovviamente, la magistratura – a fini politici di parte come non si
era mai visto in passato, se non forse ai tempi del fascismo. Il grado della
vera corruzione pubblica è salito enormemente da quando il populismo è diventato
l’ideologia unica. La corruzione non è tanto prendere una tangente: lì non fai
un gran danno. Quella è piccola corruzione, non si mina con una tangente
l’autorevolezza dello Stato né tantomeno si mina lo Stato di diritto. La
corruzione vera è quando usi lo Stato per combattere i nemici. Con le inchieste
della magistratura, con le interdittive, con i sequestri dei beni (leggetevi la
storia di quella azienda siciliana della quale parliamo oggi in prima pagina e a
pagina 7) e ora anche con l’Inps, oltre che con l’uso disinvolto dei giornali e
delle Tv. Lo Stato che promuove il giustizialismo trasformandosi in struttura
non più di diritto ma di propaganda. Cosa fanno quei magistrati che aprono
inchieste a raffica, senza reato, senza indizi, solo per cercare notorietà?
Propaganda. E cosa faceva il ministro dell’Interno quando usava il dramma
dell’immigrazione e la struttura del ministero dell’Interno, per guadagnare
voti? E cosa sta facendo l’Inps? E cosa fa il tribunale dei ministri che vuole
trasformare in reati le scelte (a mio giudizio sciagurate) di Salvini sul blocco
dei porti? Questa è la corruzione. Per l’Italia sta diventando un problema
gravissimo, e i danni di quel che sta succedendo possono diventare
irreversibili. Il passaggio dal Diritto alla Propaganda. Che è l’anticamera del
passaggio dallo Stato di Diritto allo Stato Etico. Sono solo i 5 Stelle e
la Lega a guidare questa rincorsa reazionaria? No, altrimenti non riuscirebbero
a vincere. Invece stanno vincendo perché il Pd li insegue, FdI li scavalca e gli
altri partiti restano imbambolati, impauriti. P.S. Ho fatto un calcolo sulle
origini geografiche dei deputati e dei consiglieri regionali fin qui coinvolti:
3 sono del Veneto, 3 del Piemonte, 2 sono emiliani, uno ligure, uno
della Lombardia e un friulano. Oddio. Mi sono immaginato cosa si sarebbe detto
se fossero stati 5 siciliani, tre calabresi, due di Napoli e uno di Brindisi. Vi
immaginate Salvini? Vi immaginate i giornali del Nord? Beh, un pochino pochino a
me viene da ridere…
Società civile assolta e politici alla gogna: il populismo
all’italiana. Paolo Delgado su Il Dubbio il 13 agosto
2020. La Lega ha sospeso i deputati Murelli e Dara perchè sono tra quelli che
hanno incassato i bonus. Ma nessuno si scandalizza delle centinaia di notai che
hanno preso i 600 euro nonostante gli incassi da favola. Alla fine l’Inps
comunicherà a una folla assetata di severa punizione i nomi dei tre reprobi che,
pur godendo dello stipendio di parlamentari, hanno chiesto e ottenuto a
differenza di altri due colleghi a cui è stato negato, il bonus di 600 euro
mensili, passati poi a mille tondi. Intanto la Lega ha sospeso i deputati
Murelli e Dara perchè sono tra quelli che hanno incassato i bonus. Pur se del
tutto legittima la richiesta non è stata precisamente un bel gesto e un certo
grado di indignazione è in questo caso giustificato. Negli ultimi tre giorni,
però, si è prodotto nel Paese un clima che è andato ben oltre i confini della
comprensibile e legittima indignazione. Una sorta di caccia alle streghe che
dallo sparuto drappello di parlamentari si è allargato ai consiglieri comunali,
senza tener conto della spesso enorme differenza di stipendi. Il particolare è
considerato secondario dal momento che sempre di politici si tratta e che si
portino a casa un gettone da mille euro o una busta paga da 12mila che spesso
lievita poi intorno ai 18mila, cosa cambia? Ci sono state autodenunce, impegni a
espiare evitando la ricandidatura, messe all’indice, cancellazioni preventive
dalle future liste. Come se nulla fosse è stato chiesto a voce stridula di
ignorare la Costituzione costringendo i 3 deputati a restituire il maltolto (
che in realtà non è tale, almeno a termini di legge) con norma retroattiva. Si è
invocata una impossibile costrizione alle dimissioni. Complice la campagna
referendaria sulla riforma costituzionale, i 5S non hanno esitato a sbandierare
l’efferato delitto come prova della turpitudine del Parlamento, svelando così il
carattere compiutamente antiparlamentare sia della riforma che del correlato
referendum. E’ indicativo che a questa furia, non solo popolare ma altrettanto
diffusa tra i politici e i giornalisti, nei confronti dei deputati e consiglieri
comunali o regionali non si sia accompagnato nessuna reazione scandalizzata a
proposito delle altre categorie. Le notizie fatte filtrare in maniera opaca e
poco accettabile dall’Inps parlavano di 5 deputati e di un noto conduttore
televisivo. Nessuno ne ha reclamato il nome. Nessuno se l’è presa, pur sapendo
che in linea di massima gli emolumenti dei “noti conduttori” vanno ben oltre
quelli dei parlamentari, per non parlare dei consiglieri comunali. E’ noto da
mesi, pur se mai ufficialmente quantificato, che nelle categorie professionali
la percentuale di quanti che hanno battuto cassa invocando un bonus del quale
non avevano bisogno va ben oltre quella, in realtà molto esigua riscontrata fra
i parlamentari. In fondo a chiedere quei 600 euro sono stati in 5 su mille, pari
appunto allo 0,5%, percentuale che scende, considerando quelli che il bonus lo
hanno effettivamente incassato, allo 0,3%. Corre voce che tra i notai ad
avanzare la quella richiesta siano stati in centinaia. Tenendo conto del fatto
che i notai sono una professione a numero chiuso, sono in tutto 5.115, e che di
conseguenza si tratta anche di quella più lucrosa, il dato dovrebbe suscitare
quantomeno un qualche disappunto. E’ poi il segreto di Pulcinella che molte
aziende abbiano usufruito della cassa integrazione, ma senza ritenersi di
conseguenza obbligate a non far lavorare i dipendenti cassintegrati. Un bel
risparmio, lo si riconosca. La stessa giustificazione accampata dalla
viceministra Castelli per spiegare la totale assenza di condizioni nella
distribuzione del bonus, “Dovevamo fare presto”, non è stata confutata quasi da
nessuno ricordando alla viceministra che nel caso del reddito di emergenza non è
stata avvertita alcuna esigenza di fare presto e le condizioni sono state
pensate freddamente per impedire a molti degli aventi diritto di incassare quei
400 euro una tantum. Nessuno o quasi se l’è presa a male di fronte a quest’onda
gigantesca sulla cresta della quale figurano come trascurabile schiuma quei
cinque deputati. Nessuno ha reclamato chiarimenti, invocato punizioni esemplari,
puntato l’indice. E’ il frutto di un decennio e oltre nel quale i politici sono
stati descritti come una combriccola di inutili mangiapane a tradimento, ceto
parassitario nella migliore delle ipotesi, corrotto e venefico nella peggiore.
Se un notaio chiede e ottiene il bonus, la cosa appare certamente disdicevole ma
si ferma lì. Se a fare la stessa cosa è un politico la colpa si somma a quella
di essere, appunto, un politico. Diventa la goccia che fa traboccare il vaso, il
particolare lercio che getta una luce acquitrinosa su tutto il resto,
l’occasione per cogliere una a lungo attesa vendetta. Difficile immaginare una
temperie politica più infida e pericolosa.
Stasera Italia, ira per le parole di Federico Rampini: "Gli
statali fannulloni, con lo smart working non hanno fatto nulla".
Libero Quotidiano il 06 agosto 2020. Rabbia per la puntata di
mercoledì 5 agosto di Stasera Italia. Il dirigente pubblico Alfredo Ferrante se
la prende con Veronica Gentili e Carlo Cottarelli. Il motivo? Aver riso alle
parole di Federico Rampini. Il giornalista, in collegamento con Rete Quattro, ha
sparato a zero sui dipendenti pubblici: "Bisogna fare pulizia dei sabotatori
della rinascita italiana - ha esordito -. Andiamo a guardare cos'è stato il
crollo della produttività dei lavoratori pubblici che si sono fatti a casa il
lockdown con il cosiddetto smart working". E ancora senza pietà: "Il significato
di 'smart working' è 'lavoro intelligente', questi già non facevano un lavoro
intelligente prima, figuriamoci ora". Per Rampini molti di loro si sono fatti
"le vacanze a casa, il lockdown è diventato un alibi per i lazzaroni". Il
giornalista smaschera la vergogna dello Stato, visto che gli statali hanno lo
stipendio assicurato senza fare nulla, mentre i lavoratori normali no. Le
reazioni non si sono fatte attendere. Ferrante ha rilanciato l'intervento
commentando: "Le parole vergognose di Federico Rampini sui lavoratori in
smartworking sono indegne: populismo a un tanto al chilo. Questo sarebbe
giornalismo? Il tutto mentre la conduttrice Veronica Gentili e l'immarcescibile
Carlo Cottarelli se la ridono allegri. Trasecolo".
My dear Mr. Rampini. Alfredo
Ferrante per linkiesta.it il 6 agosto 2020. Caro Rampini, non è la prima volta
che mi capita di scrivere qualche riga indirizzata a illustri opinionisti della
carta stampata per ribattere a esternazioni in materia di lavoro pubblico e PA:
l’Italia, d’altronde, è il Paese dei 60 milioni di CT della Nazionale e di
luminari del funzionamento delle amministrazioni pubbliche. In ogni caso, come
sibilava Humphrey Bogart ne “L’ultima minaccia” (1952), è la stampa, bellezza:
libero diritto di critica, conseguente ampio diritto di replica. It’s a free
country, come usano dire dalle Sue parti. Spero vorrà allora seguirmi mentre
dedico qualche minuto delle mie ferie a fare le pulci ad alcune delle
dichiarazioni da Lei rese nel corso della trasmissione “Stasera Italia News”, in
onda su Rete 4 lo scorso 3 agosto, che meritano, per diversi motivi, una qualche
attenzione. Veda, caro Rampini, poiché Lei ha parlato di “sabotatori della
rinascita Italiana” (modello collaboratori dei nazifascisti, ad occhio e croce)
e del “crollo della produttività, già bassissima, di tanti statali, di tanti
pubblici dipendenti, che si sono fatti il lockdown a casa col cosiddetto smart
working”, vorrei chiederLe conto dei dati e delle evidenze sui quali basa tali
affermazioni. Immagino che, prima di sparare ad alzo zero sull’operato di così
tante persone, si sarà attentamente documentato prima della trasmissione,
consultando con pignoleria le analisi e le percentuali più aggiornate messe a
disposizione da università e centri di ricerca pubblici e privati. La mia
domanda, dunque, è: quali fonti ha consultato, esattamente? È in grado, egregio
dottor Rampini, di citare un qualche studio che possa suffragare tali
affermazioni così tranchant? Glisserei, per carità di Patria, sulla lamentata
pretesa di spendere i mesi di confinamento a casa da parte dei dipendenti
pubblici: probabilmente nelle lontane terre americane in cui Lei spende buona
parte del suo tempo non è pervenuta la sconcertante notizia che un atto con
forza di legge ha stabilito che, nei mesi di emergenza sanitaria, il lavoro
agile fosse la modalità ordinaria di lavoro nella pubblica amministrazione. Non
un ghiribizzo di qualche sfaccendato travet, dunque, ma una disposizione del
Governo per arginare il diffondersi del contagio. Stranezze tutte italiane,
forse. Ma andiamo oltre. Ho molto poco burocraticamente inarcato un
sopracciglio, scuotendomi dal mio usuale stato atarassico, nell’udire il
prosieguo del Suo ragionamento, quando, a proposito di smart working (o lavoro
intelligente, come da Lei prontamente tradotto), ha sostenuto che “questi (sic!)
già non facevano un lavoro intelligente prima, hanno lavorato ancora meno, ancor
peggio”, con “tanti di loro che hanno fatto delle vere e proprie ferie a casa”.
Al netto del rischio di dover riconoscere delle corpose royalty a Pietro Ichino,
che ha avuto modo di precederLa nella propalazione di una simile argomentazione,
mi sono chiesto – con una buona dose di impudenza, lo ammetto – come facesse ad
essere così dettagliatamente informato circa le modalità con cui centinaia di
migliaia di lavoratori pubblici (e privati!) hanno impiegato le ore di lavoro a
casa nei mesi del confinamento. La mia personale esperienza è stata oltremodo
positiva, e di questo ringrazio chi lavora con me, ma forzatamente circoscritta
alla mia cerchia esperienziale. Comprenderà, dunque, il mio sordo stupore
nell’apprendere che, pur non vivendo in Italia, Lei ha, tuttavia, “raccolto le
lamentele, i pianti, le urla di decine di amici” che sta incontrando nel Bel
Paese “per il livello vergognoso cui è precipitata l’improduttività della
pubblica amministrazione”. Provo, con una certa audacia, a tradurre: i Suoi
venti o trenta (quaranta e lascio?) amici, povere anime ululanti al pari dei
protagonisti di una tragedia shakespeariana, rappresentano, a Suo dire, un
campione statistico a tutti gli effetti. All right, man. Imbarazzo a parte,
arriviamo, tuttavia, al climax del Suo intervento. Mentre il dottor Carlo
Cottarelli e la padrona di casa, Veronica Gentili, beatamente se la
ridacchiavano, ecco l’affondo: “Il lockdown è diventato un alibi per un esercito
di lazzaroni, a loro lo stipendio non glielo nega mai nessuno, mentre ci sono
milioni di Italiani che in questo momento vivono in un’incertezza tragica.
Quelli lì –“quelli lì”? – quando stanno a casa e non fanno un beato niente, lo
stipendio lo incassano, quindi va bene cacciare il Presidente dell’INPS, ma poi
occorre cacciare a fare pulizia di tutti i dirigenti e quadri che non sono
capaci di far lavorare i loro collaboratori”. Caro Rampini, Lei può naturalmente
sostenere tutto ed il contrario di tutto, quando e dove vuole. Tuttavia, quel
che trovo stupefacente è l’aperto, gratuito disprezzo mostrato verso quelle
lavoratrici e quei lavoratori del settore pubblico che, in condizioni difficili
e molto spesso con mezzi propri, hanno assicurato la continuità amministrativa
pur non potendo recarsi in ufficio. Un furore ideologico testimoniato da un
linguaggio sprezzante e, cosa assai più grave, da casistiche da Bar dello Sport.
Da inveterato burocrate, ho il brutto vizio di leggere le carte e formulare
ipotesi attendibili prima di pronunciarmi: da un giornalista professionista mi
aspetterei, parimenti, ragionamenti basati su dati e circostanze documentati, su
cui costruire tesi, analizzare i problemi, offrire, se del caso, soluzioni.
Urticanti magari, ma solide. La PA Italiana è un paradiso? Ma niente affatto! I
problemi sono molti e radicati, in larga parte derivanti dall’utilizzo
spregiudicato che della macchina pubblica ha fatto nel tempo tanta parte della
politica, ed è incombenza di tutti, in primis di chi ha responsabilità pubbliche
e amministrative, rimboccarsi le maniche e fare di tutto perché, in ultima
analisi, cittadini e imprese abbiano i servizi cui hanno diritto. Lei sostiene,
peraltro, con fare sbrigativo, che si deve cacciare e fare pulizia dei dirigenti
che non sono capaci di far lavorare gli altri: parole rozze, principio
sacrosanto. Ma vorrà perdonarmi se nutro più di qualche dubbio sul fatto che
tali decisioni vengano prese sulla base dei suoi personalissimi cahiers de
doléances. In fondo, caro Rampini, fin qui nulla di nuovo. Molti dipendenti
pubblici si saranno offesi o arrabbiati, ma Lei è solo buon ultimo in una lunga
schiera di illustri professionisti nel nobile sport dell’insulto contro i
lavoratori del settore pubblico. Alimentare odio sociale fa cassa, analizzare
problemi complessi e imbastire soluzioni assai meno. Quel che è assai singolare
– imperdonabile, aggiungo – è che Lei, da osservatore internazionale di tante
realtà avanzate, abbia clamorosamente mancato di cogliere, anche solo in parte,
le potenzialità che questo imprevisto smart working d’emergenza ha esplicitato,
permettendo finalmente di immaginare, al pari delle tante e consolidate realtà
del settore privato in Italia e nel mondo, una diversa organizzazione del lavoro
pubblico. Lei parla di “lazzaroni” (ce ne han dette di peggio, Le assicuro)
chiudendo ostinatamente gli occhi di fronte al fatto che in tanti hanno
apprezzato modalità nuove di lavoro che, se opportunamente sfruttate, possono
rappresentare una delle leve per riorientare in profondità un bene comune
indispensabile per il Paese come la nostra amministrazione pubblica. Inutile
ripetere cose già dette: ognuno, Lei incluso, potrà documentarsi in merito.
Sappia, tuttavia, my dear Mr. Rampini, che le chiacchiere hanno fatto il loro
tempo: in molti, ed io per primo, hanno fiducia che si possa e si debba entrare
in una agorà nuova per il settore pubblico, che dovrà scuotere alle radici
prassi e schemi ormai desueti. Si aggiorni, se può. And so long!
Federico Rampini, Renato Farina lo difende: "I compagni lo
linciano? Per forza: è l'unico giornalista intelligente della sinistra".
Renato Farina Libero Quotidiano l'8 agosto 2020. Il fenomeno
si ripete da circa un anno a questa parte. Quando, collegato per video con
qualsivoglia talk-show da San Francisco, Singapore, Bruxelles o - ad ogni morte
di Papa - da Roma, Federico Rampini esprime un suo giudizio argomentato,
peraltro sempre con gli accenti circonflessi al posto giusto, si trova contro i
compagni che ogni volta non riescono a crederci. Com' è possibile che da quella
bocca un tempo adorata partano fulmini e saette - ovviamente flautate -contro le
verità di ferro della sinistra italiana ed europea? Non ha rinnegato niente,
Rampini. Semplicemente si è spostato dall'ideologia alla realtà. Ha deciso di
privilegiare l'evidenza delle cose alle fumisterie della dialettica. In Italia è
rimasto intatto, nonostante gli scossoni della storia, il vecchio juke-box
progressista a doppia selezione: una tastiera con le canzonette pop, l'altra con
i cantautori profondi. Lui era il campione della lista numero due, il super-figo
che detta il Verbo dalle cime dei grattacieli e dagli sprofondi della Silicon
Valley, ma comunque in linea con i sacri dogmi. Rampini ha finito i gettoni.
Scusate l'immagine anni 60, ma la storia è questa qua. La cosa peggiore è che
Federico non rinnega niente, non si sogna di proclamare nessun me-ne-frego. E
questo è pure peggio. Non possono trattarlo da fedifrago. Togliatti reincarnato
lo strapperebbe con le sue dita da latinista, dandogli del pidocchio, «dalla
criniera del cavallo da corsa» naturalmente rosso. Altro che purosangue: Pd o
Cgil o Leu sono ronzini buoni per lo scortichino, secondo Rampini la scuderia
progressista può tornare a galoppare se dismette i destrieri dopati dai luoghi
comuni, se getta dalla finestra i miti dello statalismo, dei lavoratori sempre e
comunque bravi, mai da licenziare. Se ascoltasse Federico magari non ci
troveremmo in pista Varenne, ma almeno qualcuno contro cui correre senza
disperare se si perde.
FERIE RUBATE. Ieri abbiamo assistito e oggi continueremo a
osservare il fenomeno del linciaggio di Rampini. Ha detto con semplicità e
periodare ben tornito che i compagni lavoratori statali sono dei "lazzaroni" che
con un falso smart-working, che dovrebbe voler dire lavoro intelligente, invece
furbescamente si sono goduti ferie rubate ai cittadini che gli pagano lo
stipendio. Oddio. Si è levato un coro universale su internet, ciò che se non
altro smentisce quel che a me - scusate il caso personale - è stato comunicato
dagli uffici di un Tribunale vicino casa. Spiego in due parole, pronto a fornire
ogni documentazione del caso. Inviata per posta elettronica certificata tramite
legale una circostanziata richiesta, la busta elettronica non è stata aperta per
mesi. Perché? Causa lockdown. Ma come? Non accettavano il deposito a mano perché
c'era il lockdown, e ora dicono che siccome stavano a casa non hanno aperto la
posta elettronica dell'ufficio? E si sa il digitale funziona e non funziona.
Diremmo soprattutto la seconda che ho detto. È stata una valanga social, è
persino possibile che qualcuno tra i lavoratori statali domestici sia disposto
persino a prendere il tram per rincorrerlo. Anzi no, perché adesso ci sono le
ferie ufficiali. Il caso della Sicilia è noto. Il presidente della Regione (di
destra) Nello Musumeci ha spiegato che l'80 per cento dei suoi 13mila dipendenti
non fa nulla e da casa anche meno di nulla. Un assessore ha invocato che per una
volta rinunciassero alle ferie, dato che ci sono pratiche inevase per spendere
mezzo miliardo di fondi europei altrimenti perduto. Forse un riposino se l'erano
fatto, lungo quattro mesi. I sindacati della pubblica amministrazione hanno
risposto duramente che le ferie sono un diritto costituzionale irrinunciabile.
Eh sì, minchia. Chi ha dato il diritto a Rampini di considerare come ferie
truffaldine il doloroso sacrificio dei tre milioni circa di dipendenti statali?
Costoro in questi mesi, senza lamentarsi, senza assembrarsi nei bar per il
tradizionale cappuccino, hanno dovuto pendolare con grande senso del dovere,
qualche volta in mutande per la disperazione, dal divano alla sedia di casa, con
quel computer che non funziona, internet che traballa, senza postura ergonomica
con conseguente strazio dei glutei. Talvolta pure senza buono pasto. Vicino a
lui, il professor Carlo Cottarelli, che queste cose non le dice perché spera
sempre di tornare con il suo trolley a Palazzo Chigi, non riusciva a trattenere
le ganasce dall'erompere di un riso liberatorio. Pietro Ichino, giuslavorista
minacciato anni fa dalle Brigate rosse, aveva espresso i medesimi concetti di
Rampini, e oggi si ritrova nel mirino delle Brigate lazzarone, che per fortuna
sono troppo stanche per nuocergli. A costoro i difensori degli statali
strepitano: dove sono le prove? Forniteci le statistiche! È un negazionismo di
sinistra rispetto al quale quello sull'inesistenza del Covid appare essere
persino più serio.
PANE E COMUNISMO. Questo è solo l'ultima disfida che Rampini si è
trovato a combattere tra i suoi di sinistra. Uno della sua pasta fluorescente è
il professor Luca Ricolfi, ma qui parliamo di giornalisti e non di sociologi
progressisti. E tra i gazzettieri nati e restati tra i compagni, l'editorialista
e inviato di Repubblica è certamente il migliore (splendida la sua news letter
settimanale dagli Usa). Non intendiamo trascinarlo sull'altro lato del campo.
Infatti, bretelle a parte, che sono di destra, Federico Rampini è senza alcun
dubbio di sinistra. È cresciuto a pane, comunismo su cui crescendo ha spalmato
il caviale. C'è lo ricordiamo bene, fino a tre o quattro anni fa. Cinque o sei
lingue, tutte ricamate con la evve color pastello alla Agnelli; un amore
viscerale per il popolo e un'allergia da choc anafilattico per la popolazione;
il fatto di essere diventato ancora giovane (oggi ha 64 anni) il giornalista
prediletto da Carlo De Benedetti: tutto questo gli ha garantito un sana
antipatia tra le plebi di destra, che si sentivano guardate da questo signore di
eleganza casual come se fossero porcellini d'India però un po' obesi. Ma non
erano tanto gli occhi a fargli voler male dai non-progressisti, ma la molletta
sul bel naso per non rovinarsi l'odorato. Per altro, l'uomo suscitava già dai
tempi della sua ortodossia molte invidie tra i colleghi di sinistra che lo
sapevano perennemente in viaggio in business class lungo gli itinerari del
potere globale. San Francisco, Pechino, New Delhi, Bruxelles, ovviamente Davos.
Per cui volentieri lo vedono attaccato dai piranha dacché prima ha negato che in
Italia ci sia un qualsivoglia pericolo fascista, e poi ha rovinato la retorica
degli "ultimi", spiegando che i dimenticati dalla sinistra (e dalla Chiesa) non
sono gli stranieri, ma i "penultimi". Chi sono? Quelli per cui non corre lo
stipendio sicuro, e cui tocca vivere in periferie pestilenziali. I penultimi
sono esattamente i non-statali. Logico che costoro azzannino Rampini: uno di
sinistra che ha il torto di evitare le bugie. Finché dura (la sinistra).
Rampini contro la P.a.: "Sabotatori, nel lockdown hanno fatto
ferie". Le parole del giornalista naturalizzato
statunitense continuano a far discutere: "La traduzione letterale di "smart
working" sarebbe lavoro intelligente, questi già non facevano un lavoro
intelligente. Hanno lavorato ancora meno, ancora peggio". Federico Garau,
Giovedì 06/08/2020 su Il Giornale. Stanno creando un vespaio di polemiche le
pesanti parole pronunciate dal giornalista Federico Rampini durante la
trasmissione "Stasera Italia", andata in onda su Retequattro durante la serata
dello scorso lunedì 3 agosto, nei confronti dei dipendenti pubblici e dello
scarso impegno che a detta sua avrebbero dimostrato durante il periodo del
lockdown, specie lavorando da casa. Anche le risate che hanno accompagnato le
esternazioni di Rampini, sia da parte della conduttrice Veronica Gentili che
dell'economista Carlo Cottarelli, non sono passate inosservate a quanti nelle
ultime ore hanno voluto replicare all'attacco portato dal giornalista
naturalizzato statunitense. "Purtroppo questa è la vergogna italiana in
assoluto. Guardate, aveva piena ragione Cottarelli a dire che il presidente
dell'Inps se ne dovrebbe andare. Però non basta, non se ne deve andare solo lui.
Bisogna cominciare a fare pulizia in un mondo che è un mondo di sabotatori della
rinascita italiana", ha esordito Rampini prima di affondare il colpo. "Andiamo a
guardare che cosa è stato il crollo della produttività già bassissima di tanti
statali, di tanti pubblici dipendenti che si sono fatti il lockdown a casa col
cosiddetto “smart working”. La traduzione letterale di 'smart working' sarebbe
lavoro intelligente, questi già non facevano un lavoro intelligente. Hanno
lavorato ancora meno, ancora peggio. Tanti di loro si sono fatti delle vere e
proprie ferie a casa", ha accusato Rampini, che le problematiche italiane le
vive solo indirettamente, risiedendo negli Stati Uniti. Cosa che non gli
impedisce comunque di valutare sulla base dei racconti di alcuni
conoscenti. "Guardate, io non vivo in Italia, però ho raccolto le lamentele, i
pianti, le urla di decine di amici che sto incontrando in Italia per il livello
vergognoso a cui è precipitata l'improduttività della pubblica amministrazione.
Compresa ovviamente l'Inps, ma anche l'Agenzia delle entrate. Cioè il lockdown è
diventato un alibi per un esercito di lazzaroni. A loro lo stipendio non glielo
nega mai nessuno. Mentre ci sono milioni di italiani che in questo momento
vivono in un'incertezza tragica sul loro futuro e sul loro tenore di vita,
quelli lì quando se ne stanno a casa e non fanno un beato niente lo stipendio lo
incassano. Quindi", conclude il giornalista, "giusto quello che dice Cottarelli,
ovvero cacciare il presidente dell'Inps che non mantiene le promesse, ma poi
bisogna fare pulizia di tutti i dirigenti e quadri che non sono capaci di far
lavorare i loro collaboratori, è una vergogna italiana". Tra le varie reazioni
all'attacco andato in onda su Retequattro anche quello della Cgil. "Sono
inaccettabili ed assolutamente pretestuosi gli attacchi che lunedì sera nel
corso della trasmissione “Stasera Italia “sono stati rivolti da Carlo Cottarelli
e dal giornalista Federico Rampini nei confronti dei lavoratori pubblici in
smart working durante la pandemia", ha dichiarato il segretario generale
Annamaria Furlan su Facebook. "La stragrande maggioranza dei lavoratori pubblici
ha svolto il proprio lavoro durante i mesi più duri e drammatici della pandemia
in maniera seria e responsabile. E non ci riferiamo solo al comportamento
prezioso ed eroico di tutti i lavoratori della sanità pubblica , ma anche a
quelli degli enti come l’Inps, dei ministeri, della scuola, delle regioni, degli
enti locali, dei vigili del fuoco e di tutti i corpi dello stato che spesso
utilizzando propri mezzi telematici, hanno assicurato servizi indispensabili ai
cittadini. Non fa onore a Cottarelli ed a un giornalista come Rampini", ha
chiuso la Furlan, "fare ricorso alla demagogia ed a vecchi luoghi comuni , come
quello dei fannulloni , per attaccare milioni di dipendenti pubblici".
Aldo Grasso per il “Corriere della Sera” il 2 agosto 2020. Essere
in ferie significa non avere niente da fare e avere tutto il giorno per farlo.
Alla Regione Siciliana «almeno l' 80% dei lavoratori si gratta la pancia». Così
pare, stando alle lamentele del presidente Nello Musumeci, irritato con buona
parte dei suoi 13 mila dipendenti, «assolutamente improduttivi». Ma Felice
Cavallaro ha raccolto per il Corriere uno sfogo ancora più grave: «Il servizio
che io dirigo - ha confessato il dirigente dell' assessorato all' Energia, l'
ingegnere Salvatore D' Urso - ha fondi comunitari da distribuire per 560
milioni. Che facciamo? Restiamo immobili su una montagna di denaro
disponibile?». E così ha provato a richiamare in servizio i dipendenti in ferie.
L' immobilità deriverebbe dal fatto che dopo i «faticosi» mesi dello smart
working molti impiegati hanno pensato bene di andare in ferie, a riposarsi. In
ufficio non c' è nessuno (o quasi), impossibile sbrigare le pratiche, anche se
di mezzo ci sono parecchi milioni che potrebbero far ripartire l' economia della
regione, a «statuto speciale». A D' Urso si sono subito opposte le sigle
sindacali dei dipendenti, che invocano il diritto costituzionale alle ferie
«anche per ragioni psicologiche». In Sicilia abbiamo tutto, ci manca il resto,
diceva con ironia Pino Caruso. Il resto è mancia: 560 milioni. Forse qualcosa di
più.
Arrestata in flagranza nota chef stellata di Palermo: rubava
la corrente elettrica per il suo ristorante. Gli
uomini dell'Arma hanno arrestato una nota chef stellata di Palermo colta in
flagranza di reato: grazie a un magnete "rubava" la corrente elettrica.
Francesca Galici, Domenica 02/08/2020 su Il Giornale. Arrestata e condannata a
un anno per "furto di luce". È la parabola della chef stellata Patrizia Di
Benedetto, molto nota a Palermo perché titolare di uno dei ristoranti più noti
del litorale di Mondello. A raccontare la vicenda è stato il Giornale di
Sicilia, che ha ricostruito i fatti fino al fermo della donna, colta in
flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Partanna e di San Lorenzo.
L'escamotage utilizzato dall'imprenditrice è uno dei più noti alle forze
dell'ordine nell'ambito dei reati di furto di energia elettrica. La donna pare
abbia posizionato una calamita sul contatore dell'Enel. Il semplice dispositivo
funge da freno magnetico e così impedisce al sistema di girare a pieno regime,
permettendo una riduzione del conteggio fino al 50%, con conseguente risparmio
sulle bollette della luce. L'accertamento è avvenuto nella serata di venerdì,
quando il locale di Patrizia Di Benedetto era in piena attività con i suoi
clienti. Proprio la presenza di numerose persone all'interno del noto ristorante
della località balneare ha spinto gli uomini dell'Arma ad agire con la massima
discrezione e così, dopo aver verirficato la flagranza di reato e aver
notificato il fermo alla donna, hanno atteso la fine della serata per completare
le operazioni d'arresto e accompagnare l'imprenditrice in caserma. Espletate le
formalità del caso, che hanno obbligato la donna a un soggiorno forzato nella
camera di sicurezza della stazione, per lei sono stati disposti gli arresti
domiciliari. Patrizia Di Benedetto ha scelto di procedere con il patteggiamento
e davanti agli inquirenti si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Un suo
diritto, che però esprime finora la volontà non collaborativa della donna. Al
momento la sua condanna è a un anno, con pena sospesa, ma gli inquirenti stanno
ora procedendo nelle indagini per valutare l'effettiva entità del furto di
corrente elettrica. Il ristorante di sua proprietà non è stato chiuso e continua
a svolgere regolarmente l'attività anche senza il servizio d'eccellenza del suo
chef stellato. Quella del furto di corrente elettrica è una pratica molto
diffusa. Si tratta di un reato perseguibile penalmente in base all'articolo 624
del codice penale o 625, nel caso in cui ci siano aggravanti. La reclusione può
andare da 6 mesi a 3 anni per il furto semplice o da 1 a 6 anni per il furto
aggravato, con multe che possono arrivare fino a 1.032euro. Proprio perché si
tratta di uno dei reati più frequenti in materia di furto, le compagnie di
erogazione dell'energia elettrica negli anni hanno previsto diverse soluzioni
per limitare questa pratica.
Il pedone investito 6 volte in un minuto. Ecco perché paghiamo
le polizze Rc auto più alte d’Europa. Pubblicato
domenica, 01 marzo 2020 su Corriere.it da Milena Gabanelli, Mario Gerevini e
Fabio Savelli. Di vincitori in questa storia se ne trovano pochi, ma ci sono,
come dimostra il maxi-fascicolo sul clan Contini a Napoli. Un sistema predatorio
e subdolo, nutrito da una schiera di professionisti a libro paga delle
organizzazioni mafiose, che hanno costruito un indotto sofisticatissimo a basso
rischio giudiziario e ad alto rendimento vista la dimensione dei risarcimenti.
Medici che fabbricano referti falsi. Periti che certificano incidenti mai
avvenuti. Finti testimoni che giurano di aver visto una macchina accartocciarsi
o un pedone investito sulle strisce, dopo essere stati remunerati con apposito
prezzario stabilito dai capizona della Camorra. Giudici di pace che lavorano per
le compagnie assicurative come consulenti e al tempo stesso stabiliscono
l’entità dei danni. Avvocati che scrivono pareri per maxi-ristori su sinistri
inesistenti, incassando commissioni a mò di parcella. La ricaduta di tutto
questo è che a Napoli il cittadino onesto paga la polizza più alta d’Italia.
Esempio: un’Audi Q3 se intestata ad un automobilista residente a Bologna costa
500 euro di Rc auto, che diventano 1.040 a Napoli. E così succede che a Trento
(dove le polizze sono meno care) una finta società si è intestata 340 contratti
di clienti residenti a Napoli.La casistica delle truffe tocca «vette di
eccellenza». A Palermo si sono fatti martellare un ginocchio per ottenere un
risarcimento a quattro zeri. Ad Avellino un pedone è stato schiacciato da sei
automobili diverse nel giro di un minuto; ha chiesto sei risarcimenti diversi ed
è stato pure liquidato da alcune compagnie. A Foggia proprietario e affittuario
dello stesso terreno chiedono (e ottengono) due risarcimenti per la grandine che
ha distrutto lo stesso raccolto. Un po’ ovunque in Italia si prende a calci la
scatola nera per smontare il Gps simulando un frontale mai avvenuto. Vediamo
cosa dice l’articolo 642 del codice penale: «Chiunque, al fine di conseguire per
sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione distrugge, disperde, deteriora
od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la
documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto è punito con la
reclusione da uno a cinque anni». Su questa ipotesi di reato le compagnie
assicurative sporgono querela, e i tribunali di mezza Italia si ingolfano,
perché l’azione penale è obbligatoria. Eppure le Assicurazioni hanno i loro
uffici antifrode, ma per vedere il grado di fraudolenza di quel sinistro occorre
accedere all’archivio integrato (Aia) che mette insieme le banche dati di tutti
gli incidenti sospetti, testimoni ricorrenti e la filiera della criminalità. Se
ne parla da dieci anni, e forse entro il 2020 sarà operativo. Intanto
nell’ultimo rapporto Ivass (2018) i sinistri non liquidati, perché
potenzialmente fraudolenti, sono aumentati dell’11% rispetto al 2017. Sempre nel
2018 si sono verificati oltre 2,8 milioni di sinistri. Si stima che circa il 22%
siano a rischio frode, al Sud addirittura il 37%. Secondo l’Ania, l’associazione
di rappresentanza delle compagnie assicurative, i tempi di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno (2 anni, 5 in caso di lesioni personali),
«permettono al frodatore di eliminare gran parte degli indizi che potrebbero
consentire all’impresa di scoprire l’attività fraudolenta». Le truffe però non
sono soltanto a danno delle compagnie (che si rifanno alzando il prezzo delle
polizze), nella rete del web ci sono cascati in migliaia: hanno pagato, ma le
polizze ricevute sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. Oltre 300
i siti-truffa denunciati dall’Ivass negli ultimi tre anni: 224 quelli finiti
sotto inchiesta della Procura di Milano, e sui quali lavora anche il Nucleo
frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Solo i siti web ubicati in Italia e
finora identificati, hanno totalizzato raggiri per circa 4 milioni. Considerando
400 euro il premio per una polizza media, significa 10 mila mezzi che circolano
(o hanno circolato) fuorilegge inconsapevolmente. Ed è solo una piccola porzione
del «mercato». Molti di questi siti utilizzano grafica o denominazione simile a
quella delle compagnie più conosciute. Possibile che il sito-truffa della
Goldassicura.com, denunciato dall’Ivass il 22 gennaio, si apra tuttora con la
foto di una sede UnipolSai? Ma il problema è che per un sito-truffa individuato
un altro nasce. E per rendersi più credibile riporta anche i numeri di
iscrizione all’Ivass, numeri rubati ad un ignaro intermediario vero. Ma chi
accede al sito non lo sa. Di questi siti web ne nascono uno al giorno con nomi
tipo: genertelassicura.com (provider in Arizona), misterpolizza.com (Lituania),
directassicurazione.com (Canada), polizzadiretta.net. La truffa si consuma quasi
sempre intascando il premio attraverso la ricarica di una carta prepagata, che
viene immediatamente svuotata ai bancomat, in cambio di un contrassegno falso
spedito per mail o whatsapp. Ma intanto sono stati acquisiti anche i dati
personali del truffato e del mezzo assicurato: dati che vengono riutilizzati per
creare identità false, intestare veicoli, carte prepagate, nuovi siti web. Il
truffato viaggia senza copertura e se viene fermato si becca la multa, il
sequestro del veicolo e decurtazione di punti sulla patente.
I trucchi dei casellanti per intascare i pedaggi: truffa da
200mila euro. Pubblicato lunedì, 24 febbraio 2020
su Corriere.it da Riccardo Bruno. La truffa del casellante era semplice e molto
redditizia. Teneva da parte un biglietto con un basso importo, poi quando
arrivava un automobilista con un lungo chilometraggio invece di registrare il
suo biglietto recuperava quello conservato, intascando la differenza. Un
operatore dell’uscita Milano Ovest dell’Autostrada A7 , secondo l’accusa,
avrebbe utilizzato il trucco del «doppio biglietto» ben 1.917 volte. È uno dei
sette indagati dalla procura di Milano per truffa aggravata che andrà a processo
il prossimo 11 giugno come dà notizia La Provincia Pavese nell’edizione di
lunedì. L’inchiesta è nata nel 2018 quando la Milano Serravalle Spa, che
gestisce l’autostrada Milano-Genova, notò che mancava una parte degli incassi.
Venne così incaricata una società di investigazione privata che con «auto
civetta» scoprì quello che poi i magistrati hanno ritenuto un comportamento
scorretto di alcuni dipendenti. Le indagini hanno svelato tre «sistemi» per
lucrare illecitamente sui pedaggi. Oltre a quello del «doppio biglietto», i
casellanti avrebbero anche agito sul display nel quale appare il pedaggio, anche
in questo caso per poter registrare una cifra inferiore rispetto a quella
effettivamente sborsata dal cliente. Il terzo trucco escogitato era invece il
più ingegnoso. Veniva oscurata la telecamera ai caselli, così che il sistema non
riusciva più a sbloccarsi automaticamente al termine del transito di un veicolo,
non riconoscendo poi il passaggio delle auto successive. I cui pedaggi venivano
gestiti manualmente e non tutti registrati. Secondo l’accusa nel periodo
considerato (2018) sarebbero stati sottratti almeno 200 mila euro. Ai sette
indagati è stata riconosciuta l’aggravante sia per la presenza del danno a un
ente pubblico (la Serravalle è partecipata dalla Regione Lombardia), sia per
aver commesso il fatto con abuso di relazione d’ufficio.
(ANSA il 21
febbraio 2020) - Sono 141 - tra medici e paramedici - i dipendenti dell'ospedale
G.B. Grassi di Lido di Ostia denunciati all'autorità giudiziaria dai Finanzieri
del Comando Provinciale di Roma per aver permesso ad amici e parenti di eseguire
accertamenti diagnostici completamente gratuiti senza seguire le ordinarie liste
di attesa. L'indagine, delle Fiamme Gialle del 6/o Nucleo operativo
metropolitano di Roma, diretta e coordinata dalla Procura capitolina, ha preso
le mosse nel novembre 2017 da una denuncia presentata nei confronti di
un'infermiera. I militari informano di aver proceduto "ad un meticoloso esame
dei tabulati relativi alle prestazioni erogate e all'assunzione di
testimonianze, individuando artefici e beneficiari della truffa che, oltre a
danneggiare il Servizio Sanitario Nazionale, ha leso i diritti degli altri
utenti i quali, prenotandosi regolarmente al Cup, dovevano attendere il proprio
turno prima di sottoporsi a un esame diagnostico". La frode era piuttosto
semplice quanto diffusa: la persona bisognosa di una prestazione si rivolgeva a
uno dei sanitari compiacenti che, grazie alla password personale per l'accesso
al sistema informativo dell'ospedale, avanzava richiesta all'articolazione
competente. Eseguito l'esame diagnostico o l'analisi chimico-clinica, gli stessi
sanitari venivano in possesso del referto, che provvedevano a consegnare al
beneficiario, evitando così il pagamento del ticket alla Regione Lazio. A
usufruire della "corsia preferenziale" 523 tra parenti e amici dei medici ed
infermieri, questi ultimi a loro volta beneficiari dell'illecito sistema. Oltre
a dover rispondere all'Autorità Giudiziaria ordinaria del reato di truffa
aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, gli indagati dovranno
vedersela con la Corte dei Conti per il danno all'Erario.
I segreti
della tv clandestina: "La pay tv? Tutto a 10 euro..."
L'indagine della Guardia di Finanza sulle pay-tv pirata ha portato identificare
e denunciare 223 persone. Ma online il traffico non si placa. I reseller:
"Beccano solo i polli…" Marco Vassallo, Giovedì 20/02/2020 su Il Giornale.
L’indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di identificare e denunciare 223
persone ritenuti responsabili dell’acquisto di abbonamenti pirata per le
principali piattaforme televisive a pagamento. Un evento che prima di ieri
(martedì 18 febbraio) non si era mai verificato in Italia. Una vittoria, sulla
carta. Online, però, la vendita di questo tipo di prodotto non cessa e i
reseller non hanno paura di essere identificati.
Novantamila
canali a una manciata di euro. Intanto facciamo chiarezza. Il caso riguarda
l’Internet protocol television, anche meglio conosciuta come Iptv. Si tratta del
metodo di distribuzione e fruizione illecita molto comune. Il funzionamento è
complesso, ma cercheremo di semplificarlo. I cosiddetti “pirati” acquisiscono
tutti i contenuti da piattaforme a pagamento come Sky, Dazn, Netflix e
moltissime altre, modificano il codice e poi le trasmettono sulla app che fanno
scaricare ai clienti dagli store digitali Android. Non serve essere degli hacker
per abbonarsi: basta una televisione smart, ovvero con la possibilità di essere
connessa a internet, e il gioco è fatto. I prezzi variano in base al
rivenditore, ma sono sempre molto accessibili e danno la possibilità di
visionare circa 90mila canali. Un business che non si ferma mai. A poche ore
dalla conclusione dell’indagine della Finanza, i “reseller” della Iptv sono già
a lavoro. Basta aprire Telegram e fare una rapidissima ricerca per trovare
diversi gruppi che smerciano le piattaforme a pagamento per pochissimi euro. Ne
contattiamo un paio, giusto per capire se qualcosa è cambiato. Per capire come
lavorano e se veramente non sono intimoriti dalle mosse delle forze dell’ordine.
Il primo gruppo a cui ci iscriviamo vanta 3616 iscritti e offre un catalogo
vastissimo, con tanto di locandina personalizzata e filmati promozionali: “Tutti
i pacchetti Sky, Tutto Mediaset Premium, Dazn, Lega Pro, Seria A, Serie B,
Champions League, Europa League, Formula Uno, Moto Go, documentari, musica,
regionali…”. Una lista infinita che include addirittura “canali hot”. Tutto a
soli 10 euro. E come si paga? Scorrendo la chat, scrivono: “Ricordo a tutti che
accettiamo una delle modalità di pagamento più sicure ed anonime che ci sono.Vi
basterà andare in un tabacchi e richiedere una ricarica Paysafe dell’importo che
desiderate e vi rilasceranno un foglio con un codice che poi fornirete a me”. E
così "non dovrete lasciare nessun nominativo e il pagamento avverrà in forma
anonima”. Un dettaglio mica da poco. Contattiamo l’amministratore per capire
come iscriversi e godersi un infinito mondo di televisione clandestina.
“Ho un
migliaio di clienti”. Ci risponde in pochi minuti: “Ciao, il servizio funziona
tramite un app che scarichi sul telefono o sul tv box o Firestick o sulla Smart
tv se ne hai una. Compreso nel pacchetto hai tutto Sky compresi i Primafila,
Dazn, Premium,film On demand, serie tv”. Poi precisa: “I costi sono 1 mese 10
euro, 3 mesi 30, 6 mesi 50, 12 mesi 90”. E infine aggiunge: “Modalità pagamento
Paypal, Paysafe o Postepay”. Nulla di nuovo. Chiediamo se non rischiamo denunce
(domanda più che lecita di questi tempi). Lui digita e preme invio: “No, no. Il
nostro servizio è top per quanto riguarda la sicurezza: criptato coperto da vpn
sever estero”. Prima di fingere di recarci al tabaccaio per pagare, chiediamo
come mai sono stati pizzicati in 200. Ancora una volta, il “pirata” si collega e
scrive: “Sono quei deficienti che prendono liste online non sicure. II nostri
server sono sicuri: attivi da 9 anni”. Un vero professionista. Ma che giro
d’affari gestisce? Ci rivela che non fa tanti soldi ma “arrotondiamo”,
precisando che “siamo più soci” e ognuno guadagna circa “1500 al mese”. Un
stipendio pulito pulito. Purtroppo per lui la trattativa si stoppa sul
pagamento: non siamo poi così interessanti. Preferiamo sondare il mercato.
"Beccano solo
i polli". E infatti contattiamo un secondo gruppo di pay-tv hackerate. Qui gli
iscritti sono poco meno di un migliaio ma i server a disposizione per fruire di
tutte le piattaforme a pagamento sono ben 3. Anche qui non manca nulla: si va
dalla partite dalle Seria A fino alla Champions League, passando per le serie tv
e i film. Per richieste e domande si viene indirizzati a un bot, ma le risposte
sono gestite da una persona. Lo notiamo da un dettaglio: dietro alla tastiera
non hanno voglia di perdere tempo con domande ritenute sciocche e tagliano
corto: “Hai internet? Hai un dispositivo con Playstore per scaricare un app
player? Se hai questi facciamo tutto”. Replichiamo di sì e domandiamo se non c’è
il rischio essere beccati dalla polizia. L’”operatore” all’altro capo dello
schermo è stizzito e ci da una spiegazione lampo: “È illegale. È pirateria. Se
non vuoi o hai paura consiglio Sky”. E prosegue: “Solo i polli beccano… i nostri
clienti sono in anonimato.. non sono mai stati beccati”. Vuole chiudere in
fretta la trattativa e infatti ci gira il listino prezzi: “Per quanti mesi? 1
mese 10€, 3 mesi 25€, 6 mesi 50€,12 mesi 90€”. E ci inoltra l’indirizzo sul
quale inviare il denaro tramite Paypal. Noi titubiamo. Facciamo domande. Forse
troppe. Anzi sicuramente troppe: veniamo bannati. Poco male. La multa per chi
acquista il servizio pirata di pay-tv è di 25mila euro, con il rischio finire in
carcere per 8 anni. Siamo conigli e teniamo alla fedina penale e al portafoglio.
Ecco l'esercito dei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Posteggiatori abusivi, ballerine, pusher, camerieri,
commessi, muratori. C'è un esercito di beneficiari del reddito di cittadinanza
che nel frattempo lavora in nero. Roberto Chifari, Domenica 09/02/2020 su Il
Giornale. Partiamo da un doveroso presupposto: il reddito di cittadinanza è un
sussidio che aiuta tantissime persone sotto la soglia di povertà, ma per onestà
intellettuale non possiamo non raccontare l'altro lato della medaglia. Ci sono
le storie di chi in barba a qualunque regola riesce ad eludere i controlli,
accede al beneficio e intasca il sussidio fino a quando...non intervengono le
forze dell'ordine. Grazie al lavoro incessante di carabinieri, polizia e guardia
di finanza sono stati scoperti centinaia di furbetti che percepivano
indebitamente il reddito mentre lavoravano in nero. I giornali sono pieni di
decine di episodi, Cerchiamo di raccogliere solo quelli dell'ultima settimana
per scattare una fotografia di un fenomeno che va attentamente studiato.
A Palermo la polizia municipale, nell'ambito delle attività di controllo del
territorio volte al contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi, ne ha
individuato 7, due dei quali fruitori del reddito di cittadinanza. In
particolare, sabato sera, gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico
hanno sanzionato tre posteggiatori, rispettivamente due a piazza Marina, F.D.C
di 24 anni che percepisce il reddito di cittadinanza e E.H. di 19 anni. L’altro
è stato sanzionato a piazza Sant’Oliva. In altre zone della città, sono stati
quattro i posteggiatori abusivi individuati. L.V. di 25 anni è stato fermato a
piazza Giovanni Paolo II, A.M. di 20 anni in viale Diana; gli altri due
posteggiatori, F.M. di 44 anni e S.C. di 24 anni "esercitavano" in viale del
Fante. Il primo di questi, denunciato all’autorità giudiziaria perché recidivo,
percepisce il reddito di cittadinanza. Ai posteggiatori è stata comminata una
sanzione di 771 euro ciascuno. A Rimini una donna percepiva il reddito di
cittadinanza ma allo stesso tempo lavorava in nero in un night-club come
ballerina di lap-dance. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Rimini durante
un controllo in un locale notturno della riviera romagnola dove, assieme a lei,
sono state individuate altre quattro lavoratrici sconosciute al fisco. La
ragazza, 20enne originaria di Modena, faceva parte di un nucleo familiare che
godeva del beneficio statale e aveva omesso di comunicare l'avvio dell'attività
lavorativa. Per il datore di lavoro è scattata la sospensione dell'attività
imprenditoriale, subito revocata a seguito del pagamento di una maxi-sanzione da
20mila euro e dell'assunzione delle ragazze. Sempre a Rimini nell'ambito di
altri controlli è stata individuata anche una donna ucraina che, seppur assunta
regolarmente come cameriera in un hotel, percepiva il reddito di cittadinanza
non avendo comunicato l'avvio dell'impiego e il reddito del coniuge.
A Roma arriva un'altra storia interessante: ufficialmente era disoccupato, ma in
realtà era uno spacciatore di cocaina e percepiva il reddito di cittadinanza. A
scoprirlo la guardia di finanza di Roma, che lo ha trovato in possesso di 62
dosi e 5700 euro in contanti durante una perquisizione eseguita nel suo
appartamento nella zona di Mezzocammino. Il Tribunale di Roma, oltre a
convalidare l'arresto e a disporre la misura cautelare per il reato di spaccio
di sostanze stupefacenti, ha disposto la sospensione del beneficio, in attesa
del giudizio. A Fiumicino c'erano otto lavoratori "in nero" - uno dei quali
percepiva il reddito di cittadinanza - sono stati individuati sul litorale di
Fiumicino dai finanzieri del Comando provinciale di Roma durante controlli
finalizzati al contrasto del "lavoro sommerso". Le fiamme gialle, coordinate dal
Gruppo di Civitavecchia, li hanno scoperti mentre erano al lavoro in un rinomato
ristorante, contestando al datore di lavoro la mancata effettuazione delle
prescritte comunicazioni telematiche al ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Da approfondimenti svolti è risultato che uno dei lavoratori, di
origine egiziana, percepiva dal luglio dello scorso anno circa 500 euro al mese
a titolo di "reddito di cittadinanza". L'uomo, nel frattempo assunto a tempo
indeterminato dal ristoratore, è stato denunciato per non aver comunicato la
variazione della sua posizione lavorativa ed è stato segnalato all'ufficio
dell'Inps per la decadenza del beneficio. Due lavoratori non regolari sono stati
scoperti dalla Guardia di Finanza, nel corso di una serie di controlli, in un
cantiere edile di Mendicino (Cosenza). Uno dei due era anche percettore di
reddito di cittadinanza. I finanzieri hanno sanzionato il datore di lavoro e
inviato all'Inps la proposta di revoca del sussidio economico statale per
l'operaio abusivo percettore del reddito di cittadinanza. A Matino, in provincia
di Lecce, in un controllo svolto presso una ditta di abbigliamento dai
carabinieri sono state denunciate due persone per violazioni in materia di
lavoro e sicurezza. Durante il servizio, su 28 lavoratori, sono stati scoperti
dieci irregolari, vale a dire sei in nero, due beneficiari del reddito di
cittadinanza e altri due beneficiari di indennità di disoccupazione.
Lavinia Greci per ilgiornale.it il 9 febbraio 2020. Da una parte
percepiva il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal Movimento 5 Stelle e
varata l'anno scorso dal governo giallo-verde. E dall'altra percepiva uno
stipendio in nero, lavorando come ballerina di lap dance all'interno di un night
club di Rimini. Al centro della vicenda, una ragazza di 20 anni di Modena, che
sarebbe stata scoperta dalla guardia di Finanza della città romagnola durante un
controllo in un locale notturno della riviera.
La scoperta delle fiamme gialle. Secondo quanto riportato da Il
resto del Carlino, la giovane ballerina faceva parte di un nucleo familiare che
poteva godere del sussidio statale. Ma, al tempo stesso, avrebbe omesso di
comunicare l'avvio della sua attività lavorativa e di pagarne regolarmente le
tasse. In base a quanto ricostruito dal quotidiano, insieme a lei, sarebbero
state individuate altre quattro lavoratrici rimaste ignote al fisco.
La multa per l'imprenditore. Per il datore di lavoro delle
dipendenti in nero è stata disposta la sospensione dell'attività
imprenditoriale, subito revocata però a seguito del pagamento di una
maxi-sanzione da 20mila euro e dall'assunzione delle giovani. Nell'ambito di
altri controlli, sempre disposti dalle fiamme gialle, sarebbe stata individuata
una donna ucraina che, nonostante l'assunzione con regolare contratto da
cameriera in un hotel, percepiva comunque il reddito di cittadinanza, non avendo
comunicato l'avvio dell'impiego e il reddito del coniuge.
Gli ultimi casi. Ma il caso della ballerina modenese è soltanto
l'ultimo. A Roma, proprio in queste ore, sarebbero stati scoperti due uomini
che, pur risultando nullatenenti ai fini dell'ottenimento della misura, in
realtà, avevano avviato il primo una rivendita di auto su inernet, conseguendo
quindi profitti in nero, e il secondo un giro di sostanze illecite. A scoprire
il giro dei due, che erano riusciti a chiedere e a percepire il reddito di
cittadinanza, sono stati i finanzieri del comando provinciale della capitale
che, una volta scoperto e accertato la sussitenza dei reati, ha denunciato i due
uomini all'autorità giudiziaria e ha interessato gli uffici provinciali
dell'Inps per la sospensione del sussidio e per il recupero delle somme ricevute
indebitamente.
Reddito di cittadinanza "indebito". Soltanto negli ultimi giorni,
i carabinieri hanno accertato altri episodi simili, in particolare tra chi si
sostenta spacciando droga. Pochi giorni fa, durante un controllo all'interno di
un ristorante a Fiumicino, le fiamme gialle avevano scoperto sette dipendenti
abusivi, mentre l'unico lavoratore assunto con regolare contratto non aveva
comunicato il nuovo impiego ai fini dell'annullamento del reddito di
cittadinanza. Anche in quella circostanza, l'uomo è stato denunciato
all'autorità giudiziaria per non aver comunicato la variazione della sua
posizione lavorativa ed è stato segnalato.
Da leggo.it il
3 febbraio 2020. Mesi a lavorare senza un contratto di lavoro e con una paga «da
fame», come la definisce lei stessa. È la storia vissuta da Elisa (nome di
fantasia), che dopo averci pensato su per giorni ha voluto replicare alle
esternazioni di Maura Cavallaro, titolare de “Il Locale” di via Miani, che dalle
colonne de Il Gazzettino si lamentava di non riuscire a trovare personale da
impiegare nel suo bar. «Penso di sapere il perché...», sbotta Elisa. Lei, come
tante ragazze e ragazzi, da giovane ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro
facendo la barista. Così, terminati da poco gli studi, decide di rispondere
all’annuncio di lavoro della signora Cavallaro, quando all’epoca gestiva un
altro locale nel cuore del centro storico rodigino. «Ho conosciuto la signora
Maura più di dieci anni fa, quando verso fine estate ha accettato di farmi un
colloquio di lavoro come barista - racconta - Le spiegai che non avevo alcuna
esperienza in quel campo, ma mi disse che l’avrei fatta con lei. Dopo avere
fatto il tradizionale giorno di prova decise di assumermi senza un contratto,
chiarendomi sin da subito, però, che non voleva che io lasciassi il lavoro prima
della fine della stagione invernale. Pensai che, giustamente, non volesse
rimanere senza personale durante il periodo natalizio, in cui la clientela
aumenta molto. Inizialmente andò tutto bene: un po’ alla volta mi aveva
insegnato alcune cose basilari, come fare il caffè e servire ai tavoli. Come
detto, però, non avevo un contratto, solo un foglio in cui c’era scritto che
quello era il mio giorno di prova, anche se in realtà erano già passati alcuni
mesi dalla mia “assunzione”».
E per i
pagamenti?
«Io mi
scrivevo le presenze, ho provato a tenere il conto di quanto avrebbe dovuto
pagarmi, ma quel poco che ho percepito me lo dava quando voleva lei - risponde
Elisa - Mi pagava in contanti, non mi mostrava i conti che lei si era fatta.
Inizialmente erano otto euro all’ora, ma in realtà erano molti meno. Quando poi
ero io a chiederle lo stipendio, mi rispondeva che aveva problemi familiari e me
li avrebbe dati più avanti. In circa sei mesi che sono stata lì, lavorando nei
weekend, mi avrà dato si e no due o trecento euro».
Con il
protrarsi di una situazione del genere cosa hai deciso di fare?
«La vicenda
non si è mai risolta: mi diceva sempre che aveva dei problemi familiari, così le
ho mandato una lettera in cui le chiedevo di rispettare almeno gli accordi che
avevamo preso. Per tutta risposta lei mi ha scritto a sua volta una lettera che
tengo ancora dall’epoca, nella quale mi rinfacciava di non esserle stata
riconoscente per avermi insegnato un mestiere, che quando ho deciso di lavorare
lì non avevo un fucile puntato alla testa e che avrei dovuto essere più
sensibile verso i suoi problemi personali. Morale della favola: non ho visto un
euro, nonostante concludesse la sua lettera dicendomi che avrebbe saldato il suo
debito dopo avere parlato con il commercialista».
Sai di altre
persone che hanno avuto gli stessi problemi?
«So di non
essere stata l’unica. Anche una mia amica e altre persone che conosco hanno
avuto la mia stessa esperienza: alla fine se ne sono sempre andati via perché
non venivano pagati».
Nei giorni
scorsi Maura Cavallaro diceva che i giovani non hanno voglia di lavorare…
«Mi sono
sentita offesa per quelle parole. Non è assolutamente vero che i giovani non
hanno voglia di fare: non c’ è fiducia, non ci viene data la possibilità di
metterci in gioco. Io credo, e questo discorso vale per tutti, non solo per i
giovani, che se una persona venisse pagata per la sua effettiva prestazione
lavorativa, quella signora non si troverebbe senza personale. Quando vieni
pagato per quello che fai provi soddisfazione e lavori anche meglio».
Da grande voglio fare l'avvocato - Pianeta praticanti:
inchiesta della Repubblica degli Stagisti. Fabrizio
Patti il 22 Giugno 2009. Tempo fa la Repubblica degli Stagisti aveva acceso un
faro sul pianeta praticanti, denunciando come - in modo analogo a quanto avviene
per gli stagisti - sia una prassi comunemente accettata quella di lavorare senza
una retribuzione o per cifre irrisorie. Oggi comincia un viaggio nel pianeta
praticanti, per capire meglio chi sono, cosa fanno, come vivono.
Prima fermata: i praticanti avvocati. Quanti sono. Moltissimi.
Secondo il Consiglio nazionale forense nel 2008 si sono presentati all’esame di
Stato 33.028 praticanti. Altri 6mila hanno fatto domanda ma non si sono
presentati all’esame. Secondo la Cassa nazionale forense, il 52% dei praticanti
iscritti alla Cassa è costituito da donne. Dai dati Almalaurea risulta che il
93% di chi ha una laurea a ciclo unico, e l’82% di chi ha conseguito la
specialistica in Giurisprudenza, a un anno dalla laurea svolge il praticantato.
Quanti diventano avvocati. L’esame di Stato viene passato, in media, da un terzo
di chi si presenta. Nel 2006, a fronte di 41.400 presenti agli scritti, gli
idonei sono stati 16.358. Nel 2007 la percentuale è scesa: su 40.000 presenti,
gli idonei sono stati 9.905, circa uno su quattro. Non sono ancora noti i dati
complessivi sul 2008. La severità crescente deriva dalla volontà degli organi
dell’avvocatura di limitare gli accessi. I 200mila avvocati iscritti all’albo in
Italia, infatti, sono una fetta consistente dei circa 850mila avvocati presenti
in tutta Europa (dato Ccbe del 2005). In Francia il numero totale degli avvocati
è di 50mila.
Quanto costa sostenere l’esame. Per i giovani aspiranti avvocati
i costi da affrontare in vista dell’esame sono di circa 50 euro (in pratica i
bolli da accompagnare alla domanda stessa). Se si supera l’esame, ad altri tre
bolli da 14,62 euro (per l’istanza e i certificati di compiuta pratica e
superati esami) si aggiungono 168 euro per concessioni governative, 103 euro per
tassa di iscrizione e 207 euro come contributo annuo all’Ordine (nell’esempio si
tratta di quello di Milano). Quanto guadagnano i praticanti. Non esiste una
rilevazione ufficiale. In genere si tratta di un rimborso spese che cresce nel
tempo. Nel Mezzogiorno una prassi diffusa consiste semplicemente nel non pagare
i praticanti avvocati. In realtà come Milano, invece, un praticante guadagna
all’inizio più o meno 500 euro al mese in uno studio tradizionale. Negli studi
d’affari internazionali la retribuzione può salire fino a 1.500-2.000 euro al
mese, a fronte di un impegno in termini di ore di lavoro molto elevato. La Cassa
nazionale forense dà delle indicazioni interessanti sul reddito professionale ad
inizio carriera, una volta che l’esame è stato superato: circa 10mila euro
all’anno - meno di un quinto dei 51.313 euro del reddito professionale medio
degli avvocati.
Retribuzione minima? In Italia attualmente non esiste una
retribuzione minima per i praticanti avvocati. Per quanto nel Codice
deontologico forense sia previsto l'obbligo di corrispondere, «dopo un periodo
iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto»,
l’indicazione non è vincolante. Una proposta di riforma
dell’avvocatura approvata da tutte le organizzazioni della professione (e in
particolare dal Cnf) e attualmente allo studio della commissione Giustizia del
Senato prevede, tra l’altro, l’obbligo di retribuire i praticanti. Non si fissa,
tuttavia, una soglia minima per il salario, perché, spiegano dal Cnf, «sono
troppe le variabili da considerare, dal tipo di impegno al tipo di lavoro alla
zona geografica dello studio». Forme di salario minimo per i praticanti sono
previste in Germania (circa 700 euro) e nel Regno Unito (almeno l’equivalente di
1.000 euro per i pupils aspiranti “barristers”). Cosa fanno. Ci sono alcune
attività tipiche. Come emergeva in un precedente post, il praticante in studio
svolge delle ricerche propedeutiche al lavoro di altri avvocati e redige atti,
memorie, comparse, citazioni. In tribunale, oltre ad assistere alle udienze,
deposita atti presso la cancelleria, oppure va all’ufficio notifiche per
rilasciare atti da notificare. La procedura. La pratica dura almeno 24 mesi.
All’inizio il praticante riceve un libretto, che ogni sei mesi dev'essere
controllato da un “tutore” dell’Ordine e firmato dal “dominus”, cioè
dall’avvocato presso cui si svolge la pratica. Sul libretto si devono segnare le
udienze seguite (almeno 20 a semestre), gli atti processuali e le attività
stragiudiziali a cui il praticante partecipa; infine si devono trattare almeno
dieci questioni giuridiche studiate durante il semestre. Alla fine di ogni anno
si devono poi scrivere dieci relazioni sulle cause seguite e sulle questioni
giuridiche osservate. Dopo il primo anno è possibile fare la domanda per
ottenere l’abilitazione al patrocinio, che permette di seguire in proprio alcune
cause minori, come quelle di competenza del giudice di pace. Per l'intera
procedura si veda, per esempio, il vademecum dell'Ordine di Firenze.
La scuola di specializzazione. Secondo l’attuale disciplina, dei
due anni di pratica uno può essere sostituito dal conseguimento del diploma
delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. La riforma della
professione allo studio al Senato prevede, oltre alla pratica negli studi, anche
la “frequenza obbligatoria e con profitto”, per almeno 24 mesi, di corsi di
formazione tenuti esclusivamente da Ordini e associazioni forensi. I corsi,
particolare non trascurabile, possono essere a pagamento. Fabrizio Patti
Pianeta praticanti, videointervista a Duchesne: il libro
«Studio illegale» vola sulle ali del blog, e presto diventerà un film.
Fabrizio Patti il 26 Giugno 2009 su La Repubblica. Federico Baccomo, alias
Duchesne, con il suo «Studio illegale» è diventato una punto di riferimento per
i praticanti e i giovani avvocati in Italia. Prima un blog commentato ogni
giorno da centinaia di persone, poi un libro (Studio illegale, pubblicato dalla
casa editrice Marsilio) che ha già raggiunto le 15mila copie vendute e da cui
presto potrebbe essere tratto un film. Intanto il trentenne Baccomo lavora alla
sua opera seconda, che uscirà - ma il quando è ancora un segreto - sempre per
Marsilio.
La Repubblica degli Stagisti gli ha fatto una videointervista
sulla condizione dei praticanti nelle law firm internazionali, sulla riforma
dell’avvocatura e sugli stage negli studi legali. Rispetto a uno dei temi che
stanno più a cuore ai praticanti, e cioè il rimborso spese, Duchesne ricorda
che «l'obbligo di retribuzione esisteva già nel Codice deontologico», e ritiene
che la nuova proposta di legge non sia poi così incisiva: «Non dice quasi nulla,
anzi peggiora la situazione». E affonda: «Io questa cosa non la capisco: è vero
che un praticante comincia da zero e non sa niente, che all'inizio bisogna
insegnargli il lavoro, ma poi ci sarà un motivo se l'avvocato si tiene un
praticante, e non credo che sia bontà o solidarietà! E credo che
questo motivo vada retribuito». E gli stagisti negli studi legali? «Non fanno
niente: pinzano fogli uno con l'altro, e spesso neanche benissimo» scherza
l'avvocato-blogger-scrittore, aggiungendo però che lo stage è utile ai ragazzi
per capire se vogliono passare la loro futura vita lavorativa tra le quattro
mura di uno studio legale o no: «Lo stagista vede un ambiente, e riesce a farsi
un'idea in tre mesi di che tipo di lavoro è». Ebbene sì, anche gratis: «Spesso
non sono pagati: ma trattandosi di un periodo universitario, ci sta anche che
possa essere soltanto un vantaggio in termini di conoscenza professionale».
Rubavano fiori al cimitero, poi li vendevano nel loro negozio
abusivo.
Pubblicato mercoledì, 22 gennaio 2020 su Corriere.it da Salvo Toscano. Rubavano
i fiori dei morti al cimitero. Anche sotto il naso dei parenti in lacrime. Con
questa accusa sono state denunciate due persone a Catania. E una denuncia è
arrivata anche per le loro mogli che, avendo presentato la documentazione che
attestava l'assenza di reddito familiare, percepivano il reddito di
cittadinanza. Il commissariato di Librino ha indagato sugli episodi di
illegalità nel cimitero, dove erano stati segnalati numerosi furti di fiori e
addobbi. Il primo caso è stato scovato dagli agenti all’obitorio, dove un
pregiudicato, approfittando del momento di distrazione dei familiari dei
defunti, si è impossessato di una quantità fiori che ha portato nella sua auto
per poi allontanarsi e nasconderli all’interno di un vicoletto cimiteriale, nei
pressi di altre tombe. L’uomo ha poi riferito di esercitare in nero l’attività
di fioraio davanti al cimitero e di percepire sussidi statali, in quanto
ufficialmente disoccupato. I poliziotti hanno poi notato un altro
pluripregiudicato, sottoposto all’obbligo di soggiorno nel Comune di Catania,
che rubava in obitorio corone e addobbi floreali, e li portava nella sua auto
(guidava senza patente e senza assicurazione, si è poi accertato) in un negozio
di fiori di via della Concordia gestito da lui stesso e dal fratello,
pregiudicato anche lui. Il negozio sarebbe per giunta del tutto abusivo, con
dipendenti in nero e precarie condizioni di sicurezza. Storie di illegalità
legate ai cimiteri, come quella incredibile emersa la settimana scorsa a
Palermo, dove un uomo, che lavora in un'agenzia di pompe funebri, è finito ai
domiciliari (e altre tre persone risultano indagate) perché accusato di aver
«rubato» la salma di una donna dalla camera mortuaria dell'ospedale Cervello,
per accaparrarsi il servizio funebre. E tre mesi dopo la stessa persona si
sarebbe disfatta della bara con il corpo di un'altra donna svizzera che abitava
a Mondello (di cui l'agenzia avrebbe dovuto curare la tumulazione),
abbandonandolo per i viali del cimitero dei Rotoli.
Reddito di cittadinanza: 237 “furbetti” con Ferrari, ville o
in galera per mafia. Le Iene News il 23 gennaio 2020.
La Guardia di Finanza di Locri ha scoperto 237 persone che, secondo le indagini,
percepirebbero il reddito di cittadinanza irregolarmente. Alcuni hanno delle
Ferrari, altri delle ville oppure sarebbero addirittura in galera per attività
mafiose. Noi de Le Iene con Ismaele La Vardera vi abbiamo parlato in onda di due
casi di presunti “furbetti”. La Guardia di Finanza di Locri indaga su 237
presunti furbetti che percepirebbero da tempo il reddito di cittadinanza in
maniera irregolare, per un totale di 870mila euro. Tra loro ci sarebbero,
secondo le indagini, proprietari di bolidi come Ferrari, ville lussuose
e addirittura mafiosi in galera. L’inchiesta è partita dopo che la Guardia di
Finanza di Locri ha indagato su alcuni casi di falsi braccianti agricoli e falsi
rimborsi fiscali segnalati dalla procura. Alcuni degli indagati per presunto
reddito di cittadinanza irregolare dicono di “essersi dimenticati di fare la
dichiarazione di redditi” oppure risulterebbero in galera per atti mafiosi. Noi
de Le Iene abbiamo scoperto con Ismaele La Vardera i primi presunti “furbetti”
del reddito di cittadinanza a Palermo nel servizio che potete vedere qui sopra.
Un intervistato ha strappato il microfono dalle mani di Ismaele e ha iniziato a
picchiare in testa l’operatore. L’accusa: Giuseppe e Fabio, questi i loro nomi,
percepivano rispettivamente 500 e 638 euro, ma lavoravano entrambi in due negozi
che affittavano biciclette per turisti in visita nel centro cittadino. Di
presunti furbetti del reddito di cittadinanza vi abbiamo parlato anche per i
casi di un uomo che avrebbe percepito la misura di sostegno mentre in realtà
faceva lo spacciatore di droga con tanto di Porsche personale, di una donna che
è stata pizzicata a lavorare in nero in un centro estetico, nonostante
percepisse l’assegno, e dei quattro accusati di Civitavecchia che
avrebbero avviato alla prostituzione una ragazza mentre uno di loro, 64enne,
avrebbe percepito il reddito di cittadinanza.
Locri, reddito di cittadinanza con ville e Ferrari: 237
denunciati. Pubblicato giovedì, 23 gennaio 2020
su Corriere.it da Ferruccio Pinotti. Tra di loro anche mafiosi in galera. La
Finanza è partita da una precedente inchiesta sui falsi braccianti agricoli.
C’era chi aveva la villa e chi la Ferrari, chi era titolare di un’impresa ma si
era «dimenticato» di fare la dichiarazione dei redditi e chi, invece, era
direttamente in galera perché mafioso: sono i 237 furbetti che tra aprire e
dicembre del 2019 hanno chiesto il Reddito di cittadinanza e che sono stati
scoperti dalla Guardia di Finanza di Locri nell’ambito di un’indagine,
coordinata dalla Procura, nata da una precedente inchiesta sui falsi braccianti
agricoli e sui falsi rimborsi fiscali. L’attività è scaturita dall’analisi della
numerosa platea di persone già denunciate per i fenomeni dei «falsi braccianti
agricoli» nonché dei «falsi rimborsi fiscali»: tra di essi infatti ne sono stati
individuati molteplici che avevano richiesto ed ottenuto anche la misura del
reddito di cittadinanza. Le attività d’indagine, condotte secondo le modalità
tipiche della polizia economico-finanziaria e dei successivi rilevamenti
anagrafici presso i comuni di residenza dei soggetti richiedenti, sono state
rivolte ad appurare la presenza di eventuali anomalie nelle Dichiarazioni
Sostitutive Uniche (DSU) poste a fondamento della richiesta del beneficio. Tali
attività hanno permesso di riscontrare irregolarità su 237 istanze. Nel corso
delle azioni ispettive è stata accertata l’omessa indicazione nelle DSU di
componenti del nucleo familiare anagrafico, del coniuge non separato, nonché del
possesso di redditi, di beni mobili (veicoli e moto) ed immobili (terreni e
fabbricati). Tra i soggetti analizzati, i casi più eclatanti riguardano: due
persone che risultano detenute per il reato di associazione di stampo mafioso a
seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita la scorsa estate
nell’ambito di un’importante operazione di polizia giudiziaria denominata
“Canada Connection”; un intero nucleo familiare riconducibile ad una nota
famiglia di ‘ndrangheta, colpita nella maggior parte dei suoi componenti da una
condanna penale definitiva con la conseguente interdizione dai pubblici uffici.
Uno di essi è peraltro in stato di arresto dall’aprile del 2018; diversi
soggetti titolari di redditi, alcuni anche per oltre 55.000 euro, che non sono
stati indicati nel nucleo familiare; alcuni intestatari di ville ed autovetture
di lusso (tra cui uno è stato intestatario di una Ferrari oltre ad essere stato
anche destinatario di ordinanza di custodia cautelare domiciliare nell’ambito
dell’operazione «Le Mille e una Notte»); titolari di attività imprenditoriale
con partita Iva attiva che, pur avendone l’obbligo, non avevano presentato
alcuna dichiarazione dei redditi. I 237 indebiti percettori sono stati inoltre
segnalati all’Inps per l’avvio del procedimento di revoca dei benefici ottenuti,
con il conseguente recupero delle somme già elargite che ammontano a circa
870mila euro (importo consistente se posto in relazione ai soli 9 mesi di
erogazione del beneficio); nel contempo, sarà conseguentemente interrotta
l’erogazione del sussidio che avrebbe altrimenti comportato, fino al termine del
periodo di erogazione della misura, un’ulteriore perdita di risorse pubbliche di
oltre 1milione di euro. Il risultato conseguito testimonia l’approccio
multidisciplinare e trasversale dell’azione sviluppata nelle attività di
servizio dalla Guardia di Finanza, che vigila allo scopo di assicurare che le
misure di sussidio siano effettivamente destinate alle fasce più deboli e
bisognose della popolazione e non siano invece preda di individui disonesti ed
irrispettosi delle leggi.
Iptv e pezzotto, chiusi 15 siti pirata: trasmettevano la Serie
A in streaming. Le Iene News il 17 gennaio 2020. Giro
di vite al fenomeno del pezzotto e delle Iptv pirata. La Guardia di Finanza ha
oscurato 15 siti che trasmettevano partite di Serie A in streaming. L’indagine
ora punta a individuare i reseller e i clienti di questo traffico. Alessandro Di
Sarno ha incontra un venditore all’ingrosso, anello di congiunzione tra chi sta
ai vertici e gli installatori. Quindici siti oscurati che
consentivano illegalmente la visione di partite di Serie A a pagamento.
L’operazione della Guardia di Finanza punta a dare un giro di vite alla vendita
illegale del pezzotto, il dispositivo che permette di vedere in maniera illegale
canali tv che richiederebbero un abbonamento. Nel servizio che vi riproponiamo
qui sopra, Alessandro Di Sarno ci ha mostrato che cosa si nasconde dietro questo
fenomeno (a volte addirittura la camorra). Il tribunale di Roma ha oscurato ora
15 siti web con un sequestro preventivo. La nuova indagine è partita da una
denuncia presentata dalla Lega di Serie A, contitolare, assieme alle singole
squadre organizzatrici delle partite di calcio, dei diritti audiovisivi del
campionato di Serie A Tim, Coppa Italia, Supercoppa e competizioni Primavera.
Gli inquirenti hanno smascherato il traffico di pirateria che nasce dalla
distribuzione illecita dei segnali delle Iptv. Le indagini in corso hanno come
obiettivo principale l'individuazione dell'organizzazione composta da decine di
“reseller” che vendono per poche decine di euro abbonamenti illegali a migliaia
di clienti che ora rischiano una denuncia. Con Alessandro Di Sarno abbiamo
cercato di capire come funziona e si organizza questo business illegale. Il
nostro viaggio è iniziato circa un anno fa a Napoli, dove abbiamo incontrato la
base di questa piramide illegale: gli installatori. E, se alla base ci sono
loro, ai vertici troviamo gli amministratori, cioè le persone che gestiscono la
distribuzione e la vendita di tutti gli abbonamenti. Qualche settimana fa ne
abbiamo intervistato uno che era stato arrestato e che rischia la condanna per
associazione a delinquere. Queste sono le persone che guadagnano di più
all’interno della piramide. “Al mese guadagnavo sui miei 40mila user almeno un
euro a user. Entravano circa 40mila euro al mese”. Tra gli installatori e gli
admin ci sono i reseller, venditori all’ingrosso di pezzotti che superano
mediamente i 1.000 utenti. Ci siamo infiltrati in uno dei gruppi di venditori
all’ingrosso più grandi d’Italia e siamo riusciti a ottenere un appuntamento con
un reseller. “Nel mio gruppo siamo in 109”, ci spiega. “Ogni gruppo ha 1.000
utenti”. Si tratterebbe quindi di un giro d’affari da oltre un milione di euro
al mese. Ci fingiamo convinti a comprare da lui gli abbonamenti e gli diamo
appuntamento nel parcheggio per dargli i soldi in cambio dei codici degli
abbonamenti. Invece dei soldi ad aspettarlo c’è il nostro Alessandro di Sarno.
La reazione del reseller ci lascia senza parola. “Io non vendo niente”, ci
dice. “Io ho due figli per favore!”, e scoppia in un pianto disperato: “Non
arrivo a fine mese”. La Iena gli chiede per chi lavora. “È un gruppo troppo
gigantesco non so neanche io chi sono i capi. Sono flussi che arrivano tutti
dall’Europa e anche fuori. Io guadagno 10 euro a abbonamento”. E ci parla di “un
boss troppo grande, uno che è nel giro da tanti anni, è il proprietario dei
flussi”.
Michela Allegri per ilmessaggero.it il 29 dicembre 2019. Notizie
riservate spifferate sottobanco, una contabilità parallela e un vero e proprio
«sistema Rai», escogitato da decine di dipendenti per gonfiare le spese di
trasferta. Agli atti dell’inchiesta sul maxi raggiro costato all’azienda di
Stato circa 120mila euro di rimborsi non dovuti elargiti a tecnici del suono e
delle luci, registi, autori, direttori della fotografia e scenografi incaricati
di seguire il Festival di Sanremo, c’è un’informativa della Guardia di finanza
di Imperia che tratteggia i contorni dell’imbroglio. La procura di Roma - il pm
è Alberto Pioletti - ha chiuso le indagini per 52 persone, tutte accusate di
truffa: 51 dipendenti Rai e Matteo Paracchini, cognato del sindaco di Sanremo e
titolare dell’hotel Belsoggiorno, che dal 2013 al 2015 avrebbe emesso fatture
false permettendo ai clienti di presentare all’azienda scontrini taroccati. È
stato proprio lui il primo a parlare del «sistema Rai» e a lasciare intendere di
essere stato avvisato dell’indagine a suo carico. Quando nel 2016 i finanzieri
hanno bussato alla porta del Belsoggiorno per un controllo fiscale, Paracchini
si aspettava la visita: nell’informativa si legge che prima dell’arrivo del suo
avvocato, ha detto che «nell’aprile 2016, quando è stato avviato il controllo
fiscale, ha ricevuto una telefonata nel corso della quale una persona, di cui
non ha voluto indicare le generalità, gli comunicava di essere venuto a
conoscenza del controllo». La talpa gli avrebbe anche rivelato che l’indagine
riguardava «la questione Rai», avvertendolo «di stare attento». Poi ha aggiunto
che «il sistema Rai gli era stato imposto». Paracchini sosteneva di essere
«costretto» ad accettare quelle condizioni «per garantirsi la presenza dei
dipendenti Rai». Aderendo al sistema, infatti, «sarebbe stata garantita la
sistematica occupazione delle camere per l’intero periodo delle manifestazioni
da parte di quel personale che avrebbe soggiornato per il periodo più lungo. In
caso contrario, presso la struttura sarebbero state alloggiate persone che,
ricoprendo mansioni marginali, avrebbero soggiornato per un periodo più breve».
Erano i dipendenti della tv pubblica, infatti, a scegliere tra gli alberghi
convenzionati quelli dove alloggiare. E avrebbero optato per il Belsoggiorno
proprio perché l’accordo con la proprietà avrebbe permesso loro di “taroccare”
gli scontrini. «Nel novembre dell’anno precedente il Festival qualche dipendente
chiamava per assicurarsi che l’accordo fosse sempre valido e, ottenuta la
conferma, passava la voce ai colleghi», ha raccontato un addetto alla reception.
L’albergatore avrebbe aggiunto di avere seguito le regole dopo il controllo del
2016, constatando un calo di presenze. Poi, però, in presenza del suo avvocato,
ha ridimensionato i fatti, parlando di un tentativo di evasione fiscale. In
realtà, dalle indagini è emersa l’esistenza di una «contabilità parallela a
quella ufficiale», chiosa la Finanza. Le false fatture sarebbero state emesse
anche in altre occasioni: la Milano-Sanremo, la festa dei Carri fioriti, Sanremo
giovani. A raccontarlo, sono stati i dipendenti dell’albergo, che hanno spiegato
come funzionava il «sistema Rai». Un testimone ha dichiarato che «l’albergo,
ospitando i dipendenti della tv di Stato, provvedeva a emettere fatture fiscali
per pasti che non venivano consumati, erano gratuiti, venivano consumati con un
esborso di denaro inferiore». Gli stessi documenti venivano poi «usati dai
dipendenti Rai per ottenere il rimborso di spese mai sostenute». Il testimone ha
aggiunto che «Paracchini era costretto comportarsi così in quanto, in caso
contrario, i dipendenti Rai avrebbero chiesto l’alloggiamento altrove». Un ex
addetto alla reception ha poi spiegato gli escamotage per evitare che le fatture
ritoccate venissero contabilizzate: veniva fatta una fotocopia a colori di un
documento fiscale originale in bianco, e veniva poi usata per emettere la
fattura senza inserire nulla nella contabilità ufficiale. Oppure, veniva usato
un file excel, appositamente predisposto, con i caratteri uguali a quelli del
programma contabile dell’albergo. Un altro receptionist ha detto che, nonostante
la convenzione prevedesse l’alloggio in una camera singola, spesso i dipendenti
Rai decidevano di stare in coppia, mentre la camera, già pagata dall’azienda di
Stato e lasciata libera, veniva rivenduta ad altri clienti. «Paracchini
corrispondeva ai due “conviventi” 20 euro a testa al giorno per il tempo di
soggiorno». L’accordo sui pasti funzionava così: «Il primo pasto consumato era
gratuito, mentre il secondo era pagato al 50%, cioè circa 20 euro». Mentre il
rimborso chiesto alla Rai era relativo a due pasti, per un totale di 60 euro.
Alessio Ribaudo per corriere.it il 30 dicembre 2019. Tra qualche
giorno, come tutti beneficiari del Reddito di cittadinanza, avrebbero ricevuto
l’attesa «ricarica». Invece, non solo la loro carta resterà a secco per sempre
ma dovranno pure pagarsi gli avvocati perché sono stati denunciati per truffa ai
danni dello Stato. Sono i «furbetti» del reddito di cittadinanza che, pur di
incassare soldi che non gli spettavano, hanno dichiarato dati non veritieri e
hanno «beffato» persino le «forche Caudine» dei primi controlli da parte Inps.
Secondo il suo presidente, Carlo Tridico, l’ente ha respinto il 26 per cento
delle domande ricevute. In particolare, in Campania è stata bocciata una
richiesta su cinque mentre in Lombardia circa un terzo. Nella prima fase di
verifica, finita a giugno, l’Ispettorato generale del lavoro, ne ha «beccati»
185 che non ne avevano diritto. Scorrendo, i comunicati delle forze dell’ordine
e le notizie sparse, i casi sono saliti di molto. Un vero e proprio spaccato di
malcostume italiano. Per esempio, un «furbetto» è stato trovato, con 600 euro in
tasca, mentre guidava una Porsche Macan (costa a partire da 60 mila euro) con
120 grammi di cocaina, nascosta a casa in doppi fondi ricavati nelle lattine di
bevande e di un piccolo estintore. La mappa dei «pizzicati» è, un vero e
proprio, Giro d’Italia: dalla Lombardia alla Sicilia passando per la Liguria,
l’Emilia Romagna, la Campania, la Puglia e la Calabria.
IL «CAMPIONARIO». Il «campionario» dei «furbetti», denunciati
dagli inquirenti, è sconfinato e comprende imprenditori, negozianti, soci di
Onlus, cassieri, baristi, camerieri, lavoratori in «nero» ma anche fotografi,
cantanti neomelodici, venditori ambulanti. Non mancano delinquenti, spacciatori,
mafiosi e... defunti!. A Rimini, per esempio, un settantenne ha pensato bene di
dichiarare di ricevere «solo» una pensione sociale. Le fiamme gialle hanno
scoperto che aveva semplicemente «dimenticato» di dichiarare le sue proprietà
immobiliari oltre a essere proprietario di un albergo (attualmente non attivo)
del valore commerciale stimato pari a oltre 800 mila euro. Andando più a fondo
hanno accertato che l’anziano usufruiva dal 2017, indebitamente, già di altre
prestazioni sociali, erogate sempre dall’Inps. Un po’ più a Nord, a Milano, a
dicembre ne sono stati scovati 22: in 16 sono facevano i venditori ambulanti di
gadget in occasione di manifestazioni organizzate presso il Forum di Assago. Una
donna invece è stata sorpresa mentre lavorava «in nero» nell’officina del padre.
A mezz’ora di strada, a Bergamo, la Gdf ne ha denunciati 12. Si va da lavoratori
in «nero» a due donne che riscuotevano il beneficio malgrado, nel frattempo,
fossero state assunte oppure una donna, di origine libanese, che, simulando una
separazione dal coniuge, non aveva indicato nella domanda il reddito del marito:
oltre 120mila euro. Non sempre le operazioni sono mirate alla scoperta del
reddito di cittadinanza ottenuto in modo truffaldino. A Torino una badante di
origine rumena aveva ottenuto il sussidio ma non aveva dichiarato il reddito
incassato nei quattro anni precedenti: 140mila euro. A Genova, invece,
nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su un
traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica, uno degli arrestati —
condannato in primo grado dal Tribunale di Locri per falsa testimonianza per
l’omicidio dell’allora vice-presidente del Consiglio Regionale della Calabria —
percepiva, da giugno, il beneficio. L’indagato, proprietario di una villetta
appena ristrutturata nel comune di Gioiosa Jonica, è stato denunciato anche per
questo motivo e l’Inps gli ha sospeso l’erogazione di 500 euro al mese.
LA MAPPA. La mappa delle indagini riguarda davvero tutto lo
Stivale. Nel Frusinate ne sono stati scoperti 37. Un imprenditore, per esempio,
aveva omesso di dichiarare intere quote di una società dove, tra l’altro, il
figlio, facente parte del nucleo familiare, lavorava in «nero», producendo un
reddito non inserito nella dichiarazione. Ventisei persone, un tempo nomadi,
invece sono stati denunciati perché avevano ottenuto fraudolentemente il reddito
di cittadinanza: per un ammontare complessivo di 110.000 euro. Non avevano
dichiarato possidenze mobiliari e immobiliari o una composizione del nucleo
familiare diversa da quella reale. Nel Casertano ne sono stati smascherati
ottanta. La lista dei «furbetti» comprende baristi, pizzaioli, operai, cassieri,
addetti ad autolavaggi, magazzinieri, muratori, contrabbandieri di sigarette e
il «mago» della pirateria informatica. «Pizzicato» pure l’ex titolare di un
caseificio che, dopo aver ceduto le quote dell’impresa ai familiari, manteneva
un tenore alto di vita ed era stato più volte fermato su auto lussuose. Peccato
che percepiva il reddito di cittadinanza. Per la Gdf, nella domanda non aveva
inserito sua moglie nel nucleo familiare. Scoperti pure due coniugi che, tra
l’altro, avevano un negozio di abbigliamento ma la loro partita Iva era chiusa.
Così non dichiaravano nulla e avevano il sussidio. Nel Cosentino, sono scattate
41 denunce e una ha riguardato un fotografo professionista che pubblicizzava i
propri servizi sui social network. Oltre a lavoratori in «nero» c’era anche la
gestrice di un B&B che anche lei pubblicizzava l’attività sui social e su vari
motori di ricerca. In molti pensavano che trasferendo, in modo fittizio, la loro
residenza per far figurare un nucleo familiare ristretto la potessero fare
franca. A Sora, nel Frusinate, è stata scoperto che in una attività di vendita
di bibite e alimenti, a lavorare costantemente era il padre del titolare che
percepiva, da giugno, il reddito di cittadinanza. Per ottenerlo aveva presentato
all’Inps false dichiarazioni sulla propria posizione lavorativa. A Trapani, è
stato «beccato» un pasticcere che aveva affittato un appartamento e lo aveva
trasformato in laboratorio dove era aiutato dalla moglie. Da giugno, lui
incassava però 700 euro al mese come beneficio da reddito di cittadinanza. La
strategia per dichiarare guerra ai «furbetti» è stata messa a punto dal comando
generale della Guardia di finanza attraverso una circolare operativa che punta a
individuare chi ha provato ad approfittare. «È bene ricordare che il reddito di
cittadinanza è un beneficio riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di
particolari requisiti (cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e
patrimoniali) — spiegano dalla guardia di finanza — che si ottiene presentando
all’Inps, telematicamente o presso i centri autorizzati (Caf e uffici Postali),
un’apposita domanda. Presuppone una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da
parte di chi propone l’istanza sulla posizione patrimoniale e reddituale
dell’intero nucleo familiare. È proprio sulla veridicità dei dati
auto-dichiarati dai richiedenti che sono concentrati i controlli. Sono
informazioni che non emergono dalle verifiche automatiche del sistema ma che
possono essere scoperte solo attraverso l’azione di servizio sul territorio e
grazie all’incrocio delle notizie contenute nelle diverse banche dati in uso al
Corpo». Non sempre i «furbetti» vengono scoperti con azioni mirate ma attraverso
indagini successive. Per esempio, a Modena, una 39enne è stata «beccata» dalla
polizia locale, durante il Gay Pride, mentre vendeva abusivamente alcolici ai
manifestanti e le era stata elevata una multa salata: 5.164 euro. Le indagini
successive hanno accertato che percepiva il reddito di cittadinanza da aprile e
poi aveva aperto anche una partita Iva, continuando a ricevere il beneficio
economico, incompatibile per legge. A Partinico, nel Palermitano, in un
panificio sono stati trovati quattro lavoratori erano tutti occupati in «nero».
Uno di loro percepiva anche il reddito di cittadinanza. Per il proprietario del
panificio è stata invece accertata, non solo una violazione delle norme sul
lavoro, ma anche una consistente evasione fiscale: 15mila euro di Iva non pagata
e imposte evase su un reddito non dichiarato di 275mila euro. Per altri 11 soci
di una Onlus, percettori di reddito di cittadinanza, sono in corso
approfondimenti per capire se va tolto del tutto o rimodulato. Durante una
verifica fiscale, le fiamme gialle hanno trovato centinaia di autocertificazioni
sottoscritte dai volontari, attraverso le quali richiedevano il rimborso delle
spese sostenute nel corso del servizio, senza l’indicazione però delle spesa
effettuate e del giorno in cui le stesse sarebbero state sostenute. Da un
raffronto è stato constatato che alcuni di questi percepivano la massima somma
spettante nel mese pur avendo prestato la propria opera volontaria per meno di
dieci giorni. In alcuni casi sono stati addirittura rilevati rimborsi spese nei
confronti di “volontari” senza che risultasse traccia della loro presenza. Per
questo, dal punto di vista prettamente fiscale, i finanzieri hanno riqualificato
i rimborsi spese forfettari percepiti dai soci come veri e propri compensi. A
carico della Onlus, è stato constatato l’omesso versamento di ritenute Irpef non
operate per oltre 75mila euro. Invece, lo scorso ottobre, la questura di Catania
ha denunciato tre manager e dieci cantanti neomelodici per reati connessi,
direttamente e indirettamente, durante un concerto, conclusosi con fuochi
d’artificio, che si sarebbe svolto illegalmente, chiudendo al traffico una
strada. Secondo gli agenti, la «star» della serata era una cantante neomelodica
Agata Arena, denunciata per affissione abusiva di manifesti pubblicitari e per
truffa aggravata allo Stato per l’indebita percezione del reddito di
cittadinanza. Reato che, secondo l’accusa, avrebbe reiterato presentando una
nuova domanda. Oltre alla Arena, per gli inquirenti, due dei promoter e altre
due persone estranee all’organizzazione del concerto sono stati denunciati per
truffa perché anche loro avrebbero percepito illegalmente il reddito di
cittadinanza. Nel Siracusano, in un supermercato sono stati trovati nove
dipendenti in divisa che erano pagate in nero: in due percepivano il reddito di
cittadinanza. Eppure, le pene sono severe: la legge prevede anche la reclusione
da due a sei anni per chiunque presenti dichiarazioni false oppure ometta
informazioni dovute. È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei
casi in cui si ometta la comunicazione all’Inps delle variazioni di reddito, del
patrimonio o del nucleo familiare, nonché informazioni dovute e rilevanti ai
fini della riduzione o revoca del beneficio. «La decadenza ricorre allorquando
uno dei componenti del nucleo familiare viene trovato — precisano dalla guardia
di finanza — a svolgere: “in nero” un’attività di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa senza la preventiva comunicazione
obbligatoria on line ai servizi per l’impiego un’attività di impresa o di lavoro
autonomo, senza la comunicazione di inizio di attività all’Inps, da effettuare
entro trenta giorni dall’inizio della stessa». La revoca, invece, ricorre «con
efficacia retroattiva, qualora al termine del processo penale, sia stata
accertata la responsabilità della persona, oltre alla condanna definitiva ne
sussiste una accessoria che comporta la restituzione di quanto indebitamente
percepito l’Inps abbia accertato la non veridicità della documentazione e delle
informazioni prodotte a corredo dell’istanza o l’omessa comunicazione successiva
delle variazioni patrimoniali o riferite ai componenti del nucleo familiare». Lo
scopo dei controlli per la guardia di finanza è chiaro: «bisogna tutelare la
fiducia che i cittadini onesti devono poter nutrire nella corretta destinazione
delle ingenti risorse che il Paese, non senza sacrifici, destina agli aiuti
economici e ai servizi sociali riservati a chi si trovi in una reale condizione
economica e sociale di svantaggio». Secondo i calcoli dell’Inps, il reddito avrà
un costo per le casse statali nel 2019 di 5,2 miliardi. La distribuzione
territoriale vede in testa il Sud continentale (39%), seguita dal Nord (24%),
dalle isole (22%) e, quindi, dal Centro (15%) ed alle isole il 22%. La media
mensile percepita dai cittadini è di 549,71 euro. Le verifiche sui percettori
sono appena iniziate e tanto è ancora da fare ma se si considera che a intascare
il reddito — secondo Tridico, presidente dell’Inps — sono 2,4 milioni di persone
(oltre 982 mila i nuclei familiari), significa che la percentuale dei truffatori
è bassissima. I problemi sul campo per le casse dello Stato sono tanti. Secondo
gli ultimi dati Istat, nel 2017, l’economia sommersa ammonta a poco meno di 192
miliardi di euro (12,1% del Pil) e le attività illegali a circa 19 miliardi. I
lavoratori irregolari sono 3,7 milioni, in crescita di 25 mila unità rispetto al
2016. Un dato, purtroppo, spaventoso.
Cantanti con Porsche e hotel. Tutti i furbi del reddito M5S.
Nelle varie indagini di verifica sull'effettiva
presenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza spunta di tutto.
Stefano Damiano, Domenica 29/12/2019, su Il Giornale. Da lavoratori in nero agli
imprenditori, passando per persone con precedenti penali e artisti. La lista dei
"furbetti"del RdC (reddito di cittadinanza) è estremamente variegata, non solo a
livello geografico ma anche nella tipologia di persone che hanno cercato di
accedere alla misura di sostegno fortemente voluta dal M5S pur non avendo i
requisiti richiesti. La compagine governativa, con il cambio della componente
leghista con quella democratica, aveva preannunciato controlli a tappeto per la
verifica del possesso dei criteri per ricevere il sostegno economico e, nei
fatti, i controlli sono iniziati e ciò che emerge, purtroppo, non è per nulla
incoraggiante e costringe ad una riflessione sulla modalità di assegnazione del
RdC. Difatti, pur di incassare la cifra che poteva arrivare a 780 euro, in tanti
hanno fatto di tutto, compreso quello di uscire dalla legalità. Così dalle
indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza nelle varie città italiane, a
partire da Milano e Siracusa, passando per Torino, Roma, Napoli e Cosenza,
quello che emerge è poco edificante. È vero che l'Inps una prima scrematura dei
richiedenti l'aveva fatto, come evidenzia il Corriere della Sera in
un'inchiesta, rifiutando una richiesta su 5 in alcune regioni, come in Campania,
mentre in Lombardia ne aveva rifiutato circa un terzo. Troppo poco,
evidentemente, se si analizzano i dati successi derivati dalle azioni di
controllo. L'ispettorato generale del lavoro, ad esempio, nella prima fase di
verifica avvenuta a giugno, aveva immediatamente trovato 185 persone che
ricevevano il RdC senza averne diritto. Tra questi controlli un furbetto era
stato trovato a bordo di una Porche Macan (oltre 60mila euro di automobile) e
con 600 euro in contati nel portafogli. Difficile credere che i suoi beni siano
stati frutto dei risparmi del reddito di cittadinanza. Tra i furbi ci sono anche
cantanti neomelodici, fotografi, imprenditori, venditori ambulanti, negozianti,
pasticceri, pregiudicati e lavoratori in "nero". Tra i profili controllati c'è
anche il 70enne che, a Rimini, aveva deciso di dichiarare solo la pensione
sociale dimenticandosi di dichiarare le proprietà immobiliari oltre ad un
albergo (attualmente non attivo) del valore commerciale stimato superiore agli
800 mila euro. Poi c'è una donna, di origine libanese, che aveva simulato una
separazione dal coniuge per non indicarne il reddito da oltre 120mila euro. A
Torino, invece, una badante di origine rumena aveva ottenuto il reddito di
cittadinanza ma perché non aveva dichiarato il reddito dei precedenti quattro
anni di lavoro: 140mila euro. Nel quartiere Ponticelli, a Napoli, invece, è
stato registrato un anomalo record di acquisti di bottiglie di Dom Perignon da
150 euro. Strano, se si considera che dall'ultima indagine della Guardia di
Finanza in quell'area la GdF ha scovato numerosi furbetti del sussidio di Stato.
La legge prevede pene fino alla reclusione, da 2 a 6 anni, per chi presenti
dichiarazioni mendaci o con omissione di informazioni. Prevista anche la
reclusione da 1 a 3 anni per l'omessa comunicazione all’Inps delle variazioni di
reddito, del patrimonio o del nucleo familiare, oltre a quelle informazioni
dovute e rilevanti ai fini della riduzione o della revoca del sussidio al
beneficiario.
La "guerra" delle Fiamme Gialle ai furbetti del reddito di
cittadinanza. Il Corriere del Giorno il 30 Dicembre
2019. Sinora sono stati denunciati imprenditori, pregiudicati e lavoratori in
“nero”, negozianti, pasticceri, fotografi, cantanti neomelodici, venditori
ambulanti. Le indagini della Guardia di Finanza partite da Milano passando per
Torino, Genova, Roma, Napoli, Frosinone, Cosenza arrivando sino a Siracusa,
verranno estese a tutt’ Italia. Le pene sono severe in quanto la legge prevede
anche la reclusione da due a sei anni per chiunque presenti dichiarazioni false
oppure ometta informazioni dovute. I “furbetti-predoni” del reddito di
cittadinanza, ottenuto senza averne i requisiti, circostanza che la dice tutta
sull’inconsistenza delle verifiche dell’ INPS in sede di erogazione del
contributo pubblico, sono stati scoperti e denunciati dagli investigatori
delle Fiamme Gialle, con una operazione di controllo estesa a tutte le categorie
professionali e commerciali, e che comprende imprenditori, commercianti, soci di
Onlus, baristi, camerieri, cassieri, una marea di lavoratori in “nero”. Fra i
quali anche cantanti neomelodici, fotografi, persino venditori ambulanti. Molti
“furbetti” credevano che la potessero fare franca trasferendo la loro residenza
, in modo fittizio, per far risultare un nucleo familiare più ristretto rispetto
al reale. La strategia con cui lo Stato ha dichiarare guerra ai soliti
“furbetti” è stata messa pianificata dai vertici del Comando
Generale della Guardia di Finanza che ha emanato una circolare operativa alle
proprie legioni regionali e comandi provinciali con il chiaro intento di scovare
ed identificare chi ha provato ad approfittare del reddito di cittadinanza.
Dalla Guardia di Finanza spiegano che “è bene ricordare che il reddito di
cittadinanza è un beneficio riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di
particolari requisiti (cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e
patrimoniali) che si ottiene presentando all’INPS, telematicamente o presso i
centri autorizzati (Caf e uffici Postali), un’apposita domanda. Presuppone una
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da parte di chi propone l’istanza sulla
posizione patrimoniale e reddituale dell’intero nucleo familiare. È proprio
sulla veridicità dei dati auto-dichiarati dai richiedenti che sono concentrati i
controlli. Sono informazioni che non emergono dalle verifiche automatiche del
sistema ma che possono essere scoperte solo attraverso l’azione di servizio sul
territorio e grazie all’incrocio delle notizie contenute nelle diverse banche
dati in uso al Corpo“. E potevano mancare pregiudicati, spacciatori, mafiosi e…
persino i defunti ? Certo che no ! . Per esempio un settantenne a Rimini, ha
dichiarato di incassare “solo” una pensione sociale. La Guardia di Finanza ha
scoperto che il pensionato romagnolo aveva semplicemente “dimenticato”…. di
dichiarare le sue proprietà immobiliari. Infatti oltre a essere proprietario di
un albergo (anche se al momento non attivo) del valore commerciale stimato pari
a oltre 800 mila euro è stato accertato, approfondendo la situazione , che
l’anziano pensionato dal 2017, usufruiva indebitamente anche di altre
prestazioni sociali erogate sempre dall’INPS. Una circostanza che prova la
leggerezza e l’inconsistenza , ancora una volta, e sopratutto la “latitanza” dei
controlli interni effettuati dall’ Istituto pubblico erogante. A Milano, a
dicembre sono stati scovati 22 “furbetti”: 16 di loro facevano i venditori
ambulanti in occasione di manifestazioni organizzate presso il Forum di Assago.
Una donna invece è stata sorpresa mentre lavorava “in nero” all’interno
dell’officina del padre. A Bergamo, le Fiamme Gialle ne ha denunciati 12. Si va
da lavoratori in “nero” a due donne che nonostante fossero state assunte,
riscuotevano il contributo pubblico, così come una donna di origine libanese ha
simulato una separazione dal coniuge, per non indicare nella domanda il reddito
del marito che superava i 120mila euro. Gli accertamenti della Guardia di
Finanza non sono sempre indirizzati all’accertamento di aver usufruito del
reddito di cittadinanza in modo truffaldino. Una badante di origine rumena aveva
ottenuto a Torino il sussidio ma non aveva dichiarato il reddito di 140mila euro
percepito nei precedenti quattro anni, a Genova nell’ambito di un’inchiesta
della Direzione distrettuale antimafia su un traffico internazionale di cocaina
dal Sudamerica, uno degli arrestati, già condannato in primo grado dal Tribunale
di Locri per “falsa testimonianza” e per l’omicidio dell’ex vice-presidente
del Consiglio Regionale della Calabria , incassava dallo scorso mese di giugno
del reddito di cittadinanza. L’indagato a seguito degli accertamenti effettuati
dalle Fiamme Gialle è risultato essere proprietario di una villetta appena
ristrutturata nel comune di Gioiosa Jonica, e pertanto è stato denunciato anche
per questo e l’INPS gli ha sospeso l’erogazione di 500 euro al mese che gli
aveva erogato. Ma la mappa delle indagini delle Fiamme Gialle riguarda davvero
tutto il Paese. Ventisei persone, un tempo nomadi, invece sono stati denunciati
perché avevano ottenuto fraudolentemente il reddito di cittadinanza: per un
ammontare complessivo di 110.000 euro. Non avevano dichiarato proprietà
immobiliari e mobiliari o in alcuni casi la composizione del nucleo familiare
differente da quella reale. Ottanta sono stati smascherati nel Casertano. Nella
provincia di Frosinone nel Lazio ne sono stati scoperti 37. Per esempio, un
imprenditore (in questo caso trasformatosi in “prenditore” di denaro pubblico !)
, aveva omesso di dichiarare intere quote di una società all’interno della
quale peraltro lavorava in “nero”suo figlio, facente parte del nucleo familiare,
producendo quindi un reddito non inserito nella dichiarazione. A Sora è stata
scoperto che in una attività di vendita di bibite e alimenti, a lavorare
costantemente era il padre del titolare che percepiva, da giugno, il reddito di
cittadinanza. Per ottenerlo aveva presentato all’INPS delle false dichiarazioni
sulla propria posizione lavorativa. La lista dei “furbetti” scovati dalle
indagini delle Fiamme Gialle vede presenti contrabbandieri di sigarette ed un
“mago” della pirateria informatica, pizzaioli, baristi, cassieri, operai. Fra i
tanti è stato scovato persino l’ex titolare di un caseificio il quale, dopo aver
ceduto le quote dell’impresa ai familiari, manteneva un tenore alto di vita ed
era stato più volte fermato per controlli di routine alla guida di auto
lussuose. Incredibilmente percepiva il reddito di cittadinanza. Secondo gli
accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, il “furbetto” non aveva inserito
nella domanda la presenza di sua moglie nel nucleo familiare. Sono stati
“pizzicati” anche due coniugi che, tra l’altro, gestivano un negozio al
dettaglio nonostante la loro partita Iva risultasse chiusa, cioè cessata, non
dichiarando alcun reddito e percependo il sussidio. In Calabria nel Cosentino,
sono scattate 41 denunce ed una di esse ha interessato un fotografo
professionista che pubblicizzava i propri servizi fotografici da realizzare,
persino sui social network, così come anche la gestrice di un B&B la quale
pubblicizzava anche lei la sua attività commerciale sui social e su vari motori
di ricerca. Onnipresenti i lavoratori in “nero”. In Sicilia a Trapani, è stato
“scoperto” un pasticcere che dal giugno 2019, incassava 700 euro al mese quale
beneficio proveniente dal reddito di cittadinanza, soldi con i quali aveva
affittato un appartamento e lo aveva trasformato in laboratorio dove lavorava in
nero affiancato dalla moglie, anch’essa rigorosamente in “nero” ! Nel
Palermitano a Partinico, sono stati trovati in un panificio quattro lavoratori
tutti occupati in “nero”, uno dei quali percepiva anche il reddito di
cittadinanza. A carico dell proprietario del panificio è stata invece accertata,
non solo la violazione delle norme sul lavoro, ma anche una consistente evasione
fiscale: 15mila euro di Iva non pagata e imposte evase su un reddito non
dichiarato di 275mila euro. La Questura di Catania ha denunciato lo scorso
ottobre, tre manager e dieci cantanti neomelodici per reati connessi,
direttamente e indirettamente, durante un concerto, conclusosi con fuochi
d’artificio, che si sarebbe svolto illegalmente, chiudendo al traffico una
strada. Secondo gli agenti della Polizia di Stato, la “star” della serata
sarebbe stata Agata Arena, che è stata denunciata per affissione abusiva di
manifesti pubblicitari e per “truffa aggravata allo Stato” per l’indebita
percezione del reddito di cittadinanza. Reato che avrebbe reiterato , secondo
l’accusa, presentando una nuova domanda. Oltre alla Arena, per gli inquirenti,
due dei “promoter” e altre due persone estranee all’organizzazione del concerto
sono stati denunciati per truffa perché anche loro avrebbero percepito
illegalmente il reddito di cittadinanza. Nel Siracusano, in un supermercato sono
stati trovati ben 9 dipendenti in divisa le quali venivano pagate in nero. 2 di
loro percepivano anche il reddito di cittadinanza. I “furbetti” del reddito di
cittadinanza sono stati scoperti non sempre con delle azioni mirate ma anche
attraverso successive indagini. In Emilia-Romagna a Modena , una 39enne è stata
“beccata” dalla Polizia Locale mentre vendeva abusivamente alcolici ai
manifestanti , durante il Gay Pride, e le era stata elevata una multa salata:
5.164 euro. Le successive indagini della Guardia di Finanza hanno accertato che
la modenese da aprile percepiva il reddito di cittadinanza e successivamente
aveva aperto anche una partita Iva, continuando a ricevere il beneficio
economico, che è incompatibile per legge. Per altri 11 percettori di reddito di
cittadinanza, risultanti essere soci di una Onlus, sono in corso accertamenti
per verificare se il reddito di cittadinanza va annullato del tutto o rimodulato.
Durante una verifica fiscale, le Fiamme Gialle hanno trovato centinaia di
autocertificazioni sottoscritte dai volontari, attraverso le quali
richiedevano il rimborso delle spese sostenute nel corso del servizio, senza
però l’indicazione delle spesa effettuate e del giorno in cui le stesse
sarebbero state sostenute. Da un raffronto è stato constatato che alcuni di
questi percepivano la massima somma spettante nel mese pur avendo prestato la
propria opera volontaria per meno di dieci giorni. In alcuni casi sono stati
addirittura rilevati rimborsi spese nei confronti di “volontari” senza che
risultasse alcuna traccia della loro presenza. I finanzieri pertanto dal punto
di vista esclusivamente fiscale, hanno riqualificato i rimborsi spese forfettari
percepiti dai soci come veri e propri compensi. A carico della Onlus è stato
constatato e contestato l’omesso versamento per oltre 75mila euro di ritenute
Irpef non operate. Le pene sono severe in quanto la legge prevede anche la
reclusione da due a sei anni per chiunque presenti dichiarazioni false oppure
ometta informazioni dovute. Invece è prevista la reclusione da 1 a 3 anni nei
casi in cui si ometta la comunicazione all’ INPS delle variazioni di reddito,
del patrimonio o del nucleo familiare, nonché informazioni dovute e rilevanti ai
fini della riduzione o revoca del beneficio. «La decadenza ricorre allorquando
uno dei componenti del nucleo familiare viene trovato a svolgere un’attività di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa “in nero” cioè
senza la preventiva comunicazione obbligatoria online ai servizi per l’impiego
un’attività di impresa o di lavoro autonomo, senza la comunicazione di inizio di
attività all’INPS, da effettuare entro trenta giorni dall’inizio della
stessa” precisano dal Comando Generale della Guardia di finanza . Invece
la revoca del reddito di cittadinanza, ricorre “con efficacia retroattiva,
qualora al termine del processo penale, sia stata accertata la responsabilità
della persona, oltre alla condanna definitiva ne sussiste una accessoria che
comporta la restituzione di quanto indebitamente percepito l’INPS abbia
accertato la non veridicità della documentazione e delle informazioni prodotte a
corredo dell’istanza o l’omessa comunicazione successiva delle variazioni
patrimoniali o riferite ai componenti del nucleo familiare”.



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: